CAPITOLO
QUINTO
LE RIPARAZIONI
I. IMPEGNI ASSUNTI PRIMA DELLE TRATTATIVE DI PACE
Le categorie di danni rispetto alle quali gli Alleati avevano diritto di chiedere riparazioni sono determinate dai passi pertinenti dei Quattordici Punti dell’8 gennaio 1918 del presidente Wilson, il cui testo, con le modifiche apportate dai governi Alleati nella loro Nota di precisazione, fu comunicato formalmente il 5 novembre 1918 dal Presidente al governo tedesco come base della pace. Abbiamo citato integralmente questi passi all’inizio del capitolo quarto: la Germania «risarcirà tutti i danni recati alla popolazione civile dei paesi Alleati e ai suoi beni dall’aggressione tedesca per terra, per mare e dall’aria». Il carattere limitativo di questa frase è rafforzato dal passo del discorso presidenziale dell’11 febbraio 1918 al Congresso (discorso i cui termini fanno espressamente parte del contratto con il nemico), secondo il quale non ci saranno «contribuzioni» né «indennizzi punitivi».
Si è a volte argomentato che il preambolo al paragrafo 1977 delle condizioni di armistizio, dichiarante che «restano impregiudicate future rivendicazioni e richieste degli Alleati e degli Stati Uniti d’America», cancellava tutte le condizioni precedenti, e lasciava liberi gli Alleati di chiedere ciò che volevano. Ma non è possibile sostenere che questa incidentale frase cautelativa, alla quale nessuno a suo tempo attribuì particolare importanza, facesse piazza pulita di tutte le comunicazioni formali circa la base dei termini di pace scambiate tra il Presidente e il governo tedesco nei giorni precedenti l’armistizio, abolisse i Quattordici Punti, e mutasse l’accettazione tedesca delle condizioni d’armistizio in una resa incondizionata, per quanto attiene alle clausole finanziarie. Si tratta soltanto della frase consueta con cui l’estensore di un elenco di rivendicazioni vuole tutelarsi dall’illazione che tale elenco sia esauriente. In ogni caso l’argomento è liquidato dalla risposta Alleata alle osservazioni tedesche sulla prima bozza del trattato, risposta in cui si ammette che le norme del capitolo riparazioni saranno guidate dalla Nota presidenziale del 5 novembre.
Supponendo, dunque, che i termini di questa Nota siano vincolanti, ci resta da chiarire il senso preciso della frase: «tutti i danni recati alla popolazione civile dei paesi Alleati e ai suoi beni dall’aggressione tedesca per terra, per mare e dall’aria». Poche frasi della storia hanno dato ai sofisti e agli avvocati tanto lavoro quanto questa dichiarazione apparentemente semplice e inequivoca. Taluni non si sono fatti scrupolo di sostenere che essa copre l’intero costo della guerra; infatti, argomentano, all’intero costo della guerra bisogna provvedere con la tassazione, e la tassazione «danneggia la popolazione civile». Ammettono che la frase pecca di goffaggine, e che sarebbe stato più semplice dire: «tutte le perdite e spese di qualsiasi genere»; e concedono che l’apparente enfasi posta sui danni alle persone e ai beni dei civili è infelice; ma, a loro avviso, gli errori di redazione non devono privare gli Alleati dei diritti spettanti ai vincitori.
Ma non ci sono soltanto le limitazioni della frase nel suo significato naturale e l’accento posto sui danni civili distinti dalla spesa militare in genere; bisogna anche ricordare che il contesto della frase vuole chiarire il significato del termine «restaurazione» nei Quattordici Punti del Presidente. I Quattordici Punti tengono conto dei danni nei territori invasi – Belgio, Francia, Romania, Serbia e Montenegro (l’Italia è inspiegabilmente omessa) – ma non coprono le perdite marittime dovute ai sommergibili, quelle per i cannoneggiamenti dal mare (come a Scarborough), né i danni delle incursioni aeree. Fu per rimediare a queste omissioni, riguardanti perdite di vite e beni civili non distinguibili essenzialmente da quelle causate nei territori occupati, che il Supremo Consiglio Alleato a Parigi propose al presidente Wilson i suoi emendamenti. Credo che all’epoca – gli ultimi giorni dell’ottobre 1918 – nessuno statista responsabile pensasse di esigere dalla Germania un indennizzo per i costi generali della guerra. Si voleva soltanto mettere in chiaro (punto di considerevole importanza per la Gran Bretagna) che le riparazioni per i danni recati ai non combattenti e ai loro beni non erano limitate ai territori invasi (come sarebbe stato in base ai Quattordici Punti non emendati), ma si applicavano egualmente a tutti i danni del genere, «per terra, per mare o dall’aria». Solo in una fase successiva la diffusa richiesta popolare di un indennizzo che coprisse i costi interi della guerra rese politicamente opportuno praticare la disonestà e tentare di leggere nella parola scritta quello che non c’era.
Quali danni, dunque, possono essere richiesti al nemico in base a un’interpretazione rigorosa dei nostri impegni?78 Nel caso del Regno Unito, il conto riguarderebbe le voci seguenti:
(a) Danni alle persone e ai beni civili causati dagli atti di un governo nemico, con incursioni aeree, bombardamenti navali, guerra sottomarina e mine.
(b) Indennizzo per trattamento scorretto dei civili internati.
Nel conto non sarebbero inclusi i costi generali della guerra né (per esempio) i danni indiretti per le perdite subìte dal commercio.
La richiesta francese comprenderebbe, oltre alle voci corrispondenti a quelle suindicate:
(c) Danni arrecati ai beni e alle persone dei civili in zona di guerra, e da operazioni aeree dietro le linee nemiche.
(d) Indennizzo per le depredazioni di viveri, materie prime, bestiame, macchinari, masserizie, legname e simili effettuate dai governi nemici o loro cittadini nel territorio occupato.
(e) Rimborso delle multe e requisizioni imposte dai governi nemici o loro ufficiali a municipalità o cittadini francesi.
(f) Indennizzo ai cittadini francesi deportati o costretti a lavoro forzato.
In aggiunta a queste c’è un’altra voce di natura più dubbia, ossia:
(g) Spese della commissione d’assistenza per la fornitura di cibo e vestiario alla popolazione civile francese nelle zone occupate dal nemico.
Le richieste belghe consisterebbero di voci analoghe. 79 Se si sostenesse che nel caso del Belgio è giustificabile qualcosa che somigli di più a un indennizzo per i costi generali della guerra, ciò potrebbe valere soltanto a motivo della violazione del diritto internazionale costituita dall’invasione del Belgio, mentre, come abbiamo visto, i Quattordici Punti non contengono richieste speciali a questo riguardo.80 Dato che il costo dell’assistenza al Belgio di cui a (g), come pure i suoi costi generali di guerra, sono già stati coperti da anticipi dei governi britannico, francese e americano, il Belgio userebbe presumibilmente i relativi rimborsi da parte tedesca a parziale pagamento del suo debito verso questi governi; di modo che ogni richiesta del genere è, di fatto, un’aggiunta a quelle dei tre governi prestatori.
Le richieste degli altri Alleati andrebbero compilate con criteri analoghi. Ma nel loro caso sorge più acuto il quesito della misura in cui la Germania possa essere resa responsabile dei danni compiuti non da lei ma dai suoi cobelligeranti, Austria-Ungheria, Bulgaria e Turchia. Tale quesito è uno dei molti ai quali i Quattordici Punti non danno chiara risposta; da un lato, essi coprono esplicitamente al punto 11 i danni recati a Romania, Serbia e Montenegro, senza precisare la nazionalità delle truppe autrici del danno; dall’altro, la Nota degli Alleati parla di aggressione «tedesca» quando avrebbe potuto parlare di aggressione «della Germania e dei suoi alleati». Stando a un’interpretazione letterale e rigorosa, dubito che siano imputabili alla Germania i danni prodotti, per esempio, dai turchi al canale di Suez o dai sommergibili austriaci nell’Adriatico. Ma si tratta di un caso in cui gli Alleati, se volessero forzare un po’ le cose, potrebbero imporre alla Germania una responsabilità sussidiaria senza contravvenire gravemente ai loro impegni.
Quanto ai rapporti degli Alleati tra loro la situazione è molto diversa. Sarebbe un atto di iniqua slealtà se Francia e Inghilterra prendessero tutto quanto la Germania può pagare e lasciassero Italia e Serbia a raccapezzare quello che possono dai resti dell’Austria-Ungheria. È chiaro che i crediti andrebbero messi in comune e ripartiti tra gli Alleati in proporzione alle richieste aggregate.
In questo caso, e se si accetta la mia stima (vedi oltre) secondo la quale la capacità di pagamento della Germania sarà interamente assorbita dalle richieste dirette e legittime degli Alleati nei suoi confronti, la questione della sua responsabilità sussidiaria per i debiti dei suoi cobelligeranti diventa accademica. Sarebbe stata, quindi, politica saggia e onorevole darle il beneficio del dubbio, e reclamare da lei solo i danni che aveva causato direttamente.
A quanto ammonterebbe, sulla base delle legittime pretese suddette, la richiesta complessiva? Non esistono cifre su cui basare una stima scientifica o esatta, e io do la mia ipotesi per quel che vale, premettendovi le osservazioni seguenti.
L’entità dei danni materiali prodotti nei territori invasi è stata oggetto di enormi benché naturali esagerazioni. Un viaggio attraverso le zone devastate della Francia è indescrivibilmente impressionante per l’occhio e per l’immaginazione. Durante l’inverno 1918-1919, prima che la natura rivestisse e abbellisse la scena col suo manto, l’orrenda desolazione della guerra appariva in tutta la sua sciagurata grandezza. La totalità della distruzione era evidente. Per miglia e miglia non restava nulla; non una casa abitabile, non un campo adatto all’aratro. Impressionava anche la monotonia. Un’area devastata era identica all’altra: un cumulo di macerie, un pantano di crateri, un groviglio di reticolati. 81 La quantità di lavoro umano necessaria per restaurare un simile paesaggio sembrava incalcolabile; e per il viaggiatore che ne riemergeva non c’era numero di miliardi sufficiente a esprimere materialmente la distruzione impressa nel suo spirito. Alcuni governi, per varie comprensibili ragioni, non si sono vergognati di sfruttare alquanto questi sentimenti.
L’opinione popolare è soprattutto in errore, credo, riguardo al Belgio. Il Belgio è un piccolo paese, e nel suo caso l’area effettivamente devastata è un’esigua porzione dell’insieme. Il primo assalto tedesco nel 1914 produsse localmente qualche danno; in seguito la linea di battaglia non oscillò avanti e indietro, come in Francia, in una vasta fascia di territorio. Fu praticamente stazionaria, e le ostilità si limitarono a una zona ristretta, buona parte della quale era in tempi recenti arretrata, povera e sonnolenta, e non conteneva l’industria attiva del paese. Restano alcuni danni nella piccola area allagata, i guasti deliberati inferti dai tedeschi in ritirata a edifici, fabbriche e trasporti, la depredazione di macchinari, bestiame e altri beni mobili. Ma Bruxelles, Anversa e anche Ostenda sono sostanzialmente intatte, e la terra, principale ricchezza del Belgio, è in grandissima parte ben coltivata come prima. Il viaggiatore può attraversare in automobile da un capo all’altro l’area devastata del Belgio quasi senza accorgersene; mentre le distruzioni in Francia sono su scala ben diversa. Industrialmente, il saccheggio è stato grave, e per il momento paralizzante; ma l’effettivo costo monetario della sostituzione dei macchinari è relativamente modesto; e pochissime decine di milioni avrebbero coperto il valore di ogni macchina di qualsiasi tipo che il Belgio abbia mai posseduto. Inoltre, un freddo esame statistico non deve trascurare il fatto che nei belgi l’istinto della tutela dei propri interessi individuali è insolitamente sviluppato; e l’ingente massa di banconote tedesche82 possedute nel paese alla data dell’armistizio dimostra che almeno talune classi hanno trovato il modo, nonostante tutte le asprezze e le barbarie del dominio tedesco, di profittare a spese dell’invasore. Le richieste belghe alla Germania quali io le ho vedute, ammontanti a una somma superiore al totale della ricchezza prebellica stimata dell’intero paese, sono semplicemente irresponsabili.83
Aiuterà ad orientarci uno sguardo al prospetto ufficiale della ricchezza del Belgio pubblicato nel 1913 da quel ministero delle Finanze:
| Milioni di sterline | |
|---|---|
| Terra | 264 |
| Fabbricati | 235 |
| Ricchezza personale | 545 |
| Contanti | 17 |
| Mobilia, ecc. | 120 |
| Totale | 1181 |
Questo totale dà una media di 156 sterline per abitante, che il dottor Stamp, massima autorità in materia, è incline a considerare a prima vista troppo bassa (sebbene egli non accetti certe stime molto più alte diffuse di recente), dato che la corrispondente ricchezza pro capite dei vicini immediati del Belgio è pari a 167 sterline per l’Olanda, 244 per la Germania e 303 per la Francia.84 Un totale di 1500 milioni di sterline, che dà una media di circa 200 sterline pro capite, sarebbe tuttavia abbastanza generoso. La stima ufficiale di terra e fabbricati è verosimilmente più precisa delle altre. D’altra parte bisogna tenere conto dell’aumento dei costi di costruzione.
Considerati tutti questi elementi, io ritengo che il valore monetario delle effettive perdite di beni materiali subìte dal Belgio a causa di distruzioni e saccheggi non sia superiore a 150 milioni di sterline al massimo, e mentre esito ad abbassare ulteriormente una stima che tanto differisce da quelle correnti, sarò sorpreso se si riuscirà ad addurre valide prove per richieste pari a questa cifra. Le richieste relative a imposizioni, multe, requisizioni e simili potrebbero forse ammontare ad altri 100 milioni di sterline. Se si includono le somme anticipate al Belgio dai suoi alleati per i costi generali della guerra, bisogna aggiungere circa 250 milioni di sterline (somma comprendente il costo dell’assistenza), che portano il totale a 500 milioni di sterline.
In Francia la distruzione è stata di tutt’altro ordine di grandezza, in ragione non solo della lunghezza della linea di battaglia ma anche del territorio enormemente più ampio sul quale si sono spostati di volta in volta i combattimenti. È un popolare abbaglio vedere nel Belgio la vittima principale della guerra; tenendo conto delle perdite umane e di beni, e del futuro onere debitorio, risulterà, credo, che fra tutti i belligeranti, ad eccezione degli Stati Uniti, il Belgio è quello che ha fatto relativamente meno sacrifici. Degli Alleati, la Serbia ha subìto in proporzione le sofferenze e le perdite maggiori, e dopo la Serbia, la Francia. La Francia è stata essenzialmente vittima dell’ambizione tedesca tanto quanto il Belgio, e la sua entrata in guerra fu altrettanto inevitabile. A mio giudizio la Francia, nonostante la sua politica alla Conferenza di pace, politica largamente riconducibile alle sue sofferenze, ha il massimo diritto alla nostra generosità.
La posizione speciale occupata dal Belgio nell’animo popolare è dovuta naturalmente al fatto che nel 1914 i suoi sacrifici furono di gran lunga maggiori di quelli di ogni altro paese Alleato. Ma dopo il 1914 il Belgio ha avuto un ruolo secondario. Pertanto alla fine del 1918 i suoi sacrifici relativi, a parte le sofferenze prodotte dall’invasione, non misurabili in denaro, erano scaduti di rango, e per certi aspetti non equivalevano nemmeno a quelli, per esempio, dell’Australia. Dico questo senza nessuna intenzione di eludere gli obblighi verso il Belgio che certamente ci impongono le dichiarazioni fatte a più riprese dai nostri politici responsabili. L’Inghilterra non dovrebbe pretendere dalla Germania un soldo per sé finché i giusti diritti del Belgio non siano stati pienamente soddisfatti. Ma questa non è una ragione per non dire la verità, noi e loro, sull’ammontare di tali diritti.
I diritti della Francia sono immensamente più ingenti, ma anche qui ci sono state forti esagerazioni, come hanno osservato gli stessi statistici responsabili francesi. Non più del 10% del territorio francese è stato effettivamente occupato dal nemico, e non più del 4% ha subìto sostanziali devastazioni. Delle sessanta città francesi con più di 35.000 abitanti due soltanto sono state distrutte: Reims (115.178) e San Quintino (55.571); altre tre sono state occupate – Lilla, Roubaix e Douai – e hanno subìto saccheggi di macchinari e altri beni, ma non sono state altrimenti danneggiate in modo considerevole. Amiens, Calais, Dunkerque e Boulogne hanno subìto danni non particolarmente gravi per bombardamenti navali ed aerei; ma il valore di Calais e Boulogne deve essere stato accresciuto dalle nuove attrezzature di vario genere create per uso dell’esercito britannico.
L’Annuaire statistique de la France, 1917 valuta l’intero patrimonio edilizio francese a 2380 milioni di sterline (59,5 miliardi di franchi).85 Una stima corrente in Francia di 800 milioni di sterline (20 miliardi di franchi) per la distruzione dei soli fabbricati è perciò manifestamente lontana dal vero.86 120 milioni di sterline ai prezzi anteguerra, ossia, diciamo, 250 milioni di sterline ai prezzi attuali, è una cifra molto più vicina alla realtà. Le stime del valore della terra in Francia (a parte i fabbricati) variano da 2480 a 3116 milioni di sterline, sicché sarebbe una forte esagerazione far arrivare i danni a questo titolo a 100 milioni di sterline. Il capitale agricolo per l’intera Francia non supera nelle stime dei competenti i 420 milioni di sterline.87 Restano le perdite di mobilia e macchinari, i danni alle miniere di carbone e al sistema dei trasporti, e molte altre voci minori. Ma il valore di queste perdite, per quanto gravi, non può essere calcolato in centinaia di milioni di sterline in relazione a una parte tanto piccola della Francia. In breve, sarà difficile redigere un conto superiore ai 500 milioni di sterline per i danni fisici e materiali delle aree occupate e devastate della Francia settentrionale.88 Mi conferma in questa stima l’opinione di René Pupin, autore della stima più completa e scientifica della ricchezza della Francia prima della guerra,89 di cui sono venuto a conoscenza solo dopo essere arrivato alla mia cifra. Questo studioso stima le perdite materiali delle regioni invase in 400-600 milioni di sterline (da 10 a 15 miliardi di franchi);90 la mia cifra si colloca a metà strada.
Nondimeno il signor Dubois, parlando a nome della commissione bilancio della Camera, ha fatto la cifra di 2600 milioni di sterline (65 miliardi di franchi) «come minimo», senza contare «le imposizioni di guerra, le perdite in mare, le strade, e la perdita di monumenti pubblici». E il 17 febbraio 1919 Louis Loucheur, ministro della Ricostruzione industriale, ha dichiarato davanti al Senato che il reintegro delle regioni devastate richiederà una spesa di 3000 milioni di sterline (75 miliardi di franchi): più del doppio dell’intera ricchezza dei loro abitanti secondo la stima di Pupin. Ma c’è da dire che all’epoca Loucheur aveva una parte di primo piano nel propugnare i diritti della Francia davanti alla Conferenza di pace, e forse, come altri, trovava una rigorosa veridicità incompatibile con le esigenze del patriottismo.91
La cifra discussa finora non rappresenta, peraltro, la totalità delle richieste francesi. Rimangono, in particolare, le imposizioni e requisizioni nelle aree occupate e le perdite della marina mercantile francese per gli attacchi degli incrociatori e sommergibili tedeschi. Probabilmente 200 milioni di sterline basterebbero ampiamente a coprire tutte queste voci; ma per stare sul sicuro ne calcoleremo 300, portando il nostro totale delle spettanze francesi a 800 milioni di sterline in tutto.
Le dichiarazioni di Dubois e Loucheur risalgono all’inizio della primavera 1919. Il discorso pronunciato davanti alla Camera francese sei mesi dopo (5 settembre 1919) dal ministro delle Finanze, Klotz, è meno scusabile. In questo discorso il ministro stimò il totale delle richieste francesi per danni materiali (incluse presumibilmente le perdite in mare, ma non le pensioni e i sussidi) in 5360 milioni di sterline (134 miliardi di franchi), cioè più di sei volte la mia stima. Anche se la mia cifra risultasse erronea, per quella di Klotz non c’è giustificazione possibile. L’inganno in cui il popolo francese è stato indotto dai suoi ministri è talmente grave, che quando verrà in luce la verità (riguardo sia alle richieste francesi, sia alla capacità della Germania di soddisfarle), com’è inevitabile che avvenga, e presto, le ripercussioni colpiranno altri che il ministro Klotz, e potranno anche investire l’assetto del governo e della società che egli rappresenta.
In base ai miei criteri i diritti inglesi sarebbero praticamente limitati alle perdite marittime: perdite di scafi e perdite di carichi. Un risarcimento è dovuto, naturalmente, per i danni a beni civili causati da incursioni aeree e bombardamenti navali, ma rispetto alle cifre di cui stiamo parlando il valore monetario in questione è insignificante: 5 milioni di sterline basterebbero probabilmente, e 10 milioni certamente, a coprirli tutti.
Le navi mercantili britanniche perdute per azione nemica, esclusi i pescherecci, sono 2479, per complessive 7.759.090 tonnellate lorde.92 C’è campo per notevoli divergenze d’opinione circa la giusta somma esigibile per i costi di rimpiazzo; all’aliquota di 30 sterline per tonnellata lorda – che probabilmente con il rapido sviluppo della cantieristica risulterà tra breve troppo elevata, ma può essere sostituita da altra preferita da esperti migliori – 93 la somma complessiva è 230 milioni di sterline. A questa va aggiunta la perdita dei carichi, il cui valore è quasi del tutto congetturale. Una stima di 40 sterline per tonnellata di naviglio perduto è probabilmente la migliore approssimazione possibile; sarebbero quindi 310 milioni di sterline, che fa 540 milioni in tutto.
Un’aggiunta di 30 milioni di sterline per coprire i danni di incursioni aeree, bombardamenti navali, internamento di civili, e voci miscellanee di ogni genere, dovrebbe essere più che sufficiente; e porta le richieste britanniche a un totale di 570 milioni di sterline. Può forse sorprendere che il valore monetario delle nostre spettanze sia di poco inferiore a quello della Francia e addirittura superiore a quello del Belgio. Ma, in termini sia di perdita pecuniaria sia di perdita reale di potenza economica del paese, i danni inflitti alla nostra marina mercantile sono stati enormi.
Restano le richieste di Italia, Serbia e Romania per i danni dovuti all’invasione, e le richieste di questi e altri paesi, per esempio la Grecia,94 per le perdite in mare. Presuppongo per il discorso presente che queste richieste si rivolgano alla Germania, anche quando i danni non siano stati causati da lei ma dai suoi alleati; e che non vengano avanzate richieste analoghe per conto della Russia.95 Le perdite dell’Italia per l’invasione e in mare non possono essere gravissime, e una cifra tra i 50 e i 100 milioni di sterline sarebbe pienamente bastante a coprirle. Le perdite della Serbia, sebbene dal punto di vista umano le sue sofferenze siano state le maggiori di tutte,96 non si misurano pecuniariamente con cifre molto elevate, a causa del basso sviluppo economico del paese. Il dottor Stamp (art. cit.) cita la stima dello statistico italiano Lanfranco Maroi, che valuta la ricchezza nazionale della Serbia in 480 milioni di sterline, pari a 105 sterline pro capite;97 ricchezza rappresentata per la maggior parte dalla terra, che non ha subìto danni permanenti.98 In considerazione dell’insufficienza di dati, che non consente di andare oltre una congettura circa l’ordine generale di grandezza delle richieste legittime di questo gruppo di paesi, preferisco avanzare un’unica ipotesi anziché parecchie, e fisserei per tutto il gruppo 250 milioni di sterline in cifra tonda.
Abbiamo, dunque, il seguente prospetto finale:
| Milioni di sterline | |
|---|---|
| Belgio | 500 99 |
| Francia | 800 |
| Gran Bretagna | 570 |
| Altri Alleati | 250 |
| Totale | 2120 |
Non occorre far presente al lettore che in queste cifre c’è molto di ipotetico; la cifra relativa alla Francia in particolare sarà probabilmente criticata. Ma sono abbastanza fiducioso che l’ordine di grandezza, distinto dalle cifre precise, non sia irrimediabilmente erroneo; e si può esprimerlo dicendo che una richiesta di danni alla Germania basata sull’interpretazione degli impegni prearmistiziali delle Potenze Alleate adottata sopra risulterebbe sicuramente superiore a 1600 e inferiore a 3000 milioni di sterline.
Tale è l’ammontare delle richieste che avevamo diritto di presentare al nemico. Per ragioni che vedremo meglio in seguito, credo che sarebbe stato saggio e giusto proporre al governo tedesco nelle trattative di pace il pagamento di una somma di 2000 milioni di sterline a forfait, senza ulteriore esame dei particolari. Si sarebbe avuta così una soluzione immediata e certa, e la richiesta alla Germania di una somma che, ove le fossero state concesse talune indulgenze, non le sarebbe probabilmente riuscito impossibile pagare. Questa somma, poi, avrebbe dovuto essere ripartita tra gli Alleati in base ai bisogni e a criteri generali di equità.
Ma le cose sono andate altrimenti.
II. LA CONFERENZA E I TERMINI DEL TRATTATO
Credo che alla data dell’armistizio nessuna autorità responsabile dei paesi Alleati si aspettasse dalla Germania indennizzi superiori al costo di riparazione dei danni materiali diretti causati dall’invasione di territorio Alleato e dalla campagna sottomarina. All’epoca c’erano seri dubbi sull’intenzione della Germania di accettare le nostre condizioni, che per altri aspetti erano inevitabilmente molto dure, e sarebbe sembrato impolitico rischiare una continuazione della guerra chiedendo pagamenti in denaro che l’opinione Alleata non si aspettava e che comunque non si sarebbero probabilmente ottenuti. Penso che i francesi non abbiano mai accettato del tutto questo punto di vista; ma ad esso si intonava certamente l’atteggiamento britannico, e fu in questa atmosfera che vennero concepite le condizioni prearmistiziali.
Un mese dopo l’atmosfera era completamente cambiata. Avevamo scoperto quanto fosse in realtà disperata la situazione tedesca; scoperta che alcuni, non tutti, avevano previsto, ma su cui nessuno aveva osato fare sicuro assegnamento. Era evidente ormai che avremmo potuto ottenere una resa incondizionata se decidevamo di pretenderla.
Ma c’era nella situazione un altro fattore nuovo di maggiore importanza locale. Il primo ministro britannico, Lloyd George, aveva capito che la conclusione delle ostilità poteva portare ben presto con sé la dissoluzione del blocco politico su cui si basava la sua supremazia personale, e che le difficoltà interne conseguenti alla smobilitazione, la riconversione dell’industria al regime di pace, la situazione finanziaria, e le generali reazioni psicologiche della popolazione, avrebbero fornito ai suoi avversari armi poderose, se egli lasciava a queste circostanze il tempo di maturare. Perciò il modo migliore di consolidare il suo potere – potere personale, e in quanto tale indipendente da partiti o princìpi in una misura inusitata nella vita politica britannica – era evidentemente muovere all’attacco prima che il prestigio della vittoria fosse sfumato, e tentare di costruire sulle emozioni del momento una nuova base di potere in grado di durare oltre le inevitabili reazioni del prossimo futuro. Quindi il popolare vincitore, al culmine della sua influenza e autorità, indisse le elezioni generali all’indomani dell’armistizio. Questa mossa fu largamente giudicata a suo tempo un atto di immoralità politica. Tutte le ragioni di interesse pubblico chiedevano un breve indugio, finché i problemi della nuova èra si fossero un poco definiti, e finché il paese avesse davanti a sé qualcosa di più preciso su cui pronunciarsi e su cui indirizzare i suoi nuovi rappresentanti. Ma le ragioni dell’ambizione privata decisero diversamente.
Per qualche tempo tutto andò bene. A campagna elettorale avviata, però, i candidati governativi si videro svantaggiati dalla mancanza di un’efficace linea propagandistica. Il Gabinetto di guerra chiedeva un nuovo mandato in base al fatto che aveva vinto la guerra; ma sia perché i nuovi problemi non si erano ancora definiti, sia per riguardo ai delicati equilibri di un governo di coalizione, la futura politica del Primo ministro era oggetto di silenzio o di discorsi generici. La campagna, perciò, sembrava alquanto priva di mordente. Alla luce degli eventi successivi pare improbabile che la coalizione governativa sia mai stata in serio pericolo. Ma i dirigenti di partito sono facili ad allarmarsi. I consiglieri più nevrotici del Premier gli dissero che egli non era al riparo da brutte sorprese, e il Premier prestò loro ascolto. I dirigenti di partito chiedevano più «grinta». Il Premier cercò di provvedere.
Stabilito che l’essenziale era che Lloyd George tornasse al potere, il resto seguì naturalmente. In quel periodo si vociferava da più parti che il governo non aveva dato chiare assicurazioni di voler punire debitamente la Germania. Il primo ministro australiano Hughes suscitava molta attenzione reclamando un indennizzo ingentissimo,100 e Lord Northcliffe dava man forte alla stessa causa. Lloyd George pensò bene di prendere due piccioni con una fava. Adottando le posizioni di Hughes e di Lord Northcliffe avrebbe al tempo stesso messo a tacere quei critici temibili, e fornito alla sua coalizione una efficace piattaforma elettorale per soffocare le crescenti voci critiche provenienti da altre parti.
L’andamento delle elezioni generali del 1918 è la storia triste e drammatica dell’intima debolezza di un uomo che trae maggiormente ispirazione non dai propri impulsi sinceri ma dalle suggestioni più rozze dell’atmosfera che al momento lo circonda. Gli istinti naturali di Lloyd George erano, come sono sovente, giusti e ragionevoli. Non pensava di impiccare il Kaiser e non credeva nella saggezza e nella possibilità di un grande indennizzo. Il 22 novembre egli e Bonar Law pubblicarono il loro manifesto elettorale. Il manifesto non contiene allusioni di sorta all’una o all’altra cosa, ma parlando, piuttosto, di disarmo e di Società delle Nazioni conclude che «il nostro primo compito è realizzare una pace giusta e duratura, e stabilire le basi di una nuova Europa, tali da eliminare per sempre occasioni di altre guerre». Il discorso di Lloyd George a Wolverhampton alla vigilia dello scioglimento delle Camere (24 novembre) non fa parola di riparazioni o indennizzi. Il giorno seguente, a Glasgow, Bonar Law non promise nulla. «Andiamo alla Conferenza» disse «come uno fra più alleati, e non potete aspettarvi che un membro del governo, qualunque cosa pensi, dichiari in pubblico prima di andare a quella conferenza quale linea adotterà riguardo alle singole questioni». Ma pochi giorni dopo a Newcastle (29 novembre) il Premier cominciò a infervorarsi: «La Germania quando sconfisse la Francia la costrinse a pagare. Questo è il principio che essa stessa ha stabilito. Non c’è assolutamente alcun dubbio circa il principio, ed è questo il principio al quale dovremmo attenerci: che la Germania paghi i costi della guerra fino al limite della sua capacità». Egli accompagnò peraltro questa dichiarazione di principio con molte «parole di monito» circa le difficoltà del caso: «Abbiamo nominato una valente commissione di esperti, rappresentante ogni sfumatura d’opinione, perché consideri con la massima attenzione questo problema e ci consigli. La giustizia della richiesta è fuori dubbio. La Germania dovrebbe, deve pagare fin dove può, ma non le consentiremo di pagare in modo tale da rovinare le nostre industrie». A questo punto il Premier voleva mostrarsi incline a grande severità, senza però suscitare eccessive speranze di ottenere effettivamente il denaro e senza impegnarsi su una particolare linea di condotta alla Conferenza. Correva voce che un autorevole personaggio della City avesse dichiarato che la Germania era certamente in grado di pagare 20.000 milioni di sterline, e che secondo lui era plausibile una cifra anche doppia. I funzionari del Tesoro, come indicava Lloyd George, erano di parere diverso. Il Premier, perciò, poteva ripararsi dietro la grande divergenza di opinioni dei suoi vari consiglieri, e considerare la cifra esatta della capacità di pagamento della Germania una questione aperta, riguardo alla quale egli doveva agire al meglio nell’interesse del suo paese. Quanto ai nostri impegni derivanti dai Quattordici Punti, non ne parlava mai.
Il 30 novembre l’onorevole Barnes, membro del Gabinetto di guerra, dove rappresentava in teoria i laburisti, gridò da una tribuna: «Io sono per l’impiccagione del Kaiser».
Il 6 dicembre il Premier emanò una dichiarazione di intenti in cui sostenne, con un accento significativo sulla parola europei, che: «Tutti gli Alleati europei hanno accettato il principio che le Potenze Centrali devono pagare il costo della guerra fino al limite della loro capacità».
Ma mancava ormai poco più di una settimana al giorno della votazione, e Lloyd George non aveva ancora detto abbastanza per soddisfare gli appetiti del momento. L’8 dicembre il «Times», fornendo al solito un manto di apparente decoro al minore ritegno dei suoi colleghi, dichiarò in un editoriale intitolato Far pagare la Germania che l’opinione pubblica era «sconcertata dalle varie dichiarazioni del Primo ministro». «Ci sono troppi sospetti» aggiungeva «di influenze tendenti a lasciare che i tedeschi se la cavino a buon mercato, mentre l’unico criterio nel determinare la loro capacità di pagare deve essere quello degli interessi degli Alleati». «È il candidato che tratta le questioni di oggi,» scriveva il corrispondente politico del giornale «il candidato che adotta il motto di Mr Barnes, “impiccare il Kaiser”, e si scalda perché la Germania paghi il costo della guerra, quello che entusiasma il pubblico e tocca le corde cui esso è più sensibile».
Il 9 dicembre, alla Queen’s Hall, il Premier evitò l’argomento. Ma da qui in avanti la sfrenatezza di pensieri e parole crebbe d’ora in ora. Lo spettacolo più triviale fu offerto da Sir Eric Geddes alla Guildhall di Cambridge. Un precedente discorso in cui Sir Eric in un momento di imprudente schiettezza aveva gettato qualche dubbio sulla possibilità di estrarre dalla Germania l’intero costo della guerra era stato oggetto di gravi sospetti, ed egli doveva perciò rifarsi una reputazione. «Le tireremo fuori tutto quello che si può spremere da un limone e qualcosa di più» gridò il penitente. «La voglio spremere fino a far scricchiolare i semi». La sua proposta era di confiscare ogni briciola di proprietà tedesca nei paesi neutrali e Alleati, e tutto l’oro, l’argento e i gioielli della Germania, le pinacoteche e le biblioteche, e vendere ogni cosa a beneficio degli Alleati. «Spoglierei la Germania» esclamò «come lei ha spogliato il Belgio».
L’11 dicembre il Premier aveva ormai capitolato. Il manifesto finale in sei punti da lui annunciato quel giorno agli elettori offre un paragone malinconico col suo programma di tre settimane prima. Lo cito per intero:
- Processo del Kaiser.
- Punizione dei responsabili di atrocità.
- Indennizzi integrali da parte della Germania.
- Britain for the British, socialmente e industrialmente.
- Riabilitazione di chi è stato rovinato dalla guerra.
- Un paese più felice per tutti.
Qui c’è pane per i cinici. A questa mistura di avidità e sentimento, di inganno e pregiudizio, tre settimane di campagna elettorale avevano ridotto i potenti governanti d’Inghilterra, che poco prima avevano parlato non ignobilmente di disarmo, di Società delle Nazioni, di una pace giusta e duratura che stabilisse le basi di una nuova Europa.
La stessa sera, a Bristol, Lloyd George cancellò di fatto le sue riserve precedenti e fissò quattro criteri della sua politica in materia di indennizzi. I principali erano: primo, abbiamo l’assoluto diritto di esigere il pagamento dell’intero costo della guerra; secondo, intendiamo esercitare pienamente tale diritto; terzo, una commissione nominata per ordine del governo giudica che la Germania può pagare.101 Quattro giorni dopo andò alle urne.
Il Primo ministro non disse mai di ritenere personalmente che la Germania fosse in grado di pagare l’intero costo della guerra. Ma in bocca ai tribuni suoi sostenitori il programma divenne molto più concreto. Il comune elettore fu indotto a credere che la Germania potesse pagare, se non tutto, la maggior parte del costo della guerra. Coloro in cui le spese di guerra avevano destato timori pratici ed egoistici per il futuro, e coloro che i suoi orrori avevano emotivamente sconvolto, erano entrambi accontentati. Votare per un candidato della Coalizione significava crocifiggere l’Anticristo e scaricare sulla Germania il debito nazionale britannico.
Era una combinazione irresistibile, e ancora una volta l’istinto politico di Lloyd George non fallì. Nessun candidato poteva attaccare impunemente questo programma, e nessuno lo fece. Il vecchio Partito liberale, non avendo nulla di paragonabile da offrire all’elettorato, fu spazzato via.102 Si riunì una nuova Camera dei Comuni, composta in maggioranza di membri che nei loro impegni si erano spinti molto più in là delle caute promesse del Premier. Poco dopo l’arrivo di costoro a Westminster io chiesi a un amico conservatore, che aveva conosciuto Camere precedenti, che cosa ne pensava. «Sono un mucchio di facce di bronzo,» rispose «che hanno l’aria di avere ben profittato della guerra».
Questo il clima in cui il Premier partì per Parigi, e questi i lacci che egli si era creato. Aveva vincolato sé e il suo governo a fare a un nemico inerme richieste contrastanti con gli impegni solenni da noi assunti, e confidando nei quali questo nemico aveva deposto le armi. Ci sono nella storia pochi episodi che la posterità avrà minor motivo di condonare: una guerra dichiaratamente combattuta in difesa della sacralità degli impegni internazionali, che termina con la patente violazione di uno tra i più sacri di tali impegni da parte dei campioni vittoriosi di questi ideali.103
A parte altri aspetti dell’operazione, credo che la campagna per ottenere dalla Germania il pagamento dei costi generali della guerra sia una delle peggiori stoltezze politiche di cui i nostri statisti si siano mai resi responsabili. Quale ben diverso futuro l’Europa avrebbe potuto sperare se Lloyd George o Wilson avessero capito che i problemi più gravi reclamanti la loro attenzione non erano politici o territoriali ma finanziari ed economici, e che i pericoli del futuro non stavano in frontiere e sovranità ma in cibo, carbone e trasporti. Nessuno dei due si occupò adeguatamente di questi problemi in nessuna fase della Conferenza. Ma in ogni caso l’atmosfera adatta a una loro saggia e ragionevole considerazione era annebbiata irrimediabilmente dagli impegni della delegazione britannica sulla questione degli indennizzi. Le speranze che Lloyd George aveva fatto nascere non solo lo costrinsero a propugnare una base economica iniqua e irrealizzabile per il trattato con la Germania, ma lo misero in contrasto con il Presidente, e d’altro canto con gli interessi concorrenti di Francia e Belgio. Più diventava chiaro che dalla Germania c’era poco da cavare, e più era necessario esercitare l’avidità patriottica e il «sacro egoismo» e strappare l’osso alle più giuste richieste e maggiori bisogni della Francia o alle ben fondate aspettative del Belgio. Ma i problemi finanziari che incombevano sull’Europa non potevano essere risolti dall’avidità. Per essi la possibilità di cura stava nella magnanimità.
L’Europa, se vuol sopravvivere ai suoi guai, avrà bisogno di tanta magnanimità da parte dell’America, che è bene cominci a praticarla lei. È inutile che gli Alleati, reduci dalla spoliazione della Germania e dalla spoliazione reciproca, si rivolgano agli Stati Uniti perché li aiutino a rimettere in piedi gli Stati europei, Germania inclusa. Se le elezioni generali inglesi del dicembre 1918 si fossero imperniate su una visione di prudente generosità invece che di avidità imbecille, quanto migliori potrebbero essere adesso le prospettive finanziarie dell’Europa. Continuo a essere convinto che prima della conferenza principale, o nelle fasi iniziali dei suoi lavori, i rappresentanti della Gran Bretagna avrebbero dovuto esaminare a fondo, insieme a quelli degli Stati Uniti, la situazione economica e finanziaria nel suo complesso, ed essere autorizzati a fare proposte concrete su queste linee generali: (1) cancellazione immediata di tutti i debiti interalleati; (2) accordo su 2000 milioni di sterline come somma da pagarsi dalla Germania; (3) rinuncia della Gran Bretagna a ogni pretesa su questa somma; e l’eventuale quota cui avesse diritto messa a disposizione della Conferenza per aiutare le finanze dei nuovi Stati di prossima istituzione; (4) garanzia di tutti i firmatari del trattato su una porzione conveniente delle obbligazioni tedesche rappresentanti la somma da pagarsi dalla Germania, al fine di costituire una base di credito immediatamente disponibile; (5) dare anche alle potenze ex nemiche, ai fini del loro risanamento economico, la facoltà di emettere una moderata quantità di titoli provvisti di una garanzia analoga. Tali proposte comportavano un appello alla generosità degli Stati Uniti. Ma questo era inevitabile; e in considerazione dei sacrifici finanziari molto minori da essi subìti era un appello che poteva essere loro equamente rivolto. Erano proposte praticabili; senza niente di donchisciottesco o di utopico. E avrebbero aperto all’Europa buone prospettive di stabilità finanziaria e di ricostruzione.
Ma l’ulteriore elaborazione di queste idee va rimandata al capitolo settimo, e dobbiamo tornare a Parigi. Ho descritto le pastoie che Lloyd George aveva portato con sé. La situazione dei ministri finanziari degli altri Alleati era anche peggiore. Noi in Gran Bretagna non avevamo basato le nostre disposizioni finanziarie sull’aspettativa di indennizzi. Introiti da questa fonte avrebbero avuto più o meno il carattere di un colpo di fortuna; e, nonostante gli sviluppi successivi, si prevedeva all’epoca di pareggiare il nostro bilancio con metodi ordinari. Ma questo non era il caso di Francia e Italia. I loro bilanci di pace non si proponevano né avevano prospettive di pareggio senza una profonda revisione della politica finanziaria. La loro situazione era e rimane quasi disperata. Questi paesi erano avviati alla bancarotta nazionale; un fatto che si poteva occultare solo puntando sulla speranza di vasti introiti provenienti dal nemico. Se si ammetteva che far pagare alla Germania le spese di entrambi i paesi era di fatto impossibile, e che non si potevano scaricare sul nemico le loro passività, la posizione dei ministri finanziari di Francia e Italia diventava insostenibile.
Così un esame scientifico della capacità della Germania di pagare fu escluso fin dall’inizio dai lavori. Le aspettative che le esigenze della politica avevano imposto di suscitare erano talmente lontane dalla realtà che una leggera modifica delle cifre non sarebbe servita a nulla; bisognava ignorare completamente i fatti. La non veridicità risultante era fondamentale. Sulla base di tanta falsità diventava impossibile mettere in piedi una politica finanziaria costruttiva che funzionasse. Per questa ragione tra altre era essenziale una politica finanziaria magnanima. La situazione finanziaria di Francia e Italia era talmente cattiva che non c’era modo di far sì che sentissero ragioni sull’argomento degli indennizzi tedeschi, se non gli si indicava al tempo stesso una via alternativa per uscire dalle loro difficoltà. 104 Non avere proposte costruttive di sorta da offrire a un’Europa sofferente e sconvolta fu a mio avviso una grave mancanza dei delegati degli Stati Uniti.
Vale la pena di segnalare per inciso un altro elemento della situazione, cioè il contrasto esistente tra la politica di «schiacciamento» di Clemenceau e le necessità finanziarie del ministro Klotz. Clemenceau mirava a indebolire e distruggere la Germania in tutti i modi possibili, e ho idea che nutrisse un certo disprezzo per la questione degli indennizzi; non aveva nessuna intenzione di lasciare la Germania in grado di praticare una vasta attività commerciale. Ma non si lambiccava il cervello per capire qualcosa né di indennizzi né delle soverchianti difficoltà economiche del povero Klotz. Se divertiva i ministri finanziari inserire nel trattato richieste mastodontiche, non c’era niente di male; ma non si doveva permettere che la soddisfazione di queste richieste interferisse con le esigenze essenziali di una pace cartaginese. La combinazione tra politica «realistica» di Clemenceau su questioni irreali, e politica fittizia di Klotz su questioni che reali erano fin troppo, introdusse nel trattato tutta una serie di norme contraddittorie, in aggiunta alle impraticabilità insite nelle proposte di riparazioni.
Non posso qui descrivere gli intrighi e le controversie interminabili tra gli Alleati medesimi, che dopo alcuni mesi approdarono alla presentazione alla Germania del capitolo riparazioni nella sua forma finale. Di rado possono esserci stati nella storia negoziati così contorti, così miserabili, così totalmente insoddisfacenti per tutti gli interessati. Dubito che chiunque abbia avuto molta parte in quel dibattito possa ripensarci senza vergogna. Devo accontentarmi di un’analisi degli elementi del compromesso finale che tutto il mondo conosce.
Il punto principale da stabilire era naturalmente per quali voci fosse giusto chiedere alla Germania di pagare. La dichiarazione elettorale di Lloyd George che gli Alleati avevano diritto di pretendere dalla Germania l’intero costo della guerra si dimostrò subito chiaramente insostenibile; o piuttosto, per dirla in modo più imparziale, fu chiaro che nessun sofisma sarebbe riuscito a persuadere il presidente Wilson della conformità di questa pretesa con i nostri impegni prearmistiziali. L’effettivo compromesso alla fine raggiunto risulta il seguente, nei paragrafi del trattato quale è stato pubblicato.
Dice l’articolo 231: «I governi Alleati e Associati affermano e la Germania accetta la responsabilità della Germania e dei suoi alleati per tutti i danni e le perdite subìti dai governi Alleati e Associati e dai loro cittadini a causa della guerra loro imposta dall’aggressione della Germania e dei suoi alleati». Questo è un articolo formulato con cura sapiente, perché il Presidente poteva leggerlo come un’ammissione da parte della Germania di responsabilità morale per aver scatenato la guerra, mentre il Primo ministro britannico poteva spiegarlo come ammissione di responsabilità finanziaria per i costi generali della guerra. L’articolo 232 continua: «I governi Alleati e Associati riconoscono che le risorse della Germania, tenuto conto delle diminuzioni permanenti di tali risorse che risulteranno da altre disposizioni del presente trattato, non sono sufficienti a fare completa riparazione per tutti questi danni e perdite». Il Presidente poteva rassicurarsi pensando che questa era solo l’enunciazione di un fatto indubitato, e che riconoscere che la Germania non può pagare un certo risarcimento non implica che essa sia obbligata a pagarlo; ma il Primo ministro poteva osservare che nel contesto la frase sottolinea al lettore l’assunzione di responsabilità teorica della Germania affermata nell’articolo precedente. L’articolo 232 prosegue: «I governi Alleati e Associati, tuttavia, esigono e la Germania si impegna a risarcire tutti i danni recati alle persone e ai beni della popolazione civile delle Potenze Alleate e Associate, durante il periodo di belligeranza di ciascuna di esse quale potenza Alleata o Associata contro la Germania, da questa aggressione per terra, per mare e dall’aria, e in generale tutti i danni definiti nell’allegato I al presente articolo».105 Le parole in corsivo, essendo in pratica una citazione delle condizioni prearmistiziali, soddisfacevano gli scrupoli di Wilson, mentre l’aggiunta delle parole «e in generale tutti i danni definiti nell’allegato I» davano a Lloyd George possibilità di manovra nell’allegato stesso.
Fin qui, peraltro, si tratta solo di parole, di virtuosismi redazionali, che non fanno male a nessuno e che probabilmente sembrarono all’epoca molto più importanti di quanto mai torneranno a esserlo da adesso al giorno del Giudizio. Per la sostanza dobbiamo rivolgerci all’allegato I.
Una gran parte dell’allegato I è strettamente conforme alle condizioni prearmistiziali, o almeno non le forza oltre il lecitamente sostenibile. Il paragrafo 1 chiede risarcimento per danni alle persone subìti da civili come diretta conseguenza di atti di guerra (in caso di morte, a favore delle persone a carico); il paragrafo 2, per atti di crudeltà, violenza o maltrattamenti da parte del nemico verso vittime civili; il paragrafo 3, per atti nemici lesivi della salute, della capacità lavorativa o dell’onore di vittime civili nei territori occupati o invasi; il paragrafo 8, per lavori forzati imposti dal nemico a civili; il paragrafo 9, per danni recati a beni, «ad eccezione di opere o materiali navali e militari», come conseguenza diretta delle ostilità; e il paragrafo 10, per ammende e imposizioni del nemico alla popolazione civile. Tutte queste richieste sono giuste e rispondenti ai diritti degli Alleati.
Il paragrafo 4, reclamante «i danni per maltrattamenti di qualsiasi genere di prigionieri di guerra», è più dubbio a rigor di lettera, ma può essere giustificabile in base alla convenzione dell’Aia e implica una somma modestissima.
Ma nei paragrafi 5, 6 e 7 entra in campo una questione di portata immensamente maggiore. Questi paragrafi affermano un diritto di indennizzo per l’ammontare dei sussidi di vario genere concessi dai governi Alleati alle famiglie dei mobilitati, e per l’ammontare delle pensioni e indennità per invalidità o morte di combattenti pagabili da questi governi ora e in seguito. Finanziariamente ciò aggiunge al conto, come vedremo più avanti, una somma ingentissima, pari a circa il doppio di tutte le altre richieste messe insieme.
Al lettore sarà facile comprendere come si possa argomentare una tesi plausibile a favore dell’inclusione di queste categorie di danni, non foss’altro sul piano sentimentale. Si può osservare, anzitutto, che dal punto di vista di una generale equità è mostruoso che una donna la quale ha avuto la casa distrutta abbia diritto a un risarcimento da parte del nemico, e che non lo abbia una donna il cui marito è caduto sul campo di battaglia; o che un agricoltore privato della sua fattoria sia risarcito, e non lo sia una donna privata della capacità di guadagno del marito. Di fatto la sostenibilità dell’inclusione di pensioni e sussidi dipende largamente dallo sfruttamento del carattere piuttosto arbitrario del criterio fissato nelle condizioni prearmistiziali. Di tutte le perdite causate dalla guerra alcune pesano più gravemente sui singoli individui e altre sono distribuite in modo più uniforme sull’insieme della comunità; ma mediante le indennità concesse dal governo molte delle prime sono di fatto convertite nelle seconde. Il criterio più logico per un risarcimento limitato, al di qua dei costi interi della guerra, sarebbe stato di riferirsi ad atti nemici contrari agli impegni internazionali o alle norme di guerra riconosciute. Ma anche questo criterio sarebbe stato di assai difficile applicazione e indebitamente sfavorevole agli interessi francesi rispetto a quelli del Belgio (la cui neutralità la Germania aveva garantito) e della Gran Bretagna (vittima principale di azioni illecite della guerra sottomarina).
In ogni caso gli appelli suaccennati al sentimento e all’equità sono gratuiti: perché per il beneficiario di un sussidio o di una pensione non fa differenza se lo Stato che li corrisponde riceve indennizzo sotto questo o sotto altro titolo, e un recupero da parte dello Stato sugli introiti di risarcimento avvantaggia il comune contribuente tanto quanto lo avrebbe avvantaggiato un contributo ai costi generali della guerra. Ma il punto principale è che era troppo tardi per considerare se le condizioni prearmistiziali fossero perfettamente giudiziose e logiche o per emendarle; la sola questione in ballo era se queste condizioni non fossero di fatto limitate alle categorie di danni diretti ai civili e ai loro beni indicate nei paragrafi 1, 2, 3, 8, 9 e 10 dell’allegato I. Se le parole hanno un senso, e gli impegni un valore, noi non avevamo diritto di chiedere risarcimento per le spese di guerra dello Stato derivanti da pensioni e sussidi più di quanto ne avessimo per qualunque altro dei costi generali della guerra. E chi è disposto a sostenere in dettaglio che noi avevamo diritto di esigere questi ultimi?
Ciò che in realtà era accaduto era un compromesso tra l’impegno di Lloyd George verso l’elettorato britannico di reclamare il rimborso totale dei costi della guerra e l’impegno contrario assunto dagli Alleati verso la Germania con l’armistizio. Il Premier poteva affermare che pur non avendo ottenuto quel rimborso totale se ne era tuttavia assicurata una parte cospicua; che egli aveva sempre condizionato le sue promesse alla capacità della Germania di pagare, e che il conto ora presentato esauriva abbondantemente tale capacità quale veniva stimata dai competenti più avveduti. Il Presidente, d’altro canto, aveva ottenuto una formula che non violava troppo palesemente la parola data, e aveva evitato uno scontro con i suoi associati su una questione dove gli appelli al sentimento e alle passioni sarebbero stati tutti contro di lui, nel caso che essa diventasse materia di aperta controversia popolare. Il Presidente non poteva sperare di indurre Lloyd George ad abbandonare interamente, senza una pubblica lotta, le sue promesse elettorali; e la rivendicazione delle pensioni avrebbe esercitato un richiamo irresistibile in tutti i paesi. Ancora una volta Lloyd George si era dimostrato un maestro di tattica politica.
Un altro punto di grande difficoltà è agevolmente percepibile tra le righe del trattato. Il trattato non fissa in una somma precisa il debito della Germania. Questo elemento è stato oggetto delle critiche generali: nel senso che è altrettanto incomodo per la Germania e per gli stessi Alleati che essa non sappia quanto deve pagare e loro quanto devono incassare. Il metodo in apparenza contemplato dal trattato, di arrivare al risultato finale nel corso di molti mesi, sommando centinaia di migliaia di singole richieste per danni alla terra, agli edifici agricoli e al pollame è evidentemente impraticabile; la via ragionevole sarebbe stata che le due parti si accordassero su una cifra globale senza esame dei dettagli. Se si fosse specificata nel trattato questa cifra globale, la sistemazione finale sarebbe stata posta su una base più concreta.
Ma ciò era impossibile per due ragioni. Due falsità di diverso genere erano state ampiamente propalate, una circa la capacità di pagamento della Germania, l’altra circa l’ammontare delle giuste richieste degli Alleati riguardo alle aree devastate. Fissare una cifra nell’uno e nell’altro caso presentava un dilemma. Una cifra relativa alla probabile capacità di pagamento tedesca che non superasse oltremisura le stime dei competenti più schietti e meglio informati sarebbe rimasta irrimediabilmente molto al di sotto delle aspettative popolari in Inghilterra e in Francia. D’altro canto, una cifra definitiva per il risarcimento dei danni che non deludesse disastrosamente le aspettative suscitate in Francia e in Belgio rischiava di non reggere alle contestazioni,106 e di prestarsi a critiche deleterie da parte dei tedeschi, che a quanto si credeva avevano avuto la prudenza di accumulare una documentazione considerevole sull’entità effettiva dei loro misfatti.
Per i politici la via più sicura era quindi di non indicare cifre di sorta; e da questa necessità derivano essenzialmente in buona parte le complicazioni del capitolo riparazioni.
Al lettore, tuttavia, può interessare conoscere la mia stima delle richieste di fatto sostenibili in base all’allegato I del capitolo riparazioni. Nella prima parte del presente capitolo ho già valutato le richieste altre da quelle per pensioni e sussidi in 3000 milioni di sterline al massimo. La richiesta per pensioni e sussidi di cui all’allegato I non va basata sul costo effettivo di queste indennità per i governi interessati, ma deve essere una cifra calcolata in base al tariffario esistente in Francia alla data dell’entrata in vigore del trattato. Questo metodo evita l’odiosità di valutare una vita americana o britannica a una cifra più alta di una vita francese o italiana. Il livello francese di pensioni e sussidi è a una quota intermedia, meno alto di quello americano e britannico, ma superiore a quello italiano, belga e serbo. I soli dati occorrenti per il calcolo sono le effettive tariffe francesi, e il numero degli uomini mobilitati e dei morti e feriti in ciascuna categoria dei vari eserciti Alleati. Nessuna di queste cifre è disponibile in dettaglio, ma si sa abbastanza del livello generale dei sussidi, del numero dei mobilitati e delle perdite per consentire una stima che probabilmente non è molto lontana dal segno. La mia stima della somma da aggiungere per pensioni e sussidi è la seguente:
| Milioni di sterline | |
|---|---|
| Impero britannico | 1400 |
| Francia | 2400107 |
| Italia | 500 |
| Altri (inclusi gli Stati Uniti) | 700 |
| Totale | 5000 |
Sono molto più fiducioso nell’esattezza approssimativa della cifra totale108 che nella sua ripartizione tra i vari pretendenti. Il lettore osserverà che in ogni caso l’aggiunta di pensioni e sussidi accresce enormemente la richiesta aggregata, raddoppiandola quasi. Aggiungendo questa cifra alla stima per altre voci abbiamo una richiesta totale alla Germania di 8000 milioni di sterline.109 Credo che questa cifra sia alta abbastanza, e che la somma effettiva possa risultare alquanto inferiore.110 Nella prossima parte di questo capitolo esamineremo il rapporto di questa cifra con la capacità di pagamento della Germania. Qui è necessario soltanto ricordare al lettore certi altri particolari del trattato che parlano da soli:
(1) Sull’ammontare totale della richiesta, quale che risulti alla fine, va pagata prima del 1° maggio 1921 la somma di 1000 milioni di sterline. Discuteremo tra breve della possibilità di farlo. Ma il trattato stesso prevede certe riduzioni. In primo luogo, questa somma includerà le spese degli eserciti di occupazione dal giorno dell’armistizio (un grosso onere dell’ordine di 200 milioni di sterline che in base a un altro articolo del trattato – il 249 – è imposto alla Germania).111 Inoltre, «anche i rifornimenti di viveri e materie prime che dalle principali Potenze Alleate e Associate siano giudicati indispensabili per mettere in grado la Germania di far fronte ai suoi obblighi di riparazione possono essere pagati, previa approvazione di detti governi, con detrazione dalla somma suddetta».112 Questa è una precisazione di grande importanza. La clausola, per come è formulata, permette ai ministri finanziari dei paesi Alleati di prospettare ai loro elettori la speranza di sostanziosi pagamenti nel futuro prossimo, mentre al tempo stesso dà alla commissione riparazioni il potere discrezionale, che la forza dei fatti la costringerà a esercitare, di restituire alla Germania ciò che occorre per il mantenimento della sua esistenza economica. Questo potere discrezionale rende la richiesta del pagamento immediato di 1000 milioni di sterline meno perniciosa di quanto sarebbe altrimenti, ma non la rende innocua. In primo luogo, le mie conclusioni nella prossima parte del presente capitolo indicano che questa somma non è reperibile nel periodo prescritto, anche se una larga porzione ne è in pratica restituita alla Germania al fine di metterla in grado di pagare le importazioni. In secondo luogo, la commissione riparazioni può esercitare effettivamente il suo potere discrezionale solo assumendo il controllo dell’intero commercio estero della Germania, insieme alla valuta estera che ne deriva, cosa che esorbita completamente dalla capacità di un organo del genere. Se la commissione riparazioni tenterà seriamente di amministrare la riscossione di questa somma di 1000 milioni di sterline, e di autorizzare la restituzione alla Germania di una parte di essa, il commercio dell’Europa centrale sarà strangolato da regolamenti burocratici del tipo più inefficiente.
(2) In aggiunta al sollecito pagamento in denaro o in natura di questa somma di 1000 milioni di sterline, la Germania è tenuta a consegnare titoli al portatore per un ulteriore ammontare di 2000 milioni di sterline, o, nell’eventualità che i pagamenti in denaro o in natura prima del 1° maggio 1921 disponibili per le riparazioni siano inferiori a 1000 milioni di sterline in ragione delle deduzioni permesse, per un ulteriore ammontare tale da portare i pagamenti totali della Germania in denaro, in natura e in titoli al portatore entro il 1° maggio 1921 a una cifra pari a complessivi 3000 milioni di sterline.113 Questi titoli al portatore danno un interesse del 2½% annuo dal 1921 al 1925, e del 5% più 1% di ammortamento in seguito. Supponendo, perciò, che la Germania non sia in grado di fornire una eccedenza apprezzabile in conto riparazioni prima del 1921, essa dovrà trovare una somma annuale di 75 milioni di sterline dal 1921 al 1925, e una somma annuale di 180 milioni in seguito.114
(3) Non appena la commissione riparazioni si persuada che la Germania può fare di più, dovranno essere emessi titoli al portatore al 5% per altri 2000 milioni di sterline; il tasso di ammortamento sarà fissato in seguito dalla commissione. Ciò porterebbe il pagamento annuale a 280 milioni di sterline, esclusa ogni quota di riscatto del capitale degli ultimi 2000 milioni di sterline.
(4) Il debito della Germania, tuttavia, non è limitato a 5000 milioni di sterline, e la commissione riparazioni chiederà ulteriori quote di titoli al portatore fino all’estinzione totale del debito nemico di cui all’allegato I. Sulla base della mia stima di 8000 milioni di sterline per il debito totale, che pecca probabilmente più per difetto che per eccesso, l’ammontare di questo saldo sarà di 3000 milioni di sterline. Supponendo un interesse del 5% ciò porterà il pagamento annuale a 430 milioni di sterline, senza alcuna quota di ammortamento.
(5) Ma questo non è ancora tutto. C’è un’altra clausola di portata rovinosa. Titoli per pagamenti eccedenti i 3000 milioni di sterline non dovranno essere emessi finché la commissione non ritenga che la Germania è in grado di pagare gli interessi sui medesimi. Ma questo non significa che nel frattempo gli interessi saranno sospesi. A partire dal 1° maggio 1921 saranno addebitati alla Germania gli interessi su quella parte del suo debito pendente che non sia stata coperta con pagamenti in denaro o in natura o con l’emissione di titoli come sopra,115 e «il tasso di interesse sarà del 5% a meno che la commissione determini in futuro che le circostanze giustificano una variazione di questo tasso». Cioè, la somma capitale del debito aumenta di continuo all’interesse composto. Supponendo che la Germania non sia in grado di pagare in un primo tempo una somma ingentissima, questa clausola avrà l’effetto di accrescere enormemente l’onere. All’interesse composto del 5% una somma capitale si raddoppia in quindici anni. Nell’ipotesi che la Germania non possa pagare annualmente più di 150 milioni di sterline fino al 1936 (ossia il 5% di interesse su 3000 milioni di sterline), i 5000 milioni di sterline sui quali l’interesse viene differito saranno saliti a 10.000 milioni, con una spesa annua per interessi di 500 milioni. Vale a dire che anche se la Germania paga annualmente 150 milioni di sterline fino al 1936, a quella data essa ci dovrà quasi il doppio di quanto ci deve adesso (13.000 milioni di sterline invece di 8000). Dal 1936 in poi essa dovrà versarci annualmente 650 milioni di sterline per tenersi al passo con i soli interessi. Alla fine di ogni anno in cui essa paghi meno di questa somma il suo debito sarà maggiore di quanto era all’inizio dell’anno. E se vuole estinguere la somma capitale in trent’anni a partire dal 1936, cioè in quarantotto anni dalla data dell’armistizio, la Germania dovrà pagare annualmente 130 milioni di sterline in più, che fanno 780 milioni di sterline in tutto.116
A mio giudizio è assolutamente certo, per ragioni che spiegherò fra un momento, che la Germania non può pagare niente che si avvicini a questa somma. Finché il trattato non sarà modificato, perciò, la Germania si è di fatto impegnata a consegnare in perpetuo agli Alleati il suo intero surplus di produzione.
(6) Questo non è meno vero perché si sono dati alla commissione riparazioni poteri discrezionali di variare il tasso di interesse, e di differire e anche annullare il debito capitale. In primo luogo, alcuni di questi poteri possono essere esercitati soltanto se la commissione o i governi in essa rappresentati sono unanimi.117 Ma inoltre, cosa forse più importante, sarà dovere della commissione riparazioni, finché non ci sia stato un unanime e drastico cambiamento della politica che il trattato rappresenta, ricavare dalla Germania anno dopo anno la massima somma ottenibile. C’è una grossa differenza tra fissare una somma precisa, pur grande, che la Germania abbia la capacità di pagare tenendo al tempo stesso qualcosa per sé, e fissare una somma molto superiore alla sua capacità, che poi può essere ridotta a discrezione di una commissione straniera guidata dall’obbiettivo di ottenere ogni anno il massimo consentito dalle circostanze di quell’anno. La prima alternativa lascia alla Germania un qualche incentivo all’iniziativa, all’energia e alla speranza. La seconda la scortica viva anno per anno in perpetuo, e per quanto abilmente e discretamente sia condotta l’operazione, badando a non uccidere il paziente sotto i ferri, rappresenta una politica che se fosse davvero contemplata e deliberatamente attuata sarebbe condannata dal giudizio degli uomini come uno degli atti più obbrobriosi di un crudele vincitore nella storia del mondo civile.
Ci sono altre funzioni e poteri di grande importanza che il trattato accorda alla commissione riparazioni. Ma sarà opportuno trattarne in un paragrafo a sé.
III. LA CAPACITÀ DI PAGAMENTO DELLA GERMANIA
Le forme in cui la Germania può corrispondere la somma che si è impegnata a pagare sono tre:
(1) ricchezza immediatamente trasferibile sotto forma di oro, navi e titoli esteri; (2) valore dei beni esistenti nei territori ceduti, o consegnati a norma dell’armistizio; (3) pagamenti annuali distribuiti in un periodo di anni, parte in denaro e parte in materiali quali carbone e derivati, potassa e coloranti.
È esclusa da quanto sopra la restituzione vera e propria di beni asportati da territori occupati dal nemico, come per esempio oro russo, titoli belgi e francesi, bestiame, macchinari e opere d’arte. Nella misura in cui tali beni possono essere identificati e reintegrati, essi devono ovviamente essere restituiti ai legittimi proprietari, e non possono essere compresi nel novero generale delle riparazioni. Ciò è stabilito espressamente dall’articolo 238 del trattato.
1. Ricchezza immediatamente trasferibile
(a) Oro. Dedotto l’oro da restituire alla Russia, il patrimonio aureo ufficiale indicato nel rendiconto della Reichsbank del 30 novembre 1918 ammontava a 115.417.900 sterline. Questa somma, molto maggiore di quella indicata nel rendiconto della Reichsbank alla vigilia della guerra,118 era il risultato della vigorosa campagna condotta in Germania durante la guerra per la consegna alla Reichsbank non solo di monete d’oro ma di oggetti d’oro d’ogni genere. Esistono ancora senza dubbio tesori privati, ma considerando i grandi sforzi già fatti è improbabile che il governo tedesco o gli Alleati riescano a scovarli. Si può quindi ritenere che il rendiconto rappresenti verosimilmente la quantità massima d’oro che il governo tedesco può ricavare dalla popolazione. Insieme all’oro c’era nella Reichsbank una somma di circa 1 milione di sterline in argento. Inoltre deve esserci in circolazione un’altra somma cospicua, perché i depositi della Reichsbank ammontavano a 9,1 milioni di sterline il 31 dicembre 1917, e si mantennero intorno ai 6 milioni fino alla seconda metà dell’ottobre 1918, quando cominciò la corsa interna alle valute di ogni genere.119 Possiamo quindi calcolare, diciamo, un totale di 125 milioni di sterline tra oro e argento alla data dell’armistizio.
Queste riserve, peraltro, non sono più intatte. Nel lungo periodo trascorso fra l’armistizio e la pace gli Alleati si trovarono costretti ad approvvigionare la Germania dall’esterno. La situazione politica della Germania e la grave minaccia dello spartachismo rendevano necessario questo passo nell’interesse degli stessi Alleati, se volevano il permanere in Germania di un governo stabile con cui trattare. La questione di come andassero pagate queste forniture presentava però grandi difficoltà. Si tennero una serie di conferenze, a Treviri, a Spa, a Bruxelles e successivamente a Château Villette e a Versailles, tra i rappresentanti degli Alleati e della Germania, allo scopo di trovare un modo di pagamento che pregiudicasse il meno possibile le future prospettive di pagamenti in conto riparazioni. I delegati tedeschi sostennero fin dall’inizio che per adesso il loro paese era finanziariamente esausto, e che la sola soluzione possibile era un prestito temporaneo alleato. Questo gli Alleati difficilmente potevano ammetterlo, in un momento in cui stavano preparando richieste alla Germania di pagamenti immediati per somme incomparabilmente maggiori. Ma a parte ciò, l’asserzione tedesca non era accettabile come rigorosamente veritiera finché le riserve auree della Germania restavano intatte e i suoi titoli esteri non commercializzati. In ogni caso, era impensabile che nella primavera 1919 l’opinione pubblica dei paesi Alleati o degli Stati Uniti avrebbe permesso la concessione di un prestito cospicuo alla Germania. D’altro canto gli Alleati erano comprensibilmente restii a consumare per l’approvvigionamento della Germania l’oro che sembrava costituire uno dei pochi cespiti ovvii e certi per le riparazioni. Si spese molto tempo nell’esaminare tutte le possibili alternative; ma alla fine fu evidente che anche se le esportazioni e i titoli esteri vendibili della Germania avessero avuto un valore sufficiente, non era possibile liquidarli in tempo, e che dato il completo esaurimento finanziario della Germania la sola cosa disponibile in quantità cospicua era l’oro della Reichsbank. Pertanto parte di questo oro per un valore di oltre 50 milioni di sterline fu trasferito dalla Germania agli Alleati (principalmente agli Stati Uniti, ma anche la Gran Bretagna ebbe una somma sostanziosa) nei primi sei mesi del 1919 in pagamento di viveri.
Ma questo non fu tutto. Sebbene la Germania avesse convenuto, in base alla prima proroga dell’armistizio, di non esportare oro senza il permesso degli Alleati, tale permesso non sempre poteva essere negato. C’erano impegni della Reichsbank verso i vicini paesi neutrali che non potevano essere assolti altrimenti che in oro. Se la Reichsbank non vi avesse fatto fronte, ne sarebbe derivato un deprezzamento del cambio talmente deleterio per il credito della Germania da ripercuotersi sulle future prospettive di riparazioni. In taluni casi, perciò, il permesso di esportare oro fu accordato alla Reichsbank dal Supremo Consiglio Economico Alleato.
Il risultato di questi vari provvedimenti fu di ridurre di oltre la metà le riserve auree della Reichsbank, da 115 a 55 milioni di sterline nel settembre 1919.
Sarebbe possibile in base al trattato prelevare tutta quest’ultima somma in conto riparazioni. Tuttavia essa ammonta di fatto a meno del 4% dell’emissione di biglietti della Reichsbank, e l’effetto psicologico della sua totale confisca (tenuto conto dell’ingentissimo volume di marchi in banconote posseduto all’estero) distruggerebbe probabilmente quasi per intero il valore di scambio del marco. Una somma di 5, 10 o anche 20 milioni di sterline potrebbe essere prelevata per uno scopo speciale. Ma possiamo presumere che la commissione riparazioni giudicherà imprudente, in vista delle ripercussioni sulle prospettive future di ottenere pagamenti, rovinare del tutto il sistema monetario tedesco, tanto più che i governi francese e belga, possedendo una massa ingente di marchi cartacei già circolanti nei territori occupati o ceduti, hanno tutto l’interesse di mantenere un certo valore di scambio del marco, a prescindere dalle prospettive di riparazioni.
Ne consegue che non si può contare su nessuna somma apprezzabile sotto forma di oro o argento per il pagamento iniziale di 1000 milioni di sterline in scadenza nel 1921.
(b) Naviglio. La Germania, come abbiamo visto, si è impegnata a cedere agli Alleati pressoché tutta la sua marina mercantile. Una parte considerevole di essa era invero già in mano agli Alleati prima della conclusione della pace, o perché trattenuta nei loro porti o per il provvisorio trasferimento di tonnellaggio a norma dell’accordo di Bruxelles in connessione con la fornitura di viveri.120 Stimando in 4 milioni di tonnellate lorde il tonnellaggio di naviglio tedesco da prelevare in base al trattato, e in 30 sterline il valore medio a tonnellata, il valore monetario totale è di 120 milioni di sterline.121
(c) Titoli esteri. Prima del censimento dei titoli esteri effettuato dal governo tedesco nel settembre 1916,122 i cui risultati esatti non sono stati resi pubblici, non c’erano in Germania rendiconti ufficiali di questi investimenti, e le varie stime private sono basate dichiaratamente su dati insufficienti, quali l’ammissione di titoli esteri alle borse tedesche, gli introiti per diritti di bollo, i rapporti consolari, ecc. Le principali stime tedesche correnti prima della guerra sono date in nota.123 Ne risulta un generale consenso degli autori su un’entità degli investimenti esteri netti tedeschi superiore a 1250 milioni di sterline. Prendo questa cifra come base dei miei calcoli, sebbene la ritenga esagerata; 1000 milioni di sterline sarebbe probabilmente una cifra più attendibile.
Da questo totale aggregato vanno fatte deduzioni per quattro motivi.
(I) Gli investimenti nei paesi Alleati e negli Stati Uniti, che costituiscono insieme una buona parte del mondo, sono stati sequestrati da pubblici amministratori fiduciari, depositari di beni nemici e altri simili funzionari, e non sono disponibili per le riparazioni se non nella misura in cui presentino un’eccedenza rispetto ai vari crediti privati. In base al piano per il trattamento dei debiti nemici delineato nel capitolo quarto, su queste attività hanno la prelazione i crediti privati di cittadini Alleati verso cittadini tedeschi. È improbabile che ci saranno, salvo negli Stati Uniti, apprezzabili eccedenze per altri scopi.
(II) I campi più importanti di investimento estero della Germania prima della guerra non erano, come i nostri, oltremare, ma in Russia, Austria-Ungheria, Turchia, Romania e Bulgaria. Gran parte di questi investimenti sono ora diventati quasi privi di valore, almeno per il momento; specialmente quelli in Russia e in Austria-Ungheria. Se si prende come criterio l’attuale valore di mercato, nessuno di questi investimenti è adesso vendibile al di sopra di una cifra nominale. A meno che gli Alleati siano disposti ad acquisire questi titoli molto al di sopra della loro valutazione di mercato e a tenerli per realizzarli in futuro, non ci sono, sotto forma di investimenti nei paesi in questione, fonti rilevanti di fondi per pagamenti immediati.
(III) Durante la guerra la Germania non era in condizione di realizzare i suoi investimenti esteri in misura pari alla nostra, tuttavia lo fece in certi paesi e per quanto poté. Si ritiene che prima dell’entrata in guerra degli Stati Uniti essa abbia rivenduto gran parte dei suoi investimenti migliori in titoli americani, anche se talune stime correnti di queste vendite (si è fatta la cifra di 60 milioni di sterline) sono probabilmente esagerate. Ma nel corso di tutta la guerra e in particolare nelle ultime fasi, quando i suoi cambi erano deboli e il suo credito nei vicini paesi neutrali era in forte calo, essa è andata vendendo i titoli che Olanda, Svizzera e Scandinavia erano disposte a comprare o ad accettare come garanzia collaterale. È abbastanza certo che nel giugno 1919 i suoi investimenti in questi paesi erano ridotti a una cifra trascurabile, ed erano molto inferiori alle sue passività verso i medesimi. La Germania ha venduto anche taluni titoli d’oltreoceano, come le cedole argentine, per i quali si poteva trovare un mercato.
(IV) È certo che dopo l’armistizio c’è stata una massiccia fuga dalla Germania dei titoli esteri ancora in mani private; cosa che è estremamente difficile impedire. Gli investimenti esteri tedeschi sono di solito sotto forma di titoli al portatore e non sono registrati; è facile contrabbandarli attraverso le lunghe frontiere terrestri della Germania, e da alcuni mesi prima della conclusione della pace si sapeva con certezza che ai proprietari non sarebbe stato consentito di conservarli se i governi Alleati trovavano il modo di impadronirsene. Questi fattori hanno contribuito a stimolare l’ingegnosità umana, e si ritiene che gli sforzi dei governi Alleati e del governo tedesco per ostacolare efficacemente l’efflusso siano stati per lo più vani.
Considerato tutto questo, sarà un miracolo se resta molto per le riparazioni. I paesi Alleati e gli Stati Uniti, i paesi alleati della Germania e i paesi neutrali contigui alla Germania costituiscono insieme quasi l’intero mondo civile; e come abbiamo visto non possiamo aspettarci di ricavare grandi somme per le riparazioni dagli investimenti in nessuno di essi. Non restano altri paesi dove la Germania avesse investimenti di rilievo tranne quelli del Sud America.
La conversione in cifre dell’entità di queste deduzioni è in larga misura congetturale. Do al lettore la stima personale migliore a cui sono giunto dopo aver considerato la questione alla luce delle cifre disponibili e di altri dati pertinenti.
Calcolo la deduzione per il punto (I) in 300 milioni di sterline, di cui possono da ultimo essere disponibili 100 milioni dopo aver soddisfatto i debiti privati, ecc.
Riguardo al punto (II), secondo un censimento effettuato dal ministero delle Finanze austriaco il 31 dicembre 1912 il valore nominale dei titoli austro-ungarici in possesso di tedeschi era di 197.300.000 sterline. Gli investimenti anteguerra della Germania in Russia, a parte i titoli di stato, sono stati stimati in 95 milioni di sterline, che è molto meno di quanto si presumerebbe; e nel 1906 Sartorius von Waltershausen stimava gli investimenti tedeschi in titoli di stato russi in 150 milioni di sterline. Ciò dà un totale di 245 milioni di sterline, confermato in qualche misura dalla cifra di 200 milioni di sterline proposta nel 1911 dal dottor Ischchanian come stima deliberatamente moderata. Una stima rumena pubblicata al tempo dell’entrata in guerra di quel paese dava il valore degli investimenti tedeschi in Romania in 4-4,4 milioni di sterline, di cui 2,8-3,2 milioni in titoli di stato. Secondo una notizia del «Temps» (8 settembre 1919), una associazione per la difesa degli interessi francesi in Turchia ha stimato il totale del capitale tedesco investito in Turchia intorno ai 59 milioni di sterline, di cui, stando all’ultimo Rapporto del consiglio degli obbligazionisti esteri, 32,5 milioni posseduti da cittadini tedeschi in titoli del debito estero turco. Non dispongo di stime degli investimenti tedeschi in Bulgaria. Per l’insieme di questo gruppo di paesi ipotizzerei una deduzione complessiva di 500 milioni di sterline.
Calcolo la rivendita e l’impegno di titoli come garanzia collaterale durante la guerra di cui al punto (III) in 100-150 milioni di sterline, comprendenti praticamente tutti i titoli scandinavi, olandesi e svizzeri in possesso della Germania, una parte dei suoi titoli sudamericani e una cospicua percentuale dei suoi titoli nordamericani venduti prima dell’entrata in guerra degli Stati Uniti.
Riguardo alla corretta deduzione per il punto (IV) non ci sono naturalmente cifre disponibili. Da mesi la stampa europea è piena di storie sensazionali degli espedienti adottati. Ma probabilmente non è esagerato calcolare in 100 milioni di sterline il valore dei titoli che hanno già lasciato la Germania e di quelli accantonati all’interno del paese al riparo dalle indagini più oculate e vigorose.
Queste varie voci portano perciò a una deduzione complessiva di circa 1000 milioni di sterline in cifra tonda, lasciando un avanzo di 250 milioni di sterline teoricamente ancora disponibili.124
A qualche lettore questa cifra sembrerà bassa, ma si tenga presente che essa vuole rappresentare il residuo dei titoli vendibili su cui il governo tedesco potrebbe riuscire a mettere le mani per finalità pubbliche. Secondo me la cifra è fin troppo alta, e considerando il problema da un’altra angolazione io arrivo a una cifra inferiore. Se, infatti, escludiamo dal conto i titoli e gli investimenti Alleati in Austria, Russia, ecc. già sequestrati, quali pacchetti di titoli, specificati per paesi e imprese, può avere ancora la Germania, che ammontino a 250 milioni di sterline? Non so rispondere a questa domanda. La Germania ha una certa quantità di titoli di stato cinesi che non sono stati sequestrati, forse alcuni giapponesi, e un valore più sostanzioso in beni sudamericani di prima classe. Ma ci sono pochissime imprese di questa classe ancora in mani tedesche, e anche il loro valore si misura in una o due decine di milioni, non in cinquantine o in centinaia. A mio parere sarebbe molto avventato chi aderisse a un consorzio per acquistare con 100 milioni di sterline in contanti il residuo non ancora sequestrato degli investimenti tedeschi oltreoceano. Se la commissione riparazioni vorrà realizzare finanche questa cifra ridotta, dovrà probabilmente custodire per alcuni anni le attività che preleva, senza tentare di disporne al presente.
Abbiamo così una cifra di 100-250 milioni di sterline come contributo massimo proveniente dai titoli esteri della Germania.
La sua ricchezza immediatamente trasferibile si compone, dunque, di: (a) oro e argento, diciamo 60 milioni di sterline; (b) navi, 120 milioni; (c) titoli esteri, 100-250 milioni.
Non è di fatto possibile prelevare una parte considerevole dell’oro e dell’argento senza dar luogo nel sistema monetario tedesco a conseguenze deleterie per gli interessi degli Alleati. Il contributo complessivo di tutte queste fonti che la commissione riparazioni può sperare di ottenere per il maggio 1921 è perciò calcolabile in 250-350 milioni di sterline al massimo.125
2. Beni esistenti in territori ceduti, e beni consegnati in base all’armistizio
A termini del trattato la Germania non riceverà per i suoi beni nei territori ceduti accrediti importanti in conto riparazioni.
I beni privati nella maggior parte del territorio ceduto sono utilizzati per pagare i debiti tedeschi verso cittadini Alleati, e solo l’eventuale eccedenza è disponibile per le riparazioni. Il valore di questi beni in Polonia e negli altri nuovi Stati è pagabile direttamente ai proprietari.
I beni statali in Alsazia-Lorena, nel territorio ceduto al Belgio e nelle ex colonie tedesche sono confiscati senza accredito. Anche gli edifici, le foreste e altri beni statali che appartenevano all’ex regno di Polonia vanno ceduti senza accredito. Rimangono perciò i beni statali, altri dai succitati, ceduti alla Polonia, i beni statali nello Schleswig ceduto alla Danimarca,126 il valore dei giacimenti carboniferi della Saar, il valore di certo naviglio fluviale, ecc., da cedere in base al capitolo relativo ai porti, alle vie d’acqua e alle ferrovie, e il valore dei cavi sottomarini tedeschi trasferiti in base all’allegato VII del capitolo sulle riparazioni.
Qualunque cosa dica il trattato, la commissione riparazioni non otterrà pagamenti in denaro dalla Polonia. I giacimenti carboniferi della Saar sono stati valutati, credo, da 15 a 20 milioni di sterline. Per tutte queste voci una cifra tonda di 30 milioni di sterline, escluse eventuali eccedenze riguardo ai beni privati, è probabilmente una stima generosa.
Rimane il valore del materiale consegnato in base all’armistizio. L’articolo 250 prevede che la commissione riparazioni determini un accredito per il materiale rotabile e per certe altre voci specificate, e in generale per il materiale, consegnato allo stesso titolo, per il quale la commissione ritenga doversi riconoscere un accredito, «in quanto non avente carattere militare». Il materiale rotabile (150.000 vagoni e 5000 locomotive) è la sola voce di valore considerevole. La cifra complessiva di 50 milioni di sterline per tutte le consegne in base all’armistizio è probabilmente, di nuovo, una stima generosa.
Abbiamo perciò 80 milioni di sterline da aggiungere per questo titolo ai 250-350 milioni del paragrafo precedente. Questa cifra aggiuntiva differisce dall’altra in quanto non rappresenta denaro contante che possa giovare alla situazione finanziaria degli Alleati, ma è solo un credito contabile tra di loro o tra loro e la Germania.
Il totale di 330-430 milioni di sterline cui ora siamo pervenuti non è però disponibile per le riparazioni. La prima voce a suo carico, in base all’articolo 251 del trattato, è il costo degli eserciti di occupazione sia durante l’armistizio sia dopo la conclusione della pace. La cifra complessiva fino al maggio 1921 non è calcolabile finché non sia noto il ritmo di ritiro delle truppe che ridurrà il costo mensile dagli oltre 20 milioni di sterline della prima parte del 1919 a 1 milione, che sarà poi la cifra normale. Stimerei, comunque, che la cifra complessiva sarà di circa 200 milioni di sterline. Restano quindi disponibili 100-200 milioni di sterline.
Di questa cifra, del valore delle esportazioni di merci, e dei pagamenti in natura previsti dal trattato prima del maggio 1921 (dei quali non ho finora tenuto conto), gli Alleati hanno fatto sperare che restituiranno alla Germania, per i necessari acquisti di viveri e materie prime, le somme che ritengano indispensabili. Non è possibile per adesso un giudizio preciso circa il valore monetario delle merci che la Germania avrà bisogno di acquistare all’estero per ricostituire la sua vita economica, e circa il grado di liberalità con cui gli Alleati eserciteranno il loro potere discrezionale. Se le sue scorte di viveri e materie prime dovessero essere riportate per il maggio 1921 a qualcosa che si avvicini al livello normale, la Germania avrebbe verosimilmente bisogno di un potere d’acquisto all’estero di 100-200 milioni di sterline almeno, in aggiunta al valore delle sue esportazioni correnti. Mentre è improbabile che ciò le sia consentito, affermerei come cosa non ragionevolmente contestabile che le condizioni economiche e sociali della Germania non permetteranno un’eccedenza delle esportazioni sulle importazioni nel periodo anteriore al maggio 1921, e che il valore dei pagamenti in natura previsti dal trattato che essa sia in grado di fornire agli Alleati sotto forma di carbone, coloranti, legname e altri materiali dovrà esserle restituito per metterla in grado di pagare le importazioni indispensabili alla sua esistenza.127
La commissione riparazioni non può quindi contare su aggiunte da altre fonti alla somma di 100-200 milioni di sterline che le abbiamo in via di ipotesi accreditato dopo la realizzazione della ricchezza immediatamente trasferibile della Germania, il calcolo dei crediti dovuti alla Germania in base al trattato, e il pagamento del costo degli eserciti di occupazione. Dato che il Belgio ha concluso un accordo particolare, fuori trattato, con Francia, Stati Uniti e Inghilterra, per cui riceverà a parziale soddisfazione delle sue richieste i primi 100 milioni di sterline disponibili per le riparazioni, la conclusione di tutta la faccenda è che il Belgio avrà forse i suoi 100 milioni per il maggio 1921, ma nessuno degli altri Alleati otterrà verosimilmente per quella data contributi significativi. In ogni caso, sarebbe una grossa imprudenza che i ministri finanziari fondassero i loro piani su una diversa ipotesi.
3. Pagamenti annuali distribuiti in un periodo di anni
È evidente che la capacità prebellica della Germania di pagare un tributo estero annuale non è rimasta indenne, data la perdita quasi totale delle colonie, dei rapporti d’affari internazionali, della marina mercantile e dei beni in paesi stranieri, la cessione di un decimo del territorio e della popolazione, di un terzo del carbone e di tre quarti del minerale ferroso, la perdita di due milioni di uomini nel fiore dell’età, la fame subìta per quattro anni dal suo popolo, il fardello di un enorme debito di guerra, il deprezzamento della sua moneta a meno di un settimo del valore precedente, la disgregazione dei suoi alleati e dei loro territori, la rivoluzione in patria e il bolscevismo ai confini, l’incalcolabile scempio di energie e di speranze di una guerra devastatrice quadriennale terminata con la sconfitta.
Tutto questo è, si sarebbe supposto, evidente. Eppure quasi tutte le stime di grandi indennizzi da parte della Germania si basano sull’ipotesi che essa sia in grado di condurre in futuro un commercio di gran lunga maggiore di quello mai avuto in passato.
Allo scopo di arrivare a una cifra importa poco se il pagamento sia sotto forma di denaro contante (o meglio di valuta estera), oppure sia in parte effettuato in natura (carbone, coloranti, legname, ecc.), come previsto dal trattato. In ogni caso, solo l’esportazione di determinate merci può permettere alla Germania di pagare, e il modo di trarre profitto dal valore di queste esportazioni ai fini delle riparazioni è una questione relativamente secondaria.
Ci perderemo in mere congetture se non torniamo in qualche misura ai princìpi primi e, quando possiamo, alle statistiche esistenti. È certo che la Germania sarà in grado di effettuare pagamenti annuali per una serie di anni solo diminuendo le sue importazioni e aumentando le esportazioni, ampliando così il saldo a suo favore disponibile per i pagamenti all’estero. La Germania può pagare nel lungo periodo in merci, e in merci soltanto, sia che queste merci siano fornite direttamente agli Alleati, o vendute a paesi neutrali e i crediti neutrali derivanti trasferiti poi agli Alleati. La base più solida per calcolare fino a che punto può essere condotto questo processo sta, perciò, in un’analisi delle statistiche commerciali tedesche d’anteguerra. Solo sulla base di tale analisi, integrata da alcuni dati generali sulla capacità complessiva del paese di produrre ricchezza, si può formulare una congettura razionale sulla misura in cui sarà possibile che le esportazioni della Germania superino le sue importazioni.
Nell’anno 1913 le importazioni tedesche ammontarono a 538 milioni di sterline e le sue esportazioni a 505 milioni, esclusi il commercio di transito e i metalli preziosi. Le importazioni, cioè, superarono le esportazioni di circa 33 milioni di sterline. Nei cinque anni precedenti il 1913, peraltro, l’eccedenza delle importazioni sulle esportazioni fu molto maggiore, ossia di 74 milioni di sterline in media. Ne consegue, perciò, che più dell’intero bilancio prebellico della Germania per nuovi investimenti esteri derivava dagli interessi sui suoi titoli esteri, dai profitti del suo traffico marittimo e della sua attività bancaria all’estero, ecc. Dato che ora essa sarà privata dei beni esteri e della marina mercantile, e che la sua attività bancaria estera e altre fonti varie di entrate esterne sono state in gran parte distrutte, risulta che sulla base prebellica del rapporto import-export la Germania, lungi dall’avere eccedenze da usare per pagamenti esteri, non riuscirebbe nemmeno a sostentarsi. Il suo primo compito, perciò, è necessariamente di attuare un riassetto dei consumi e della produzione in modo da coprire questo deficit. Ogni ulteriore economia che essa riesca a realizzare nell’uso di merci importate e ogni ulteriore incremento delle esportazioni saranno quindi disponibili per le riparazioni.
Due terzi del commercio di importazione e d’esportazione della Germania sono elencati per voci distinte nelle tabelle seguenti. Le considerazioni relative a queste porzioni si possono ritenere più o meno valide anche per il terzo restante, composto di merci di minore importanza singola.
Risulta dalle tabelle che le esportazioni principali consistevano di: (1) prodotti siderurgici, latta inclusa (13,2%); (2) macchinari, ecc. (7,5%); (3) carbone, coke e bricchette (7%); (4) lanerie, inclusa la lana grezza e pettinata (5,9%); (5) cotonerie, inclusi il filato di cotone e il cotone grezzo (5,6%). Queste cinque categorie di merci rappresentano il 39,2% delle esportazioni totali. Si noterà che sono tutte categorie in cui prima della guerra c’era una dura concorrenza tra Germania e Regno Unito. Quindi, uno sviluppo cospicuo del volume di tali esportazioni verso destinazioni europee o d’oltreoceano è destinato ad avere corrispondenti effetti negativi sul commercio d’esportazione britannico. Per quanto riguarda due delle categorie, cioè cotoni e lane, un incremento del commercio di esportazione dipende da un aumento dell’importazione di materia prima, dato che la Germania non produce cotone né, praticamente, lana. Questi commerci, quindi, non possono espandersi se non si dà modo alla Germania di procurarsi le materie prime (necessariamente a spese degli Alleati) in misura maggiore del livello di consumo prebellico; e anche così l’incremento effettivo non è dato dal valore lordo delle esportazioni, ma solo dalla differenza tra il valore dei manufatti esportati e quello delle materie prime importate. Quanto alle altre tre categorie – macchinari, prodotti siderurgici, carbone – la Germania non potrà aumentare le esportazioni a causa delle sue cessioni territoriali in Polonia, Alta Slesia e Alsazia-Lorena. Come già abbiamo osservato, queste regioni fornivano quasi un terzo del carbone prodotto dalla Germania. Ma fornivano anche non meno dei tre quarti della sua produzione di minerale ferroso, il 38% degli altiforni, e il 9,5% delle fonderie siderurgiche. Perciò, a meno che l’Alsazia-Lorena e l’Alta Slesia non mandino in Germania il loro minerale di ferro per essere lavorato – il che comporta un aumento delle importazioni che la Germania dovrà trovare il modo di pagare – non solo non sarà possibile un aumento delle esportazioni, ma sarà inevitabile una loro diminuzione.128
| Esportazioni tedesche, 1913 | Valore in milioni di sterline | Percentuale delle esportazioni totali |
|---|---|---|
| Prodotti siderurgici (inclusa latta, ecc.) | 66,13 | 13,2 |
| Macchinari e parti (incluse autovetture) | 37,55 | 7,5 |
| Carbone, coke e bricchette | 35,34 | 7,0 |
| Lanerie (inclusi lana grezza e pettinata e vestiario) | 29,40 | 5,9 |
| Cotonerie (inclusi cotone grezzo e filati) | 28,15 | 5,6 |
| 196,57 | 39,2 | |
| Cereali, ecc. (inclusi segale, avena, frumento, luppolo) | 21,18 | 4,1 |
| Cuoio e pelletterie | 15,47 | 3,0 |
| Zucchero | 13,20 | 2,6 |
| Carta, ecc. | 13,10 | 2,6 |
| Pellicce | 11,75 | 2,2 |
| Prodotti elettrici (impianti, macchine, lampadine, cavi) | 10,88 | 2,2 |
| Seterie | 10,10 | 2,0 |
| Coloranti | 9,76 | 1,9 |
| Prodotti in rame | 6,50 | 1,3 |
| Giocattoli | 5,15 | 1,0 |
| Gomma e prodotti in gomma | 4,27 | 0,9 |
| Libri, mappe, musica | 3,71 | 0,8 |
| Potassa | 3,18 | 0,6 |
| Vetro | 3,14 | 0,6 |
| Cloruro di potassio | 2,91 | 0,6 |
| Pianoforti, organi e parti | 2,77 | 0,6 |
| Zinco grezzo | 2,74 | 0,5 |
| Porcellana | 2,53 | 0,5 |
| 142,34 | 28,0 | |
| Altre merci, non specificate | 165,92 | 32,8 |
| Totale | 504,83 | 100,0 |
| I. Materie prime: | ||
| Cotone | 30,35 | 5,6 |
| Pellami | 24,86 | 4,6 |
| Lana | 23,67 | 4,4 |
| Rame | 16,75 | 3,1 |
| Carbone | 13,66 | 2,5 |
| Legname | 11,60 | 2,2 |
| Minerale di ferro | 11,35 | 2,1 |
| Pellicce | 9,35 | 1,7 |
| Lino e semi di lino | 9,33 | 1,7 |
| Salnitro | 8,55 | 1,6 |
| Seta | 7,90 | 1,5 |
| Gomma | 7,30 | 1,4 |
| Iuta | 4,70 | 0,9 |
| Petrolio | 3,49 | 0,7 |
| Stagno | 2,91 | 0,5 |
| Gesso fosforoso | 2,32 | 0,4 |
| Olio lubrificante | 2,29 | 0,4 |
| 190,38 | 35,3 | |
| II. Alimentari, tabacco, ecc.: | ||
| Cereali, ecc. (frumento, orzo, crusca, riso, mais, avena, segale, trifoglio) | 65,51 | 12,2 |
| Semi oleosi e panelli, ecc. (inclusi noci di cocco, copra, semi di cacao) | 20,53 | 3,8 |
| Bestiame, grasso d’agnello, vesciche | 14,62 | 2,8 |
| Caffè | 10,95 | 2,0 |
| Uova | 9,70 | 1,8 |
| Tabacco | 6,70 | 1,2 |
| Burro | 5,93 | 1,1 |
| Cavalli | 5,81 | 1,1 |
| Frutta | 3,65 | 0,7 |
| Pesce | 2,99 | 0,6 |
| Pollame | 2,80 | 0,5 |
| Vino | 2,67 | 0,5 |
| 151,86 | 28,3 | |
| III. Manufatti: | ||
| Filato di cotone e cotonerie | 9,41 | 1,8 |
| Filato di lana e lanerie | 7,57 | 1,4 |
| Macchinario | 4,02 | 0,7 |
| 21,00 | 3,9 | |
| IV. Varie | 175,28 | 32,5 |
| Totale | 538,52 | 100,0 |
Seguono nell’elenco cereali, pelletterie, zucchero, carta, pellicce, prodotti elettrici, seterie e coloranti. I cereali non costituiscono un’esportazione netta e sono più che bilanciati dalle importazioni delle stesse derrate. Quanto allo zucchero, quasi il 90% delle esportazioni prebelliche della Germania erano dirette nel Regno Unito.129 Un aumento di questo commercio potrebbe essere stimolato dalla concessione di una preferenza allo zucchero tedesco nel nostro paese, o da un accordo per cui lo zucchero sia accettato in pagamento parziale delle riparazioni come si è proposto per il carbone, i coloranti, ecc. Anche l’esportazione di carta potrebbe avere un certo incremento. Pelletterie, pellicce e seterie dipendono da corrispondenti importazioni dei materiali. Le seterie sono per lo più in concorrenza con il commercio di Francia e Italia. Le altre voci sono singolarmente molto modeste. Ho sentito suggerire che l’indennizzo potrebbe essere pagato in gran parte in potassa e simili. Ma prima della guerra la potassa rappresentava lo 0,6% del commercio d’esportazione tedesco, e circa 3 milioni di sterline di valore complessivo. Inoltre la Francia, disponendo di giacimenti di potassa nel territorio che le è stato restituito, non sarà favorevole a un grande sviluppo delle esportazioni tedesche di questo materiale.
Da un esame dell’elenco delle importazioni risulta che esse consistono per il 63,6% di materie prime e di alimenti. Le voci principali della prima categoria – cotone, lana, rame, pellami, minerale di ferro, pellicce, seta, gomma, stagno – non potrebbero essere ridotte di molto senza ripercussioni sul commercio di esportazione, e forse andrebbero aumentate se si vogliono incrementare le esportazioni. Le importazioni di alimenti – frumento, orzo, caffè, uova, riso, mais e simili – presentano un problema diverso. È improbabile che, a parte certi generi di conforto, il consumo alimentare delle classi lavoratrici tedesche prima della guerra superasse il quantitativo occorrente per un massimo di efficienza; è anzi verosimile che fosse inferiore a tale quantitativo. Una sensibile riduzione delle importazioni alimentari influirebbe perciò sull’efficienza della popolazione industriale, e di conseguenza sul volume dell’eccedenza esportabile che essa potrebbe essere spinta a produrre. Non è possibile pretendere un forte aumento della produttività industriale tedesca se gli operai sono denutriti. Ma ciò può non essere altrettanto vero per l’orzo, il caffè, le uova e il tabacco. Se fosse possibile imporre un regime per cui in futuro nessun tedesco beva birra o caffè e fumi tabacco, si potrebbero ottenere notevoli risparmi. Altrimenti sembra ci sia poco margine per riduzioni significative.
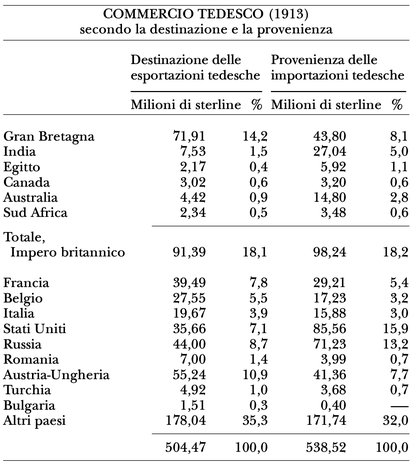
Anche l’analisi seguente delle esportazioni e importazioni tedesche secondo la destinazione e la provenienza è ricca di interesse. Ne risulta che nel 1913 il 18% delle esportazioni tedesche andavano nell’Impero britannico, il 17% in Francia, Italia e Belgio, il 10% in Russia e Romania, e il 7% negli Stati Uniti; vale a dire che più di metà delle esportazioni trovavano il loro mercato nei paesi dell’Intesa. Del rimanente, il 12% andava in Austria-Ungheria, Turchia e Bulgaria, e il 35% altrove. Perciò, a meno che gli attuali Alleati siano disposti a favorire l’importazione di prodotti tedeschi, un sostanziale aumento del volume totale è realizzabile solo inondando su larga scala i mercati neutrali.
Questa analisi dà qualche indicazione sulla modificazione massima della bilancia delle esportazioni tedesche possibile nelle condizioni vigenti dopo la pace. Supponendo: (1) che noi non favoriamo in special modo la Germania rispetto a noi medesimi quanto all’approvvigionamento di materie prime come il cotone e la lana (la cui offerta mondiale è limitata); (2) che la Francia, essendosi assicurata i giacimenti di minerale ferroso, voglia provvedersi di altiforni e sviluppare il proprio commercio dell’acciaio; (3) che la Germania non venga incoraggiata e aiutata a soppiantare il commercio siderurgico e altri commerci degli Alleati nei mercati d’oltreoceano; (4) che nell’Impero britannico non venga data una sostanziale preferenza alle merci tedesche: è evidente, da un esame delle voci specifiche, che la Germania non potrà fare molto.
Rivediamo le voci principali. (1) Prodotti siderurgici. Data la perdita di risorse subìta dalla Germania, un aumento dell’export netto sembra impossibile, e un’ampia riduzione probabile. (2) Macchinari. Un certo aumento è possibile. (3) Carbone e coke. Prima della guerra il valore dell’esportazione netta della Germania era di 22 milioni di sterline; gli Alleati hanno convenuto che per il momento la massima esportazione possibile è di 20 milioni di tonnellate, con un problematico (e di fatto impossibile) aumento a 40 milioni in futuro; anche sulla base di 20 milioni di tonnellate non abbiamo praticamente alcun aumento di valore, misurato ai prezzi anteguerra;130 mentre, se questo quantitativo è prelevato dagli Alleati, è inevitabile una diminuzione di valore molto maggiore nell’esportazione di manufatti che hanno bisogno di carbone per essere prodotti. (4) Lanerie. Un aumento è impossibile senza la lana grezza, e considerando la domanda altrui di lana grezza è probabile una diminuzione. (5) Cotonerie. Vale quanto detto per la lana. (6) Cereali. Non c’è mai stata e non ci potrà mai essere esportazione netta. (7) Pelletterie. Vale quanto detto per la lana.
Abbiamo così considerato quasi metà delle esportazioni prebelliche della Germania, e non c’è nessun’altra merce che allora arrivasse a rappresentare il 3 per cento delle sue esportazioni. Con quale merce la Germania potrà pagare? Coloranti? Nel 1913 il loro valore totale era di 10 milioni di sterline. Giocattoli? Potassa? Se ne esportarono nel 1913 per 3 milioni di sterline. E anche se si potessero individuare le merci, in quali mercati dovrebbero essere vendute? Teniamo presente che parliamo di merci per un valore annuale non di decine ma di centinaia di milioni di sterline.
Dal lato delle importazioni è possibile fare qualcosa di più. Abbassando il tenore di vita, si può ottenere una sensibile riduzione della spesa per merci importate. Ma, come abbiamo già visto, per molte voci importanti le riduzioni si ripercuoterebbero sul volume delle esportazioni.
Facciamo l’ipotesi più ottimistica ammissibile senza cadere nell’assurdo, e supponiamo che dopo qualche tempo la Germania sia in grado, nonostante la falcidia delle sue risorse, attrezzature, mercati e capacità produttiva, di aumentare le esportazioni e ridurre le importazioni in modo da migliorare complessivamente la sua bilancia commerciale di 100 milioni di sterline all’anno, ai prezzi anteguerra. Questo riassetto è necessario anzitutto per liquidare il passivo della bilancia commerciale, che nei cinque anni prima della guerra era in media di 74 milioni di sterline; ma supponiamo che provveduto a questo resti un saldo attivo di 50 milioni di sterline all’anno. Raddoppiamolo computando l’aumento dei prezzi anteguerra, e avremo la cifra di 100 milioni di sterline. Considerati i fattori politici, sociali e umani, oltre a quelli puramente economici, dubito che si possa far pagare annualmente alla Germania questa somma per un periodo di trent’anni; ma non sarebbe assurdo affermare o sperare che ciò sia possibile.
Questa cifra, contando un 5 % di interesse e l’1% per l’ammortamento del capitale, rappresenta una somma capitale avente un valore attuale di circa 1700 milioni di sterline.131
Arrivo, perciò, alla conclusione finale che comprendendo tutti i modi di pagamento (ricchezza immediatamente trasferibile, beni ceduti, tributo annuale), 2000 milioni di sterline è la cifra massima pagabile verosimilmente dalla Germania. E tenuto conto di tutte le circostanze effettive, non credo che essa sia in grado di pagare nemmeno tanto. Chi giudica questa cifra troppo bassa rifletta sul confronto seguente, degno di nota. La ricchezza della Francia nel 1871 era stimata a un po’ meno della metà di quella della Germania nel 1913. A parte i cambiamenti del valore monetario, un indennizzo tedesco di 500 milioni di sterline sarebbe perciò all’incirca paragonabile alla somma pagata dalla Francia nel 1871; e dato che l’onere reale di un indennizzo aumenta più che in proporzione al suo ammontare, i 2000 milioni di sterline pagati dalla Germania avrebbero conseguenze molto più pesanti dei 200 milioni pagati dalla Francia nel 1871.
Io vedo una sola possibilità di aumentare la cifra stabilita in base alle considerazioni precedenti: ed è che lavoratori tedeschi siano materialmente trasferiti nelle aree devastate e adibiti all’opera di ricostruzione. Ho sentito che è in esame un progetto limitato del genere. Il contributo aggiuntivo così ottenibile dipende dal numero di lavoratori che il governo tedesco riuscirebbe a mantenere in questo modo, e anche dal numero che gli abitanti belgi e francesi tollererebbero in mezzo a loro per un periodo di anni. In ogni caso, sembrerebbe molto difficile impiegare nell’opera effettiva di ricostruzione, sia pure per un certo numero di anni, manodopera importata avente un valore odierno superiore (diciamo) a 250 milioni di sterline; e anche questa somma non sarebbe in pratica un’aggiunta netta ai contributi annui ottenibili in altri modi.
Una capacità di pagamento di 8000 o anche di 5000 milioni di sterline è quindi al di fuori di ogni ragionevole possibilità. Spetta a quanti ritengono che la Germania possa pagare annualmente centinaia di milioni di sterline dire con quali merci specifiche pensano che il pagamento verrà effettuato, e in quali mercati queste merci saranno vendute. Finché non scendono in particolari e non sono in grado di produrre argomenti concreti a favore delle loro conclusioni, costoro non meritano di essere presi sul serio.132
Faccio solo tre riserve, nessuna delle quali infirma, agli effetti pratici immediati, la validità della mia argomentazione.
Primo: se gli Alleati facessero da balia al commercio e all’industria tedeschi per un periodo di cinque o dieci anni, fornendo alla Germania in tale periodo grossi prestiti, e naviglio, viveri e materie prime in abbondanza, creandole mercati, dedicando deliberatamente ogni loro risorsa e buona volontà a farne la massima nazione industriale d’Europa, se non del mondo, poi potrebbero probabilmente ricavare da lei una somma molto maggiore, essendo la Germania capace di un’altissima produttività.
Secondo: facendo le mie stime in termini monetari, presumo che non ci saranno cambiamenti rivoluzionari nel potere d’acquisto della nostra unità di valore. Se l’oro scendesse alla metà o a un decimo del suo valore presente, l’onere reale di un pagamento fissato su base aurea si ridurrebbe in proporzione. Se una sovrana d’oro viene a valere quanto adesso uno scellino, la Germania naturalmente sarà in grado di pagare una somma molto maggiore, misurata in sovrane d’oro, di quella da me indicata.
Terzo: presumo che non ci saranno cambiamenti rivoluzionari nel rendimento della natura e dei materiali al lavoro umano. Non è impossibile che il progresso della scienza metta a nostra disposizione metodi e congegni grazie ai quali l’intero tenore di vita migliori a dismisura, e un determinato volume di prodotti richieda solo una frazione del lavoro umano che rappresenta adesso. In tal caso tutti i criteri di «capacità» cambierebbero ovunque. Ma il fatto che tutto è possibile non autorizza a parlare a vanvera.
È vero che nel 1870 nessuno avrebbe potuto prevedere la capacità della Germania nel 1910. Non possiamo pretendere di legiferare per una generazione o più. I cambiamenti secolari della condizione economica dell’uomo e il rischio d’errore delle previsioni umane possono portarci a sbagliare così in un senso come nell’altro. Da persone ragionevoli, possiamo soltanto basare la nostra politica sugli elementi che abbiamo e adattarla ai cinque o dieci anni sui quali ci è lecito supporre di poter prevedere qualcosa; e non siamo in difetto se lasciamo da parte le possibilità estreme dell’esistenza umana e di cambiamenti rivoluzionari nell’ordine della natura o nel rapporto dell’uomo con essa. Il fatto che non abbiamo cognizione sufficiente della capacità della Germania di pagare nel corso di un lungo periodo di anni non giustifica (come ho sentito dire da alcuni) l’affermazione che essa può pagare diecimila milioni di sterline.
Perché il mondo è stato così credulo verso le falsità dei politici? Se occorre una spiegazione, attribuisco in parte questa credulità alle influenze seguenti.
In primo luogo, le enormi spese belliche, l’inflazione dei prezzi e lo svilimento della moneta, portando a una completa instabilità dell’unità di valore, ci hanno fatto perdere il senso delle dimensioni in materia finanziaria. Quelli che credevamo essere i limiti del possibile sono stati superati in misura così enorme, e chi fondava le sue aspettative sul passato si è sbagliato così spesso, che l’uomo della strada ormai è disposto a credere a qualunque cosa gli venga detta con una parvenza di autorevolezza, e più la cifra è sballata più volentieri la ingoia.
Ma chi guarda più a fondo nelle cose è talvolta fuorviato da un abbaglio molto più perdonabile in una persona ragionevole. Costui potrebbe basare le sue conclusioni sul surplus totale di produttività annua della Germania, distinto dal surplus delle esportazioni. Nel 1913 Karl Helfferich stimava l’incremento annuo di ricchezza della Germania in 400-425 milioni di sterline (escluso l’accresciuto valore monetario di terra e beni immobili). Prima della guerra la Germania spendeva da 50 a 100 milioni di sterline in armamenti, spesa di cui ora può fare a meno. Perché, dunque, non dovrebbe pagare agli Alleati una somma annua di 500 milioni di sterline? L’argomento si presenta così nella sua forma più incisiva e plausibile.
In esso, però, ci sono due errori. Anzitutto, il risparmio annuo della Germania, dopo le perdite subìte in guerra e con la pace, sarà molto inferiore a prima, e se le viene tolto in futuro di anno in anno non potrà tornare al livello precedente. La perdita dell’Alsazia-Lorena, della Polonia e dell’Alta Slesia non può essere valutata in termini di surplus di produttività a meno di 50 milioni di sterline all’anno. Si calcola che la Germania traesse un guadagno di circa 100 milioni di sterline all’anno dalla sua marina mercantile, dagli investimenti esteri e dalle operazioni bancarie e relazioni d’affari all’estero, tutte cose di cui ora è stata privata. Il risparmio relativo agli armamenti è molto più che controbilanciato dalla sua spesa annua per le pensioni, ora stimata in 250 milioni di sterline,133 che rappresenta una perdita reale di capacità produttiva. E anche se lasciamo da parte l’onere del debito interno, che ammonta a 240 miliardi di marchi, in quanto questione di distribuzione interna anziché di produttività, dobbiamo tuttavia tener conto del debito estero contratto dalla Germania durante la guerra, dell’esaurimento delle sue scorte di materie prime, del depauperamento del patrimonio zootecnico, della diminuita produttività del suolo per mancanza di concime e di manodopera, e della riduzione di ricchezza dovuta all’omissione di molte riparazioni e sostituzioni per un periodo di quasi cinque anni. La Germania è meno ricca di prima della guerra, e la diminuzione del suo futuro risparmio per queste ragioni, a parte i fattori considerati precedentemente, non può essere calcolata in meno del 10%, ossia 40 milioni di sterline all’anno.
Questi fattori hanno già ridotto il surplus annuo della Germania a meno dei 100 milioni di sterline cui eravamo arrivati per altri motivi come cifra massima dei suoi pagamenti annuali. Ma anche se si obbiettasse che non abbiamo ancora tenuto conto dell’abbassamento del livello di vita e di agi che si può ragionevolmente imporre a un nemico sconfitto,134 permane un errore fondamentale nel metodo di calcolo. Un surplus annuale disponibile per l’investimento interno può essere convertito in un surplus disponibile per l’esportazione all’estero soltanto grazie a un radicale cambiamento del tipo di attività svolta. Il lavoro, mentre può essere disponibile ed efficiente per utilizzo interno in Germania, può tuttavia non trovare uno sbocco nel commercio estero. Torniamo allo stesso quesito che ci si è proposto nell’esame del commercio di esportazione: in quale commercio di esportazione il lavoro tedesco può trovare uno sbocco grandemente accresciuto? Il lavoro può essere deviato in nuovi canali solo con perdita di efficienza e cospicua spesa di capitale. Il surplus annuale che il lavoro tedesco è in grado di produrre per incrementi di capitale in patria non è né in teoria né in pratica una misura del tributo annuale che la Germania può pagare all’estero.
IV. LA COMMISSIONE DELLE RIPARAZIONI
Questo organo è uno strumento così singolare, e può, se funziona, esercitare un’influenza così ampia sulla vita europea, che i suoi attributi meritano un esame specifico.
Non esistono precedenti per l’indennizzo imposto alla Germania con il presente trattato; infatti le esazioni in denaro facenti parte degli accordi di pace seguiti alle guerre passate differiscono per due aspetti fondamentali da queste. La cifra richiesta era determinata, e consisteva in una somma di denaro forfettaria; e purché la parte sconfitta pagasse regolarmente le rate annuali in contanti, non erano necessarie ulteriori ingerenze.
Ma per ragioni già esposte, in questo caso le esazioni non sono state ancora determinate, e la somma, quando sarà precisata, risulterà superiore a quanto può essere pagato in contanti, e superiore anche a quanto può essere pagato comunque. Di qui la necessità di istituire un organo per stabilire la lista delle richieste, fissare le modalità di pagamento, e autorizzare le necessarie riduzioni e dilazioni. Per mettere questo organo in condizione di esigere anno dopo anno il massimo, era indispensabile assegnargli ampi poteri sulla vita economica interna dei paesi nemici, trattati d’ora in avanti come un patrimonio fallimentare che va amministrato dai creditori a proprio beneficio. In realtà, tuttavia, i poteri e funzioni della commissione riparazioni sono stati ampliati anche al di là di quanto occorreva a questo scopo, dandole il ruolo di arbitro finale su numerose questioni economiche e finanziarie che conveniva lasciare in sospeso nel trattato medesimo.135
I poteri e lo statuto della commissione riparazioni sono definiti principalmente negli articoli 233-41 e nell’allegato II del capitolo riparazioni del trattato con la Germania. Ma la stessa commissione è competente per l’Austria e la Bulgaria, e probabilmente lo sarà per l’Ungheria e la Turchia quando si concluderà la pace con questi paesi. Ci sono perciò articoli analoghi, mutatis mutandis, nel trattato austriaco136 e in quello bulgaro.137
Gli Alleati principali sono rappresentati ciascuno da un delegato in capo. I delegati di Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Italia partecipano a tutti i lavori; il delegato del Belgio a tutti i lavori tranne a quelli presenziati dai delegati del Giappone o dello Stato serbocroato-sloveno; il delegato del Giappone a tutti i lavori riguardanti questioni marittime o specificamente giapponesi; e il delegato dello Stato serbo-croato-sloveno partecipa quando si trattano questioni relative all’Austria, all’Ungheria o alla Bulgaria. Altri Alleati sono rappresentati da delegati, senza diritto di voto, quando sono in esame i loro rispettivi diritti e interessi.
In generale la commissione decide con voto a maggioranza, tranne in certi casi specifici dove occorre l’unanimità, i più importanti dei quali sono la cancellazione di debiti tedeschi, lunghe dilazioni delle rate e la vendita di buoni del debito tedesco. La commissione è dotata di pieni poteri esecutivi per l’attuazione delle proprie decisioni. Può istituire un ufficio esecutivo a cui delegare potere. La commissione e il suo personale godono dei privilegi diplomatici, e i loro stipendi sono pagati dalla Germania, che peraltro non ha voce alcuna nel determinarli. Se vuole adempiere adeguatamente alle sue numerose funzioni, la commissione dovrà necessariamente creare una vasta organizzazione burocratica poliglotta, con centinaia di addetti. A questa organizzazione, con sede centrale a Parigi, sarà affidato il destino economico dell’Europa centrale.
Le sue funzioni principali sono le seguenti:
(1) La commissione determinerà l’ammontare preciso delle richieste a carico delle potenze nemiche mediante un esame dettagliato delle richieste di ciascuno degli Alleati, in base all’allegato I del capitolo riparazioni. Tale compito deve essere completato entro il maggio 1921. La commissione darà al governo tedesco e agli alleati della Germania «una giusta possibilità di essere ascoltati, ma non di partecipare in qualsiasi modo alle decisioni della commissione». In altre parole, la commissione agirà al tempo stesso da parte in causa e da giudice.
(2) Determinata l’entità delle richieste, la commissione redigerà un programma per il pagamento dell’intera somma con gli interessi entro trent’anni. Di tanto in tanto, per modificare eventualmente il programma nei limiti del possibile, essa «esaminerà le risorse e la capacità della Germania ... dando ai suoi rappresentanti una giusta opportunità di essere ascoltati».
«Nello stimare periodicamente la capacità di pagamento della Germania, la commissione esaminerà il sistema fiscale tedesco, primo, affinché le somme che la Germania è tenuta a pagare per le riparazioni siano imputate alle sue entrate con priorità su quelle destinate al servizio o pagamento di prestiti interni, e, secondo, per assicurarsi che in generale lo schema di tassazione tedesco sia non meno gravoso, proporzionalmente, di quello di qualsiasi potenza rappresentata nella commissione».
(3) Fino al maggio 1921 la commissione ha facoltà, al fine di ottenere il pagamento di 1000 milioni di sterline, di esigere la cessione di qualsiasi proprietà tedesca, ovunque situata; ossia, «la Germania pagherà con le rate e nei modi – in oro, merci, navi, titoli o altrimenti – stabiliti dalla commissione».
(4) La commissione deciderà quali dei diritti e interessi di cittadini tedeschi in imprese di utilità pubblica operanti in Russia, Cina, Turchia, Austria, Ungheria e Bulgaria, o in territori prima appartenenti alla Germania o ai suoi alleati, vadano espropriati e trasferiti alla commissione stessa; valuterà il valore degli interessi così trasferiti; e dividerà le spoglie.
(5) La commissione determinerà quanta parte delle risorse così tolte alla Germania debba esserle restituita per mantenere nella sua organizzazione economica vitalità bastante a permetterle di continuare a fare in futuro i pagamenti per le riparazioni.138
(6) La commissione valuterà, senza appello né arbitrato, il valore dei beni e diritti ceduti a termini dell’armistizio e del trattato: materiale rotabile, marina mercantile, naviglio fluviale, bestiame, miniere della Saar, beni in territori ceduti per i quali va riconosciuto un accredito, ecc.
(7) La commissione determinerà l’ammontare e il valore (entro certi limiti definiti) dei contributi che la Germania dovrà fornire in natura anno per anno secondo i vari allegati del capitolo riparazioni.
(8) La commissione procurerà la restituzione da parte della Germania dei beni identificabili.
(9) Spetta alla commissione ricevere, amministrare e distribuire tutti i pagamenti della Germania in denaro o in natura. Inoltre essa emetterà e porrà in vendita titoli di debito tedeschi.
(10) La commissione stabilirà la quota del debito pubblico prebellico che dovrà essere assunta dalle aree cedute di Schleswig, Polonia, Danzica e Alta Slesia. La commissione distribuirà altresì il debito pubblico dell’ex Impero austro-ungarico fra le sue parti costitutive.
(11) La commissione liquiderà la Banca Austro-Ungarica e sopraintenderà al ritiro e alla sostituzione del circolante dell’ex Impero austro-ungarico.
(12) È compito della commissione riferire se a suo giudizio la Germania manchi all’adempimento dei propri obblighi, e consigliare metodi di coercizione.
(13) In generale la commissione, tramite un organo subordinato, eserciterà per l’Austria e la Bulgaria, e presumibilmente anche per l’Ungheria e la Turchia,139 le stesse funzioni che per la Germania.
Alla commissione sono assegnati anche molti altri compiti, relativamente secondari. Ma il sommario precedente indica a sufficienza l’ampiezza e importanza dei suoi poteri. Tali poteri acquistano un peso molto maggiore in quanto le richieste del trattato superano in genere la capacità della Germania. Di conseguenza le clausole che consentono alla commissione di applicare riduzioni, se a suo avviso le condizioni economiche della Germania lo richiedano, la renderanno in una molteplicità di casi arbitra della vita economica tedesca. La commissione dovrà non solo indagare sulla capacità generale di pagamento della Germania, e decidere (nei primi anni) quali importazioni di viveri e materie prime siano necessarie; è autorizzata a esercitare pressioni sul sistema di tassazione (allegato II, paragrafo 12b)140 e sulla spesa interna della Germania, al fine di assicurare che le risorse del paese servano in primo luogo a provvedere ai pagamenti per le riparazioni; e dovrà accertare l’effetto sulla vita economica tedesca delle richieste di macchinario, bestiame, ecc., e delle programmate consegne di carbone.
Per l’articolo 240 del trattato la Germania riconosce espressamente la commissione e i suoi poteri «quali siano stabiliti dai governi Alleati e Associati», e «accetta irrevocabilmente che la commissione possieda ed eserciti il potere e l’autorità conferitile in base al presente trattato». Si impegna a fornire alla commissione tutte le informazioni pertinenti. E infine, per l’articolo 241, «la Germania si impegna ad approvare, emanare e mantenere in vigore tutti i provvedimenti legislativi, ordinanze e decreti che siano necessari per dare pieno effetto a queste norme».
Non c’è esagerazione nei commenti in proposito della delegazione finanziaria tedesca a Versailles: «La democrazia tedesca viene annientata nel momento stesso in cui il popolo tedesco si accingeva a costruirla dopo una dura lotta; annientata da coloro medesimi che durante tutta la guerra non si sono stancati di affermare che intendevano portarci la democrazia ... La Germania non è più un popolo e uno Stato, ma diventa una pura impresa commerciale messa dai creditori nelle mani di un curatore giudiziale, senza concederle nemmeno la possibilità di dimostrare che è disposta a far fronte spontaneamente ai propri obblighi. La commissione, che avrà sede permanente fuori della Germania, possiederà in Germania diritti incomparabilmente maggiori di quelli mai posseduti dal Kaiser; sotto il suo regime il popolo tedesco rimarrebbe per decenni avvenire spogliato di ogni diritto, e privato, assai più dei popoli nell’età dell’assolutismo, di ogni indipendenza d’azione, di ogni aspirazione individuale di progresso economico e finanche etico».
Gli Alleati risposero negando validità e fondamento a questi commenti. «Le osservazioni della delegazione tedesca» dichiararono «fanno di questa commissione un quadro così distorto e inesatto, che è difficile credere che le clausole del trattato siano state esaminate attentamente e con calma. La commissione non è uno strumento d’oppressione o un congegno per interferire nella sovranità tedesca. Non ha forze al suo comando; non ha poteri esecutivi entro il territorio della Germania; non può, come si asserisce, dirigere o controllare il sistema scolastico o altro del paese. Il suo compito è di chiedere ciò che va pagato; accertarsi che la Germania può pagare; e ove la Germania sia in difetto, riferirne alle Potenze delle quali è delegazione. Se la Germania procura il denaro richiesto a modo suo, la commissione non può ordinare che sia procurato in modo diverso; se la Germania offre pagamenti in natura, la commissione può accettarli, ma, salvo quanto è specificato nel trattato, non può esigerli».
Questa non è una fedele descrizione dell’àmbito e autorità della commissione riparazioni, come si vedrà confrontandone i termini con il sommario sopra ricordato o con il trattato medesimo. Per esempio, l’affermazione che la commissione «non ha forze al suo comando» sembra difficilmente giustificabile alla luce dell’articolo 430 del trattato, che dice: «Ove durante l’occupazione o dopo lo scadere dei quindici anni di cui sopra la commissione riparazioni constati che la Germania rifiuta di rispettare in tutto o in parte gli obblighi che le derivano dal presente trattato riguardo alle riparazioni, le aree specificate nell’articolo 429 saranno immediatamente rioccupate in tutto o in parte dalle Potenze Alleate e Associate». Decidere se la Germania abbia rispettato i suoi impegni e se le sia possibile rispettarli compete, si noti, non alla Società delle Nazioni bensì alla stessa commissione riparazioni; e un verdetto negativo della commissione sarà seguito «immediatamente» dall’uso della forza armata. Inoltre la svalutazione dei poteri della commissione tentata nella replica Alleata muove sostanzialmente dal presupposto che la Germania sia perfettamente in grado di «procurare il denaro richiesto a modo suo», nel qual caso è vero che molti dei poteri della commissione riparazioni non avrebbero effetto pratico; mentre in realtà una delle ragioni principali per cui la commissione è stata istituita è la previsione che la Germania non sarà in grado di sostenere l’onere nominalmente impostole.
Pare che i viennesi, sentendo che una parte della commissione riparazioni si prepara a visitarli, abbiano deciso, com’è tipico per loro, di riporre in essa le loro speranze. A loro un organo finanziario non può ovviamente togliere nulla, dato che non hanno nulla; perciò tale organo deve avere lo scopo di recar loro aiuto e sollievo. Così ragionano i viennesi, spensierati anche nell’avversità. Ma forse non sbagliano. La commissione riparazioni toccherà con mano i problemi europei, e avrà una responsabilità proporzionale ai suoi poteri. Può darsi quindi che finisca per svolgere un ruolo molto diverso da quello cui la destinavano alcuni dei suoi promotori. Trasferita alla Società delle Nazioni, organo di giustizia e non più d’interesse, chissà che mutando animo e obbiettivi la commissione riparazioni non possa ancora trasformarsi da strumento di oppressione e di rapina in un consiglio economico europeo inteso a ridar vita e felicità, perfino ai paesi nemici?
V. LE CONTROPROPOSTE TEDESCHE
Le controproposte tedesche furono alquanto oscure, e anche piuttosto fraudolente. Si ricorderà che le clausole del capitolo riparazioni relative all’emissione di titoli obbligazionari da parte della Germania produssero nell’opinione pubblica l’impressione che l’indennizzo fosse stato fissato in 5000 milioni di sterline, o comunque in questa cifra come minimo. La delegazione tedesca, perciò, si diede a costruire la sua replica sulla base di tale cifra, supponendo a quanto pare che l’opinione pubblica dei paesi Alleati non si sarebbe accontentata di niente di meno della parvenza di 5000 milioni di sterline; e siccome non era in realtà disposta a offrire una somma così ingente, si studiò di produrre una formula che potesse essere presentata all’opinione Alleata come capace di fornire questa cifra, mentre rappresentava in realtà una cifra molto più modesta. La formula prodotta era trasparente per chiunque la leggesse con attenzione e fosse a conoscenza dei fatti, e i suoi autori non potevano certo aspettarsi che ingannasse i negoziatori Alleati. Era quindi una mossa tattica che partiva dall’ipotesi che questi ultimi fossero segretamente non meno desiderosi dei tedeschi di arrivare a un accomodamento che avesse qualche rapporto con la realtà, e che perciò, in considerazione dell’impiccio in cui si erano messi con il proprio pubblico, fossero disposti a una certa connivenza nella stesura del trattato: una ipotesi che in circostanze leggermente diverse avrebbe potuto avere buon fondamento. Ma per come stavano di fatto le cose questa sottigliezza non fu di alcun beneficio ai delegati tedeschi, cui avrebbe giovato assai più presentare una stima onesta e schietta di quello che ritenevano essere l’ammontare del loro debito da un lato, e della loro capacità di pagare dall’altro.
L’offerta tedesca dei presunti 5000 milioni di sterline aveva il seguente tenore. In primo luogo, era condizionata a concessioni nel trattato che garantissero alla Germania «di mantenere l’integrità territoriale corrispondente alla convenzione d’armistizio;141 di conservare i suoi possedimenti coloniali e le sue navi mercantili, incluse quelle di grosso tonnellaggio; di avere in casa propria e nel resto del mondo la stessa libertà d’azione di tutti gli altri popoli; la revoca immediata di tutta la legislazione di guerra; il regolamento secondo il principio di reciprocità di tutte le manomissioni dei suoi diritti economici e dei beni privati tedeschi, ecc. durante la guerra»; l’offerta, cioè, era condizionata all’abbandono della maggior parte del resto del trattato. In secondo luogo, le richieste non dovevano superare un massimo di 5000 milioni di sterline, di cui 1000 milioni da pagarsi entro il 1° maggio 1926; e nessuna parte di questa somma doveva essere gravata da interessi mentre ne era in corso il pagamento.142 In terzo luogo, andavano riconosciuti come accrediti a suo sconto (tra l’altro): (a) il valore di tutti i beni consegnati a termini d’armistizio, incluso il materiale militare (per esempio la flotta da guerra tedesca); (b) il valore delle ferrovie e proprietà statali nei territori ceduti; (c) la quota proporzionale dei territori ceduti nel debito pubblico tedesco (incluso il debito di guerra) e nei pagamenti di riparazione che tali territori avrebbero dovuto sostenere se fossero rimasti parte della Germania; (d) il valore della cessione dei crediti della Germania per somme da essa prestate ai suoi alleati durante la guerra.143
I crediti da dedurre per (a), (b), (c) e (d) potrebbero superare quelli riconosciuti nel trattato, secondo una stima approssimativa, di una somma pari a 2000 milioni di sterline, sebbene la somma da computare per (d) sia difficilmente calcolabile.
Quindi, se vogliamo stimare il valore reale dell’offerta tedesca di 5000 milioni di sterline in base a quanto stabilito dal trattato, dobbiamo anzitutto defalcare i 2000 milioni di sterline corrispondenti a compensazioni che il trattato non contempla, e poi dimezzare il residuo per avere il valore attuale di un pagamento differito cui non sono imputabili interessi. L’offerta si riduce così a 1500 milioni di sterline, a fronte degli 8000 milioni che secondo la mia stima approssimativa il trattato chiede alla Germania.
L’offerta era di per sé molto cospicua (tanto che suscitò ampie critiche in Germania); ma, essendo condizionata all’abbandono della maggior parte del resto del trattato, era ben difficile che fosse considerata una proposta seria.144 Alla delegazione tedesca sarebbe convenuto dichiarare in termini meno equivoci a quale cifra si riteneva in grado di arrivare.
Nella replica finale degli Alleati a questa controproposta c’è una clausola importante, di cui finora non mi sono occupato ma che può essere opportunamente esaminata qui. In generale non vennero contemplate concessioni rispetto alla stesura originaria del capitolo riparazioni, ma gli Alleati riconobbero che l’indeterminatezza dell’onere imposto alla Germania era un inconveniente, e proposero un metodo che permetterebbe di precisare prima del 1° maggio 1921 il totale ultimo delle richieste. La Germania avrà la facoltà di presentare entro quattro mesi dalla firma del trattato (cioè sino alla fine di ottobre 1919) l’offerta di una somma globale a saldo del proprio debito complessivo definito dal trattato; ed entro i due mesi seguenti (cioè prima della fine del 1919) gli Alleati «risponderanno, per quanto possibile, alle eventuali proposte».
L’offerta Alleata è soggetta a tre condizioni. «Primo, le autorità tedesche saranno tenute, prima di fare tali proposte, a conferire con i rappresentanti delle Potenze direttamente interessate. Secondo, le proposte devono essere inequivoche, chiare e precise. Terzo, le autorità tedesche devono accettare le categorie e le clausole delle riparazioni come cose già definite e non più discutibili».
L’offerta, quale è, non sembra prevedere un esame del problema della capacità di pagamento della Germania. Si preoccupa soltanto della determinazione del conto totale dei debiti definiti nel trattato: se il conto sia (per esempio) di 7000, 8000 o 10.000 milioni di sterline. «Le questioni» aggiunge la risposta Alleata «sono pure questioni di fatto, riguardanti cioè l’ammontare dei debiti, e come tali possono essere trattate».
È improbabile che, se davvero condotti con questi criteri, i negoziati promessi saranno proficui. Arrivare prima della fine del 1919 a una cifra concordata non sarà molto più facile che al tempo della Conferenza; e non gioverà alla situazione finanziaria della Germania sapere con certezza che essa deve pagare la somma enorme cui ammontano sicuramente i debiti attribuitile dal trattato, comunque vengano computati. Questi negoziati, tuttavia, offrono in effetti la possibilità di riaprire tutta la questione dei pagamenti per le riparazioni; anche se c’è poco da sperare che gli umori dell’opinione pubblica dei paesi Alleati siano, in così breve tempo, cambiati a sufficienza.145
Non posso lasciare questa materia come se il giusto modo di affrontarla dipendesse unicamente dai nostri impegni o dalla realtà economica. La politica di ridurre la Germania in servitù per una generazione, di degradare la vita di milioni di esseri umani e di privare un’intera nazione della felicità dovrebbe essere odiosa e ripugnante: odiosa e ripugnante anche se fosse possibile, anche se ci arricchisse, anche se non fosse fonte di rovina per tutta la vita civile d’Europa. C’è chi la predica in nome della giustizia. Nei grandi eventi della storia umana, nel dipanarsi degli intricati destini delle nazioni, la giustizia non è tanto semplice. E se pur lo fosse, le nazioni non sono autorizzate, dalla religione o dalla morale naturale, a punire i figli dei loro nemici per i misfatti di genitori o di governanti.