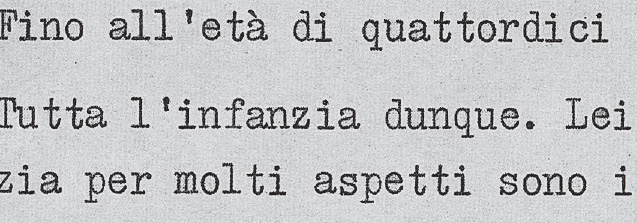
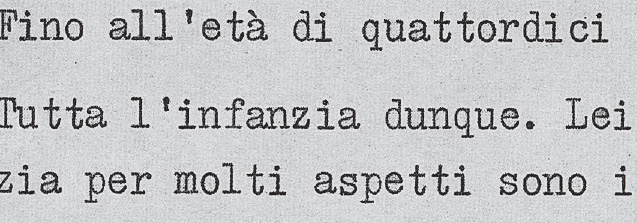
Quando, alla fine del febbraio 1962, era arrivata la nomination, non ci volevo credere. «L’Oscar? Il Premio Oscar?» Rileggevo i nomi delle altre candidate, mi passavano davanti Audrey Hepburn e Natalie Wood, Piper Laurie e Geraldine Page, e tra me e me dicevo: “Ma che, scherziamo? In più La ciociara è un film italiano, recitato in italiano, quando mai si è visto?”.
Eppure, ero lusingata all’idea, mi faceva sentire bene, mi illudevo che essere arrivata a tanto potesse bastarmi. Dentro di me, però, sapevo che non era vero, ogni gradino che salivo, sotto sotto, mi faceva sognare sempre più la vittoria. Forse stavo osando troppo, ma non c’era niente da fare. La speranza e l’ambizione erano parte di me, anche se sapevo che la delusione stava dietro l’angolo e il trionfo era destinato a pochi.
Dopo molto tergiversare, avevo deciso di non andare alla premiazione. Se avessi perso, sarei svenuta. E se avessi vinto, sarei svenuta lo stesso. Non potevo permettermelo, davanti a quella platea, sotto lo sguardo del mondo intero. “Me ne sto a Roma, sul mio divano”, così mi ero detta, e così feci.
La sera fatidica, anche Carlo era agitato, benché fingesse un certo distacco. Era un uomo solido, tutto d’un pezzo, molto concentrato sul suo lavoro, sugli obiettivi da raggiungere. Se dovessi descriverlo in un aggettivo, direi che era presente: alle situazioni, agli altri, a se stesso. Appassionato di cinema fin da quando era ragazzo, al cinema aveva dedicato la vita. Era determinato negli affari, attento ai risultati, ma sapeva combattere per un buon film. E se non gli piaceva come era venuto, si metteva di persona alla moviola per tagliarlo e rimontarlo come voleva lui. Era colto e sensibile, di poche parole; mi aveva capita fin dall’inizio e non aveva mai cercato di farmi essere diversa da quella che ero.
Avevamo lavorato tanto per arrivare a quel punto, complici e solidali, complementari l’una all’altro come accade nelle migliori famiglie. Chissà che ne pensavano quelle famiglie perfette, sempre dalla parte del giusto, che davanti alla nostra unione avevano gridato allo scandalo. Facevano presto a giudicare, ma non sapevano nulla di questo nostro amore, così sereno e concreto, nella vita come nel lavoro. Oggi si parlerebbe di “sinergia”, allora si chiamava “affetto” e “sostegno reciproco”. Avevamo viaggiato, ci eravamo esposti, eravamo tornati a casa a nostro rischio e pericolo, nonostante le accuse mosse contro di noi. Eravamo consapevoli che nessuno ti regala niente, ogni piccola vittoria è fatta di fatica e sacrificio e non sempre rappresenta il traguardo finale.
Quel 9 aprile 1962 eravamo nel nostro appartamento in piazza D’Aracoeli, dove abitavamo insieme più o meno ufficialmente già da un po’. Sapevamo bene che, per via della differenza di fuso orario fra l’Italia e la California, ci aspettava una notte bianca. Di fronte a noi, un deserto di ore lunghissime da passare. La trasmissione in mondovisione ancora non esisteva. Troppo tesi per chiacchierare, non riuscivamo a riposare né a leggere, il telefono continuava a suonare sommergendoci di auguri più o meno sinceri. I più sfrontati facevano previsioni, si dicevano sicuri di questo e di quello, sapevano tutto loro. Noi ci guardavamo con un mezzo sorriso. Comunque fosse andata, sarebbe stata una notte indimenticabile. Una notte da Oscar. Un po’ di musica, un sorso di vino, l’ennesima sigaretta, una camomilla, la finestra aperta per far entrare un po’ di primavera. E poi?
Era ormai molto tardi quando mi venne l’illuminazione. Il sugo, ecco, il sugo, che stupida, dovevo pensarci prima. In cucina mi sarei sentita al sicuro, potevo distrarmi da questo vortice d’ansia che non sapevo come placare. Mentre sbucciavo l’aglio, un pensiero volò leggero a mamma Luisa, che da qualche anno non c’era più. Forse per me sognava un’altra vita. Forse mi avrebbe preferito maestrina a Pozzuoli, due stanze sullo stesso pianerottolo o anche un piano più in su, con i pranzi della domenica e magari qualche nipotino tra i piedi. Eppure, stasera, quanto sarebbe stata orgogliosa di me. Proprio lei che mi aveva insegnato il valore della disciplina, il gusto di fare il proprio dovere, il piacere di sentirsi a posto con il mondo, sarebbe stata fiera di un successo conquistato solo a forza di volontà.
Gli occhi mi si velarono di lacrime. Che scherzi può fare l’emozione. Squillò ancora il telefono, di nuovo mammina, per la ventesima volta. Diceva di volermi tranquillizzare, invece cercava un argine alla sua agitazione. Rispose Carlo, un po’ più duro del solito. «Romilda, lasci un po’ in pace Sophia; la chiamiamo noi appena sappiamo qualcosa.» Tra loro c’era un rapporto di stima reciproca, di rispetto. Avevano suppergiù la stessa età e, in qualche modo, erano in competizione. O almeno lo era Romilda, che all’ingresso di questo signore così autorevole nella mia vita si era sentita messa un po’ da parte. E poi, quasi inutile dirlo, temeva “l’effetto Scicolone”. Mai fidarsi di un uomo, tanto più se sposato.
Tagliai anche la cipolla per nascondere le lacrime e mi sentii subito meglio. A volte basta poco per tornare con i piedi per terra, per riprendere l’equilibrio che le sorprese, belle o brutte, rischiano di portarti via.
Alle tre di notte arrivò un cablogramma da Santiago del Cile, con cui si informava doña Loren che aveva vinto il Golden Laurel per la miglior attrice 1961. Presagio di vittoria o beffa della sorte? L’alba era ancora lontana, e il sonno definitivamente svanito. “E mo’, che si fa?” mi chiesi pensando a come ingannare il tempo. Mi acciambellai sul divano, aspettando la luce, e presto mi raggiunse anche Carlo.
Per fortuna il tempo, anche quando va piano, così piano da sembrare a marcia indietro, non smette di passare. Anche quella volta i minuti diventarono ore e la notte sfumò nel giorno. Alle sei di mattina, secondo i nostri calcoli, era tutto finito, ma non arrivava nessuna telefonata, nessun telegramma, niente di niente. Il silenzio intorno a noi faceva quasi male. “A questo punto possiamo anche pensare di andare a dormire” ci dicemmo senza parlare. Eppure non osavamo alzarci. Stavamo lì nel grigio dell’alba, fissando le pareti, i quadri, le fotografie, finché ci assopimmo come due ragazzini.
Ma ecco, alle 6.39, uno squillo. Impietoso come una sveglia, come una sirena. Carlo si getta sul ricevitore.
«Chi? Chi? Cary? Cary Grant?» Un baratro di silenzio e poi l’esplosione di gioia, in quel suo inglese improbabile che si accese come un mortaretto a una festa di paese: «Sophia win! Sophia win! Sophia win!!!».
Gli strappai la cornetta di mano. Dall’altra parte del filo, la voce calda di Cary Grant. «It’s wonderful, Sophia, it’s wonderful. You are always the best!»
Sorridevo a Cary oltre l’oceano, sorridevo a me stessa, a noi, alla vita. Posata la cornetta, cominciai a saltare su e giù per il salotto. Poi, all’improvviso, mi sentii invadere da una spossatezza infinita. Non sapevo cosa pensare, che sentimenti provare. Feci il vuoto dentro di me e corsi in cucina a controllare che il sugo non si fosse bruciato.
Giù al portone, si accalcava un fiume di giornalisti impazienti. Tra loro si fecero largo mammina e Maria, promettendo che presto li avrei ricevuti. Mia sorella aveva in mano una piantina di basilico per me: «Così ti ricordi da dove sei partita…».
Il nostro abbraccio fu uno dei momenti più intensi di tutta la mia vita. Il mio Oscar era il loro. La loro felicità, la mia.
Un altro abbraccio indimenticabile – che portava con sé metri di pellicola girata insieme negli ultimi otto anni tra i bassi di Napoli e le piazze di Trastevere, i vicoli di Sorrento e le brulle colline di Ciociaria – fu quello di Vittorio De Sica. Era stato lui a scorgere per primo la promessa dietro la comparsa, l’attrice dietro la maggiorata, e ora la madre dietro la figlia. Sì, perché anche questa volta era tutta una questione di madri e di figlie, per niente facile da districare.
Tutto era partito da un romanzo di Alberto Moravia, che Carlo stimava e rispettava immensamente. Si vedevano spesso, condividevano progetti, letture, opinioni. Da uno spunto di una sua novella era nato Peccato che sia una canaglia, che mi aveva fatto conoscere Marcello. Ed era stato sempre lui a scrivere, con altri grandi autori, La donna del fiume. Ma La ciociara mi aveva strappato il cuore. Parlava della nostra terra, di me e di mia madre, della guerra che avevamo vissuto e di quella che avevamo temuto, delle ferite che non si rimarginano più. In quelle pagine avevo trovato il coraggio, la fame, la cieca stupidità degli ignoranti, l’istinto materno che abita in tutte le donne del mondo.
Tre anni prima, a Bürgenstock, Carlo voleva comprare i diritti del romanzo e aveva chiesto il mio parere. Io lo avevo divorato in due giorni, senza riuscire a metterlo giù.
La voce di Cesira mi aveva incantata. Lei, “burina” venuta dalla campagna a Roma, imprigionata giovanissima dentro un matrimonio sbagliato, trovandosi da sola sotto le bombe a proteggere quello che ha – la roba, la bottega, la figlia –, decide di scappare nella sua terra, la Ciociaria. Tanto, dicono, è questione di qualche settimana: gli Alleati sono alle porte.
Cesira è una donna piena di buon senso, aperta e combattiva, che per la sua Rosetta farebbe qualunque cosa. Il suo modo di pensare, così onesto, così vero, così conscio dei propri limiti, si scontra con la confusione del momento, con la banalità del male, con un treno diretto a Napoli che si ferma in mezzo alla campagna, senza più una direzione.
La campagna è fatta di polvere e sassi, di mulattiere che risalgono le colline, coltivate a terrazze, per arrivare in cima, tra le montagne, alla ricerca di una sicurezza che ormai non esiste più. Capanne e casette, più simili a stalle che a case cristiane, ospitano contadini e sfollati, costretti dall’emergenza a vivere insieme. Durante quelle lunghe settimane che diventano mesi, e addirittura stagioni, uomini di campagna e di città si ritrovano a intrecciare le loro vite, le loro mentalità così diverse eppure così uguali, ognuno alla fine concentrato solo su se stesso e sul poco che gli è rimasto. Gli ideali contano sempre meno davanti alla fame, al freddo, alla paura. «Inglesi o tedeschi, vince chi vince… Ma si sbrigassero, però!»
Moravia in Ciociaria è sfollato davvero con sua moglie Elsa Morante. Ha avuto fame e freddo anche lui, ha provato la noia e la paura, ha dormito su quei materassi fatti di spighe di granoturco che bucano la schiena, tra cimici e topi. Ha divorato il pane di carrube e il pecorino duro, le arance e le budella di capra. E ora, dopo dieci anni, impresta i suoi ricordi a Cesira e a Rosetta che, così lontane da casa, si sentono sperdute.
Nel paesino di Sant’Eufemia, dove trovano ospitalità a caro prezzo, madre e figlia iniziano a frequentare Michele, un essere alieno, lontano mille miglia da tutti gli altri. Il ragazzo ha studiato, parla difficile, e nessuno lo capisce. Eppure con le sue idee cerca di risvegliare i “morti”, di accendere in chi lo circonda la voglia di ricostruire un mondo migliore. La loro amicizia cresce piano piano, fresca come il cielo, come i ciclamini e il capelvenere sui bordi delle terrazze, come la cicoria, il crispigno, la nipitella di cui sono costretti a cibarsi quando, passato l’autunno e passato pure l’inverno, le provviste sono finite e inglesi e tedeschi, immobili sul fronte del Garigliano, chiudono l’Italia in una morsa. Dopo quaranta giorni di pioggia e fango, la tramontana spazza le nuvole e riporta il sereno, ma il peggio deve ancora venire. Riprendono i bombardamenti, che graffiano il cielo e colpiscono a caso. Iniziano i rastrellamenti dei tedeschi, resi ancora più feroci dalla sconfitta. Arrivano perfino gli americani, gentili e distanti, che risalgono svogliati la via Appia verso Roma distribuendo caramelle e sigarette.
È una lotta di tutti contro tutti, in cui domina l’egoismo, la paura, l’“arraffa arraffa”. Perfino la gioia di Cesira davanti all’imminente liberazione le fa dimenticare l’amicizia per Michele che l’ha nutrita per tutto questo tempo. Eppure, la sua è una gioia di breve durata. Su di lei, e soprattutto su Rosetta, sta per abbattersi una violenza estrema, che arriva all’ultimo momento per mano di coloro che si dicono liberatori.
Quell’estate 1959, passeggiando tra i boschi di Bürgenstock, non avevamo parlato d’altro: La ciociara era un pensiero fisso. Carlo cercava per questa avventura un respiro internazionale, ma gli sceneggiatori hollywoodiani, pur apprezzando il libro, non riuscivano a vederci il film. «Troppo lunga l’attesa del dramma, troppo lento il ritmo, non succede niente fino alla fine» dicevano. Ma noi, che la guerra l’avevamo vista da vicino e che avevamo imparato ad aspettare, il film lo vedevamo eccome. Conoscevamo fin troppo bene quella storia.
Cesira nel libro aveva trentacinque anni, Rosetta ne aveva diciotto. Io ero a metà, ne avevo ventisei. Inizialmente si era pensato ad Anna Magnani nel ruolo della madre, e a me in quello della figlia. Alla regia doveva esserci George Cukor, che mi aveva diretta da poco e amava Anna appassionatamente. Entusiasta dell’idea, era volato in Italia da lei, che però era stata irremovibile.
«Il personaggio è stupendo, ma non posso fare la madre di Sophia» aveva detto senza esitare. «È troppo alta, troppo imponente. La stimo molto come attrice, ma nel ruolo di mia figlia proprio non ci sta. Dovrei guardarla dal basso in alto, che senso ha?»
Senza la Magnani, Cukor fece un passo indietro e Carlo dovette ricominciare tutto da capo.
Fu a questo punto che entrò in gioco De Sica, ciociaro di nascita, con il contributo dell’inseparabile Zavattini. Tornò all’attacco con la Magnani, certo di trionfare dove l’esimio collega americano aveva fallito. Ma Anna era un osso duro, ed era troppo convinta della sua posizione per cedere. Vittorio ci provò più volte, mettendo sul piatto tutto il suo savoir-faire. L’ultima con l’intercessione di Paolo Stoppa, che le fece una timida telefonata: «Nannarella, sono a cena con De Sica sotto casa tua, possiamo salire un momento?». Ma fu tutto vano. «Come figlia ci vorrebbe una figura meno ingombrante, chessò, Anna Maria Pierangeli… andremmo benissimo insieme.»
Più Vittorio cercava di convincerla, più lei si induriva. Finché, forse solo per provocarlo, gli buttò lì: «Ma se ci tieni tanto a Sophia, perché non fai fare la madre a lei?».
Detto fatto. Pur con rammarico per quel gran rifiuto, la mattina dopo De Sica mi telefonò a Parigi e mi propose questo cambio di prospettiva.
«Ma che dici? È una donna molto più grande di me. È una madre! Come faccio?»
«Ti prego, Sofi’, pensaci bene. È una madre che conosci, ne hai viste tante, assomiglia alla tua. Diminuiamo di qualche anno l’età di Rosetta ed è fatta. Ti prego, dimmi di sì.»
Carlo era divertito da questa pensata e mi incoraggiò, come sapeva fare lui: «Se Vittorio pensa che ce la puoi fare, vuol dire che ce la farai. Fidati».
D’altra parte, la varietà, la profondità dei sentimenti che può esprimere una madre sollecita tutte le corde di un’attrice. Quelle sfaccettature, quella psicologia complessa e delicata mi hanno sempre attirato, forse perché, anche per la mia storia personale, sento molto gli affetti viscerali. Non c’è niente da fare, la donna-madre rappresenta l’aspetto più compiuto della personalità femminile, e in questo senso sfida qualunque artista a dare il massimo.
Fu Vittorio, ancora una volta, a guidarmi in questa avventura: «Cesira è una mamma a tutto tondo. È umile, ha sempre lavorato e vive per la figlia. Il suo approccio alle cose è semplice e diretto. Hai già provato tutto questo sulla tua pelle, Sofi’. Sai benissimo di cosa stiamo parlando. Reciterai senza trucco, e senza trucchi. Sii te stessa, diventa tua madre, e andrà tutto bene».
Dopo tanti anni di Hollywood, La ciociara mi riportava a casa, alla durezza della mia infanzia. La guerra, che era rimasta a lungo sepolta dentro di me, ora tornava fuori per dare voce a questa donna ferita, alla sua sofferenza, al suo coraggio. Pensavo a mammina, a come aveva combattuto per difenderci, per procurarci l’acqua e il cibo. A come si doveva sentire quelle notti in cui i soldati marocchini accampati nell’androne bussavano ubriachi alla nostra porta. A come sorvegliava in silenzio, senza farsi notare, i giovani marines americani che venivano nel nostro salotto a bere il brandy. Perché sapeva che il pericolo si annidava ovunque, in qualunque momento, anche dove ci si crede al sicuro.
Quando mi presentarono Eleonora Brown, la ragazzina che avevano scelto per fare Rosetta, mi sentii subito responsabile per lei, per noi. Aveva una faccia timida e intelligente e insieme ci aspettava un duro lavoro. Come potevo diventare sua madre? Soffrire per lei? Come potevo aiutarla a fidarsi di me? Il mio istinto mi spinse a guardarla con la dolcezza con cui mi ero sentita guardata da piccola, con l’amore da cui ero stata protetta e accarezzata. E funzionò.
Eleonora era figlia di una napoletana e di un americano, che si erano incontrati durante la guerra, e sul set veniva spesso accompagnata dalla zia. Aveva tredici anni, era poco più di una bambina, lo sguardo ancora infantile su un corpo di adolescente.
De Sica era un maestro nel far recitare attori non professionisti. Lo aveva dimostrato in Sciuscià, in Umberto D., in Miracolo a Milano. Otteneva quello che voleva, in qualunque modo. Ma qui superò se stesso. Di fronte a una delle scene più drammatiche, in cui Rosetta era chiamata a disperarsi per Michele, impersonato da Jean-Paul Belmondo, arrivò a dire a Eleonora che i genitori avevano avuto un incidente…
«Mi dispiace, cara, mi dispiace…» fingeva con voce drammatica e pietosa. «Ora sono in ospedale, la loro condizione è grave ma non è detta l’ultima parola… Su, su, coraggio bambina…»
Eleonora cominciò a piangere, a piangere, a piangere. Dovemmo interrompere le riprese, non riusciva più a girare. Questa volta Vittorio aveva esagerato.
«Eleonora!» corsi subito in suo soccorso. «Non è vero niente, dice delle sciocchezze per farti piangere! Dài, tirati su, sorridi…»
Tutto inutile, lo choc era stato troppo forte.
Del resto, non era facile per una bambina tirare fuori spontaneamente emozioni così drammatiche. Dove non riusciva Vittorio, o dove ci riusciva fin troppo bene, intervenivo io, a mitigare, a sollecitare, a suggerire. Ricordo la scena in cui l’aiutavo a lavarsi e restava con il sederino di fuori. Quanta pazienza per vincere la sua vergogna, il suo pudore.
Con il tempo imparammo a conoscerci e a volerci bene, come fanno madri e figlie, e la sua Rosetta passò alla storia. L’esperienza del film fu così intensa che restammo amiche e ancora oggi ci sentiamo spesso.
Cominciammo a girare il 10 agosto 1960. La troupe si sistemò sulle colline intorno a Gaeta. Io e Carlo affittammo una grande casa bianca, affacciata sul Golfo. Dalla finestra vedevo Pozzuoli. «Altro che Beverly Hills» commentò Vittorio. «Tu sei nata qui, questo è il tuo posto.» In effetti ero completamente a mio agio, senza trucco, vestita di stracci, bianca di polvere sotto il sole d’estate. Stavo bene tra le comparse, nelle grotte, a piedi nudi con le valigie in testa.
Sotto gli allarmi antiaerei, mi rivedevo nel tunnel della ferrovia, in compagnia di topi e scarafaggi. Riconoscevo il latte di capra e il sorriso burbero dei pastori, guardavo con appetito quel cibo povero, quel pane scuro che tanto ci era mancato.
De Sica mi teneva sotto controllo, mi abbassava se volavo troppo in alto, mi alzava se ero troppo dimessa. Ma quando arrivammo all’angoscia, alla disperazione, mi liberò il cuore da ogni regola, da ogni impedimento. Lasciò che si compisse il miracolo, che la mia Cesira venisse alla luce e prendesse la sua strada.
Fu il ruolo più difficile della mia carriera. Senza Vittorio non sarei mai riuscita a fare il buio nel mondo circostante per nascere a una nuova vita, che in quel momento diventava l’unica possibile. De Sica provava la scena e gli occhi gli si riempivano di lacrime: «Stampa questa. Buona la prima!!!». Sapeva far pressione sui miei sentimenti con una maestria che mi trasformò davvero in quella donna, così lontana dal glamour della star.
Quando ancora adesso mi capita di rivedere La ciociara, mi basta una scena, una sola, per riviverne tutta l’emozione, come la prima volta. Quel sasso lanciato contro la jeep degli Alleati – «Ladri, cornuti, figli di mignotta!» – è un urlo di ribellione contro l’odio che per tanti anni aveva tenuto in ostaggio il mondo. La fiamma di quella ribellione deve restare sempre accesa, anche in tempo di pace, mantenendoci vigili e vivi. Perché tutto questo non debba più accadere.
La ciociara mi regalò venti premi oltre all’Oscar, tra cui il David di Donatello, il Nastro d’argento, il titolo di miglior attrice a Cannes, ma mi regalò anche una bellissima intervista di Alberto Moravia, che ripercorse con me la mia vita. La rileggo oggi dopo cinquant’anni e ancora mi commuovo.
Seguendo la voce del grande scrittore, ritorno a Pozzuoli, al suo porto piccolo, con l’acqua verde e oleosa sparsa di scorze gialle di limoni. La Pozzuoli di vecchie case e vecchie strade in ombra, delle rovine romane e del tempio di Serapide con le colonne immerse nell’acqua. Ma anche la Pozzuoli dei cantieri, della fabbrica di cannoni dell’Ansaldo, dove lavorava papà Mimì.
Guidata dalle sue domande, entro nel nostro piccolo appartamento, con i mobili di noce scolpito e la cucina, dove faccio i compiti mentre mamma Luisa mi offre una tazzina di caffè e mi racconta le favole in dialetto. Nel suo regno, mia nonna prepara per il pranzo il pane sotto i fagioli, lo stesso che in Ciociaria si chiama «minestrina». La sera invece si mangia la pasta asciutta, perché gli uomini tornano dal lavoro e vanno saziati. Il 27 di ogni mese si va a Napoli con zia Dora, che mi prende un bicchiere di cioccolata con la panna e una sfogliatella da Caflisch. È lì che vedo per la prima volta Anna Magnani. Campeggia grande e piena di fascino su un’insegna all’angolo di una strada, in coppa al teatro dove sta recitando. Le nostre strade potevano incontrarsi e invece si sono solo sfiorate.
In questa Pozzuoli della memoria, avverto l’ombra di mio padre, l’estraneo, che viene attirato a casa da telegrammi mandati ad arte ma che non vede l’ora di andar via. «L’asino tra i suoni», come diciamo a Napoli, nient’altro che un intruso. È alto e distinto, i capelli brizzolati, il naso adunco simile a un becco, mani e piedi grandi ma caviglie e polsi sottili. Un bel sorriso, un’espressione sprezzante. Pieno di charme.
E qui Moravia comincia a scavare, senza pietà, con tutta la sua intelligenza. E porta alla luce la ferita da cui è nata Sophia Loren. La diversità della mia famiglia – un padre assente, una madre troppo più bella delle altre – mi fa molto soffrire, mi riempie di vergogna, ma insieme è la mia fortuna. È la forza che mi spinge a lavorare, a dimostrare chi sono, a scegliere prestissimo la mia strada. In altri termini, «il successo è un surrogato per la normalità irraggiungibile». Parto per Roma fuggendo da una bambina senza padre per cercare me stessa nell’attrice che voglio diventare.
Il gioco si ripete qualche anno dopo con Carlo e la sua duplice funzione. È il produttore che potrebbe aiutarmi a coronare il mio sogno del cinema e l’uomo che potrebbe regalarmi la normalità che tanto desidero. Ma ancora una volta c’è un impedimento, una irregolarità che mi fa scartare di lato e, forse, arrivare più lontano.
Ed eccomi di nuovo in viaggio: lascio Roma per Hollywood, come avevo lasciato Pozzuoli per Roma. Lascio una situazione senza via d’uscita per trovare una mia strada “normale”. Che però non esiste. È questa impossibilità che mi induce a superare me stessa, a darmi quella spinta interiore, psicologica, che mi permette di identificarmi con i miei personaggi e portarli alla vita. Di comprendere la realtà e approfondire la conoscenza di me stessa e del mondo.
«Non si soffre mai invano» dice Moravia, «almeno quando si ha la volontà di sapere perché si soffre.»
La signora Brambilla, con la sua accusa di bigamia, mi ruba la normalità che andavo cercando. E io reagisco con La ciociara, che mi consacra agli occhi del mondo. È il mio destino. Se nel cinema prediligo le parti passionali e tragiche, i personaggi forti, emotivi, nella vita vorrei essere tutto l’opposto: fredda, controllata, introversa. Cioè normale. Ma la normalità mi sfugge, la mia gioia di vivere, la mia vivacità, il mio temperamento me lo impediscono. Dunque, cerco di affermarmi attraverso l’arte, interpretando personaggi non comuni verso i quali mi sento portata proprio perché sono così diversi da quello che vorrei essere nella vita. Tutto qua. E non è poco.
Sogno che mi trovo su una spiaggia, al tramonto, e il mare è calmissimo, immenso, liscio, simile a uno sterminato raso azzurro. Il sole è rosso come il fuoco e sta andando giù. Io a un tratto mi metto a correre sulla spiaggia e corro corro corro. Poi, sempre correndo, mi sveglio.
Moravia lo legge così, «alla maniera dei maghi caldei che interpretano i sogni di Nabucodonosor»: il mare è la normalità, che cerco invano di raggiungere. Il sole è il mio successo. Io potrei star ferma a guardare la tranquillità del mare e invece voglio rincorrere il mio sole. E, come tutti quelli che vogliono raggiungere il sole, ho da percorrere molta strada, ma lo faccio perché quel sole, pur essendo lontano, mi conforta e mi illumina nella mia corsa.