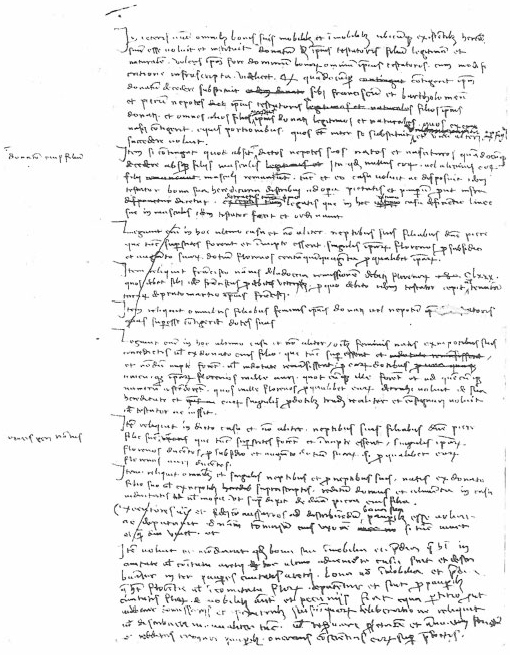
ELOGIO DELLA CITTÀ DI FIRENZE
A differenza delle «laudes civitatum» dell’eta medievale, spesso basate su aride elencazioni, poco originali, di dati e di fatti, la Laudatio florentine urbis si presenta con un’impostazione che, se e valida piu per il sottofondo ideologico che non per la struttura e l’articolazione della materia, e pero fortemente innovativa, in quanto solo in parte derivante da modelli classici, se pure tenuti presenti dal Brum. La Laudatio, infatti, appare come una interpretazione letteraria — certamente non priva di moduli retorici e di enfatiche formulazioni — dello «status» politico e sociale della citta-repubblica di Firenze negli anni iniziali del secolo XV. Uno «status» orgogliosamente presentato e celebrato dal Bruni, anche perche nella sua opera egli trasferisce una visione ed una rimeditazione della storia di Firenze che sono non solo il frutto di una personale acquisizione, ma anche il risultato di una riflessione collettiva, maturata in anni fondamentali per l’elaborazione della cultura fiorentina, e prima di tutto decisivi per la vita e l’indipendenza stessa della citta, messe in discussione, non teorica ma realmente pratica, dalla guerra mossa da Gian Galeazzo Visconti.
La Laudatio — quale che sia stato il momento esatto della sua stesura: estate-autunno del 1403 o del 1404, o tempi di poco anteriori (ma pare chiaro, comunque, sempre dopo la fine della guerra awenuta nel 1402) o posteriori — si presenta, si, come una esaltazione totale di Firenze, ma soprattutto come la proiezione politica di una citta che rivendica per se stessa e per i suoi cittadini un ruolo di primato e di privilegio nel concerto degli altri Stati: «Ipsa urbs eiusmodi est ut nihil neque luculentius neque splendidius in toto orbe terrarum inveniri possit. […] Admirabilis quidem est huius urbis prestantia et quam nullius eloquentia adequare possit» (p. 568), scrive il Bruni nella prima pagina della Laudatio. E in base a questi assunti iniziali sviluppera poi il suo ampio ragionamento, sempre volto a dimostrare le caratteristiche, tutte e sempre positive, di questa «prestantissima et ornatissima urbs».
Ma la novità essenziale dell’opera consiste nel continuo rapporto che il Bruni instaura e spiega, fin dall’apertura, fra la città e i suoi abitanti: «Ita huic nobilissime atque inclite urbi tanta cum suis civibus conventientia est ut neque eos alibi quam in illa habitasse nec ipsam alios quam huiusmodi habitatores habuisse summa ratione factum videatur» (p. 570). Così — con anni di anticipo rispetto ad una lettera famosa a Niccolò Niccoli, in cui viene esposto il diverso significato di «urbs» e di «civitas» (Ep. Ili, 9), e rispetto pure ad altre spiegazioni fornite nel De militia —, il Bruni offre nella Laudario, e nonostante che il titolo di quest’opera privilegi il concetto di «urbs», un’esemplare testimonianza del legame indissolubile che sta a fondamento della vita civile e che contraddistingue l’esistenza di una comunità di uomini, anche in base all’insegnamento di Aristotele. Qualsiasi descrizione il Bruni faccia di Firenze — la posizione geografica, la distribuzione topografica, la maestosità delle costruzioni, la fertilità del territorio, la grandezza della sua storia secolare — non rimane fine a se stessa, ma sempre viene inserita nella realtà viva del «populus florentinus», dei «viri fiorentini», dei «fiorentini homines»: la storia di Firenze è, quindi, la storia di un «populus» intero e compatto. Ne è chiara ed illuminante sintesi, ad esempio, il passo dove il Bruni mette in stretta correlazione la giustizia e la libertà, che sono le condizioni basilari su cui è ordinata la società fiorentina: «Primum igitur omni cura provisum est ut ius in civitate sanctissimum habeatur, sine quo nec civitas esse nec nominari ulla potest; deinde ut sit libertas, sine qua nunquam hic popolus vivendum sibi existimavit. Ad hec duo simul coniuncta, quasi ad quoddam signum ac portum, omnia huius rei publice instituta provisaque contendunt» (p. 634).
Ecco perché il Bruni può allontanarsi dagli schemi tipicamente medievali di questo genere di narrazioni per concretizzare quelli che gli appaiono gli splendidi ed insuperabili aspetti della città intera in un rapporto assoluto con la mentalità e la condotta dei suoi abitanti. Nasce, così, l’elaborazione ideologica che qualifica il «populus» fiorentino: l’ansia di libertà e di autonomia: «Ex quo illud evenire arbitror, quod in hac civitate egregie preter ceteras et fuisse et esse videmus: ut florentini homines maxime omnium libertate gaudeant et tyramnorum valde sint inimici» (p. 600). Questo è l’assunto di fondo che giustifica e spiega la stesura della Laudatio; ed è come il punto d’arrivo della descrizione dei «mirabilia urbis»: la città è bella, ricca e potente perché è città libera.
All’alba di una nuova stagione epocale, quale appariva l’inizio del secolo XV, e mentre sempre più vigorose erano le forze che spingevano al distacco dalle autorità somme e tutelari dell’impero e del papato, il Bruni rivendica in quest’opera — pur scritta da privato cittadino, ma in correlazione con un ben preciso e sicuro programma ideologico, che era patrimonio comune e collettivo della città intera — ogni forma di autonomia della stessa città in nome di quella libertà che Firenze aveva sempre difeso, e che sembrava garantire da ogni minaccia di tirannide o di condizionamento della sovranità e addirittura dell’esistenza del «populus».
Su questa linea maestra il Bruni elaborerà tutta la sua riflessione successiva, anche e soprattutto quando sarà non più un privato cittadino ma il cancelliere della Repubblica. I motivi della Laudatio torneranno quindi — già si è detto — con ampie riprese e verifiche nel De militia, nell’Oratio in funere lohannis Strozze, nelle Historiae florentini populi, nelle lettere pubbliche scritte per conto della città dal 1427 al 1444, gli anni, appunto, del cancellierato del Bruni. Solo la Costituzione fiorentina del 1439 si allontanerà, in parte, dalle tesi da sempre sostenute, perché lì il Bruni vorrà tentare un’impossibile mediazione fra la «sancta et inconcussa libertas», tipica della tradizione politica fiorentina, e i nuovi metodi di governo di Cosimo dei Medici, che non potevano collimare con essa.
Concludendo, la Firenze della Laudario è certamente una città ideale e idealizzata: «Hec prudentissima civitas ita omnes sui partes moderata est ut inde summa quedam rei publice sibi ipsi consentanea resultet, que mentes atque oculos hominum sua convenientia delectet. Nihil est in ea preposterum, nihil inconveniens, nihil absurdum, nihil vagum; suum queque locum tenent, non modo certum, sed etiam congruentem» (p. 634). Ma è una idealizzazione che il Bruni ribadisce con tanta forza e tanta frequenza da farne lo specchio di una realtà viva e concreta. Così Firenze è la città che tutti desiderano avere almeno come «duplex patria», se non hanno avuto la fortuna di nascervi.
Non vi è dubbio che anche queste retoriche dichiarazioni ebbero un ruolo notevole nella formazione del mito di Firenze nel corso del secolo XV.
Vellem mihi a Deo immortali datum esset ut vel fiorentine urbi, de qua dicturus sum, parem eloquentiam prestare possem, vel certe meo erga illam studio meeque voluntati. Alterutrum enim, ut opinor, abunde esset ad illius magnificentiam nitoremque ostendendum. Nam et ipsa urbs eiusmodi est ut nihil neque luculentius neque splendidius in toto orbe terrarum inveniri possit, et voluntas quidem mea, ut ego de me ipso facile intelligo, nulla in re unquam fuit ardentior: ut nullo modo dubitem, si quodvis illorum adesset, me de hac precellenti et formosissima urbe cum elegantia et dignitate verba facere posse. Verum quia non omnia que volumus eadem nobis et posse concessum est, quantum poterimus id in medium afferemus, ut non voluntas nobis sed facultas potius videatur defuisse.
Admirabilis quidem est huius urbis prestantia et quam nullius eloquentia adequare possit. Sed nonnullos et graves et bonos viros etiam de ipso Deo videmus locutos, cuius glorie ac magnitudinis ne ad minimam quidem partem quamvis eloquentissimi hominis aspirat oratio; nec deterrentur tamen ob eiusmodi excessum quominus, quantum anniti queunt, de tam immensa magnitudine loquantur. Et ipse igitur satis fecisse mihi videbor, si, quantum studio, disciplina, exercitatione dicendi, multis denique vigiliis assecutus sum, id omne in laudanda hac urbe potissimum conferam, etsi piane intelligo id eiusmodi esse ut nullo modo cum tanto splendore civitatis sit comparandum.
Quod igitur a plerisque oratoribus dictum est, nescire se unde initium sumant, id profecto nunc mihi evenire non verbis, quemadmodum illis, sed re ipsa intelligo, non solum enim quia multe sunt res et varie inter se ultro citroque connexe, verum etiam quia ita preclare omnes et quodammodo egregie sunt ut inter se ipsas de excellentia certare videantur, nec facilis sit deliberatio quenam in dicendo sit anteponenda. Sive enim pulchritudinem ac nitorem urbis intueare, nihil dignius videri potest de quo quam primum enarretur; sive potentiam atque opes, illud omnino censebis preferendum. At si res gestas vel in nostra etate vel superiori tempore contempleris, nihil tanti videri potest ut illis anteponatur; cum vero mores institutaque consideres, nihil omnino arbitraris prestantius. Hec me dubium tenent, sepeque de altero dicere parantem alterius recordatio ad se revocat, nec deliberandi permittunt facultatem. Ego tamen unde aptissimum et congruentissimum putabo, inde initium dicendi sumam; quod quidem credo etiam ceteros non esse improbaturos.
Ut enim non nullos filios videmus tantam habere cum parentibus similitudinem ut in ipso aspectu manifestissime cognoscantur, ita huic nobilissime atque inclite urbi tanta cum suis civibus convenientia est ut neque eos alibi quam in illa habitasse nec ipsam alios quam huiusmodi habitatores habuisse summa ratione factum videantur. Nam quemadmodum ipsi cives naturali quodam ingenio, prudentia, lautitia et magnificentia ceteris hominibus plurimum prestant, sic et urbs prudentissime sita ceteras omnes urbes splendore et ornatu et munditia superat.
Principio igitur, quod prudentie maxime est: nihil ad ostentationem facere nec periculosam et inanem iactantiam sequi potius quam tranquillam stabilemque commoditatem, hoc Florentiam quidem cernimus observasse. Neque enim summis in montibus collocata est ut inde se preclare ostentare posset, nec rursus in latissimo camporum equore ut quoquo versus esset aperta.
Prudentissime quidem utrunque, et optimo Consilio, ab hac urbe factum. Neque enim in summis montibus habitare licet sine adversa celi intemperie, sine ventis, sine procellis, sine summa habitatorum incommoditate atque molestia; nec rursus in immensa vastaque planitie absque uditate soli, absque impuritate aeris, absque caligine nebularum. Has igitur incommoditates fugiens, prudentissima urbs eo in loco posita est ut, quod in omni re maxime probatur, medium sit inter extrema sortita et procul ab iniquitate montis et fastidio planitiei remota. Sic tamen utrunque complectitur, ut neutrius utilitatis sit expers et mira celi suavitate fruatur. Obiecti enim ad septentriones fesulani montes, quasi propugnacula quedam urbis, ingentem vim frigoris et boree aquilonisque furentes impetus repellunt. Ad austrum vero, cuius vis minor est, humiliores muniunt colles. A ceteris autem partibus apricissimi se explicant campi, ad zephiros tamen magis aperti. Itaque plurima in his locis tranquillitas est summaque temperies, a quibus cum discedis, quocumque progrediare, aut te frigora maiora excipiunt aut solis ardores.
Ipsam vero urbem, quantum vel montis vel planitiei sua magnitudine occupat, speciosissima murorum sepit corona, non tamen tanto apparatu ut timida aut diffidens suis viribus videatur, nec rursus ita neglecta ut petulans aut inconsulta possit haberi. Quid dicam de frequentia populi, de splendore edificiorum, de templorum ornatu, de totius urbis incredibili admirandaque lautitia? Omnia, me hercule, conspicua sunt et egregia pulchritudine ornata.
Sed ea melius ex comparatione aliarum quam ex se ipsis licet cognoscere. Itaque ii qui aliquod tempus abfuere, cum Florentiam reveniunt, soli ferme intelligunt quantum hec florentissima urbs ceteris omnibus longissime prestet. Nulla est enim in toto orbe terrarum cui non aliquid maximarum rerum ad pulchritudinem desit. Hec populo caret, illa edificiorum ornatu, alia vero harum quidem rerum minime inopiam patitur, verum sita haud salubri celo. Non nulla autem ita immunda est ut, quicquid sordis noctu factum est, id mane ponat ante oculos hominum et pedibus per vias calcandum subiciat, quo nihil fedius excogitari potest. Iam enim etsi mille ibi sint regie, si inexhauste divide, si infinita populi multitudo, contemnam tamen fetidissimam urbem nec multi unquam existimabo. Quemadmodum enim in deformi corpore, etsi cetera omnia preclara habeat, felicitas tamen esse non potest, ita in urbibus, si immunde sint, etsi cetera omnia assint, pulchritudo esse nullo modo potest. Cui autem urbi pulchritudo deest ei summum maximumque ornamentum deesse quis non videt?
Florentiam vero usque adeo mundam atque abstersam cernimus ut nusquam aliquid reperiatur nitidius. Unica quidem hec est urbs, et in toto orbe terrarum sola, in qua nihil fedum oculis, nihil tetrum naribus, nihil pedibus sordidum offendas. Summa diligentia habitatorum cuncta eiusmodi cauta ac provisa sunt ut, omni turpitudine procul semota, ea tantum incurras que letitiam ac iocunditatem sensibus queant afferre. Itaque magnificentia quidem eas fortasse omnes que nunc sunt; splendore autem atque lautitia et eas que sunt et eas que unquam fuerunt urbes sine controversia superat. Est enim inaudita tanta munditia, et incredibilis iis qui nunquam Florentiam viderunt, quippe nos ipsos qui eam habitamus quotidie hec habet admiratio, nec consuetudine satiari possumus. Quid enim mirabilius quam in populosissima urbe nihil usquam limi apparere, imbrem autem quamvis maximum nihil impedire quominus siccis plantis urbem perambules, cum prius ferme opportunis rivis aqua pluvia absorta est quam in terram fuerit delapsa. Ex quo fit ut ne splendidarum quidem domorum thalami aliis in urbibus adeo mundi atque abstersi sint ut huius urbis vie atque platee. Neque vero munditiam habet, non autem ornatum edificiorum; nec ornatum edificiorum, non autem salubritatem celi; nec salubritatem celi, non autem multitudinem ac frequentiam populi. Sed de primo ad extremum omnia assunt que beatam urbem possunt efficere. Sive enim antiquitate delecteris, permulta invenies vel in publicis vel in privatis edibus antiquitatis vestigia. Sive novitatem queris, nihil novis exedificationibus magnificentius aut splendidius est.
Amnis vero, qui per mediam fluit urbem, difficile dictu est plusne utilitatis afferat an amenitatis. Quatuor enim ex lapide quadrato magnifice structi pontes fluvii ripas utrinque coniungunt, ita percommode inter se dimensi ut nulla celeberrimarum viarum interventu alvei abruptionem patiatur, nec minus commode per urbem incedas quam si a nullo prorsus amne esset divisa. Hinc atque hinc splendissime platee et nobilium familiarum ornatissime porticus, et semper cetibus hominum frequentia compita. Domus autem prope amnem site partim undis preterlabentibus abluuntur, partim tantum a fluvio recedunt quantum vie intermedie spatium relinquatur, qua frequentissima multitudo vel negotii obeundi vel voluptatis gratia possit incedere. Nihil est enim deambulationibus per hec loca suavius, aut meridianis si hiems sit, aut vespertinis si estas.
Sed quid ego in uno aliquo urbis loco occupatus sum? Quid iuxta fluvii ripas ceu piscator quidam obversor? Quasi vero hec duntaxat regio splendida sit, ac non universe totius urbis partes simili aut etiam maiori pulchritudine niteant! Quid est in toto orbe tam splendidum aut tam magnificum quod cum edificiis huius sit comparandum? Pudet me profecto ceterarum urbium, quotiens huius rei comparatio mihi venit in mentem. Ille enim, una aut summum duabus viis in tota urbe ornatis, in ceteris omnibus ita ornamentorum vacue sunt ut ab advenis conspici magnopere erubescant. In hac vero nostra nulla est via, nulla urbis regio, que non amplissimis atque ornatissimis edificiis sit referta. Que enim, Deus immortalis, domorum instructiones, que ornamenta! Quam magnus edificatorum animus in his instructionibus cernitur, quam magne eorum qui inhabitant delitie! Inter cetera tamen urbis edificia augustiori quadam amplitudine ac magnificentia prestant sacra tempia atque delubra, que frequentissime per urbem sparsa ac distributa, ut divina decet loca, mira a suis queque tribubus coluntur pietate, mira religione observantur. Itaque nihil est illis ditius, nihil ornatius, nihil magnificentius. Non enim profana tantum loca cure fuit ornare, verum etiam sacra; nec modo viventium habitacula preclara esse voluerunt, verum etiam defunctorum sepulcra.
Sed redeo ad privatorum domos, que ad delitias, ad amplitudinem, ad honestatem maximeque ad magnificentiam instructe, excogitate, edificate sunt. Quid potest esse pulchrius aut amenius, quam cernere domorum vestibula, atria, pavimenta, triclinia ceteraque domorum penetralia? Intueri laxitatem edium multitudinis capacem! Intueri proiecta, fornices, laquearia, tecta supra modum ornata, et, quod in plerisque domibus est, estiva habitacula ab hibernis divisa! Ad hec vero preclara cubicula, ditissimam supellectilem, aurum, argentum, stragulam vestem pretiosaque peristromata!
Sedne ego stultus sum qui hec enumerare aggrediar? Non mihi si centum lingue sint, oraque centum, ferrea vox1, omnem magnificentiam, ornatum, gazam, delitias, nitorem possem ostendere. Sed si quis ea nosse cupit, huc accedat, urbem peragret; nec velut festinus hospes aut citatus viator pertranseat, sed insistat, inquirat, contempletur. Nam ceterarum quidem urbium valde interest ne quis in ea peregrinus trahat moram diutius. Nam si quid ornamenti habent, id quidem omne in propatulo est atque in primo, ut ita dicam, cortice, quod simul atque urbem ingressi sunt advene homines intueantur. At si celebriora loca relinquant, si non domorum cortices sed medullas perscrutentur, nihil erit quod ei quam ante conceperant opinioni respondeat: pro domibus enim edicule sunt, proque externo decore interne sordes. Florentia vero nisi intus inspiciatur, omnis eius pulchritudo cognosci non potest. Itaque quod aliis damnum existimationis affert, huic summe auget existimationem. Non enim intra parietes minus ornamenti aut magnificentie habet quam extra; nec una aut altera via decora aut nitida est, sed universe totius urbis partes. Nam velut sanguis per universum corpus, sic ornamenta delitieque per universam urbem diffuse sunt.
Per media vero edificia superbissima insurgit arx ingenti pulchritudine miroque apparatu, que ipso aspectu facile declarat cuius rei gratia sit constituta. Ut enim in magna classe pretoria navis eiusmodi esse solet ut facile appareat in illa vectari ducem qui ceterorum sit moderator et princeps, sic huius arcis ea species est ut quivis iudicare possit in ea habitare viros qui gubernatores sint rerum publicarum. Sic enim magnifice instructa est, sic precelsa insurgit, ut omnibus que circa sunt edibus latissime dominetur, appareatque eius plus quam privatum fastigium. Quamquam vereor equidem ne hec simpliciter «arx», verum «arx arcis» appellari debeat.
Tam multa enim, statim atque menibus extuleris pedem, undique tibi occurrunt edificia, ut illa quidem «urbs», hec autem que menibus cingitur rectius «arx» appellanda videatur. Quemadmodum enim de nive scribit Homerus2: illam celitus delapsam montes occupare et colles iugaque montium et pinguia culta, ita hec extra urbem edificia universos circum montes collesque et planitiem occupant, ut potius e celo delapsa quam manu hominum facta videantur. At quanta horum edificiorum magnificentia est, quantum decus, quantus ornatus! Sunt enim ampliora etiam quam urbana, utpote latioribus in locis constituta et maiori cum licentia ad delectationem amenitatemque edificata. Quamobrem nemo in his laxitatem requirit, nemo porticum, nemo hortos, nemo viridaria. Nam quid ego de cubiculis aut tricliniis loquar, quibus nihil est magnificentius aut ornatius? Inter hec vero frondosi luci, florida prata, letissimi rivi, nitidissimi fontes et, quod omnia superat, natura ipsa locorum ad letitiam nata. Videntur enim colles ipsi ridere et quandam a se diffundere iocunditatem, qua intuentes expleri non possunt nec videndo satiari: ut universa hec regio paradisus quidam recte haberi et nominari queat, cui nihil vel ad pulchritudinem vel ad letitiam in toto orbe sit par. Obstupescunt certe homines qui Florentiam adveniunt, cum procul ex aliquo montis vertice tantam molem urbis, tantam amplitudinem, tantum ornatum, tantam frequentiam villarum conspicantur. Nec vero procul conspecta speciosa sunt, cum autem te illis admiscueris sordescunt, quod in non vera pulchritudine evenire solet. Sed ita omnia comparata sunt, ita non simulato nitent decore, ut, quanto propius intueare, tantum magnificentie tibi crescat opinio. Quare et ville longinquos aspectus, et suburbia villas, et urbs ipsa suburbia pulchritudine vincit. Quam cum ingressi sunt advene, iam externi nitoris ornatusque obliti tantum splendorem urbis velut attoniti admirantur.
Volo preterea unum narrare quod mihi in primis argumentum videri solet magnitudinis huius urbis ostendende. Gessit hec civitas complurima bella, contra potentissimos hostes reluctata est. Stravit crescentes et formidolosas potentias. Consilio, opibus, magnitudine animorum eos superavit quibus nec par quidem fore nec resistere posse ullo pacto credebatur. Nuperrime vero adversus potentissimum et opulentissimum hostem ita summa vi per multos annos contendit ut omnium mentes in admirationem converteret3. Eum enim ducem, cuius opes atque potentiam et Transalpine gentes et reliqua omnis formidabat Italia, spe elatum, victoriis exultantem omniaque miro successu quasi tempestatem quandam occupantem, hec una civitas inventa est que non solum invadentem reprimeret cursumque victoriarum retardaret, verum etiam post longum bellum affligeret. Sed de rebus quidem ab hac urbe gestis paulo post erit tempus facultasque dicendi; nunc autem quod intendimus agamus.
Dico igitur omnes homines sic esse admiratos magnitudinem contentionis et diuturnitatem belli, ut secum ipsi obstupescerent unde huic uni civitati tante vires, tante opes, tante ad bellum suppeditarent pecunie. Sed hec tanta admiratio, hic tantus stupor, tam diu apud homines est quam diu hanc pulcherrimam urbem non aspexerunt neque viderunt eius magnificentiam. Ceterum ubi illam intuiti sunt, omnis talis evanescit abitque admiratio. Videmus hoc quidem inter omnes constare, nec ullus Florentiam advenit qui non id sibi evenisse fateatur. Nam simul atque urbem conspicati sunt, cum occurrat oculis tanta moles rerum, tanta edificiorum collatio, tanta magnifì centia, tantus splendor, cum precelsas turres, cum marmorea tempia, cum basilicarum fastigia, cum superbissimas domos, cum turrita menia, cum villarum multitudinem, cum delitias, nitorem, ornatum intuentur: illico omnium mentes animique ita mutantur ut non iam de maximis atque amplissimis rebus ab hac urbe gestis obstupescant, sed potius sufficientem autument ad totius orbis dominium imperiumque adipiscendum. Ex quo intelligi potest maxime admirabilem esse hanc urbem, de cuius pulchritudine ac magnifì centia nemo satis digne vel concipere animo vel enarrare verbis potest. Sed tantum audita a visu superantur, quantum ab auditis vincebatur opinio.
Equidem nescio quid ceteri existiment, sed mihi ita perurgens videri solet eiusmodi argumentum ut vel hoc uno abunde putem huiusce urbis incredibilem quandam prestantiam confirmari posse. Neque enim illa tanta et tam communis admiratio ita facile, visa urbe, ex animo deieri et extirpari posset, nisi esset in ipsa urbe vis quedam maior ingenuitatis atque decoris, que illum animi stuporem pre magnitudine rerum gestarum conceptum non attenuaret modo, verum etiam obrueret. Velut enim si quis mihi narret inaudita quedam et incredibilia virium facinora a pugile quodam in certaminibus edita; si alios pugno contritos, alios cestu prostratos ab eo predicet; si multos ab uno victos ac precipites datos, si citatas quadrigas stetisse aut vivum taurum per stadium tulisse, quod Milo Crotoniates fecisse dicitur4, aut, cum in uncto staret clipeo, nullius vi depelli potuisse, quod a Polidamante factum legimus5; et deinde mihi super his rebus obstupescenti addat hec quidem audita incredibilia videri, ceterum si quis hominem videat contempleturque corporis robur, fore ut non amplius quisquam admiretur, sed et hec que narrata sunt et maiora etiam eum facere posse confidat; hec, inquam, si quis mihi narret affirmetque, continuo mihi fortissimi viri imago succurrat necesse est, que generosam quandam habitudinem corporis et membrorum letitiam roburque ostentet. Sic, cum hec prestantissima et ornatissima urbs omnem admirationem de se conceptam, simul atque visa est, continuo expellat in contrariumque mentes hominum reformet, necesse est infì nitam quandam vim magnificentie, ornamentorum opulentieque in se habere. Quid enim aliud dici potest in tam manifesta mutatione mentis, sententiarum, opinionum, quam esse tantam huius urbis amplitudinem ac maiestatem quantam nec lingue narrantium significare poterant nec mentes audientium concipere? Nam laudant illam quidem laudabuntque semper omnes; nullus tamen inventus est cui, cum eam cerneret, non multo preclarior quam audiens sibi finxerat videretur. Itaque non vereor equidem quin permulti sint qui me temeritatis audacieque condemnent, qui eiusmodi rem fuerim aggressus. Sed neque ego poteram tam inclitam urbem aspiciens non admirari neque admirans laudes eius reticere. Quod si eam non assequor, quam nulli unquam assequi valuerunt, ignosci mihi quam succenseri equius est. Sed iam ad rem redeamus.
Post villas autem castella sunt. Castella autem, imo vero nihil est ex omni illa regione que villas cingit, que non splendidissimis ac celeberrimis referta sit oppidis. Urbs autem media est tanquam antistes quedam ac dominatrix; illa vero circum adstant, suo queque loco constituta. Et lunam a stellis circumdari poeta recte diceret quispiam; fitque ex eo res pulcherrima visu. Quemadmodum enim in clipeo, circulis sese ad invicem includentibus, intimus orbis in umbelicum desinit, qui medius est totius clipei loeus: eodem hic itidem modo videmus regiones quasi circulos quosdam ad invicem clausas ac circunfusas. Quarum urbs quidem prima est, quasi umbelicus quidam totius ambitus media. Hec autem menibus cingitur atque suburbiis. Suburbia rursus ville circumdant, villas autem oppida; atque hec omnis extrema regio maiore ambitu circuloque complectitur. Inter oppida vero castella sunt arcesque in celum minantes et agricolarum tutissima refugia.
Multitudo autem incolarum tanta est ut omnes saltus facillime compleantur. Quid dicam de suavitate atque abundatia fructuum? Quid de agrorum splendidissima cultura? Hec quidem omnibus nota sunt et ante oculos exposita, nec demonstratione ulla indigent. Hoc tantum dico: non facile reperiri posse agrum qui tantam multitudinem incolentium nutriat. Neque enim plereque urbes tam frequentes habitatores habent, quam florentinus ager. Hos tamen omnes una cum populosissima urbe ita pascit ut non modo ad victum, sed ne ad delitias quidem externi cuiusquam indigeat auxilii. Quamobrem urbs quidem ipsa talis est, vel intra menia vel extra, ut nulla beatior sit existimanda.
Quod si quis est qui propterea deesse aliquid huic urbi arbitretur quod maritima non sit, is meo iudicio longissime errat et quod laudare debet id in vitium vertit. Est enim maris vicinia vendendis comparandisque rebus forsitan utilis, ceterum salsa atque amara nimis. Permulta sunt quippe incommoda quibus maritime urbes obnoxie sunt, permulta pericula quibus subiacere habent necesse. Plato atheniensis, omnium philosophorum longissime princeps, cum civitatem que bene ac beate viveret in suis libris institueret et que adesse queve abesse oporteret diligentissime perquireret, in primis quidem illud censuit ut procul a mari esset remota6. Nec putavit sapientissimus vir eam urbem ullo modo beatam esse posse que aut in litore posita foret aut maris fluctibus esset propinqua. Narrat multas clades, multa ad beate vivendum impedimenta que maris porrigit affertque vicinia. Et profecto si recte considerare volumus, pergrave quiddam est urbem eo in loco esse positam, ut a Tanai atque Tribisonda Gades adusque sit pertimescendum; ubi non solum quid vicine agant gentes, quid finitimi populi consilii capiant, quid moliantur, quemadmodum erga nos fuerint animati perscrutari sat est et eorum vel latentes insidias vel apertos impetus cavere, sed Egiptii, Phenices, Colchi, Scyte, Mauri, Gaditani, barbare et maxime inter se disiuncte nationes, sunt formidande. Atqui finitimarum gentium Consilia nonnunquam fallunt: quid facient igitur longinquarum? Terrestres impetus, qui tardiores esse solent, nonnunquam prius assunt quam quicquam tale potuerit presentiri: quid igitur a celeritate classium est expectandum? Non enim si hec in presenti non fiunt, ideo sperare possumus aliquando non fore; et fuisse olim certissime scimus. Est autem perstultum, cum secure tranquilleque possis degere, te ipsum sponte periculis obiectare.
Quodsi rationes minime istos movent qui fluctus ac litora tantopere amant, atne antiquitatis etiam commovebunt exempla? Lege latinas, lege grecas historias, et in his animadverte quam multi sint casus, quam crebra excidia urbium maritimarum, quam multe civitates, cum florerent opibus, viris, pecuniis, a classe hostium prius fuerint capte quam quicquam tale potuerint suspicari. Hec si illi reputabunt, iam incipient credere nihil huic urbi deesse quod maritima non sit, sed contra, ut cetera omnia, ita et hoc summa providentia factum. Troia, nobilissimum totius «Asie culmen et celitum», ut inquit ille7 «egregius labor», bis classe capta et diruta est; primo Herculis et Telamonis repentino adventu, secundo Agamemnonis et Ulixis fraude. Capi florentissima civitas nullo modo poterat, nisi vicinum mare prebuisset facultatem. Decennium terrestribus preliis frustra erat consumptum. Ad classem denique atque undas decursum est, aptissimam ad insidias tendendas materiam; et curn cives se diuturna obsidione liberatos arbitrarentur, cum nihil hostile usquam appareret, nihil suspicarentur, «at Argiva phalanx instructis navibus ibat a Tenedo tacite per amica silentia lune»8. Et paulo post: «Alii rapiunt incensa feruntque Pergama; vos celsis nunc primum a navibus iris?»9. Hec sunt maris premia, hec laudanda propinquitas!
Sed quid ego tam longinqua commemoro? Genuam, nobilissimam Italie urbem, secundo bello Punico a Magone, Hamilcaris filio, ex improviso captam et ad solum dirutam legimus. Quid Phocensium eversionem commemorem? Quid Syracusarum? Quid Alexandrie? Quid Athenarum?10 Quid, populo romano maxime fiorente et orbi terrarum imperante, nonne ita per multos annos a predatoriis classibus infestatum est mare ut complures populi romani urbes extremam cladem paterentur? Nec is populus, qui totum subegerat orbem, a classium incursionibus maritimas urbes valuit illesas prestare. Adde crassitatem aeris, adde inconstantiam celi, adde pallentes morbos, id est insalubritatem litoree plage et totius maritime confinitatis inclementiam. In his tot tantisque adversis rebus minime mirandum est si prudentissima urbs effugit portum, ut se tranquilitatis conferret in portum, et maris fluctibus maluit carere quam tot tantisque fluctibus subiacere.
Quid autem si ne portu quidem caret? Quamquam vereor quomodo hoc quis sit accepturus, sed tamen dicam quod sentio. Ut enim cetera omnia, ita et hoc summa providentia optimoque Consilio factum ab hac urbe videtur. Nam cum a litore tantum remota sit ut omnium illarum calamitatum quas maris propinquitas affert omnino sit expers, ita tamen portubus vicina est ut nulla maris militate privetur. Itaque in his dumtaxat rebus a maritimis urbibus Florentia superatur in quibus vinci Victoria est. Illis enim portus ac litora non nullam sane prebent utilitatem, sed tamen eam ipsam multis implicitam calamitatibus multisque permixtam molestiis; Florentia vero ita propinquo fruitur mari ut puram ex illo capiat utilitatem, nullis adversis rebus perturbatam nullisque calamitatibus imminutam. Nihil ex hac commoditate pestilens celum, nihil crassus atque impurus aer, nihil undarum humiditas, nihil autumnales perturbant ac detrahunt morbi; sed tota illa quantumcunque est pura ac minime periculosa minimeque infecta utilitas est.
Mihi vero solet videri illa etiam de causa ab infero mari Florentia recessisse, ut superi quoque maris opportunitatem haberet: quod quidem consilium satis laudari non potest. Nam si in alterutro litore constitisset, preterquam quod multis variisque molestiis propter maris adherentiam premeretur, illud etiam accederet incommodum quod nimis ab altero esset remota; ex quo illud fieret, ut in duobus extremis eodem tempore peccaret, vel longinquitate nimia vel propinquitate. Nunc autem sic ab utroque litore remota est ut non altero ipsorum videatur fuisse contenta, sed utrunque simul in suos usus convertere voluisse. Sedet enim media inter Tyrrenum et Adriaticum mare quasi regina quedam Italie, purissimo ac saluberrimo celo constituta nec planitiei nec montis expers. Hinc apricissimi campi, illinc letissimi insurgunt colles. Amnis vero per media fluens menia, cum maximo est ornamento, tum multo maiori utilitati. In ipsa vero urbe mirande lautitie, incomparabilis nitor, stupendi ornatus, summa omnium rerum 0magnificentia est; villarum autem immense inauditeque delitie, amenitas vero plus quam terrena, omnia piena letitie, piena suavitatis, piena decoris. His tot tantisque bonis ornamentisque referta, non solum Italie sed omnium provinciarum urbes longissime antecellit.
Verum pulcherrimarum rerum affluentia, et dives ac semper sponte sua se offerens ad dicendum materia, impetu quodam et violentia huc usque me rapuit, nec ullam consistendi prebuit facultatem. Et forsitan parum diserte facere visus sum, qui de ornamentis huius urbis disserens ea que sunt prima ac maxima ornamenta pretermiserim. In cetero enim splendore ac magnifì centia huius inclite urbis referenda occupatus, quasi oblitus mei, de multitudine populi, de virorum copia, de virtute, industria, humanitate civium dicere effugerat, que maxima quidem ornamenta sunt in primisque memoranda. Redeundum est igitur unde exieram, et his, qui hanc incolunt urbem, partes suas reddendum. Quin potius quod errore factum est id nos ad oratoriam reducamus; et aliquando nos ipsos colligamus, despiciamusque de quibus rebus iam dictum est de quibusve deinceps simus dicturi, ne diutius in hoc errore versemur. Qualis igitur urbs ipsa sit, demonstratum est. Nunc, cuiusmodi habitatores eius sint, consideremus. Volumus igitur, ut in privatis hominibus fieri solet, ita et hunc populum ab initio inspicere, et quibus parentibus ortus sit, queve eius per omnem etatem fuerint opera domi forisque, considerare. «Sic opinor; a principio» ut inquit Cicero «ordiamur»11.
Unde igitur huic populo genus est? Qui fuerunt eius parentes? A quibus mortalibus hec inclita urbs fondata est? Cognoscite, viri florentini, cognoscite stirpem ac prosapiam vestram! Reputate quam omnium gentium sitis clarissimi! Ceteri enim populi aut profugos aut extorres patriis sedibus aut agrestes aut convenas obscuros atque incertos habent auctores. Vobis autem populus romanus, orbis terrarum victor dominusque, est auctor. O Deus immortalis, tantane in hanc unam urbem bona contulisse, ut omnia que ubique sunt queve optare fas est ad eius ornamenta convenisse videantur!
Nam quanti hoc primum est, ut a populo romano Fiorentinorum genus sit ortum! Que gens in toto orbe clarior, que potentior, que omni genere virtutis prestantior populo romano unquam fuit? Res geste cuius adeo illustres sunt ut maxima ceterorum hominum facta pre illorum magnitudine pueriles ludi videantur; cuius imperium, terris adequatum, ita summa ratione per multa secula gubernatum est ut plura ex illa una urbe extent virtutis exempla, quam omnes cetere res publice omni tempore ediderint; in qua innumerabiles viri ita eximia virtute extiterunt, ut nulli unquam in terris fuerint pares. Nam, ut ceteros omittam summos ac prestantissimos duces et senati principes, ubi tu gentium Publicolas, ubi Fabritios, ubi Corruncanos, ubi Dentatos, ubi Fabios, ubi Decios, ubi Camillos, ubi Paulos, Marcellos, Scipiones, Catones, Gracchos, Torquatos, Cicerones extra urbem romanam invenies? Atqui si nobilitatem in auctore queris, nihil in toto orbe terrarum nobilius populo romano poteris invenire; si divitias, nihil opulentius; si amplitudinem ac magnificentiam, nihil omnino clarius neque gloriosius; si magnitudinem imperii, nihil intra Oceanum est quod non armis subactum in eius fuerit potestate. Quamobrem ad vos quoque, viri fiorentini, dominium orbis terrarum iure quodam hereditario ceu paternarum rerum possessio pertinet.
Ex quo etiam illud fit, ut omnia bella que a populo fiorentino geruntur iustissima sint, nec possit hic populus in gerendis bellis iustitia carere, cum omnia bella pro suarum rerum vel defensione vel recuperatione gerat necesse est, que duo bellorum genera omnes leges omniaque iura permittunt. Quod si parentum gloria, nobilitas, virtus, amplitudo, magnificentia filios quoque illustrat, nihil est in toto orbe quod Florentinorum dignitati possit preferri, quandoquidem ex huiusmodi parentibus nati sunt qui omni genere laudis cunctos mortales longissime antecellunt. Quis enim est hominum qui se a populo romano non fateatur servatum? Quis autem servus vel libertus cum domini vel patroni liberis de dignitate contendat, aut se preferendum censeat? Non parum igitur ornamenti est huic urbi, tam claros ipsius ac sue gentis conditores auctoresque habuisse.
At quo in tempore Florentinorum gens a Romanis est orta? Hoc enim plurimum arbitror referre, quod et in regiis successionibus observari aiunt ut is tandem regis filius recte appelletur qui eo tempore natus sit quo eius parens regiam habuerit dignitatem; qui autem vel ante vel postea nati sunt, eos neque regis filios esse nec in regno paterno successionem habere. Et profecto, ut quisque maxime floret maximeque sublimis est, ita maxime preclara opera maximeque egregia molitur. Videntur enim ipse secunde res, nescio quo pacto, animos tollere ingentesque spiritus adhibere, ut nihil nisi altum atque magnificum amplissimi viri queant moliri, et que eo tempore fiant ea maxime prestare contingat.
Hec igitur splendidissima Romanorum colonia eo maxime tempore deducta est quo populi romani imperium maxime florebat, quo potentissimi reges et bellicosissime gentes armis ac virtute domite erant: Carthago, Numantia, Corinthus a stirpe interierant; omnes terre mariaque omnia in potestatem eius populi venerant; nihil calamitatis populo romano ab ullis hostibus inflictum erat. Nondum Cesares, Antonii, Tiberii, Nerones, pestes atque exitia rei publice, libertatem sustulerant. Sed vigebat sancta et inconcussa libertas, que tamen, non multo post hanc coloniam deductam, a sceleratissimis latronibus sublata est. Ex quo illud evenire arbitror, quod in hac civitate egregie preter ceteras et fuisse et esse videmus: ut fiorentini homines maxime omnium libertate gaudeant et tyrannorum valde sint inimici. Tantum, ut opinor, odii adversus invasores imperii et rei publice eversores iam ex illo tempore Florentia concepit ut nec hodie quidem videatur oblita; sed si quod illorum vel nomen vel vestigium adhuc superest id hec res publica dedignatur et odit.
Non sunt nova in florentino populo hec partium studia, nec nuper, ut quidam arbitrantur, incepit: altius hec concertatio suscepta est. Cum nefarii homines, per summum scelus rem publicam adorti, populi romani libertatem, splendorem dignitatemque sustulere, tunc hoc ardore incensi, tunc hec concertatio atque hec partium studia a Florentinis suscepta, que ad hanc diem constantissime retinent. Nec si alio atque alio nomine diversis temporibus he partes appellate sunt, ideo tamen diverse fuere. Sed una fuit semper atque eadem causa contra invasores imperii, ab initio suscepta et usque ad hec tempora constantissime conservata. Iustum, me hercule, odium et antique patrie plus quam debita pietas! Quis enim ferat Romanorum imperium, tanta virtute partum, quanta Camillus, Publicola, Fabritius, Curius, Fabius, Regulus, Scipiones, Marcellus, Catones aliique innumerabiles sanctissimi et continentissimi viri prestitere, id in C. Caligule aut eiusmodi immanium ac scelestium tyrannorum manus nutumque pervenisse, quibus nulla virtus, nulla a vitiis redemptio? Unum dumtaxat, et id quidem summum, erat illis certamen, quo totis viribus inter se contendebant.
Ita enim in trucidandis civibus romanis omni crudelitatis genere intenti erant, quasi summum premium fuisset expositum si in ea urbe nullam nobilitatem, nullum ingenium, nullum omnino civem reliquissent. Itaque C. Caligula, cum tantam fecisset stragem quantam potuisset maximam, innumeri tamen cives, ut in magna urbe, superessent, fessus iam necando ac trucidando, cum satiare crudelitatem animi nullo modo posset, nefariam illam emisit vocem que testis esset sue immanitatis: «O utinam, inquit, populus romanus unam cervicem haberet, quam uno ictu possem avellere!»12 Et piane ita fecit. Nunquam enim sanguine civium satiatus est, vacuefecissetque omnino urbem si paulo longior ei vita fuisset. Adactus est gladius per senatorium ordinem, trucidati clarissimi atque optimi cives, consulares et triumphales familie funditus delete, plebs duntaxat in urbe relicta, quam tamen quotidianis cedibus veluti pecora turmatim concidebat. Huic immanissime crudelitati immaniora etiam flagitia adiungebat, non vulgaria illa quidem neque usitata, sed omni seculo inaudita et nunquam sine detestatione memoranda. Tres ab illo sorores per ordinem stuprate et pro concubinis palam habite. Hicine imperatores, hi preclari Cesares, quos non nulli homines laudandos putant! Que flagitia sunt hec, que monstra hominum! Pro quibus quidem rebus quis mirabitur si hec civitas tantum odii adversus eas partes concepit ut etiam ad hec tempora conservet?
Nam que indignatio unquam iustior? Aut quem magis tangebat iste dolor quam florentinum populum, cum cerneret populum romanum, parentem atque auctorem suum, qui paulo ante omnibus terris summa virtute domitis imperabat, tunc adempta libertate propria a facinorosissimis hominibus crudelissime lacerari, qui, si re publica valeret, in ultima fece civitatis fuissent? Quid autem Tiberius Cesar? Quamquam is ante Caligulam regnavit. Sed minime per ordinem referendi sunt in quibus neque ordo neque ratio ulla fuit. Quid enim tetrius, quid flagitiosius usquam visum aut auditum est quam aut Tiberii crudelitates in torquendis ac necandis civibus romanis apud Capream expresse, aut eiusdem imperatoris pisciculi atque spintrie, nefanda et inaudita libidinum genera13, ut mihi quidem pudor Italie videatur talia flagitiorum exempla aliquando in ea extitisse? At si hi teterrimi et pernitiosi, tamen qui postea secuti sunt meliores fuere? Quinam isti? Nero scilicet et Vitellius et Domitianus et Heliogabalus? Ita profecto. Neque enim dictu facile est quante virtutis quanteve humanitatis fuerit Nero. Agrippina mater pietatem filii miris laudibus in celum tollit; nec qui tanta pietate in matrem fuerit in alios fuisse impius aut inhumanus putandus est; qui etiam, ne cives frigore lederentur, misericordia ductus urbem ipsam incendit.
O Cai Cesar, quam piane tua facinora romanam urbem evertere! Sed comprimami ipse me. Sunt enim qui Lucanum, doctissimum et sapientissimum hominem, vera de te scripsisse permoleste ferant. Nec fortasse carent ratione: etsi enim multa ac magna in te vitia erant, multis tamen ac magnis virtutibus obumbrabantur. Quamobrem de te silere tutius erit. Et simul filium tuum eadem illa ratione preteribo; quamquam non ignoramus, cuius tu rei gratia ut illum adoptares allectus es. Sed totum pretereo, neque eius laxam crudelitatem nec proscriptiones cedesque innocentium civium neque proditionem senatus neque adulteria stupraque eius memorabo. Fuerunt enim in illo, ut in patre quoque fuerant, vestigia quedam virtutum que vitia quoque tolerabiliora faciebant. At hec monstra, quibus imperium tradidistis, nulla virtute redempta erant a vitiis, nisi forte virtus est omni conatu rem publicam delere nec ullo flagitio quantumvis maximo abstinere. Quare etsi cetera vestra obliviscar, illud tamen neque oblivisci neque ut vobis non succenseam adduci possum, quod viam tantis malis tantisque sceleribus patefecistis, quanta successores vestri omni genere impietatis nequitieque ediderunt.
Sed quorsum hec? Dicet fortasse quispiam. Utriusque videlicet gratia: primum, ut ostenderem non iniuste hanc civitatem eiusmodi partes suscepisse; et simul intelligeretur eo tempore hanc coloniam deductam fuisse quo urbs romana potentia, libertate, ingeniis, clarissimis civibus maxime florebat. Nam posteaquam res publica in unius potestatem deducta est, preclara illa ingenia, ut inquit Cornelius14, abiere: ut plurimum intersit tunc an inferiori tempore colonia hec fuerit deducta, cum ita iam omnis virtus ac nobilitas romane urbis extirpata erat ut nihil preclarum neque egregium qui ex ea migrabant secum possent efferre.
Nunc vero, cum Florentia eiusmodi habeat auctores, quibus omnia que ubique sunt virtute atque armis domita paruerint, et cum eo tempore deducta sit quo populus romanus liber atque incolumis potentia, nobilitate, virtute, ingeniis maxime florebat, a nullo profecto dubitari potest, quin hec una urbs non solum pulchritudine et ornatu et opportunitate loci, ut videmus, sed etiam dignitate et nobilitate generis plurimum prestet. Sed iam ad reliqua pergamus.
Ab his igitur parentibus orta, civitas non socordia atque ignavia se corrumpi passa est, nec paterna vel avita gloria contenta molliter tranquilleque vitam agere decrevit, sed, quanto clariori loco nata esset, tanto maiora a se exigi ac postulari putans, ita auctores suos omni genere virtutis imitata est ut omnium iudicio haud indignam se prestiterit tanto nomine tantaque successione.
Neque enim prius certare destitit, quam se antistitem quandam Italie prestitit. Eamque amplitudinem atque gloriam adepta est non sedendo atque oscitando, nec rursus sceleribus accinta et fraudibus, sed magnitudine consilii, susceptione periculorum, fide, integritate, continentia maximeque tenuiorum causa patrocinioque suscepto. Neque enim divitiis solum prestare studuit, sed multo magis industria atque magnificentia; nec potentia tantum superare pulchrum duxit, quantum iustitia atque humanitate. His illa artibus de principatu certavit, his auctoritatem gloriamque nacta est. Quibus nisi uteretur, se piane a maiorum suorum virtutibus degenerare intelligebat, nec sibi nobilitatem parentum plus honori esse quam oneri, sapienter id quidem ac verissime cogitans. Nam dignitas et amplitudo maiorum ita demum filios quoque illustrat, cum illi sua quoque nitent virtute. Enimvero si ignavi sint vel dissoluti vel alio modo a virtute degeneres, maiorum splendor non tam vitia eorum tegit, quam detegit. Nihil enim sinit esse occultum paterne glorie lumen, convertitque omnium oculos expectatio et quasi repetitio hereditarie virtutis; que spes si fallat, ob claritatem quidem generis non tam nobiles illi fiunt quam noti. Sed quemadmodum maiorum amplitudo minime eis prodest qui degeneres sunt, sic, cum generosos successorum animos nacta est, quasi multiplicato lumine vehementer illustrat. Augetur enim dignitas et gratia, tollunturque in celum homines cum in uno eodemque loco et propria virtus et maiorum nobilitas conglutinata perpenditur. Quod quidem videmus huic civitati contingere, cuius et clarissime res geste et permulta ac maxima virtutis extant exempla, in quibus romana illa virtus et magnitudo animi perfacile recognoscitur. Quare cum ob generis claritatem prestantiamque decoratur, tum multo magis ob proprias virtutes propriasque res gestas.
Sed de generis quidem claritate satis, ut opinor, dictum est, quanquam id latius per se ipsum patet. De virtute autem urbis, id est qualis ipsa foris domique fuerit, restabat dicendum; quod faciam equidem brevissime. Neque enim historiarum descriptionem presens oratio patitur. Loca igitur tantum perstringam. Sed antequam ad rem veniam, optimum simul ac necessarium mihi visum est aliquid prefari ac premonere, ne quis falsa opinione ductus me aut impudentie aut inscitie condemnet: quorum alterum stultitie crimen est, alterum levitatis, utrunque vero pariter fugiendum.
Non dubito igitur quin non nullis stultis hominibus suspectus sim, ne gratiam quandam popularem ex hac mea laudatione captare velim et, dum benivolentiam inire cupio et mentes hominum quam maxime conciliare mihi studeo, terminos veritatis longe sim pretergressus falsaque cum veris ornandi causa miscuerim. Qui mihi docendi sunt, vel potius dedocendi, ut hec putare desinant et omnem eiusmodi suspitionem deponant. Ego enim, etsi cupio me carum acceptumque omnibus esse, quod quidem me piane gliscere atque optare profì teor, non tamen unquam adductus sum ut blanditiis atque assentando id consequi vellem. Virtute equidem semper putavi carum esse oportere, non vitiis; nec ex hac laudatione gratiam ullam expecto neque expostulo. Perstultus quippe essem, si ex hac tantula re numerosissimi populi gratiam comparare mihi posse existimarem.
Sed ego, cum hanc pulcherrimam urbem viderem, cum eius prestantiam, ornatum, nobilitatem, delitias, gloriam magnopere admirarer, temptare volui possemne dicendo tantam pulchritudinem ac magnificentiam explicare. Hec scribendi causa fuit, non benivolentie aucupatio nec captatio popularis aure. Tantum autem abest ut gratie conciliande causa hoc negotium susceperim, ut semper arbitratus sim preclare mecum agi si non plus malivolentie ex hac laudatione adversus me contraheretur. Periculum enim videbatur ne omnes eos, qui hanc rem publicam florere dolent, propter eam rem haberem infensos, nec id quidem etiam nunc vereri desino. Iam omnes invidi, omnes adversarii, omnes qui vexati, fracti, superati, aut ipsi aut maiores sui, ab hac civitate unquam fuerunt, omnes, inquam, huiusmodi homines hec mea laudatio mihi faciet inimicos: ut valde equidem verear ne magnum onus malivolentie mihi sit subeundum. Sed proferam conditionem, quam nemo iuste repudiare queat. Si aliquid false aut cupide aut petulanter dixero, iure mihi infesti inimicique sunto. Sin autem vera erunt que loquar, et in his ipsis dicendis moderationem quandam servabo, ne illi mihi irascantur. Quid hac conditione potest dici equius? Quis usque adeo perversus atque iniquus est ut succensendum mihi putet quod suis ac veris laudibus civitatem ornare cupio?
Ex omnibus igitur predictis intelligi potest me neque gratia ad scribendum adductum, nec esse omnino aliquem qui mihi iuste queat irasci. Sed cum tam varia sint ingenia hominum, non ambigo equidem quin permulti inveniantur apud quos rationes mee parum roboris sint habiture. Aliis quidem enim odiosa ipsa per se ac molesta est veritas; alii vero, sive malignitate nature sive ignoratione rerum, nihil verum esse volunt nisi quod ipsis fuerit gratum. Hi me vanitatis insimulabunt et nihil sinceri scripsisse calumniabuntur. Quibus ego denuntio ne astute mecum agant, neve temere ad accusandum prosiliant, sed etiam atque etiam videant quid putent reprehendendum, maximeque illud meminerint me non privatim de singulorum civium virtute aut prestantia loqui, sed de universa re publica. Quare non, si unus atque alter in hac urbe minus probatis moribus fuere, id communiter ad calumniam civitatis referri par est, que malorum civium facta non tam sequi quam persequi ac vindicare consuevit.
Nulla unquam civitas adeo bene morata aut instituta fuit ut malorum hominum esset omnino vacua. Sed quemadmodum recte paucorum mentes stultam ac perversam multitudinem non liberant ab infamia, ita perversitas ac malitia paucorum universam rem publicam recte factorum laudibus privare non debet. Alia sunt delicta publica, alia privata, eaque inter se plurimum distant. In privatis animus agentis spectatur, in publicis universe civitatis voluntas. In qua quidem re quid unus aut alter sentiat usque adeo non attenditur, ut legibus ac moribus sancitum sit, quod maior pars populi fecerit, id quidem a tota civitate factum videri. Sed in aliis quidem populis maior pars sepe meliorem vincit; in hac autem civitate eadem semper videtur fuisse melior que maior. Quamobrem ne me illi falso accusent, neve mihi privatorum hominum facta obiciant, non magis quam aut Romanorum continentie Verrina furta, aut Atheniensium fortitudini Thersitis ignaviam15. Quod si intelligere volunt quanta sit civitatis huius prestantia, nec a me sine ratione tot verbis laudari, perscrutentur orbem terrarum et quamlibet ex eo eligant urbem, quam cum hac nostra in comparationem adducant non splendoris atque ornatus, qua in re nulla sibi in toto orbe est par, neque nobilitatis, qua in re cetere omnes sine controversia cedunt; sed rerum gestarum atque virtutis. Hoc si illi facient iam intelligere incipient quantum inter hanc urbem ceterasque intersit. Nullam enim invenient que in omni genere laudis huic nostre respondere queat.
In «omni» dixi: propius accedam. Si quam inveniunt urbem que in uno aliquo genere virtutis opinione hominum putetur excellere, in illo ipso in quo prestare dicitur periculum faciant. Nulla invenietur que vel in ipso suo genere huic non succumbat. Neque poterit ulla prorsus in ullo genere laudis inveniri par, non fide, non industria, non humanitate, non magnitudine animorum. Adducant in certamen quam velint urbem: nullius congressum Florentia reformidat. Per universum orbem querant civitatem que in una aliqua specie virtutis gloriam maximam putetur consecuta; fiat contentio egregiorum facinorum vel in eo ipso in quo videatur excellere: nullam profecto reperire quibunt, nisi ipsi piane se velint decipere, cui hec civitas non sit longe superior. Est enim admiranda huius urbis virtus, et in omni genere laudis invictum exemplar.
Nam ut prudentiam pretermittam, que omnium iudicio huic uni civitati maxima conceditur, et per quam cuncta omni tempore summa industria ab hac re publica videmus provisa, cuius unquam tanta beneficentia audita est quantam huius civitatis et fuisse et esse conspicimus? Semper enim id quidem meditata videtur, ut prodesset quam plurimis omnesque sentirent eius liberalitatem, maxime autem hi qui maxime indigerent. Itaque omnes qui aut seditionibus pulsi aut invidia deturbati patriis sedibus extorres aguntur, ii se Florentiam universi recipiunt quasi in unicum refugium tutamenque cunctorum. Nec ullus est iam in universa Italia qui non duplicem patriam se habere arbitretur: privatim propriam unusquisque suam, publice autem florentinam urbem. Ex quo quidem fit ut hec communis quedam sit patria et totius Italie certissimum asilum, ad quod omnes undique, cum sit opus, confugiunt recipiunturque cum summo incolentium favore summaque benignitate. Tantum enim studium beneficentie et humanitatis in hac re publica est, ut clara voce clamare videatur et palam omnibus attestari, ne quisquam patria se carere putet donec Florentinorum supersit urbs. Hoc benignitatis preconium facta etiam maiora quam professio sequuntur. Neque enim solum leta fronte recipiuntur, verum etiam, si non penitus indigni videantur, opibus pecuniisque adiuvantur; quibus illi freti vel manere cum dignitate, si ita malint, vel reditum sibi ad proprios penates recuperare possint. An hec vera non sunt? An quisquam malivolorum negare audebit? At sunt huius rei testes infiniti pene mortales qui, cum rei familiaris angustiis premerentur, cum iniuste suis urbibus essent eiecti, pecuniis publicis adiuti sunt et beneficio huius urbis in patrias sedes restituti.
Testes sunt etiam permulte civitates que, cum vicinorum conspiratione aut tyrannorum violentia opprimerentur, Consilio, opibus, pecuniis, sustentatè sunt et difficillimo tempore conservate. Mitto federa inter discordes populos ab hac urbe coniuncta; mitto legationes ad conciliandos animos, ubicunque ira efferbuit, demissas, qua quidem in re hec civitas suam promptissime semper interposuit auctoritatem. Potest igitur que hec tot tantaque pro alienis commodis susceperit non beneficentissima appellari? Aut satis digne pro tanta virtute meritisque laudari? Nunquam enim tulit iniurias aliarum urbium, neque otiosam spectatricem se prebuit aliene calamitatis. Sed primum omni studio conata est verbis et auctoritate rem componere inimicitiasque sedare et pacem, si fieri posset, suadere. Quod si convenire non potuit, ei semper parti opitulata est cui a potentioribus inferebatur iniuria. Sic enim imbecilles omni tempore defendit, quasi ad curam suam pertinere existimaret ne quis Italie populus excidium pateretur. Itaque non otii cupiditate nec formidine ulla potuit unquam adduci ut ad eas, quibus aliqua respublica lacesseretur, iniurias conniveret; nec putavit se in tranquillitate aut otio esse oportere, cum aliqua urbs aut socia aut amica aut saltem non inimica laboraret. Sed continuo exurgens et causas aliarum suscipiens mediam se adversus impetum opposuit, protexitque eos qui perditum iri videbantur, copiis, opibus pecuniisque adiuvit.
Quis igitur hanc pro tanta beneficentia ac liberalitate satis abunde unquam laudabit? Aut que civitas est in toto orbe, que in hoc genere laudis possit conferri? Que tot pecunias absumpserit? Tantos labores pro alienis commodis susceperit? Tam multos in periculis protexerit? Atqui que civitas in periculis alios tutatur, eam fateantur patronam necesse est. Que autem patrona sit, dignitate, potentia, industria, auctoritate precellere quis negabit?
Huic beneficentie ac liberalitati admirabilis fides coniuncta est, quam semper hec res publica summa constantia inviolatam servavit. Semper enim ita animata fuit ut putaret, antequam promitteretur, diligentissime providendum; ubi vero promissum esset, nullo modo retractandum. Quod cum a principio vidisset et ita iustum esse censuisset, ob nullam utilitatis speciem adduci unquam potuit ut pacta, conventa, federa, iusiurandum, promissa violaret. Nihil enim dignitati rei publice magis convenire arbitrata est, quam in dictis factisque omnibus observare constantiam; nihil autem alienius, quam promissa mentiri; id quidem esse facinorosorum hominum, qui maxime inimici sunt rerum publicarum. De quorum numero est ille qui ait: «Iuravi lingua, mentem iniuratam gero»16, quod iustissima civitas nunquam sibi licere putavit. Itaque in omni quidem re multa cum maturitate ad promittendum descendit; quod autem semel promisisset, id non magis a se mutari posse arbitrata est quam ea que non forent in eius potestate.
Usque autem adeo fides et integritas in hac civitate plurimum valuit, ut iura etiam hostibus religiosissime servarit, nec unquam vel in hoc genere inveniatur mentita. Ex quo factum est ut ne inimici quidem unquam dubitarint huius rei publice fidem sequi, sed etiam apud eos civitatis nomen maximam semper habuerit auctoritatem. Huius autem rei manifestissimum est argumentum quod non nulli homines, cum antea inimici eius manifestissime fuissent, liberos et fortunas suas in tutela huius populi esse voluerunt, secuti civitatis fidem atque humanitatem: quarum altera ad remittendum iniurias et suscipiendum munus promptissima videbatur, altera ad id quod suscepisset summa cum iustitia adimplendum. Nec spes eos fefellit. Nam ita res eorum summa cum diligentia administrate iis quibus debebantur restitute sunt, ut non solum non errasse putarentur qui fidem huius populi fuissent secuti, sed etiam ceteri homines allicerentur exemplo. Semper enim hec civitas cure habuit, ut suum cuique ius diligentissime tribueret et in omni re honestatem militati anteponeret; imo vero nihil utile, quod non idem honestum foret, arbitrata est.
Ex multis tamen et preclaris virtutibus, quibus hanc civitatem preditam invenio, nulla mihi neque maior neque prestabilior videri solet, neque in qua magis romanum genus virtusque recognoscatur, quam magnitudo animorum periculorumque contemptio. Nam cuius virtutis esse potest nisi romane, per omnem etatem bello contendisse et maxima quidem certamina maximasque dimicationes suscepisse, et, quod etiam rarius atque admirabilius est, in maximis periculis difficillimisque temporibus nunquam mente concidisse nec remisisse aliquid de magnitudine animorum. Cesar iratus fuit ad portas, faces atque exitium huic urbi portendens; hunc omnis inimicorum factio, stricta, parata neci, sequebatur17. Castra erant intra primum lapidem; omnia circa urbem loca ferro atque hostili clamore reboabant. Nec infestioribus signis Hannibal quondam ad Portam Collinam profectus est, quam illud tunc monstrum in florentina menia ruebat. Accedebat ad hec quod ea pars urbis, que maxime castris erat opposita, parum munita eo tempore videbatur; itaque nullus putabatur fore civis qui vel arma capere vel mente consistere valeret. At vero fortissima civitas usque adeo minas illius furoremque contempsit ut, cum ille extra urbem multos dies perbaccharetur, nusquam intra urbem sit trepidatum. Sed ita gerebantur omnia, quasi nihil pericli immineret nec ulla vis hostium esset propinqua. Omnes officine, omnia horrea per vias patebant; nulla remissio operum, nullum omnino erat iustitium. Que cum Cesari nuntiarentur, admiratus civitatis prestantiam et magnitudinem animorum, ab oppugnatione recessit.
Nec solum in resistendo fortis hec civitas fuit, sed etiam in inferenda vi, hoc est in ulciscenda iniuria, formidabilis. Nam etsi nunquam alicui nocere voluit nisi prius lacessita, tamen, ubi quid iniurie inflictum est, vehementissimam pugnatricem se prestitit pro sua dignitate. Illud enim omne tempus habuit, ut incredibili quodam amore laudis glorieque flagraret. Itaque semper res maximas et vehementer arduas aggressa est, nec in illis gerendis aut periculorum magnitudinem aut laborum formidavit. Possum commemorare munitissima oppida manu capta, innumerabilia pene trophea de finitimis populis ab hac urbe constituta, egregia rei militaris facinora edita ipso populo fiorentino exeunte atque armis fruente. Sed non est presentis temporis tot varias bellorum contentiones tantasque res gestas posse referre; proprium illa desiderant opus, et quidem magnum, quod nos, ut spero, aliquando aggrediemur et, quo pacto singula ab hoc populo gesta sunt, litteris memorieque mandabimus. In presentia vero unum aut alterum exempli gratia referemus, ut ex illis intelligi possit quanta in ceteris quoque fuerit civitatis virtus.
Vetustum est Etrurie oppidum nobileque Volterre, sed tamen ita summis montibus positum, ut vix expediti homines eo queant adire. Hanc urbem oppugnare Fiorentini aggressi sunt18. Virtus enim, durissima omnia superare consueta, neque asperitatem loci neque iniquitatem certaminis verebatur. Cohortes igitur ad ea loca deducte cum montem capessere cepissent, et oppidani a summis arcibus contra irruissent, acerrime utrinque pugnatum est. Numerus quidem bellatorum erat pene par, magnitudo autem animi et peritia pugnandi dispar, sed multum natura ipsa loci pro Vulterranis pugnabat. Cerneres illos e superiore loco non solum pilis atque gladiis ascensum prohibentes, sed etiam grandia saxa per declivia devolventes. Fiorentini autem per ipsas asperrimas rupes sursum versus annitebantur, nec ferrum nec saxa nec hostes nec asperitas ulla montis contra eorum conatum quibat resistere. Itaque superato contra vim hostium pedetentim monte, et oppidanis intra menia compulsis, ipsam quoque urbem, que munitissima erat menibus, primo impetu ceperunt. Atque hec fecit populus florentinus nullis extraneis auxiliis, sed ipse militans et pro dignitate atque gloria promptissime certans.
Sed cum ceteris hoc factum preclarum videri debet, tum ii maxime obstupescunt qui Volterras viderunt. Constat enim inter omnes nullum Italie oppidum esse munitius. Tunc autem erat refertum multis atque audacibus viris, qui pro aris atque focis acerrime pugnabant. Attamen maiori virtute superati sunt. Quis igitur non admiretur tam validissimam urbem una die captam? Quis non virtutem eorum qui ceperunt tollat in celum? Eiusmodi sunt huius civitatis res geste, huiusmodi virtus et fortitudo eius. Hac illa magnitudine animi sepe Senenses prostravit, sepe Pisanos delevit, sepe potentes hostes tyrannosque contrivit.
Illud tamen preclarum est, quod magnos labores magnasque dimicationes non tam pro sua quam pro aliorum utilitate suscepit. Hoc enim maxime convenire arbitrata est sue amplitudini sueque dignitati, si pro aliorum salute ac libertate pericula adiret multosque suo patrocinio tutaretur. Pisani, gens huic urbi male pacata, Lucenses, Florentinorum socios atque amicos, bello lacessebant19. Tandem vero, collatis signis, cum utrique dimicassent, et in eo prelio Lucensium copie fuissent delete multique capti ducerentur, Fiorentini, qui forte per id tempus in agro pistoriensi castra habebant, nuntiata amicorum clade, nequaquam mente conciderunt nec formidaverunt elatos Victoria homines. Sed relieto castro quod obsidebant, rapto post victores agmine, prius illorum aciem consecuti sunt quam Pisas se recipere potuissent; illatisque in eos signis, ita victoriam illorum commutaverunt, ut Lucenses ipsi, qui captivi ducebantur, maximum Pisanorum numerum qui a cede superfuit caperent, eosque in vinculis Lucam adducerent. Ita Florentinorum virtus Lucenses servavit, Pisanorum autem victoriam repressit, sibi vero gloriam laudemque comparavit. Sed quid magis laudet quispiam in hoc preclaro civitatis facinore? An virtutem, quod vicerunt? An magnitudinem animorum, quod victores secuti fuerunt? An beneficentiam, quod pro salute amicorum tantam contentionem subierunt? Mihi quidem tria in uno eodemque facto summe laudanda videntur. Sed nequeo singula suis laudibus prosequi; nam et vereor ne longior sim, et maiora etiam impellunt.
Non enim privatim duntaxat huic vel illi urbi benefica fuit hec civitas, sed universe simul Italie. Angusti quidem animi putavit esse pro suis duntaxat commodis sollicitudinem capere; contraque illud gloriosum, si suorum laborum fructus complurime sentirent atque caperent gentes. Que cum ita esset animata, pro incolumitate vicinarum urbium se pugilem prestitit, et quotiens vel finitima aliqua tyrannis vel avara potentia populis immineret, ita adversus eam se opposuit, ut cunctis mortalibus palam faceret sibi patrium esse pro libertate Italie dimicare. Neque ipsa quidem ita fuit animata, non autem perfecit, sed pie iusteque voluntati plurimus Dei annuit favor. Nolo nimis antiqua referre, sed ea dicam que nostra ferme vidit etas; quanquam constare video inter omnes, non semel ab hac una urbe totam Italiani a servitutis periculo fuisse liberatam. Sed nos cetera omittamus et ea que nuperrime gesta sunt consideremus.
An quisquam tam absurdus ingenio aut tam a vero devius reperiri poterit, qui non fateatur universam Italiani in potestatem Ligustini hostis perventuram fuisse, nisi hec una urbs suis viribus suoque Consilio contra illius potentiam restitisset?20 Quis enim erat in tota Italia, qui aut potentia aut industria cum ilio hoste comparari potuisset? Aut quis eius conatum pertulisset, cuius nomen ipsum cunctis mortalibus erat terrori? lam enim non Italiani solam, sed transalpinos quoque populos eius fama terrebat. Opibus, pecuniis virisque, sed multo magis Consilio astuque valebat. Potentiam habebat maximam atque formidandam: omnes Gallie cisalpine tractus, omnes ferme civitates que ab Alpibus ad Etruriam atque Flaminiam inter duo maria continentur, in eius potestate erant dictoque parebant; in Etruria vero Pisas, Senas, Perusiam, Assisium tenebat, tandem etiam Bononiam occuparat. Multa preterea oppida, multi potentes ac domi nobiles, seu metu seu rapinarum spe seu etiam fraude adducti, nomen fortunasque illius sequebantur. His tantis tamque amplis opibus Consilia non deerant. Sed felix ille, felix inquam, nimium esse potuit, si suam industriam, vigilantiam, solertiam in bonis artibus exercuisset. Nullo unquam in homine callidiora Consilia neque acriora. Omnibus in locis aderat, nihil integrum esse sinebat, nihil intentatum relinquebat. Alios pecuniis, alios largitionibus, alios caritatis specie promissisque adsciscebat. Omnes Italie populos seminatis discordiis ad invicem collidebat, et ubi satis afflicti erant ipse sua potentia superveniens occupabat. Omnibus denique locis eius artes dolique pullulabant.
Sed cetere quidem res publice tantas vires intuentes perterrite erant temporibusque cedebant. Florentina autem magnitudo animi terreri non potuit, neque remittendum aliquid censuit de pristina dignitate. Sciebat enim generis esse romani, pro libertate Italie contra hostes pugnare. Sic maiores suos contra Cimbros, contra Teutones, item contra Gallos audiebat pugnavisse, neque Pirri ferociam aut Hannibalis fraudulentiam formidasse, nec ullos unquam labores pro tuenda dignitate atque amplitudine sua vitasse, sed in maximis periculis maximam sibi gloriam peperisse; quod sibi quoque putavit faciendum, si splendorem sibi a maioribus traditum conservare vellet. Hec populus florentinus secum reputans, ita magno et elato animo ad bellum profectus est, ut putaret aut cum gloria vivendum aut pro illa ipsa oppetendum. Ita autem pulchrum duxit locum sibi a maioribus traditum tueri, ut nunquam divitias ullas pluris fecerit quam dignitatem, sed et pecunias et vitam ipsam abicere paratus fuerit pro libertate, prudenter simul et fortissime decernens. Nam et divitie et pecunie et eiusmodi omnia victorum sunt premia; quibus in bello si quis parcit et, cum illis se tutari posset, illa mavult, hostium negotium magis gerit quam suum. Sic igitur hec civitas animata cum potentissimo et opulentissimo hoste ita summa virtute congressa est, ut, qui paulo ante toti Italie imminebat nec quenquam sibi resistere posse arbitrabatur, eum et pacem optare et intra Ticini menia trepidare coegerit, et tandem non solum Etrurie ac Flaminie urbes relinquere sed etiam Gallie maximam partem amittere.
O incredibilem magnificentiam virtutemque civitatis! O vere romanum genus stirpemque romuleam! Quis iam florentinum nomen pro tanta mentis prestantia tantaque rerum gestarum magnitudine cum summo favore non excipiat? Nam quid potuit maius, quid preclarius hec civitas edere, aut in qua magis re maiorum suorum virtutem in se conservatam ostendere, quam universa Italia suo labore suisque facultatibus a servitutis periculo liberata? Ex quo quotidie ab omnibus quidem populis gratulationes, laudes, gratie huic urbi acte, ab hac vero urbe ad Deum immortalem reiecte. Semper enim ea modestia fuit ut mallet has preclaras res Dei beneficio quam sue virtuti ferri acceptas. Itaque non intumuit illa in secundis rebus, nec ira victoriam comitata est, nec adversus omnes quibus iure potuit succensere excanduit, sed summam humanitatem adversus victos servavit, ut qui fortitudinem eius in bello cognoverant iidem in Victoria experirentur clementiam. Nam et hec una est ex summis virtutibus civitatis, ut in omni tempore retineret dignitatem; nec maiori cure fuit res magnas gerere, quam in ipsis gerendis decorem servare. Itaque neque successibus ultra modum exultavit, neque adversis rebus prostrata est. Ex modestia autem in secundis, constantia in adversis, iustitia vero ac prudentia in omnibus, preclarum apud omnes mortales nomen maximamque gloriam consecuta est.
Sed cum foris hec civitas admirabilis est, tum vero disciplina institutisque domesticis. Nusquam tantus ordo rerum, nusquam tanta elegantia, nusquam tanta concinnitas. Quemadmodum enim in cordis convenientia est, ad quam, cum intense fuerint, una ex diversis tonis fit armonia, qua nihil auribus iocundius est neque suavius, eodem modo hec prudentissima civitas ita omnes sui partes moderata est ut inde summa quedam rei publice sibi ipsi consentanea resultet, que mentes atque oculos hominum sua convenientia delectet. Nihil est in ea preposterum, nihil inconveniens, nihil absurdum, nihil vagum; suum queque locum tenent, non modo certum, sed etiam congruentem: distincta officia, distincti magistratus, distincta iudicia, distincti ordines. Ita tamen hec distincta sunt ut ad summam rei publice, tanquam tribuni ad imperatorem, conveniant.
Primum igitur omni cura provisum est ut ius in civitate sanctissimum habeatur, sine quo nec civitas esse nec nominari ulla potest; deinde ut sit libertas, sine qua nunquam hic populus vivendum sibi existimavit. Ad hec duo simul coniuncta, quasi ad quoddam signum ac portum, omnia huius rei publice instituta provisaque contendunt.
Et iuris quidem grada magistratus sunt constituti, iisque imperium datum est et in facinorosos homines animadversio, maximeque ut provideant ne cuius potentia plus valeat in civitate quam leges. Magistratibus ergo privati, itemque inferioris gradus homines, parere omnes et obedire coguntur eorumque insignia vereri. Sed ne ipsi legum vindices in summa potestate constituti arbitrari possint non custodiam civium sed tyrannidem ad se esse delatam, et sic, dum alios cohercent, aliquid de summa libertate minuatur, multis cautionibus provisum est. Principio enim supremus magistratus, qui quandam vim regie potestatis habere videbatur, ea cautela temperatus est, ut non ad unum sed ad novem simul, nec ad annum sed ad bimestre tempus, deferatur. Eo enim modo preclare rem publicam administrari existimavit, cum et pluralitas sententiarum errorem consilii et brevitas temporis insolentiam auferret.
Urbe igitur in regiones quatuor divisa21, ne cui illarum suus unquam deesset honos, ex singulis partibus bini viri eliguntur, nec ii quidem fortuiti sed iudicio populi iam dudum approbati et tanto honore digni iudicati. His octo civibus ad gubernandam rem publicam unus vir, prestans virtute et auctoritate, ex illis iisdem partibus per vicissitudinem adicitur, qui sit in collegio princeps et pro iustitia exequenda contra turbulentos homines ferat vexillum. Hos igitur novem viros, quibus rei publice gubernacula commissa sunt, neque alibi quam in publica arce habitare voluit, quo ad rem publicam gerendam paratiores forent, neque sine lictorum pompa prodire, quo amplior ipsorum haberetur maiestas22. Verum quia nonnunquam accidunt tempora ut maiore Consilio opus esse videatur, additi sunt duodecim viri boni, qui cum novem prioribus rei publice consulerent. Additi preterea iuventutis signiferi, ad quos, cum armis pro tuenda libertate opus est, universa concurrit sequiturque multitudo. Hi et in Consilio assunt, et ut superiores magistratus ex quadrantibus deliguntur, et quatuor menses tenent potestatem.
Sed neque omnium rerum decernendarum hec tria collegia habent potestatem; sed pleraque, cum ab illis approbata sunt, ad populare consilium communeque referuntur. Quod enim ad multos attinet, id non aliter quam multorum sententia decerni consentaneum iuri rationique iudicavit. Hoc modo et libertas viget et iustitia sanctissime in civitate servatur, cum nihil ex unius aut alterius libidine contra tot hominum sententiam possit constitui.
Sed hi quidem homines rei publice consulunt, iura sanciunt, leges abrogant, equitatem decernunt. Iuri autem ex legibus dicendo gladioque exequendo minores presunt magistratus; nec hi quidem cives, sed peregrini ad hoc ipsum ex longinquo ad civitatem vocati23, non quia cives id facere nescirent, nam quotidie in alienis id factitant urbibus, sed ne iurisdictionis causa odia atque inimicitie inter cives nascerentur. Plerique enim, nimia sui cantate decepti, plus iuris sibi tribuunt quam leges patiantur. Qui, etsi recte iudicetur, adversus magistratum exercent querelas. Grave preterea visum est in libera civitate civem de capite civis ferre sententiam; eum enim qui id fecisset, etiam si iustissime fecerit, pollutum tamen et abominabilem inter cives videri. Ea de causa ex longinquo accersiti iudices, iisque leges prescripte sunt, a quibus discedi nullo modo licet. Nam et iurati illas suscipiunt, et magistrati! abeuntes quasi institores quidam rationem administrationis sue populo reddunt. Ita in omni re populus libertasque dominatur.
Quo autem cuique facilius esset in amplissima civitate suum ius consequi, nec, dum aliis occuparentur magistratus, aliis iustitia legesque deessent, data est quibusdam collegiis inter suos homines cognoscendi iudicandique potestas; veluti mercatoribus, nummulariis, item quibusdam aliis, quorum non nulli etiam suorum hominum cohercendorum ius habent. Sunt item alii magistratus, aut publicarum rationum gratia aut pietatis causa constituti; quorum in numero sunt magistri vectigalium et prefecti erario, item pupillorum pupillariumque rerum protectores; qui magistratus publice et privatim utilis est et a beneficentissima civitate pie salubriterque excogitatus.
Sed ex omnibus magistratibus, qui multi atque amplissimi in hac urbe sunt, nullus neque illustrior est neque a pulchriori initio causaque profectus quam optimarum partium duces24; de quorum origine non ab re forsitan erit aliquid referre, quo melius amplitudo eius possit intelligi. Erit autem brevissima digressio, nec inutilis, ut opinor, neque indigna cognitu.
Accepta enim apud Arbiam calamitate, cum propter ingens rei publice vulnus nullo pacto urbs defendi posse videretur, omnes cives qui alto ac generoso erant animo, ne eos in urbe dominantes viderent qui patriam suam manifestissime prodiderant, relictis patriis laribus cum coniugibus ac liberis Lucam se contulerunt, imitati Atheniensium illud preclarum et laudatissimum factum, qui secundo Persico bello urbem ipsam reliquere ut aliquando in ea liberi habitare possent25. Hac igitur mente egregii cives qui a tanta clade supererant urbe egressi sunt, putantes eo modo maiorem ulciscendi facultatem habituros quam si inclusi menibus famem aut interitum urbis operirentur. Lucam itaque delati, et suis, qui propter prelii fortunam dispersi erant, in unum convocatis, ita se armis, equis et omni apparatu belli comparavere ut universi homines eorum animi prestantiam promptitudinemque admirarentur. Post multa igitur fortitudinis opera per Italiani edita, cum sepe amicis auxilium tulissent, sepe inimice factionis homines sua virtute et audacia contrivissent, omnibus denique ex locis ubi pugnaretur victoriam reportassent, tempus venisse rati quod illi maxime optabant, ut patrie notas maculasque delerent, contra Manfredum Sicilie regem, quoniam is diversarum partium princeps in Italia erat et milites suos ad Arbiam miserat, profecti sunt, secuti prestantissimum atque optimum ducem quem ad comprimendam Manfredi insolentiam pontifex maximus ex Gallia accersierat26. Postquam ergo in Apuliam ventum est, quantam illi virtutem singulis in locis ostenderint libentissime equidem referrem, si hic locus tantam narrationem pateretur. Ut autem brevissime dicam, tales se prestiterunt ut etiam acerbissimus hostis decorem ac prestantiam eorum laudare cogeretur. Subacta igitur Apulia, hosteque trucidato, magnifice laudati donatique a rege in Etruriam revertuntur. Pulsisque ex urbe iis qui malo rei publice regnabant, itemque vicinis hostibus magnifice ultis, collegium sibi statuerunt virosque primarios prefecerunt, qui essent duces optimarum partium principesque legitime incliteque conspirationis27.
Ab huiusmodi initio hic magistratus profectus, plurimam in urbe habet auctoritatem. Positus est enim quasi in vigilia quadam atque custodia, ne res publica e curriculo a maioribus observato deflectat, neve ad homines diversa sentientes administratio rei publice deferatur. Quod igitur Rome censores, Athenis areopagite, Lacedemonie ephori, hoc sunt in florentina civitate partium duces, id est, ex his civibus qui bene de re publica sentiunt, primarii viri electi ad rem publicam tuendam.
Sub his igitur magistratibus ita diligens et preclara est huius urbis gubernatio ut nulla unquam domus sub frugi patre familias maiori disciplina fuerit instituta. Quamobrem nemo hic iniuriam pati potest, nec quisquam rem suam nisi volens amittit. Parata semper iudicia, parati magistratus, patet curia, patet summum tribunal. Querele adversus omne genus hominum in hac civitate liberrime sunt, iura autem prudenter et salubriter constituta et semper opitulari parata. Nec est locus ullus in terris in quo ius magis equum sit omnibus. Nusquam enim viget tanta libertas et maiorum cum minoribus exequata condicio. Nam in hoc quoque cognoscere licet civitatis huius prudentiam, nescio an maximam omnium civitatum. Cum enim potentiores, suis opibus confisi, tenues ledere aspernarique viderentur, causas eorum qui minus poterant ipsa res publica suscepit, maiorique pena res illorum personasque munivit. Rationi quippe consentaneum arbitrata est ut disparem condicionem hominum dispar pena sequeretur, et qui magis indigebat ei plus auxilii tribuere sue prudentie iustitieque putavit. Itaque ex diversis ordinibus facta est quedam equabilitas, cum maiores sua potentia, minores res publica, utrosque vero metus pene defendat. Ex quo nata est illa vox, quam adversus potentiores frequentissime iactari videmus; cum enim quid minantur, promptissime aiunt: «Ego quoque florentinus sum civis». Hac illi voce attestari videntur et palam admonere, ut nemo se propter imbecillitatem contemnat nec sibi iniuriam propter potentiam minari pergat; parem esse condicionem omnium, cum eos qui minus possint ipsa res publica polliceatur ulcisci. Quanquam non cives duntaxat hec res publica defendit, sed etiam peregrinos. Nulli enim patitur fieri iniuriam, sed sive civis sive peregrinus sit suum cuique ius ut tribuatur laborat. Hec eadem iustitia equabilitasque civitatis cum facilitatem et humanitatem inter cives parit, cum nemo magnopere inflari aut alios aspernari possit, tum vero erga omnes homines benignitatem.
Iam vero de honestate vite et, ut in hoc tempore, sanctimonia morum quis satis digne possit referre? Maxima quidem in hac urbe ingenia sunt et, quamcunque rem agere pergant, modum ceterorum hominum perfacile excedentia. Sive enim arma sequantur, sive ad rem publicam gubernandam se conferant, sive ad studia aliqua rerumve cognitiones, sive ad mercaturas, in omni denique re obeunda omnique actione cunctos mortales longissime anteeunt. Nec ulli penitus genti cuiusquam excessus locum relinquunt, patientes laborum, presentes in periculis, glorie avidi, pollentes Consilio, industrii, liberales, magnifici, iocundi, affabiles, maximeque urbani.
Nam quid ego de orationis suavitate et verborum elegantia loquar? In qua quidem re sine controversia superat. Sola enim hec in tota Italia civitas purissimo ac nitidissimo sermone uti existimatur. Itaque omnes qui bene atque emendate loqui volunt ex hac una urbe sumunt exemplum. Habet enim hec civitas homines qui in hoc populari atque communi genere dicendi ceteros omnes infantes ostenderint. Littere autem ipse, non mercenarie ille quidem neque sordide, sed que maxime sunt liberis hominibus digne, que in omni principe populo semper floruerunt, in hac una urbe plurimum vigent.
Quo igitur ornamento hec civitas caret, aut quid sibi ad summam laudem atque amplitudinem deest? Num generis claritas? Que a populo romano sit orta! Num gloria? Que preclaras res tanta virtute et industria domi forisque gesserit et quotidie gerat! Num splendor edificiorum, num ornatus, num laututia, num divitie, num multitudo populi, num salubritas atque amenitas locorum? Et quid est preterea quod ulla civitas possit optare? Nihil profecto!
Quid igitur iam dicemus, aut quid agendum superextat? Quid aliud, quam summum numen pro tanto beneficio venerari eique preces porrigere? «Tu igitur Deus omnipotens atque immortalis, cuius delubra atque aras hic tuus populus religiosissime colit; tuque sanctissima Parens, cui ingens templum ex puro ac nitido marmore in hac urbe absolvitur, que tuum dulcissimum complexa natum eadem mater es et intemeratissima virgo, tuque Iohannes Baptista, quem sibi patronum hec civitas adoptavit: hanc pulcherrimam et ornatissimam urbem populumque eius ab omni clade maloque defendite».
Vorrei che dall’immortale Iddio mi fosse concesso di poter mostrare un’eloquenza pari o alla città di Firenze, di cui mi accingo a parlare, o al mio amore verso di lei e alla mia volontà. L’una o l’altra di queste possibilità sarebbe, a mio parere, più che sufficiente a rivelare la magnificenza ed il fascino di questa città. Tale, infatti, essa è, che in tutto il mondo non si può trovare niente di più bello e di più splendido; e d’altra parte la mia volontà, per quello che io facilmente capisco di me stesso, niente ha desiderato di più. Perciò non dubito affatto che qualunque delle due possibilità ci fosse, io di questa insigne e bellissima città potrei parlare con eleganza e dignità. Ma dal momento che non ci è concesso di realizzare tutto ciò che vogliamo, quanto io potrò lo metterò avanti, in modo che si veda che non mi è mancata la volontà ma piuttosto la capacità.
Certamente meravigliosa è l’eccellenza di Firenze, e tale che l’eloquenza di nessuno potrebbe uguagliarla. Però anche riguardo a Dio stesso vediamo che alcuni uomini insigni e buoni hanno osato parlare: eppure neanche alla più piccola parte della sua gloria e della sua grandezza possono aspirare di giungere le parole di un uomo eloquente quanto si vuole; tuttavia questa così eccezionale superiorità non li distoglie dal parlare, con tutte le forze che hanno, di così immensa grandezza. A me, dunque, sembrerà di aver fatto abbastanza se tutto ciò che ho conseguito con lo studio, con gli insegnamenti, con l’esercizio del dire, e infine con molte veglie, tutto lo indirizzerò interamente a lodare questa città, nonostante capisca bene che in nessun modo esso è da mettere a confronto con tanto grande splendore.
Quello che è stato detto dalla maggior parte degli oratori, che cioè non sanno da dove incominciare, ora vedo che capita proprio a me: non però per le parole, come a loro, ma per l’argomento stesso. E non soltanto perché le cose sono molte e varie, fra sé strettamente congiunte, ma anche perché tutte sono così notevoli, e in un certo modo così straordinarie, che sembrano contendere tra loro su quale sia più eccellente; sicché non è facile decidere di che cosa si debba parlare per prima. Se tu guardi alla bellezza e allo splendore della città, niente può apparire più degno che se ne parli prima; se guardi alla sua potenza e alla sua ricchezza, penserai che proprio questo sia da preporre del tutto; ma se guarderai alle imprese compiute o nella nostra età o nel tempo passato, niente potrebbe sembrare tanto grande da essere ad esse anteposto; qualora poi tu considerassi i suoi costumi e le sue istituzioni, nulla assolutamente giudicheresti più insigne. Ora tutte queste cose mi tengono in dubbio, e spesso, mentre mi accingo a parlare di una, il ricordo di un’altra mi chiama a sé, e non mi lascia la possibilità di decidere. Ciononostante incomincerò da dove mi sembrerà più opportuno e più conveniente: e su questo credo che anche gli altri non avranno da ridire.
Come vediamo che alcuni figli hanno tanta somiglianza con i loro genitori che si riconoscono chiaramente a prima vista, così questa nobilissima ed illustre città ha tanta conformità con i suoi cittadini, che proprio a ragione sembra essere avvenuto che né loro abbiano mai abitato altrove che in essa, né essa abbia mai avuto altri abitanti che costoro. E infatti, come gli stessi cittadini per un certo loro naturale ingegno, per prudenza, per elevatezza e magnificenza, moltissimo soprawanzano tutti gli altri uomini, così anche questa città, tanto accortamente situata, supera tutte le altre in splendore, in ornamento ed eleganza.
In primo luogo, dunque, vediamo che quello che è segno di grandissima prudenza — cioè niente fare per ostentazione, e non ricercare una pericolosa e vana iattanza, piuttosto che una quieta e stabile comodità — Firenze veramente lo ha osservato. Infatti non è stata edificata sulla cima di monti, da dove potesse fare bella mostra di sé, e neppure, al contrario, in una larghissima distesa pianeggiante, in maniera da essere aperta verso ogni parte. Invece, con moltissima prudenza e accortezza, ha badato ad ambedue queste situazioni. Non è possibile, appunto, abitare sulle cime dei monti senza le avverse condizioni del clima, senza venti, senza tempeste, senza un enorme scomodo e disagio degli abitanti; e dall’altra parte, in un’immensa e vasta pianura senza umidità del terreno, senza impurità dell’aria, senza caligine delle nebbie. Fuggendo, perciò, questi inconvenienti, la prudentissima città è stata edificata in un luogo tale che — come benissimo risulta in ogni cosa — costituisce una posizione intermedia tra due estremi: lontano dalla condizione svantaggiosa del monte, libera da quella fastidiosa della pianura. Così essa abbraccia le due posizioni, di modo che non è priva dei comodi né di quella né di questa, e gode di un clima meraviglioso. Opposti al settentrione, quasi come baluardi della città, i monti di Fiesole respingono i rigori del freddo e gli impeti furiosi dei venti settentrionali, mentre contro il vento di mezzogiorno, che ha forza minore, fanno da difesa colli più bassi. Da tutte le altre parti si distendono campagne soleggiatissime e aperte specialmente verso Occidente. Così in questi luoghi c’è moltissima tranquillità ed una temperatura ideale: mentre quando ti allontani da essi, dovunque tu vada, ti accolgono o freddi più pungenti o le vampe del sole.
La città poi, per tutto lo spazio della collina e della pianura che occupa con la sua estensione, è ricinta da una bellissima corona di mura: però non di tanta grandiosità da farla apparire paurosa e diffidente nelle sue forze, e allo stesso tempo non così trascurata da poter essere giudicata sfacciata o sconsiderata. E che dirò del gran numero delle persone, dello splendore degli edifici, degli ornamenti delle chiese, dell’incredibile e meravigliosa pulizia dell’intera città ? Tutte le cose, per Ercole, sono di una straordinaria e stupenda bellezza.
Ma è possibile conoscerle meglio confrontandole con quelle delle altre città, che osservarle in se stesse. Così quelli che per qualche tempo sono stati assenti, quando ritornano a Firenze sono quasi i soli che capiscono quanto questa splendida città superi di gran lunga tutte le altre. Nel mondo intero, infatti, non ce n’è una a cui non manchi qualcuna delle cose più importanti per raggiungere la bellezza. Una manca di popolazione, un’altra dell’ornamento degli edifici, un’altra non manca affatto di queste caratteristiche ma si trova in una zona col clima non salubre. Alcune poi sono così sporche che tutto il sudiciume fatto la notte, la mattina lo mettono davanti agli occhi della gente e lo lasciano per le strade a calpestarlo con i piedi: cosa di cui non si potrebbe escogitarne una più sozza; e se lì ci fossero anche mille palazzi reali, inesauribile ricchezza e un’infinita moltitudine di abitanti, disprezzerei tale puzzolente città e mai la stimerei gran che. Come in una persona dal corpo deforme, anche se ha tutto il resto eccellente, non ci può essere felicità, così nelle città sporche, anche se ci sono tutte le altre buone qualità, non ci può assolutamente essere la bellezza. E ad una città a cui manca la bellezza, chi non vede che manca il più elevato e più grande ornamento?
Firenze, invece, la vediamo così pulita e tersa che in nessun luogo si trova una maggior pulizia. Questa è davvero l’unica città, e sola in tutto il mondo, in cui non ti imbatta in qualcosa di sozzo per gli occhi, di fastidioso per il naso, di lordo per i piedi. Con grandissima diligenza dei suoi abitanti si bada e si provvede a tutte queste necessità; così, tolta via ogni bruttura, incontri soltanto ciò che può offrire diletto e piacere ai sensi. Pertanto Firenze supera senza contrasto in magnificenza forse tutte le città che ci sono ora; in splendore poi e pulizia tanto quelle che ci sono ora, quanto quelle che mai ci sono state. Così diffusa nettezza è inaudita ed incredibile per quelli che mai hanno visto Firenze; e noi stessi che vi abitiamo ne siamo presi ogni giorno da ammirazione, e nonostante l’abitudine non riusciamo a saziarcene. Che cosa c’è di più mirabile del fatto che in una città tanto popolata come questa non si trovi punto fango, e che una pioggia anche molto abbondante non impedisca affatto di girare per le sue strade a piedi asciutti, dato che l’acqua, quasi prima che sia caduta per terra, è raccolta in adattissime condutture? Ne deriva che in altre città neppure le camere di splendidi palazzi sono così pulite e terse come le vie e le piazze di Firenze. E in verità se una città non ha pulizia neanche ha ornamento di edifici; se non ha ornamento di edifici neanche ha salubrità dell’aria, se non ha salubrità neanche ha grande numero di abitanti. In Firenze, invece, dalla prima all’ultima ci sono tutte quelle caratteristiche che possono rendere felice una città. Se ti diletti di antichità, vi troverai moltissime vestigia di antichità tanto in edifici pubblici quanto in edifici privati; se cerchi novità, niente di più magnifico e splendido c’è dei suoi nuovi edifici.
Il fiume, poi, che scorre in mezzo alla città è difficile dire se reca più utilità o piacere. Quattro ponti, magnificamente costruiti di pietra ben squadrata, congiungono le sue rive da una parte all’altra, e sono distanziati fra loro così comodamente che nessuna delle più affollate vie subisce interruzione per la presenza del fiume; perciò si può camminare per la città non meno agevolmente che se non fosse addirittura divisa da alcun fiume. Da una parte e dall’altra ci sono piazze bellissime, e portici ornatissimi di nobili famiglie, e crocicchi affollati da circoli di gente. Le case situate presso il fiume in parte sono bagnate dall’acqua che scorre, in parte si distanziano dal fiume tanto quanto lo spazio di una strada intermedia, per la quale una numerosissima quantità di persone possa andare o per affari o per spasso. Niente c’è di più gradevole del camminare per questi luoghi, o nel mezzo del giorno se è inverno, o sulla sera se è estate.
Ma perché mi sono intrattenuto su un solo luogo della città ? Perché mi aggiro presso le rive del fiume come un pescatore? Quasi che soltanto questo posto fosse splendido e non tutte le zone della città risplendessero di una simile o anche maggiore bellezza! Che c’è in tutto il mondo tanto stupendo o tanto magnifico che sia da paragonare con gli edifici di Firenze? Io davvero provo vergogna per tutte le altre città, ogni volta che mi passa per la mente un tale confronto. Quelle, infatti, hanno una sola strada, o al massimo due, adornate nell’intera loro estensione, in tutte le altre strade sono così prive di ornamenti che sentono non poco ritegno nell’essere viste da stranieri. In questa nostra, invece, non c’è una strada, non c’è una parte che non sia piena di grandiosi ed ornatissimi edifici. Quale disposizione, o Dio immortale, quali ornamenti! Che grandi architetti si scorgono in queste costruzioni, e quanto grandi agiatezze e lussi di coloro che vi abitano! Ma fra tutti gli altri edifici della città, per una più maestosa ampiezza e magnificenza si segnalano i sacri templi e le chiese, che, sparse e distribuite numerosissime per Firenze, come conviene a luoghi di Dio con mirabile attaccamento sono curate e con mirabile devozione sono custodite, ciascuna dal suo popolo. Così niente c’è più ricco di quelle, niente più adornato, niente più magnifico. Non c’è stata, infatti, la preoccupazione di adornare soltanto luoghi profani, ma anche quelli sacri; e non si volle che fossero splendide soltanto le dimore dei vivi, ma anche le sepolture dei morti.
Ma ritorno alle case dei privati, che sono state ideate, progettate ed edificate badando al piacere, alla grandiosità, al decoro e soprattutto alla magnificenza. Che ci può essere di più bello e di più attraente che guardare gli ingressi dei palazzi, i loro atri, i pavimenti, le sale da pranzo e le altre parti interne? Osservare l’ampiezza di questi edifici capaci di contenere moltitudini di gente! Osservare le balconate, le volte, i soffitti, i tetti oltremodo adornati, e — cosa che si trova nella maggior parte delle case — le stanze per l’estate separate da quelle per l’inverno! E inoltre bellissime camere, ricchissima suppellettile, oro, argento, coperte e preziosi tappeti!
Ma sono così stolto io, da mettermi ad enumerare tutte queste cose? Anche se avessi cento lingue, cento bocche, una voce di ferro1, non potrei rivelarne tutta la magnificenza, la raffinatezza, la ricchezza, la sontuosità, lo splendore. Quindi, se qualcuno vuol conoscere tutto questo, venga qua, percorra la città; e l’attraversi non come un ospite frettoloso o un viandante veloce, ma si fermi, investighi, contempli. A tutte le altre città importa molto che un forestiero non si intrattenga troppo in esse. Se hanno qualche cosa di valore, si trova subito in mostra e, per così dire, sulla prima scorza, perché i forestieri possano vederla appena entrano nella città. Ma se costoro lasciano i luoghi più rinomati, e delle cose vogliono vedere non la scorza ma la midolla, non troveranno niente che corrisponda all’opinione che si erano precedentemente fatta: invece di case ci sono casupole, e invece dell’aspetto dignitoso di fuori, dentro c’è sozzura. Al contrario se Firenze non si guarda all’interno, non si può conoscere ogni sua bellezza: così ciò che alle altre città procura una diminuzione di stima, a questa l’aumenta moltissimo. Perché entro le pareti essa non ha meno oggetti di valore e minor magnificenza che al di fuori; e non è che sia bella e pulita questa o quella sua strada, ma lo sono tutte le sue parti. Come il sangue si trova per tutto il corpo, così le cose belle e di valore sono diffuse per tutta la città.
In mezzo ai più superbi edifici s’innalza un palazzo di straordinaria bellezza e di meravigliosa struttura, il quale col suo stesso aspetto indica facilmente per quale scopo sia stato costruito. Come in una grande flotta la nave ammiraglia è di solito tale che facilmente si intuisce che su di essa si trova il comandante, che è guida e capo di tutti gli altri, così l’aspetto di questo palazzo è tale che chiunque ne può dedurre che in esso abitano coloro che sono i governanti dello Stato. Stupendamente costruito, si eleva così in alto che domina per largo spazio sugli edifici circostanti, e la sua altezza si presenta ben maggiore di quella di una costruzione privata. Sicché non so se davvero questo palazzo si deve chiamare semplicemente «fortezza», o piuttosto «fortezza della fortezza».
Infatti, appena esci dalle mura ti si presentano molti edifì ci che si potrebbero chiamare «città», e questa, che è cinta dalle mura, «fortezza». Allo stesso modo che Omero scrive della neve che, caduta dal cielo, copre le montagne, i colli, i gioghi e i fertili campi2, così questi edifici fuori della città occupano tutto all’intorno i monti e i colli e la pianura, sicché pare che siano caduti dal cielo più che fatti per mano degli uomini. E quanta è la magnificienza di questi edifici, quanta la loro bellezza, quanto il loro adornamento! Sono più ampi di quelli della città, dato che si trovano in luoghi più aperti, e sono stati costruiti con maggiore libertà a scopo di diletto e di piacere; perciò in essi non mancano spazi vuoti, né porticati, né orti, né giardini. Che dirò poi delle loro camere e delle loro sale, di cui niente c’è di più magnifico e adornato? E negli spazi fra questi edifici ci sono ombrosi boschi, prati fioriti, dolcissimi ruscelli, chiarissime fonti, e, ciò che supera tutto, una natura che di per se stessa dà gioia. Sembra che i colli ridano e che intorno a sé diffondano una certa giocondità: e chi guarda per questi luoghi non può appagarsi, e col vederli non può saziarsi. Perciò tutta questa regione potrebbe giustamente considerarsi e chiamarsi un paradiso, a cui niente in tutto il mondo è pari per la bellezza e per la gioia. Restano stupite certamente le persone che vengono a Firenze quando di lontano, da qualche cima di monte, vedono tanta maestosità della città, tanta ampiezza, tanto splendore, tanta quantità di ville. E tutte queste cose non è che siano magnifiche viste da lontano e poi, quando ti sei accostato, si presentino sporche — il che accade in una bellezza non reale —; ma tutte sono così disposte, così spiccano di non falso decoro che, quanto più da vicino le guardi, tanto più ti cresce l’idea della loro magnificenza. Perciò le ville vincono in bellezza le apparenze lontane, i sobborghi vincono le ville, la città stessa i sobborghi: e gli stranieri appena entrano in essa, dimenticata subito la squisitezza e il fascino delle cose di fuori, ammirano attoniti il suo immenso splendore.
Voglio ora narrare un fatto che a me generalmente sembra argomento fondamentale per dimostrare la grandezza di Firenze. Essa ha fatto moltissime guerre, ha combattuto contro fortissimi nemici, ha abbattuto alcune potenze che stavano innalzandosi e facevano paura; con la prudenza, con i mezzi, con la grandezza d’animo ha superato avversari a cui in nessun modo si sarebbe creduto che potesse far fronte né resistere. Ultimamente contro un potentissimo e ricchissimo nemico ha combattuto per molti anni con estremo vigore3, suscitando l’ammirazione di tutti. Quel signore — i cui mezzi e la cui potenza temevano le genti oltremontane e tutto il resto dell’Italia, gonfio di speranza, baldanzoso per le vittorie e che come una tempesta tutto conquistava con eccezionale successo — c’è stata questa sola città capace non soltanto di trattenerlo nella sua invasione e ritardarne il corso delle vittorie, ma anche di abbatterlo dopo una lunga guerra. Ma delle gesta compiute da Firenze fra poco ci sarà tempo e modo di parlare; ora facciamo ciò che ci siamo proposti.
Dico, dunque, che tutti sono rimasti così meravigliati della grandiosità della contesa e della lunghezza di questa guerra da stupirsi da dove la città trovasse tante forze, tanti mezzi, tanti denari per continuare a combattere. Ma questa così grande meraviglia, questo così grande stupore rimangono negli uomini finché non hanno osservato questa bellissima città e non hanno visto la sua magnificenza: ma quando l’hanno vista, tutta la meraviglia svanisce e scompare. Sappiamo che questo è noto a tutti; e nessuno arriva a Firenze il quale non confessi che gli è capitato proprio così. Infatti, appena osservano la città, quando dinanzi ai loro occhi si presenta tanta grandiosità, tanta quantità di edifici, tanta magnificenza, tanto splendore; quando vedono le eccelse torri, i templi marmorei, le alte basiliche, le magnifiche case, le mura turrite, il gran numero di ville, la sontuosità, il nitore, l’ornamento: immediatamente la mente e l’animo di tutti cambiano tanto che non si meravigliano più delle gesta grandiose e gloriosissime compiute da questa città; ma piuttosto la giudicano capace di acquistare il dominio e l’impero del mondo intero. Da ciò si può capire come Firenze sia straordinariamente ammirevole: una città della cui bellezza e magnificenza nessuno potrebbe degnamente o farsene un’idea o parlarne. Ma le notizie avute su Firenze sono superate dalla visione diretta di essa, tanto quanto da quelle notizie era superata l’opinione che si aveva prima.
Certamente io non so che cosa pensano gli altri, ma a me, di solito, questo argomento appare tanto calzante da credere che perfino con esso solo si possa confermare, per così dire, l’incredibile eccellenza di Firenze. Quella diffusa e comune ammirazione per la città, una volta vista, non si potrebbe tanto facilmente togliere ed estirpare dall’animo, se nella città stessa non ci fosse un qualche altro più elevato motivo di nobilità e di bellezza, il quale non soltanto attenuasse, ma anzi facesse dimenticare lo stupore concepito per la grandezza delle imprese compiute.
Se un tale mi raccontasse una qualche prova di forza eccezionale ed incredibile compiuta da un pugile durante le competizioni — come se dicesse che da costui alcuni erano stati abbattuti a terra col pugno e altri col cesto; o che da lui solo molti erano stati vinti e messi in fuga; o che egli era rimasto saldo in piedi di fronte ad una quadriga tirata al galoppo; o che aveva portato sulle spalle un toro vivo per lo stadio, cosa che si dice abbia fatto Milone di Crotone4; o che mentre stava ritto sopra uno scudo unto nessuna forza era riuscita a spingerlo giù, cosa che si legge essere stata compiuta da Polidamante5 —; e se quel tale poi alle mie meraviglie aggiungesse che queste cose sentite dire sembrano, sì, incredibili, ma se si vedesse quell’uomo e si osservasse la forza del suo fisico, nessuno si meraviglierebbe più, ed anzi si crederebbe che egli potesse fare non soltanto quelle cose che erano state riferite, ma anche maggiori; se dunque, dico, un tale mi narrasse tutto questo e lo sostenesse, necessariamente mi si presenterebbe subito l’immagine di un uomo fortissimo, che possiede una straordinaria costituzione fisica con membra di eccezionale vigore. Allo stesso modo questa magnifica città, poiché, una volta vista, allontana subito da sé tutta l’ammirazione prima concepita su di lei, e modifica le opinioni degli uomini, necessariamente deve avere in sé una risorsa eccezionale di magnificenza, di bellezza e di ricchezza. In questo così evidente mutamento della mente, in pensieri ed opinioni, che cos’altro si potrebbe dire se non che la grandiosità e la maestà di questa città sono così elevate che né lingue di narratori potrebbero spiegarle né menti di ascoltatori comprenderle? Tutti certamente la lodano e loderanno sempre, ma nessuno si è trovato a cui nel vederla non appaia molto più splendida di quanto si era immaginato nel sentirne parlare. Pertanto non dubito che ci saranno molti che mi accuseranno di temerarietà e di sfrontatezza per aver posto mano ad un’impresa di tal genere: ma io guardando questa così stupenda città non potevo non ammirarla, e, ammirandola, non farne l’elogio. Se poi non riesco ad esser pari a lei — e a lei nessuno è riuscito mai ad esser pari — è giusto che’io sia oggetto più di perdono che di sdegno. Ma ormai torniamo al nostro argomento.
Dopo le ville ci sono molti castelli. Ma che dico castelli? Anzi di tutta quella zona che circonda le ville non c’è parte che non sia piena di splendide e celeberrime città. Firenze è nel mezzo come sovrastante e dominatrice, mentre quelle stanno intorno, ciascuna collocata al suo posto. A ragione un poeta direbbe che è come la luna circondata dalle stelle; perciò è cosa bellissima a vedere. Come in uno scudo, mentre ci sono molti cerchi che a vicenda si chiudono, il giro più interno finisce nell’ombelico, che è il posto più nel centro di tutto lo scudo; allo stesso modo qui vediamo zone chiuse e recinte l’una nell’altra come cerchi: e di queste zone la città è la prima, posta nel mezzo come ombelico di tutto il circuito. E poi cinta da mura o da borghi; i borghi a loro volta li circondano le ville e le ville i villaggi: e tutte queste località le recinge l’ultima zona con maggiore orbita e circolo. Fra le città ci sono pure rocche e fortezze che s’innalzano minacciose verso l’alto, e che sono sicurissimi rifugi dei contadini.
Così grande è poi la moltitudine degli abitanti che tutti i posti ne sono senz’altro pieni. Che dire, ora, della dolcezza e dell’abbondanza dei frutti? Che della stupenda coltivazione dei campi? Queste sono cose note a tutti; e poste dinanzi agli occhi di tutti: e quindi non hanno bisogno di alcuna dimostrazione. Dico soltanto questo: che non si potrebbe trovare facilmente alcun altro territorio capace di nutrire una così grande moltitudine di abitanti. E la maggior parte delle città non hanno tanti abitanti, quanti il contado fiorentino. Eppure tutti costoro, insieme con l’enorme popolazione della città, quello li alimenta in modo che non hanno bisogno di alcun aiuto esterno non soltanto per il cibo più necessario, ma neppure per le cose più ricercate. Per tutto ciò Firenze di per se stessa è tale, sia entro le mura sia fuori, che nessun’altra città si potrebbe giudicare più felice.
Se c’è qualcuno che pensa che a questa città manchi qualcosa per il fatto di non essere sul mare, costui, a mio parere, sbaglia moltissimo, e prende per un male ciò che invece dovrebbe lodare. La vicinanza del mare è forse utile per esercitare la mercanzia, ma per il resto è troppo preoccupante e spiacevole, perché moltissimi sono gli svantaggi a cui sono soggette le città marittime, moltissimi i pericoli a cui necessariamente esse vengono a trovarsi sottoposte. L’ateniese Platone, il filosofo di gran lunga più grande di tutti, trattando nei suoi libri della città che vive bene e felicemente, ed esaminando con attenzione che cosa conviene che essa abbia o che cosa non abbia, in primo luogo sostenne proprio che deve essere lontana dal mare6. Quell’uomo sapientissimo pensava che in nessun modo possa essere felice una città situata sul litorale o vicino ai flutti del mare: e racconta le molte sciagure e i molti ostacoli ad una vita serena che la vicinanza del mare procura e reca. E certo, se vogliamo ben considerare, per una città è cosa molto grave trovarsi in un posto in cui si debbano temere offese dalle parti più diverse, dal Tanai e da Trebisonda fino a Gadi, in cui non basti osservare che cosa fanno le genti vicine, che cosa deliberino i popoli confinanti, che cosa macchinino, di quali sentimenti siano nei nostri riguardi, e guardarsi tanto dalle loro insidie occulte quanto dai manifesti assalti, ma ci sia da aver paura degli Egizi, dei Fenici, dei Colchi, degli Sciti, dei Mauri, dei Gaditari, nazioni barbare e tanto distanti fra loro. Talvolta con i loro piani ingannano le genti vicine: che faranno quelle lontane? Gli assalti per terra, che di solito sono più lenti, talvolta arrivano senza che si sia potuto presagire qualcosa del genere; che cosa, dunque, non si deve aspettarsi dalle veloci flotte? Se tutto ciò non avviene nel presente, non per questo possiamo immaginare che non accada una volta o l’altra: e sappiamo benissimo che nel passato è accaduto. E dunque una grande stoltezza esporsi di propria volontà ai pericoli, mentre si potrebbe vivere in sicurezza e tranquillità.
Se questi motivi non smuovono coloro che amano tanto il mare e le spiagge, non gli faranno cambiare idea gli esempi di fatti antichi? Leggi le storie dei Latini, le storie dei Greci, e in esse osserva quanti siano stati i pericoli corsi, quanto frequenti le distruzioni di città marittime, quante città, fiorenti per mezzi, per abitanti, per ricchezze siano state occupate da flotte nemiche prima che potessero sospettare qualcosa di simile. Se costoro penseranno a tutto questo, già incominceranno a credere che Firenze, per il fatto di non essere marittima, non manca di niente; ma al contrario, come tutte le altre cose, anche questa è stata fatta con grandissima saggezza. Troia, nobilissimo «culmine dell’Asia» ed «egregia opera degli dei» — come dice quello7 — due volte fu presa e distrutta da una flotta: la prima in seguito ad un improvviso assalto di Ercole e di Telamonio, la seconda per l’inganno di Agamennone e di Ulisse. In nessun modo quella fiorentissima città avrebbe potuto essere presa se la vicinanza del mare non ne avesse offerto l’opportunità. Invano erano passati dieci anni in battaglie per terra; alla fine i Greci ricorsero alla flotta e al mare come mezzi adattissimi per tendere insidia. Allora, quando i Troiani pensavano di essere finalmente liberi dal lungo assedio, quando non si presentava loro più niente di ostile e di niente si sospettava, ecco che «l’esercito argivo sulle navi schierate veniva da Tenedo nel complice silenzio della luna che splendeva tranquilla»8. E poco dopo <Androgeo gridava>: «Altri mettono a fuoco e a ruba Pergamo, e voi soltanto ora venite dalle grandi navi?»9. Questi, dunque, sono i premi del mare! Questa la vicinanza meritevole di essere tanto esaltata!
Ma perché io vado ora rievocando fatti tanto lontani? Di Genova, nobilissima città d’Italia, si legge che durante la seconda guerra punica fu presa all’improvviso da Magone, figlio di Amilcare, e fu distrutta10. E che dirò della distruzione della Focide, che di Siracusa, che di Alessandria, che di Atene? E mentre il popolo romano era tanto in auge e signoreggiava su tutto il mondo, il mare non continuò per molti anni ad essere infestato da flotte di predoni, tanto che molte città del popolo romano subirono estreme rovine? E questo popolo, che aveva assoggettato il mondo intero, non riuscì a proteggere le città marittime dalle incursioni delle flotte. Aggiungi poi la pesantezza dell’aria, aggiungi la variabilità del clima, aggiungi le malattie che rendono pallidi, cioè l’insalubrità della zona marina e l’inclemenza di tutti i territori vicini al mare. Fra così numerose e così gravi avversità non c’è da meravigliarsi se questa prudentissima città si è tenuta lontana dal porto di mare per stabilirsi in un porto di tranquillità, e ha preferito fare a meno dei flutti del mare che essere sottoposta a tanti e tanto gravi flutti.
Che vuol dire, poi, se Firenze non ha un porto? Sebbene io abbia dei dubbi su come qualcuno accetterà quello che sto per dire, pure esporrò il mio pensiero. Come tutte le altre cose anche questa mi sembra che sia stata fatta dalla nostra città con grandissima prudenza e con ottima decisione. Infatti, mentre è così lontana dalla costa da non essere affatto soggetta a tutte quelle avversità che la vicinanza del mare procura, è però vicina ai porti in modo da non essere privata di nessun vantaggio del mare. Dalle città marittime è superata soltanto in quelle cose in cui l’esser vinto è una vittoria. A quelle città i porti e il litorale offrono, sì, una qualche utilità, ma collegata a molti danni e mescolata a molte molestie; mentre Firenze si serve della vicinanza del mare ricavandone una pura utilità, non turbata da alcuna avversità e non sminuita da alcun danno. A tale felice condizione niente possono guastare e togliere il clima pestifero, niente l’aria pesante e malsana, niente l’umidità delle acque, niente le malattie autunnali; ma il vantaggio di quella condizione è tutto quanto puro, e per niente dannoso, per niente corrotto.
A me poi di solito sembra che Firenze si sia ritirata dal mare inferiore anche allo scopo di avere la comodità del mare superiore: una decisione che non si può lodare abbastanza. Se essa si fosse stabilita soltanto su uno dei due litorali, oltre ad essere danneggiata dai molti e vari mali dovuti al contatto col mare, le si aggiungerebbe lo svantaggio di essere troppo lontana dall’altro litorale; e da ciò le deriverebbero disagi contemporaneamente nei due estremi: da una parte per la troppa lontananza, dall’altra per la troppa vicinanza. Ora, dunque, è distante dall’uno e dall’altro litorale, di modo che pare non essere stata contenta di uno solo dei due, ma avere voluto rivolgere l’uno e l’altro insieme a suo vantaggio. Firenze siede nel mezzo fra il Tirreno e l’Adriatico, quasi come regina d’Italia, situata in un clima purissimo e soluberrimo, e non è priva né di pianura né di montagne: da una parte campi apertissimi, dall’altra colli bellissimi. Entro le mura, in mezzo alla città scorre il fiume, che è di grandissimo ornamento e di ancor maggiore utilità. Nella città c’è un’ammirevole sontuosità, un incomparabile splendore, ornamenti stupendi, somma magnificenza di tutte le cose. Delle ville, poi, immense e inaudite sono le raffinatezze: un incanto più che terreno; tutto è pieno di fascino, pieno di soavità, pieno di decoro. Di questi tanti e tanto grandi beni e ornamenti ripiena, Firenze supera di gran lunga le città non solo dell’Italia ma di tutti i paesi.
Veramente la grande abbondanza di cose bellissime, e la ricca materia, che di per se stessa si offre al discorso, con impeto, per così dire, e con violenza mi hanno trascinato fino a qui senza alcuna possibilità di fermarmi. Eppure mi pare di aver parlato con scarsa eloquenza, dal momento che nel trattare degli ornamenti di questa città ho tralasciato i principali e più grandi. Tutto preso nel riferire gli altri aspetti dello splendore e della magnificenza di Firenze, quasi dimentico di me stesso, mi era sfuggito di parlare della moltitudine della sua gente, del gran numero degli uomini, della virtù, dell’attività, dell’umanità dei cittadini, cose che sono gli ornamenti più importanti e da riferire fra i primi. Bisogna, dunque, ritornare là da dove avevo iniziato, e rendere il loro merito a coloro che abitano questa città. O piuttosto, ciò che è stato fatto per errore riportiamolo all’arte oratoria; e raccogliamo una buona volta noi stessi, guardiamo di quali argomenti si è già parlato e di quali d’ora in avanti parleremo, per non restare più a lungo in questo errore. Fin qui abbiamo illustrato quali siano le caratteristiche di Firenze. Ora dobbiamo prendere in considerazione quelle dei suoi abitanti. Come, dunque, si suole fare per persone private, vogliamo osservare questo popolo fino dal suo inizio, da quali progenitori sia disceso, ed esaminare quale sia stato in ogni età il suo comportamento in patria e fuori. «Così, penso; incominciamo dal principio» come dice Cicerone11.
Da dove, dunque, ha avuto origine questo popolo? Chi sono stati i suoi progenitori? Da quali mortali è stata fondata questa nobile città ? Imparate a conoscere, o Fiorentini, imparate a conoscere la vostra stirpe e progenie! Considerate quanto siete più illustri di tutte le genti! Tutti gli altri popoli hanno, come progenitori, o profughi o banditi dalle loro sedi, o contadini, o forestieri oscuri ed incerti. Di voi, invece, è progenitore il popolo romano, conquistatore e dominatore del mondo intero. Oh Dio immortale, tanti grandi beni hai elargito a questa sola città, che tutti quelli che sono sparsi in ogni luogo, e che si possono desiderare, sembrano essere stati radunati a suo ornamento!
Di quanto grande importanza è questo primo bene: che cioè la progenie dei Fiorentini abbia avuto origine dal popolo romano! Quale gente c’è stata mai nel mondo più insigne, più potente, più elevata in ogni tipo di virtù, del popolo romano? Le cui imprese sono così illustri che le più eccelse azioni di tutte le altre genti a confronto sembrano giuochi di fanciulli, e il cui impero, esteso quanto la terra, per molti secoli fu governato con tanto straordinaria saggezza che da quella città abbiamo esempi di virtù più numerosi di quanti abbiano offerto tutti gli altri Stati in ogni tempo, e nella quale vissero innumerevoli uomini di cosi elevata virtù, che mai ce ne furono uguali in tutto il mondo. Infatti, per tralasciare tutti gli altri sommi ed insigni condottieri e i più elevati esponenti del senato, dove mai, all’infuori della città di Roma, potrai trovare i Publicoli, dove i Fabrizi, dove i Corruncani, dove i Dentati, dove i Fabi, dove i Deci, dove i Cannili, dove i Paoli, i Marcelli, gli Scipioni, i Catoni, i Gracchi, i Torquati, i Ciceroni? E se nei progenitori ricerchi la nobilità, nessuno potrai trovare in tutto il mondo più nobile del popolo romano; se la ricchezza, nessuno più ricco; se splendore e magnificenza, nessuno affatto più illustre e glorioso; se grandezza d’impero, non c’è luogo, entro i confini dell’Oceano, che con le armi non sia stato sottomesso al suo potere.
Perciò, anche a voi, o Fiorentini, compete, per un certo diritto ereditario, il dominio su tutto il mondo, come possedimento di beni paterni. Ne deriva pure che tutte le guerre che sono fatte dal popolo fiorentino sono giustissime, e che questo popolo nel condurre guerre non può agire senza giustizia, perché tutte le guerre bisogna che le faccia o per la difesa o per il recupero dei suoi beni: e questi due tipi di guerra tutte le leggi e tutti i diritti li permettono. Che se la gloria dei padri, la loro nobiltà, virtù, grandezza, magnificenza rendono illustri anche i figli, non c’è niente in tutto il mondo che si possa anteporre alla dignità dei Fiorentini, dal momento che essi sono nati da genitori che in ogni motivo di lode superano di gran lunga tutti i mortali. Chi c’è fra gli uomini che non riconosca di essere stato conservato dal popolo romano? Chi poi, o servo o liberto, oserebbe gareggiare in dignità con i figli del suo signore o del suo patrono, o penserebbe di dover essere preposto ad essi? Non è, dunque, un piccolo ornamento per questa città avere avuto così illustri progenitori e fondatori.
Ma in quale tempo la stirpe dei Fiorentini è derivata dai Romani? Penso che questa sia una cosa molto importante, perché, a quel che si dice, anche nelle successioni dei re si osserva che a buon diritto si chiama figlio del re uno che è nato nel tempo in cui suo padre aveva la dignità reale; quelli, invece, che sono nati prima o dopo non si considerano figli del re, né possono avere la successione nel regno paterno. E certamente quanto più uno si trova in condizione fiorente ed elevata, tanto più si impegna a compiere azioni illustri e nobili. Si vede, appunto, che gli stessi eventi favorevoli innalzano, non so come, gli animi e infondono grande ardore; sicché gli uomini nobili nessuna cosa possono fare che non sia elevata e magnifica, e quelle che si compiono in quel tempo, avviene che siano le più pregevoli.
Dunque, questa splendidissima colonia dei Romani fu dedotta soprattutto nel periodo in cui l’impero del popolo romano era nelle condizioni più floride, in cui potentissimi re e bellicosissime genti erano state domate con le armi e col valore: Cartagine, Numanzia, Corinto erano state distrutte alle radici; tutte le terre e tutti i mari erano caduti in potere di quel popolo; nessun danno era stato inflitto al popolo romano da alcun nemico. Non ancora i Cesari, gli Antoni, i Tiberi, i Neroni, peste e rovina della Repubblica, avevano tolto la libertà ! Ma era in auge, sacra e inviolata, la libertà, la quale però non molto tempo dopo che questa colonia era stata costituita, fu soppressa da scelleratissimi ladroni. E da ciò io penso che derivi quanto in questa città vediamo essere stato, e continua ad essere, egregiamente al di sopra di tutte le altre: che cioè i Fiorentini godono moltissimo della libertà di tutti e sono fortemente ostili alla tirannide. A mio parere Firenze già da quel tempo ha concepito tanto odio contro gli invasori dell’impero e gli eversori dello Stato, sicché neppure oggi sembra averlo dimenticato; e se di loro resta ancora un qualche nome o traccia, questa Repubblica lo sdegna e odia.
Non sono nuove nel popolo fiorentino queste passioni di parte, e non da poco, come alcuni pensano, ma da molto tempo è iniziata questa contesa. Quando uomini perversi, assalita la Repubblica con la peggiore scellerataggine, abbatterono la libertà, lo splendore, la dignità del popolo romano, allora i Fiorentini furono accesi da questo fuoco, allora questa contesa e queste passioni di parte si diffusero fra loro, e le hanno conservate sempre fino ad ora. E se in tempi diversi le parti sono state chiamate ora con un nome ora con un altro, non per questo sono state diverse. Sempre una e medesima fu la causa, dapprima addotta contro gli invasori dell’impero e poi continuamente mantenuta fino ai nostri tempi. Giusto odio, per Ercole, e più che debito amore per l’antica patria! Chi, infatti, sopporterebbe che l’impero dei Romani, acquistato con quella grande virtù per cui si segnalarono Camillo, Publicola, Fabrizio, Curio, Fabio, Regolo, gli Scipioni, Marcello, i Catoni ed altri innumerevoli santissimi ed onestissimi uomini, questo impero cadesse nelle mani e in potere di Caligola e di simili feroci e sciagurati tiranni, privi di ogni virtù e senza essersi riscattati dai vizi? Una soltanto, e certamente sfrenata, era la loro lotta, per cui si combattevano con tutte le forze.
Infatti nel trucidare i cittadini romani erano impegnati in ogni genere di crudeltà, come se fosse stato proposto loro un grandissimo premio se non avessero lasciato nella città nessun uomo nobile, nessun elevato ingegno, insomma nessun cittadino. Così Caio Caligola, dopo aver fatto la più grande strage che aveva potuto, poiché, data l’ampiezza della città, ancora restavano moltissimi cittadini, stanco ormai dell’uccidere e del trucidare, non riuscendo a saziare la crudeltà del suo animo, pronunziò quella sciagurata espressione che doveva essere testimonianza della sua ferocia: «Volesse il Cielo che il popolo romano avesse una testa sola, che io potessi staccare con un colpo solo»12. E fece proprio così. Mai si saziò del sangue dei cittadini, e avrebbe vuotata del tutto la città se avesse avuto una vita un po’ più lunga. Fu immersa la spada nell’ordine senatorio, furono trucidati i più illustri e migliori cittadini, distrutte completamente famiglie consolari e trionfali; nella città fu lasciata soltanto la plebe, che però Caligola continuava ad uccidere con stragi giornaliere a torme come pecore. A questa tanto mostruosa crudeltà aggiungeva ancora più mostruose scellerataggini, non comuni né consuete, ma inaudite in ogni tempo e mai da ricordare senza abominio: tre sue sorelle furono da lui stuprate una dopo l’altra e poi tenute apertamente come concubine. Questi gli imperatori, questi i magnifici Cesari che alcuni giudicano degni di lode! Che infamie sono queste, che mostri di uomini! Chi si meraviglierà se, in seguito a tali misfatti, Firenze verso quelle forme di governo concepì tanto odio che lo conserva ancora?
Quale sdegno mai c’è stato più giusto di questo? O chi soffriva più del popolo fiorentino nel vedere che il popolo romano, suo padre e fondatore, dopo aver signoreggiato su tutte le terre domate dal suo valore, allora, privato della propria libertà, veniva crudelmente torturato da uomini tanto scellerati? Uomini che, se la Repubblica avesse avuto autorità, sarebbero stati nell’ultima feccia della città. E che non fece Tiberio Cesare? Ma egli regnò prima di Caligola. Non c’è però bisogno di riferire con ordine su persone che furono prive di ordine e di ragione. Che cosa mai si è visto o sentito dire di più fosco e più infame delle crudeltà compiute da Tiberio nel tormentare ed uccidere cittadini romani a Capri, o delle sue sciagurate e mostruose forme di libidine, che egli chiamava «pesciolini» e «spintrie»13, a causa delle quali mi pare davvero una vergogna per l’Italia che in essa ci siano stati tali esempi di scellerataggine? Ma se questi imperatori che ho citato furono mostruosi e rovinosi, forse quelli che vennero dopo furono migliori? Chi furono mai costoro? Davvero Nerone e Vitellio e Domiziano e Eliogabalo? Proprio così. Non è certamente difficile a dire di quanta virtù e di quanta umanità sia stato Nerone. Sua madre Agrippina innalza al cielo con meravigliose lodi l’affetto del figlio; e colui che dimostrò tanto affetto per la madre non si deve certamente considerare crudele o disumano verso gli altri: il quale, anzi, affinché i cittadini non soffrissero di freddo, spinto da compassione, dette fuoco alla città stessa.
O Caio Cesare, come le tue azioni hanno completamente rovinato la città di Roma! Ma mi tratterrò. Ci sono, infatti, di quelli che sopportano male che Lucano, uomo tanto dotto e sapiente, abbia scritto il vero su di te. E forse hanno ragione: perché anche se tu avevi molti e grandi vizi, essi erano coperti da molte e grandi virtù. Perciò nei tuoi confronti è più sicuro tacere. E per lo stesso motivo tralascerò tuo figlio, anche se non ignoriamo da quale causa fosti indotto ad adottarlo. Ma tralascerò tutto, e di lui non rievocherò né la manifesta crudeltà, né le proscrizioni e le stragi di cittadini innocenti, né il tradimento del senato, né gli adultèri e gli stupri. Egli ebbe, come anche aveva avuto suo padre, alcuni vestigi di virtù che rendevano più sopportabili anche i suoi vizi. Ma questi mostri, ai quali avete lasciato l’impero, nessuna virtù li redimeva dai loro vizi, a meno che non sia virtù cercare in ogni modo di distruggere lo Stato e non astenersi da nessuna scellerataggine, per quanto grande sia. Perciò, anche se tralascerò tutte le altre vostre azioni, non posso però dimenticare — e non posso quindi non sdegnarmi contro di voi — il fatto che voi avete aperto la strada ai tanto grandi mali e alle tanto grandi scellerataggini che i vostri successori hanno compiuto con ogni genere di empietà e di iniquità.
«Ma a quale scopo tutto questo?» dirà forse qualcuno. Per due motivi: in primo luogo per dimostrare che questa città non a torto ha preso tali posizioni; poi per far capire che questa colonia fu dedotta in un tempo in cui la città di Roma si segnalava per potere, per libertà, per ingegno, per illustrissimi cittadini. Quando poi il governo dello Stato passò nelle mani di uno solo, quegli splendidi ingegni, come dice Cornelio14, scomparvero: di modo che c’è grande differenza se la colonia fu dedotta allora oppure in tempi successivi, quando ormai ogni virtù e nobiltà della città di Roma era stata estirpata, per cui quelli che da essa emigravano non potevano portare con sé niente di splendido e di nobile.
Ora, dunque, dal momento che Firenze ha tali fondatori, a cui ha ubbidito tutto ciò che c’è nel mondo, domato dalla loro virtù e dalle loro armi, e dal momento che fu dedotta in un tempo in cui il popolo romano libero e saldo si segnalava al massimo per potenza, per nobiltà, per virtù, per ingegni, certamente nessuno può dubitare che questa unica città non soltanto eccella per la sua bellezza, per il suo decoro e per la sua favorevole posizione — come possiamo vedere — ma anche moltissimo per la dignità e la nobiltà della sua gente. Ma ormai passiamo agli altri argomenti.
Discesa, dunque, da questi progenitori, Firenze non si è lasciata corrompere né da trascuratezza né da indolenza; e neppure, contenta per la paterna o avita gloria, ha voluto vivere nell’ozio e nella quiete. Ma pensando che da quanto più illustre luogo era nata, tanto più grandi cose si esigevano da lei, ha così imitato i suoi progenitori in ogni genere di virtù che, a giudizio di tutti, non si è mostrata indegna di tanto nome e di tanta successione.
Infatti, non ha cessato di combattere prima di presentarsi, per così dire, come signora d’Italia, ed ha raggiunto grandezza e gloria non stando seduta ed in ozio, né per mezzo di scelleratezze o di frodi, ma con l’elevatezza delle sue decisioni, con l’assunzione dei pericoli, con l’onestà, con l’integrità, con la continenza, e soprattutto col prendere su di sé la causa e la difesa dei più deboli. E non ha cercato di sopravanzare soltanto nelle ricchezze, ma molto di più nell’attività e nella magnificenza; ha giudicato cosa bella superare le altre città non tanto in potenza quanto in giustizia ed umanità. Con questi sistemi essa ha gareggiato per la supremazia; con questi modi ha conseguito autorità e gloria. E se non li avesse usati capiva che avrebbe degenerato dalle virtù dei suoi antenati, saggiamente ed obiettivamente pensando che altrimenti la nobiltà dei suoi progenitori le sarebbe stata più di peso che di onore. La dignità e la grandezza degli avi illustrano anche i figli soltanto quando anche questi risplendono per la propria virtù; se, invece, sono indolenti o dissoluti, o in altro modo degeneri dalla virtù, lo splendore degli avi non soltanto non copre i loro vizi, ma li scopre. La luce della gloria paterna non permette che qualcosa resti nascosto; e l’aspettativa, e quasi la ripetizione, della virtù ereditaria attirano gli occhi di tutti. Ma se questa speranza fallisce, proprio in considerazione della fama della loro famiglia, i figli si presentano non tanto come persone nobili quanto come persone conosciute. Però la grandezza degli avi come giova ben poco ai degeneri, così quando incontra successori di animo elevato subito vivamente li illumina come per mezzo di una luce moltiplicata. Crescono la dignità e il favore; e gli uomini sono innalzati al cielo quando in un medesimo luogo si scorgono congiunte la virtù propria e la nobiltà degli avi. E ciò è quanto vediamo che accade a questa città, della quale sono note le splendide gesta e i moltissimi e grandissimi esempi di virtù, nei quali è ben facile riconoscere la gloriosa virtù romana ed un’elevata grandezza d’animo. Perciò questa città è onorata per lo splendore e la nobiltà della sua origine, ma ancor più per le proprie virtù e le proprie gesta.
Riguardo all’elevatezza della gente si è detto abbastanza, a mio parere, e del resto questo è un aspetto di per se stesso ben evidente. Resta ora da dire riguardo alla virtù della città, cioè di come essa si è comportata all’esterno e all’interno. Ed è quanto farò molto in breve, perché il mio attuale discorso non permette un lungo parlare su vicende storiche. Mi limiterò esclusivamente ai luoghi. Ma prima di venire a questo argomento, mi sembra bene e necessario premettere qualcosa, ed avvisare anticipatamente affinché qualcuno, spinto da falsa opinione, non mi incolpi di sfrontatezza o di ignoranza: accusa di stoltezza l’una, di leggerezza l’altra, ma ambedue ugualmente da evitare.
Non dubito, dunque, di suscitare in alcuni stolti il sospetto che io con questo mio elogio voglia procurarmi un qualche favore popolare, e che mentre desidero trovare benevolenza e mi do da fare per accattivarmi quanto più le menti delle persone, sia andato molto oltre i confini della verità, e che, per adornare il discorso, abbia mescolato cose vere con cose false. Ora io devo fare imparare a costoro — o piuttosto devo far loro disimparare — che smettano di pensare tutto questo e che lascino da parte ogni sospetto del genere. Io, anche se desidero essere caro ed accetto a tutti — e confesso che lo desidero e bramo moltissimo —, tuttavia mai mi sono spinto a volere ottenere quel risultato per mezzo di blandizie e di lusinghe. Ho sempre pensato che bisogna essere caro alla gente con la virtù, non con i vizi: e da questo elogio non mi aspetto, né chiedo, alcun favore. Sarei davvero stolto se da una cosa così piccola pensassi di potermi procurare il favore di una popolazione tanto grande.
Io, vedendo questa bellissima città, ammirandone moltissimo la superiorità, lo splendore, la nobiltà, le attrattive, la gloria, ho voluto tentare se col mio parlare fossi capace di illustrare tanta bellezza e magnificenza: questa è stata la ragione del mio scrivere, non la caccia alla benevolenza né la ricerca del favore popolare. Sono tanto lontano dall’avere intrapreso questo lavoro allo scopo di conciliarmi il favore della gente, che ho sempre pensato che mi sarebbe andata bene se da questo elogio mi fossi tirato addosso non più che delle malevolenze. Si presentava, infatti, il pericolo che tutti coloro a cui dispiace che Firenze sia in auge, io li avessi ostili proprio per questo mio lavoro: ed anche ora non cesso di averne paura. Ormai tutti gli invidiosi, tutti gli avversari, tutti coloro che da questa città sono stati tormentati, piegati, vinti, o loro in persona o i loro avi, tutti costoro — dico — questo mio elogio me li farà nemici. Così io temo molto di dovermi sobbarcare il grave peso della malevolenza. Ma porrò una condizione che nessuno potrà rifiutare: se dirò qualcosa di falso, di partigiano, di sfacciato, a buon diritto mi siano contrari e nemici; se, invece, le cose che dirò saranno vere, e nel dirle mostrerò moderazione, essi non si dovranno adirare contro di me. Che si può dire più giusto di questa condizione? Chi è così perverso ed iniquo da pensare di doversi sdegnare con me se io desidero esaltare la città per i suoi propri e veri motivi di lode?
Dunque, da tutte le cose finora dette si può capire che io non mi sono indotto a scrivere per la ricerca di favori, e che, d’altra parte, non c’è affatto nessuno che possa a ragione sdegnarsi con me. Ma dal momento che tanto diversi sono i caratteri delle persone, non dubito che si possano trovare moltissimi sui quali poco varranno le mie ragioni. Per alcuni la verità stessa è di per sé odiosa e molesta; altri, o per cattiveria o per ignoranza, non ammettono che sia vero se non ciò che a loro fa piacere: ed essi mi accuseranno di vanità e mi calunnieranno di non aver scritto niente di vero. Tutti costoro io li avviso di non fare i furbi con me, e di non mettersi ad accusarmi alla leggera; ma riflettano bene che cosa pensano che debba essere biasimato, e soprattutto si ricordino che io non parlo da privato della virtù e dell’eccellenza di singoli cittadini, ma di tutta la Repubblica. Perciò se in Firenze ci furono una o due persone di costumi poco corretti, non è giusto che questi casi siano presi come motivo di critica in blocco della città intera, la quale è stata solita non seguire ma perseguire e condannare le azioni degli uomini cattivi.
Del resto mai nessuna città è stata di costumi tanto buoni ed è stata tanto bene ordinata da essere del tutto priva di uomini cattivi. Ma come il retto comportamento di pochi non libera dalla brutta reputazione una moltitudine stolta e perversa, così la perversità e il brutto agire di pochi non devono privare lo Stato dell’esaltazione delle sue nobili azioni. Altre sono le colpe pubbliche, altre le colpe private; e tra di esse c’è moltissima differenza. In quelle private si guarda l’animo di colui che agisce, in quelle pubbliche la volontà dell’intera città. In questo caso non si bada tanto se ciò che pensa uno o l’altro sia conforme alle leggi e alle usanze; ciò che fa la maggior parte del popolo sembra che sia fatto da tutta la città. Negli altri popoli la parte maggiore spesso vince la migliore; in Firenze, invece, pare che sempre la migliore sia stata anche la maggiore. Perciò costoro non mi accusino falsamente e non mi mettano davanti le azioni dei privati, più di quanto alla continenza dei Romani non si rinfacciano i furti di Verre, o al valore degli Ateniesi la viltà di Tersite15. Se vogliono conoscere quanto grande è l’eccellenza di questa città, e come essa è esaltata da me non senza motivo, osservino tutto il mondo, ne scelgano la città che vogliono, e la mettano a confronto con questa nostra non per lo splendore e la bellezza — in cui nessuna in tutto il mondo le è pari —, e neppure per la nobiltà — in cui tutte le altre cedono ad essa senza discussione —, ma per le imprese compiute e per il suo valore. Se costoro faranno questo, incominceranno allora a capire quanta differenza ci sia fra Firenze e tutte le altre città. Non troveranno nessuna che possa corrisponderle in ogni motivo di lode.
In «ogni» ho detto. Mi spiegherò meglio. Se riescono a individuare una città che secondo il parere della gente eccella in qualche genere di virtù, in quello stesso genere in cui si dice che essa sopravanza, facciano la prova. Nessuna se ne troverà che perfino in quel suo particolare genere non sia vinta da questa; e nessuna assolutamente in alcun genere di lode si potrà trovare pari a questa: no nella fedeltà, no nell’attività, no nell’umanità, no nella grandezza d’animo dei suoi cittadini. Portino nella contesa la città che vogliono: Firenze non teme il confronto con nessuna. Cerchino per tutto il mondo una città che in una qualunque specie di virtù si pensa che abbia conseguito la più grande gloria; si faccia il paragone dei fatti più illustri, perfino in ciò in cui quella sembra eccellere: non potranno trovarne una — se non vogliono ingannare se stessi — di cui Firenze non sia di gran lunga superiore. La virtù di questa città è da ammirare, ed è esempio insuperato in ogni motivo di lode.
Infatti, lasciando da parte la prudenza, che a giudizio di tutti si riconosce a questa sola città nel massimo grado, e per la quale vediamo che essa in ogni tempo ha provveduto a tutto con grandissima diligenza, riguardo a quale altra città si è sentito dire che abbia dimostrato tanta beneficenza quanta vediamo che questa ne ha dimostrata e ne dimostra? Sembra addirittura che essa abbia sempre pensato a fare del bene a quanti più possibile, e quindi tutti potessero esperimentare la sua liberalità, soprattutto quelli che più erano nel bisogno. Così tutti coloro che, o cacciati per sedizioni, o allontanati per invidia, si trovano banditi dalla loro patria, tutti quanti si raccolgono a Firenze, quasi come loro unico rifugio e riparo. Perciò non c’è ormai alcuno in tutta Italia che non pensi di avere due patrie: privatamente ciascuno la sua propria, pubblicamente la città di Firenze. Ne deriva che questa viene ad essere, in un certo senso, la patria comune e l’asilo sicurissimo dell’Italia intera, al quale tutti da ogni parte, quando ne hanno bisogno, si possono rifugiare, e nel quale vengono accolti dai cittadini con grandissima disponibilità e benevolenza. Così diffuso è in questa città il sentimento della beneficenza e dell’umanità, che pare gridare con chiara voce, e a tutti apertamente testimoniare, che nessuno pensi di essere senza patria finché ci sarà la città dei Fiorentini. A questa proclamazione di benignità seguono fatti ancora più importanti della stessa promessa. I profughi non soltanto sono accolti benevolmente, ma anche, se non ne sembrano del tutto indegni, sono aiutati con mezzi e denaro: e avvalendosi di questi, essi possono poi rimanere dignitosamente in Firenze, se così preferiscono, o ritornare alle loro case. Forse non è questa la verità ? Forse qualche malevolo oserà negarlo? Di questa realtà ci sono quasi infinite persone che possono dare testimonianza; le quali, trovandosi in gravi condizioni economiche, perché cacciate ingiustamente dalle loro città, furono sostenute con denari pubblici e per l’aiuto di Firenze poterono ritornare nella loro patria.
Testimoni sono anche moltissime città che, trovandosi oppresse da congiure di vicini e da violenze di tiranni, sono state aiutate con consigli, con mezzi, con denari, e salvate in tempi difficilissimi. Tralascio i patti stretti per opera di Firenze fra popolazioni in discordia, tralascio le legazioni da essa inviate a rappacificare gli animi, là dove ribolliva l’ira: situazioni in cui questa città sempre interpose prontamente la sua autorità. Non si puo, dunque, chiamare beneficentissima la città che per il vantaggio degli altri ha compiuto queste tante e tanto importanti azioni? O ben degnamente lodare per così grande virtù e per tanti meriti? Essa mai ha sopportato le offese recate ad altre città, né è rimasta silenziosa spettatrice delle altrui sventure. Ma in primo luogo, con ogni impegno, ha cercato, con le sue parole e la sua autorità, di ricomporre i contrasti, placare le inimicizie e, se possibile, consigliare la pace; e quando tutto ciò non si poteva concludere, aiutò sempre la parte che veniva offesa da più potenti di lei. Così in ogni tempo ha difeso i deboli, quasi stimando suo compito che nessun popolo d’Italia subisse rovina. Così né per desiderio di pace né per paura alcuna, è stata indotta ad acconsentire che una qualche repubblica venisse sottoposta ad offese; e neppure ha mai pensato di poter starsene in tranquillità e pace mentre una qualche altra città, o alleata o amica o almeno non nemica, fosse in pericolo. Ma subito levandosi su, e prendendo su di sé la causa altrui, si è schierata nel mezzo contro la violenza nemica, e ha protetto quelli che sembravano ormai sul punto di andare in rovina e li ha aiutati con forze, mezzi, denari.
Chi, dunque, per così grande beneficenza e liberalità loderà mai abbastanza Firenze? O quale città c’è in tutto il mondo che si possa paragonare ad essa in questo genere di meriti? Quale ha impiegato tanti denari, ha sostenuto tanto gravi fatiche per aiutare gli altri? Ha protetto tanti in pericolo? E certamente quando una città aiuta gli altri nei pericoli, è necessario che costoro la riconoscano come loro patrona. E quella che è patrona, chi negherà che precede le altre per dignità, per potenza, per attività, per autorità ?
A questa beneficenza e liberalità è congiunta l’ammirevole fedeltà che questa Repubblica ha sempre conservato inviolata con una straordinaria costanza. Sempre essa ha pensato che prima di promettere bisogna riflettere a fondo; ma una volta fatta una promessa in nessun modo si deve ritrattare. Avendo badato a questo fin da principio e avendo stimato che è giusto così, mai per nessuna specie di vantaggio ha potuto essere indotta a violare patti, accordi, trattati, giuramenti, promesse. A suo giudizio alla dignità di uno Stato niente conviene di più che mantenere fermezza in tutte le parole e in tutti i fatti; niente le è più contrario che non conservare le promesse. Un simile comportamento è, invece, proprio degli uomini scellerati, i quali sono particolarmente nemici degli Stati. Del loro numero è chi dice: «Ho giurato con la lingua, ma la mente non ha giurato»16’: una cosa che questa giustissima città mai ha ritenuto che le fosse lecita. Così in ogni situazione con grande prudenza è giunta a promettere; ma ciò che una volta ha promesso, ha pensato che non poteva cambiarlo più di quello che non dipende da lei.
Inoltre in questa città la fedeltà e l’integrità hanno avuto tanta importanza, che con grandissimo scrupolo essa ha rispettato i diritti anche dei nemici; e neppure in questo campo si potrebbe trovare che mai abbia mentito. Ne è derivato che anche i nemici mai hanno esitato a ricercare la fedeltà di questa Repubblica, e anche presso di loro il suo nome ha sempre avuto una grandissima autorità. Di ciò è prova ben manifesta il fatto che alcuni uomini, che prima erano stati apertamente suoi nemici, vollero affidare i loro figli e le loro fortune alla custodia di questo popolo, considerando la fedeltà e l’umanità dimostrate dalla città: due doti delle quali l’una appariva prontissima a perdonare le offese e ad assumersi un ufficio, l’altra ad adempiere con totale giustizia ciò su cui ci si è impegnati. E la speranza non li ingannò, perché i beni amministrati con estrema scrupolosità furono restituiti ai loro proprietari. Di conseguenza non solo coloro che avevano avuto fiducia in questo popolo pensavano di non essersi sbagliati, ma anche gli altri erano attratti dal loro esempio. Sempre questa città ebbe cura che a ciascuno fosse dato con attenzione il suo e che in ogni affare l’onestà fosse anteposta all’utilità: anzi, niente ha giudicato utile che allo stesso tempo non sia anche onesto.
Fra le molte ed eccelse virtù di cui vedo fornita Firenze, nessuna generalmente mi appare più notevole e più elevata — e nella quale più si riconosce la stirpe e la virtù dei Romani — della grandezza d’animo e del disprezzo del pericolo da parte dei suoi cittadini. Di quale altra virtù, se non di quella romana, può essere segno l’aver combattuto in guerra in ogni tempo, l’avere affrontato gravissime contese e gravissime lotte, e — cosa che è ancora più rara ed ammirevole — nei più gravi pericoli e nelle situazioni più difficili mai essersi abbattuti né aver perso niente della propria grandezza d’animo? L’imperatore irato era alle porte della città, minacciando fuoco e rovina; e con lui c’era tutta la fazione degli avversari, stretti insieme, pronti alla morte17. Gli accampamenti dei nemici erano entro la prima pietra miliare; tutti i luoghi intorno alle mura rimbombavano del frastuono delle loro armi e delle loro grida. Un tempo Annibale era andato verso Porta Collina con manifestazioni non più ostili di quelle con cui quel mostro si scagliava allora contro le mura di Firenze. A tutto ciò si aggiungeva il fatto che la parte delle mura che più era di fronte agli accampamenti nemici in quel tempo appariva poco fortificata: e così si pensava che non ci sarebbe stato alcun cittadino capace di prendere le armi o di stare saldo di mente. Ma quella fortissima città disprezzò le minacce ed il furore di costui: tanto che, mentre egli per molti giorni stette fuori in gozzoviglie, dentro la città in nessun punto si diffuse la paura. Tutto, anzi, si continuò a fare come se non sovrastasse pericolo alcuno, e nessuna forza nemica fosse vicina. Per le strade tutte le botteghe, tutti i granai erano aperti; nessuna interruzione del lavoro, addirittura nessuna sospensione nell’amministrazione della giustizia. E quando tutto questo venne riferito all’imperatore, egli, preso da ammirazione per la superiorità e la forza d’animo della cittadinanza, tolse l’assedio.
Firenze però non soltanto è stata forte nel resistere, ma anche terribile nell’assalire, cioè nel vendicarsi delle offese ricevute. Essa mai ha voluto fare del male ad alcuno se prima non fosse stata attaccata; ma una volta offesa si è dimostrata una decisissima combattente per la sua dignità, perché in ogni tempo questo l’ha caratterizzata: ardere di un’incredibile ambizione di lode e di gloria. Perciò sempre si è indirizzata a compiere cose straordinarie e difficilissime: e nell’attuarle non ha avuto paura né della grandezza dei pericoli né di quella delle fatiche. Potrei ricordare le fortificatissime città conquistate, i quasi innumerevoli trofei di vittorie da questa città innalzati sui popoli vicini, le splendide imprese militari compiute quando il popolo fiorentino usciva con le armi. Ma non è questo il momento per poter riferire tante diverse vicende di guerra e tanto grandi imprese compiute; esse richiedono un’esposizione propria e davvero grande, che io, come spero, un giorno o l’altro mi accingerò a fare: e quindi a tramandare con scritti in quale maniera ogni cosa sia stata realizzata da questo popolo. Per il momento riferirò soltanto uno o due casi come esempio, affinché da essi si possa capire quanto eccelsa sia stata la virtù di questa città anche in tutti gli altri.
Antica e nobile città dell’Etruria è Volterra, ma è collocata su monti così elevati che a mala pena possono arrivarvi uomini senz’armi18. I Fiorentini incominciarono ad attaccarla. Il loro valore, abituato a superare tutte le situazioni più difficili, non temeva né l’asprezza del luogo né la posizione in cui si trovavano, ad essi svantaggiosa per il combattimento. Quando, dunque, le schiere dei soldati fiorentini, giunte in quei luoghi, incominciarono a salire sul monte e quelle della città balzarono giù dalle altissime rocche, da una parte e dall’altra si combatté con estremo accanimento. Il numero dei combattenti era quasi uguale fra le due parti, diverse invece la forza d’animo e la pratica del combattimento. Ma la conformazione del luogo favoriva molto i Volterrani. Avresti potuto vederli non solo impedire dall’alto la salita degli avversari con spade e lance, ma anche far rotolare giù enormi pietre per il pendio. Dall’altra parte i Fiorentini si sforzavano di salire su per le stesse asprissime rupi: e di fronte al loro tentativo non resistevano né le pietre né i nemici, né alcuna asprezza del monte. E così, passo dopo passo, giunsero sul monte vincendo l’opposizione dei nemici; e ricacciati i Volterrani dentro le mura, i nostri al primo assalto presero la città, che pure era ben guarnita di mura. Tutto questo fece il popolo fiorentino senza alcun aiuto di altri, ma conducendo la guerra da solo e combattendo per la sua dignità e la sua gloria.
Ora, mentre a tutti questa impresa deve apparire straordinaria, certamente quelli che hanno visto Volterra ne rimangono meravigliati. È noto a tutti che nessuna città d’Italia è più fortificata di questa; e in quell’occasione, inoltre, era piena di molti uomini audaci, che combattevano accanitamente per la casa e il focolare. Tuttavia i Volterrani furono superati da un valore più grande. Chi, dunque, non si meraviglierebbe del fatto che questa fortissima città fu conquistata in un sol giorno? Chi non glorificherebbe il valore di quelli che la presero? Di tal genere sono, dunque, le imprese di Firenze, di tal genere la sua virtù e la sua forza. Con questa grandezza d’animo essa spesso ha piegato i Senesi, spesso ha abbattuto i Pisani, spesso ha domato nemici potenti e tiranni.
Ma fatto eccezionale è che Firenze ha affrontato grandi fatiche e grandi lotte, non tanto a suo vantaggio ma a vantaggio di altri. Essa ha pensato che moltissimo conveniva alla sua autorità e alla sua dignità esporsi a pericoli per il bene e la libertà di altri, e molti difendere con la sua assistenza. I Pisani, gente mai in pace con questa città, provocavano con la guerra i Lucchesi, amici ed alleati dei Fiorentini19. Alla fine si azzuffarono in battaglia campale, e le forze dei Lucchesi furono sconfitte e molti di essi furono fatti prigionieri. Allora i Fiorentini, che per caso in quel tempo avevano posto gli accampamenti nel contado di Pistoia, venuti a conoscenza della sconfitta degli amici, non si perdettero affatto d’animo, né ebbero timore dei Pisani insuperbiti per la vittoria. Lasciata la fortezza che stavano assediando, si lanciarono dietro ai vincitori, li raggiunsero prima che potessero rientrare in Pisa, e, assalitili vigorosamente, capovolsero la loro vittoria: gli stessi Lucchesi, che venivano condotti prigionieri, fecero prigionieri un grandissimo numero di Pisani sfuggiti alla strage, e li portarono legati a Lucca. Così il valore dei Fiorentini salvò i Lucchesi, umiliò i Pisani vittoriosi, e a se stessi procurò gloria e lode. Ma in questa straordinaria impresa di Firenze che cosa si dovrebbe lodare di più? Forse il valore per cui i suoi cittadini riuscirono a vincere? Oppure la grandezza d’animo per cui si misero ad inseguire i vincitori? Oppure, ancora, la nobile disposizione per cui affrontarono così grave contesa per la salvezza degli amici? A me sembra che tutte e tre le cose in questa particolare impresa siano da lodare moltissimo. Ma ora non posso fermarmi ad esaltare ognuna di esse con sue specifiche lodi: temo di essere troppo lungo, proprio mentre premono cose più importanti.
Firenze non soltanto ha offerto il suo aiuto singolarmente a questa o a quella città, ma nello stesso tempo all’Italia intera. Essa, infatti, ha giudicato comportamento meschino avere sollecitudine esclusivamente per i propri interessi; comportamento nobile, invece, fare sì che moltissime genti potessero godere dei frutti delle sue fatiche. Perciò, animata da tali sentimenti, Firenze ha combattuto per il bene di città vicine; e tutte le volte che un qualche tiranno confinante o un avido potente minacciava le popolazioni, gli si è opposta, rendendo ben chiaro a tutte le genti che per lei era un fatto di patriottismo combattere per la libertà d’Italia. E non solo essa è stata animata da tali sentimenti, e li ha realizzati, ma alla sua pietosa e giusta volontà ha assentito un grandissimo favore di Dio. Non voglio raccontare vicende troppo lontane: dirò di quelle del nostro tempo, anche se vedo che a tutti è ben noto che questa città ha liberato l’Italia intera non una volta soltanto dal pericolo della servitù. Ma tralasciamo tutto il resto e prendiamo in considerazione quello che è stato fatto pochissimo tempo fa.
Si potrà trovare uno che sia tanto corto d’ingegno e tanto lontano dalla verità, da non riconoscere che tutta quanta l’Italia sarebbe caduta in potere del nemico Ligure se questa città da sola, con le sue forze e le sue sagge decisioni, non avesse resistito contro la potenza di costui?20 Chi c’era in tutta l’Italia che avrebbe potuto stare a pari di lui per mezzi ed energia? O chi avrebbe potuto sostenere il suo assalto, dal momento che il suo nome stesso faceva paura a tutta la gente? E la sua fama già atterriva non soltanto l’Italia ma anche i popoli al di là delle Alpi. Per mezzi, denari e uomini, ma ancor più per intelligenza e furbizia egli era forte. Aveva una potenza enorme e veramente da far paura. Tutte le regioni della Gallia Cisalpina, quasi tutte le città che si trovano dalle Alpi fino alla Toscana e alla Romagna tra i due mari, erano sotto il suo potere e a lui ubbidivano. In Toscana aveva dalla sua parte Pisa, Siena, Perugia, Assisi, e alla fine aveva occupato anche Bologna. Inoltre molte città, molti uomini potenti o nobili nella loro patria, spinti o dalla paura o dalla speranza di rapine o anche da perfidia, seguivano il suo nome e la sua fortuna. A tanto grandi e a tanto diffusi mezzi non mancavano gli accorgimenti. Ma egli avrebbe potuto essere ben più felice, felice dico, se il suo impegno, la sua attenzione, la sua sagacia le avesse esercitate in buone attività. Mai un uomo ha preso più astute ed energiche deliberazioni. Era presente ovunque, niente lasciava intatto, niente intentato. Attirava a sé alcuni col denaro, altri con doni, altri con dimostrazioni d’affetto e con promesse. Seminando discordie metteva in urto fra loro tutti i popoli d’Italia, e quando erano mal ridotti, sopraggiungendo con la sua forza, li soggiogava. In tutti i luoghi, infine, si propagavano le sue astuzie e i suoi inganni.
Tutti gli altri Stati, vedendo le sue enormi forze, erano atterriti e si adattavano alle circostanze. Ma la grandezza d’animo dei Fiorentini non potè essere atterrita, e così essi non vollero rinunziare alla loro antica dignità. Sapevano che era proprio della stirpe romana il combattere contro i nemici per la libertà d’Italia; sapevano che i loro antenati avevano combattuto contro i Cimbri, contro i Teutoni, contro i Galli, che non avevano avuto paura né della ferocia di Pirro né dell’astuzia di Annibale, che non avevano evitato mai fatica alcuna per difendere la propria dignità e la propria autorità, e che in grandissimi pericoli si erano procurati grandissima gloria. E questo i Fiorentini ritenevano che dovevano fare anch’essi se volevano conservare lo splendore a loro lasciato dagli avi. Tutto ciò ripensando fra sé, il popolo di Firenze si avviò alla guerra con animo tanto saldo e forte da essere deciso o a vivere con gloria o per la stessa gloria ad andare incontro alla morte. E così considerò cosa bella difendere il luogo ricevuto dagli avi, fino a non stimare mai alcuna ricchezza più della dignità, e ad essere disposto a mettere a rischio denaro e vita per la libertà, sempre decidendo con saggezza e insieme con coraggio. Le ricchezze, i denari e tutti gli altri beni simili sono premi dei vincitori; colui che in tempo di guerra li risparmia e, mentre con quelli potrebbe tutelarsi, preferisce tenerseli, fa più gli interessi del nemico che i suoi. Spinta da tali sentimenti questa città si oppose con straordinaria decisione a quel potentissimo e ricchissimo nemico. E così, colui che poco prima signoreggiava su tutta l’Italia e pensava che nessuno avrebbe potuto resistergli, fu costretto a chiedere la pace, a starsene spaventato entro le mura di Pavia, e, infine, non solo a lasciare le città della Toscana e della Romagna, ma anche a perdere larghissima parte della Gallia.
Oh incredibile grandezza e virtù di questa città ! Oh veramente gente romana e stirpe romulea! Chi
dunque, in seguito a così eccelsa altezza intellettuale e così eccelsa grandezza di gesta non accoglierebbe con eccezionale favore il nome di Firenze? Che cosa di più grande, che cosa di più splendido avrebbe potuto compiere questa città, e in quale impresa avrebbe potuto fare maggiormente mostra della virtù dei suoi avi, da lei conservata in se stessa, che nell’essere riuscita, col suo impegno e le sue forze, a liberare l’Italia dal pericolo della servitù? In seguito a tale azione ogni giorno da tutti i popoli a Firenze sono state rese dimostrazioni di gratitudine, lodi e ringraziamenti, da essa poi rivolte all’immortale Iddio: perché essa è stata sempre tanto modesta da attribuire questi illustri fatti più all’aiuto divino che al suo valore. E così non si è inorgoglita nelle situazioni favorevoli, e la collera non ha accompagnato le sue vittorie: mai si è scagliata contro tutti coloro verso i quali avrebbe avuto ragione di sdegnarsi, ma ha conservato sempre un profondo sentimento di umanità verso i vinti: in tal modo quelli che avevano conosciuto la sua forza in guerra, ne sperimentavano poi la clemenza nella vittoria. Del resto fra le altre somme virtù di questa città c’è quella di avere sempre salvaguardato la sua dignità; e non ha avuto più a cuore il compimento di grandi imprese, che il mantenimento del suo onore nel realizzarle. Né si è esaltata oltre giusta misura nelle prosperità, né si è abbattuta nelle avversità. Dalla modestia nelle situazioni favorevoli, dalla costanza nelle avverse, dalla giustizia e dalla prudenza in tutte, ha conseguito una fama eccelsa ed una grandissima gloria presso tutti i mortali.
Come è da ammirare per i suoi comportamenti esterni, Firenze lo è pure per i suoi costumi e le sue istituzioni interne. In nessun altro luogo c’è tanto ordine, in nessuno tanta correttezza, in nessuno tanta armonia. Allo stesso modo che nelle corde di uno strumento musicale c’è accordo, per cui, quando sono mosse, da suoni diversi nasce un’unica melodia, della quale niente c’è di più gradito e soave a udirsi, così questa prudentissima città ha regolato tanto bene tutte le sue parti che ne deriva un insieme, per così dire, tanto conforme a se stessa, che con la sua armonia fa piacere alle menti e agli occhi di tutti. Nessuna cosa c’è in essa disordinata, nessuna sconveniente, nessuna disdicevole, nessuna instabile; tutte hanno il loro posto, non solo fisso ma anche conveniente: distinti sono gli uffici, distinte le magistrature, distinti i processi, distinti gli ordini. Ma tutte queste cose sono distribuite in maniera tale che si accordano alla suprema autorità dello Stato come i tribuni al supremo comandante.
In primo luogo, dunque, con ogni cura è stato provveduto a che nella città sia rispettato il sacrosanto diritto, senza il quale uno Stato non può esistere né può essere chiamato tale; poi che ci sia la libertà, senza la quale questo popolo mai è stato disposto a vivere. A questi due elementi insieme congiunti tendono tutte le istituzioni ed i provvedimenti di Firenze, come ad un determinato segno e porto.
Per l’amministrazione della giustizia sono stati stabiliti magistrati con l’autorità di punire i malvagi, e soprattutto di provvedere affinché in città il potere di qualcuno non abbia maggior forza delle leggi. Ai magistrati, dunque, sono costretti a sottostare ed ubbidire, e a rispettarne le insegne, tutti i privati cittadini, e così le persone di grado inferiore. Però con molte garanzie si è provveduto a che gli stessi custodi delle leggi, collocati in una autorità elevatissima, non credano che sia stata loro affidata non la custodia dei cittadini ma la tirannide, e così, mentre tengono a freno gli altri, sia limitata in qualcosa la completa libertà. Innanzi tutto la più alta magistratura che, in un certo modo, sembrava avere la forza dell’autorità regale, è stata contenuta con l’attribuirla non ad una sola persona, ma a nove, e non per un anno ma per due mesi. In tal maniera Firenze pensò che lo stato poteva essere amministrato bene, dal momento che la pluralità avrebbe eliminato l’errore nelle deliberazioni, e la brevità del tempo l’arroganza.
Essendo, dunque, la città divisa in quattro settori21, affinché a nessuno di essi manchino mai le cariche onorifiche, da ciascuno dei quartieri si scelgono due cittadini, e non a caso, ma già da tempo graditi al popolo e giudicati degni di tale onore. A questi otto cittadini per governare lo Stato se ne aggiunge un altro, elevato in virtù e autorità, tratto a vicenda da quegli stessi quartieri, il quale sia il più importante in quel collegio; egli, per il fatto che amministra la giustizia contro i sediziosi, è dotato di un vessillo. Questi nove cittadini, a cui è stato affidato il governo della Repubblica, la città ha voluto che abitino esclusivamente nel palazzo pubblico, affinché siano più pronti nel trattare gli affari dello Stato, e che non escano senza il seguito di una scorta armata, affinché la loro autorità appaia ancor più elevata22. Ma poiché talvolta si presentano situazioni in cui pare che ci sia bisogno di più approfondita deliberazione, sono stati aggiunti dodici buoniuomini, col compito di provvedere al governo della città insieme con i nove precedenti. Furono aggiunti poi i gonfalonieri di compagnia, ai quali, quando c’è bisogno di prendere le armi per difendere la libertà, corre tutta la popolazione e li segue. Questi stanno anche in consiglio, e, come i precedenti magistrati, sono scelti dai quartieri, e tengono il potere per quattro mesi.
Ma questi tre collegi non hanno l’autorità di deliberare su tutte le questioni: la maggior parte di esse, quando sono state approvate da loro, viene riproposta al Consiglio popolare e generale, perché la città giudicò conforme al diritto e alla ragione che ciò che riguarda molti sia deciso proprio col parere di molti. In questo modo fiorisce la libertà, e la giustizia è osservata in città con ogni rispetto, dal momento che niente può essere stabilito dall’arbitrio di uno o di un altro contro il parere di tante persone.
Questi uomini, dunque, consigliano lo Stato, sanciscono i diritti, abrogano le leggi, salvaguardano l’imparzialità. Ad amministrare la giustizia secondo le leggi e a punire di spada provvedono magistrati minori; e questi non sono cittadini, ma forestieri chiamati proprio a tale scopo da lontano nella nostra città23, non perché i cittadini non sappiano farlo — e lo fanno proprio ogni giorno in città di altri —, ma affinché a causa dell’amministrazione della giustizia non nascano fra i cittadini odi ed inimicizie. I più, infatti, ingannati da eccessivo amore per se stessi, si attribuiscono più diritti di quanti siano riconosciuti dalle leggi, e anche se i giudizi sono stati giusti, hanno da lamentarsi nei riguardi dei magistrati. Inoltre, parve cosa grave che in una città libera un cittadino pronunzi una sentenza capitale contro un altro cittadino; colui che avesse fatto ciò, anche se lo avesse fatto in piena giustizia, fra gli altri cittadini sarebbe apparso disonorato e meritevole di condanna. Per questi motivi i giudici sono fatti venire da lontano, e sono loro fissate le leggi da cui in nessun modo è permesso allontanarsi, anche perché le ricevono sotto giuramento di osservarle, e poi, quando sono sul punto di andarsene, devono rendere conto al popolo della gestione del loro incarico quasi come commessi di negozio. E così in ogni cosa dominano il popolo e la libertà.
Inoltre, affinché in una città tanto vasta sia più facile a chiunque farsi riconoscere il proprio diritto e, mentre i magistrati sono occupati con alcuni, ad altri non manchi l’applicazione della giustizia e delle leggi, a certi collegi è stato dato il potere di indagare e giudicare fra di loro, come ai mercanti, agli agenti di cambio e ad altri ancora: alcuni di loro hanno anche l’autorità di arrestare membri della loro consorteria. Ci sono pure altri magistrati istituiti o per ragioni pubbliche o per motivi di pietà; fra di essi ci sono gli ufficiali delle gabelle e i sovrintendenti dell’erario; e ancora i protettori dei pupilli e dei loro beni: una magistratura, quest’ultima, utile per lo Stato e per i privati cittadini, e paternamente e vantaggiosamente creata da questa così benefica città.
Ma di tutte le magistrature, che in Firenze sono molte e di grande importanza, nessuna è più illustre, né discesa da più bello inizio e motivo, di quella dei capi della Parte degli ottimati24: sulla cui origine non sarà forse fuori del nostro argomento dire qualcosa, affinché si possa meglio comprendere la sua elevatezza. Sarà una brevissima digressione, non inutile, a mio parere, né immeritevole di essere conosciuta.
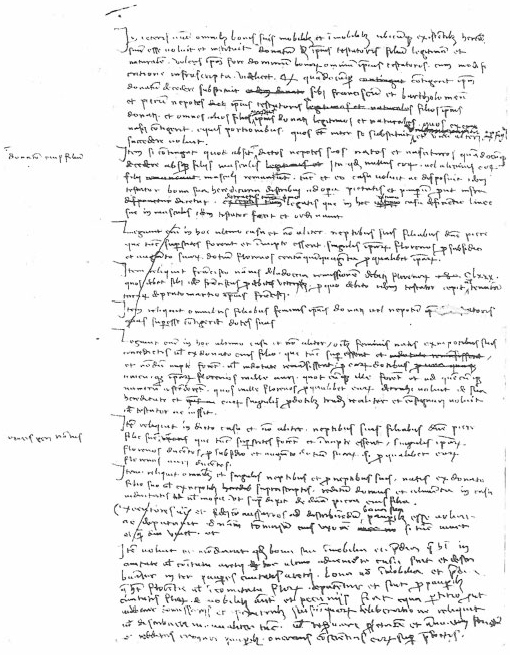
Una carta del testamento autografo di Leonardo Bruni
(Firenze, Archivio di Stato, Notarile antecosimiano, B 207, fol. 136 v.).
Dopo la sconfitta subita presso l’Arbia, poiché pareva che per quel gravissimo colpo in nessun modo Firenze si potesse difendere, tutti i cittadini che erano di animo nobile e generoso, per non vedere signoreggiare nella città coloro che apertamente avevano tradito la patria, lasciarono le case ereditate dagli avi, e con le mogli e i figli se ne andarono a Lucca, imitando quell’eccezionale e lodatissimo comportamento degli Ateniesi, che durante la seconda guerra persiana lasciarono la città per potere, una volta o l’altra, abitare in essa da liberi25. Con questa intenzione, dunque, gli egregi cittadini che erano sopravvissuti a quella terribile strage uscirono dalla città, pensando che in tal modo avrebbero avuto maggiore possibilità di vendicarsi, che se, rimasti chiusi entro le mura, avessero aspettato la fame o la distruzione della città. Giunti così a Lucca, e radunati i loro parenti, che per l’avverso esito della battaglia si erano dispersi, si rifornirono tanto di armi, di cavalli e di ogni strumento di guerra che tutti ammiravano la loro elevatezza d’animo e la loro prontezza. Dopo aver compiuto molte prove di forza in varie parti d’Italia, recando aiuto agli amici, vincendo col loro valore e la loro audacia quelli della fazione avversa, e infine riportando vittoria in tutti i luoghi ove combattevano, quando pensarono che fosse arrivato il tempo che tanto desideravano, cioè il tempo di cancellare l’onta e le macchie della patria, andarono contro Manfredi, il re di Sicilia, — perché costui era il capo della parte nemica in Italia e aveva mandato i suoi soldati all’Arbia — avendo per guida un eccellente ed ottimo condottiero che il papa aveva fatto venire dalla Francia per abbattere l’insolenza di Manfredi26. Ora, io riferirei ben volentieri sullo straordinario valore che essi, una volta giunti in Puglia, dimostrarono in ogni luogo, se a questo punto fosse possibile fare un ampio racconto. Per dire quanto più in breve possibile, essi si dimostrarono tali che anche quel duro nemico fu costretto a lodare il loro valore e la loro superiorità. Piegata, dunque, la Puglia, ucciso il nemico, dopo aver ricevuto solennemente lodi e doni dal re, ritornarono in Etruria. Cacciati, quindi, dalla città quelli che governavano con danno dello Stato, e quindi ben vendicatisi dei nemici vicini, crearono per sé un Collegio e vi misero a capo i più elevati personaggi, che fossero alla guida del partito degli ottimati e capi di quella legittima ed illustre unione27.
Partita da tale inizio, questa magistratura ha moltissima autorità nella città. E posta, infatti, come a guardia e custodia affinché la Repubblica non defletta dal corso tenuto dagli avi, e il governo dello Stato non passi ad uomini di sentimenti diversi. Quello, dunque, che furono in Roma i censori, in Atene gli areopagiti, a Sparta gli efori, questo sono nella città di Firenze i capi della Parte guelfa: cioè essi sono, fra i cittadini che si preoccupano del bene dello Stato, gli uomini più elevati, eletti per difendere la Repubblica.
Sotto questi magistrati il governo di Firenze è scrupoloso ed esemplare: nessuna casa è stata mai amministrata con maggior cura sotto un buon padre di famiglia. Qui nessuno può subire offesa, e nessuno perde il suo, a meno che non lo voglia. Sempre ci sono pronti i giudici, pronti i magistrati, aperto è il palazzo del comune, aperto il supremo tribunale. In questa città sono sempre possibili le lagnanze nei riguardi di qualunque persona; e gli organi giudiziari sono stabiliti con saggezza ed opportunità, e sempre disposti a dare aiuto. E non c’è alcun luogo sulla terra in cui il diritto sia più imparziale con tutti; in nessun luogo c’è tanta libertà e tanta parità di condizione fra i più elevati e i più umili cittadini. Anche in questo è dato riconoscere la saggezza di questa città: e non so se non sia la più grande di tutte le città. Dato che sembrava che i più potenti, fidandosi delle loro forze, volessero offendere e disprezzare i deboli, la Repubblica di suo prese su di sé la causa di quelli che avevano meno possibilità, e con pene più gravi protesse le loro case e le loro persone. Stimò anche giusto che, come sono differenti le condizioni della gente, differissero anche le punizioni da applicare, e giudicò saggio e giusto offrire più aiuto a chi più ne aveva bisogno. Così da ordini diversi è stata prodotta una certa parificazione, dal momento che i cittadini più elevati li difendeva la propria potenza, i più bassi lo Stato, gli uni e gli altri il timore della punizione. Da tutto ciò è nata quella voce, che tante volte sentiamo venire alzata contro i più potenti: quando costoro fanno qualche minaccia, gli altri dicono subito: «Anch’io sono cittadino di Firenze». Con queste parole sembra che vogliano attestare, ed apertamente avvertire, affinché nessuno li disprezzi per la loro piccolezza né intenda minacciar loro del male per la sua potenza; uguali, dunque, le condizioni di tutti, dal momento che lo Stato stesso promette di vendicare i più deboli. Però Firenze non difende soltanto i suoi cittadini ma anche i forestieri. A nessuno essa permette che venga recata offesa; ma, sia cittadino sia forestiero, si impegna perché a ciascuno venga riconosciuto il suo. Questa stessa giustizia e uguaglianza della città, mentre produce disponibilità e cordialità fra i cittadini — dal momento che nessuno può troppo inorgoglirsi o disprezzare gli altri —, produce anche benevolenza verso tutte le persone.
Ma ora riguardo all’onestà della vita e riguardo alla rettitudine dei costumi, in considerazione di questo tempo, chi potrebbe riferire abbastanza degnamente? Certo, in questa città ci sono ingegni altissimi, e qualunque cosa si accingano a fare, facilmente superano tutti gli altri uomini. Sia che seguano la strada delle armi, sia che si rivolgano al governo della Repubblica, sia che si dedichino a qualche studio o a qualche scienza, oppure alla mercatura: insomma, nell’affrontare qualunque cosa e in ogni attività, superano di gran lunga tutti. Non tralasciano, i Fiorentini, di giungere in qualunque luogo di popolazioni lontane: pazienti nelle fatiche, presenti nei pericoli, avidi di gloria, capaci nelle decisioni, industriosi, liberali, magnifici, allegri, affabili e soprattutto cortesi.
Che dovrei dire, infatti, della dolcezza del loro parlare e dell’eleganza delle loro parole? In questo campo Firenze supera certamente tutte le altre città: si pensa che essa sola, nell’Italia intera, parli una lingua purissima e bellissima. Così tutti coloro che vogliono parlare bene e correttamente prendono esempio da lei. Essa ha uomini che in questo linguaggio volgare e comune farebbero apparire tutti gli altri come fanciulli. Lo studio poi delle lettere, non certo quelle da poco e meschine, ma quelle che sono degne degli uomini liberi, che sempre sono fiorite in tutti i popoli più elevati, in questa città hanno grandissimo sviluppo.
Di quale pregio, dunque, è priva questa città ? O che cosa le manca per la più alta lode e per il più alto splendore? Forse la nobiltà della progenie, a lei che è discesa dal popolo romano? Forse la gloria, a lei che ha compiuto imprese straordinarie, e ogni giorno le compie, con tanta virtù e tanto impegno, in patria e fuori? Forse lo splendore degli edifici, forse gli ornamenti, forse la pulizia, forse le ricchezze, forse la grande quantità della popolazione, forse la salubrità e l’amenità dei luoghi? E che c’è oltre a tutto questo che una città possa desiderare? Certo, niente.
Che cosa, dunque, diremo? O che cos’altro resta da fare? Che cos’altro, se non che adorare e ringraziare il sommo Iddio per un beneficio così grande, e a lui rivolgere questa preghiera: «Tu, dunque, Dio onnipotente e immortale, le cui chiese e i cui altari questo tuo popolo onora con tanta devozione; e tu, Santissima Madre, a cui in questa città viene innalzato un tempio immenso di puro e nitido marmo, che abbracciando il tuo dolcissimo figlio sei insieme madre e purissima vergine; e tu, Giovanni Battista, che questa città ha preso per suo patrono: questa bellissima e splendidissima città e il popolo suo difendeteli da ogni avversità e da ogni male».
1. Cfr. VERG., Aen. 6, 623-626.
2. Cfr. HOM., Od. 19, 205.
3. Il riferimento è a Gian Galeazzo Visconti e alla guerra da lui scatenata contro Firenze dopo il 1387; cfr. la successiva nota n. 20.
4. Cfr. HEROD., 3, 137; CIC., Cato 33; OV., met. 15,288; VAL. MAX., 9,12 ext. 9.
5. Cfr. HOM., II. 1l,57; XENOPH., Hell. 6,1,25; PLAT., rep. 338C.
6. Cfr. PLAT., leg. 704-707.
7. Cfr. SEN., Tro. 7-8.
8. VERG., Acn. 2, 254-255.
9. VERG., Aen. 2, 374-375. Sono parole dette da Androgeo, un guerriero greco che nella furia dell’assalto contro Troia credette di avere incontrato un gruppo di commilitoni greci, a cui rimprovera il ritardo nella battaglia, mentre, invece, erano soldati troiani con Enea.
10. Cfr. LIV., 28,46,7 e 30,1,10.
11. Cfr. CIC, Phil. 2,44.
12. Cfr. SUET., Cal. 30.
13. Cfr. TAC, ann. 6,1; SUET., Tib. 43-44; 60. Riguardo al termine «spintriae» e ad un altro di valore analogo, «sellaria», indicanti le mostruose oscenità compiute e fatte compiere da Tiberio, Tacito nota: «Tunc primum ignota antea verba reperta sunt».
14. Cfr. TAC., bist, 1,1. Il discorso sull’origine di Firenze è qui appena accennato; troverà più spazio soprattutto nelle Historiae florentini populi, pp. 5-6, dove viene specificato che la fondazione della città avvenne al tempo e per opera di Siila: il quale, per ricompensare i soldati romani dei servizi che gli avevano reso, avrebbe dato loro il territorio di Fiesole e la parte di pianura sottostante. La scelta cronologica dell’età di Siila, corrispondente a quella dell’età repubblicana, era determinata dall’avversione ideologica verso l’età imperiale, sentita come riduttrice e negatrice di ogni forma di libertà. Il Bruni veniva così a modificare la tradizionale convinzione medievale che vedeva in Cesare il fondatore di Firenze.
15. Gaio Verre, dopo essere stato questore, legato in Oriente e pretore urbano, fu propretore in Sicilia dal 73 al 71 a.C; nel 70 venne denunciato dai Siculi e in seguito alle accuse, per loro conto formulate da Cicerone, si autoesiliò. Tersite per Omero (IL, 2,211 sgg.) è il più turpe dei Greci, tanto che meritò la punizione di Ulisse; il nome è divenuto sinonimo di insolenza e di tracotanza, di demagogia e presunzione, ma anche di vigliaccheria.
16. Cfr. EURIP., Hipp. 612 apud CIC., off. 3,108.
17. Il Bruni si riferisce qui all’assedio di Firenze fatto da Arrigo VII nel 1312; l’imperatore aveva posto il suo accampamento a Porta Aretina, dove le fortificazioni non erano state ancora completate: cfr. Historiae, pp. 108-109. Per il successivo riferimento ad Annibale e a Porta Collina cfr. LIV. 26,10,10.
18. Volterra, alleata con Pisa e governata dal partito ghibellino, venne assalita dai Fiorentini nel 1254; l’impresa fu particolarmente difficoltosa a causa dell’asprezza del territorio: cfr. Historiae, pp. 29-30.
19. Alleata di Firenze contro la ghibellina Pisa, nel 1252 Lucca subì una sconfitta da parte dei Pisani a Montopoli; ma in un successivo scontro sull’Era ottenne la vittoria sugli stessi Pisani con l’aiuto dei Fiorentini: cfr. Historiae, p. 28.
20. Il riferimento è alla guerra portata da Gian Galeazzo Visconti, signore (conte, poi dal 1395 duca) di Milano, contro Firenze a partire dal 1387, e poi conclusasi nel 1402 con l’improvvisa morte, avvenuta a Marignano, del Visconti, poco dopo aver riportato una vittoria, che sembrava decisiva per le sue fortune, sui Fiorentini a Casalecchio ed aver conquistato Bologna. Il Visconti è qualificato come «ligure» perché il suo dominio si estendeva anche alla Liguria.
21. Firenze fu suddivisa in quattro quartieri — Santo Spirito, Santa Maria Novella, San Giovanni, Santa Croce — nel 1343, dopo una precedente ripartizione in sestieri, nell’ambito della riforma istituzionale promossa dopo la cacciata del duca d’Atene, Gualtieri di Brienne (cfr. Historiae, pp. 165-169). Ciascuno dei quattro quartieri era a sua volta diviso in quattro gonfaloni.
22. Si tratta dei Priori — la suprema magistratura della Repubblica, istituita nel 1282 (il numero, subì alcune variazioni: inizialmente tre, poi sei, dodici e infine otto, due per quartiere dopo il 1343) — e quindi del Gonfaloniere di giustizia (attivato nel 1289), che rivestiva un ruolo primario rispetto agli stessi Priori. Nel governo dello Stato erano ad essi affiancati i sedici Gonfalonieri di compagnia (istituiti nel 1289) e i Dodici Buoniuomini (istituiti nel 1321) che, con i Priori, formavano i Tre maggiori uffici e partecipavano ai Consigli opportuni, cioè all’assemblea legislativa.
23. Si tratta del Capitano del Popolo e del Podestà, già presenti a Firenze nel 1280.
24. La Parte guelfa si diffonde nella seconda metà del Duecento assumendo una progressiva e crescente influenza in ambito cittadino: nel 1267 ha già conseguito un ruolo politico di guida e riferimento generali in seguito alla sconfitta della fazione ghibellina: proprio l’amministrazione dei beni espropriati ai ghibellini serve alla Parte per difendere e potenziare le idee guelfe, strettamente collegate con quelle della Chiesa. I Capitani della Parte sono la magistratura più importante e rappresentativa, ma non l’unica, della Parte guelfa, che a lungo, per lo meno per tutto il Trecento, si identifica direttamente con lo Stato.
25. Cfr. HEROD. 7,3,41; 8,2,41; 9,1,6.
26. Manfredi di Svevia, figlio dell’imperatore Federico II, re di Sicilia dal 1258 e capo della fazione ghibellina, fu riconosciuto per tre mesi signore di Firenze dopo la sconfitta dei Fiorentini sull’Arbia, a Montaperti, nel 1260 e la conseguente instaurazione del governo di Guido Novello. Contro Manfredi fu organizzata, nel 1265, una coalizione guidata da Carlo d’Angiò e voluta dal papa Alessandro IV, che già negli anni precedenti aveva cercato di fermare Manfredi con le truppe del cardinale Ottaviano Ubaldini. Manfredi fu poi sconfitto nel 1266 nella battaglia di Benevento, dove morì (cfr. Historiae, PP. 34-37).
27. Nell’ambito della temporanea riforma delle istituzioni fiorentine voluta da Guido Novello nel tentativo di riequilibrare la forza dei Guelfi, cresciuta dopo la vittoria di Benevento, fu attivato il Collegio delle arti del popolo. Ma la situazione non durò a lungo perché Guido Novello abbandonò poco dopo Firenze, dove tornarono trionfalmente i Guelfi. L’anno successivo, cioè nel 1267, il papa revocò a sé il governo della Toscana nominandovi come suo vicario Carlo d’Angiò (cfr. Historiae, pp. 48-51).