La vita tornò a Tōkyō, in due righe.
Takeshi, come preso da una smania di definizione, cercò di riassumere le due righe in una soltanto: si sarebbero sposati, avrebbero vissuto sotto lo stesso tetto. Lui, Yui e Hana.
A Yui ufficialmente non lo domandò, e non perché gli mancasse il garbo o la fermezza, ma perché dopo tutto quel che c’era stato tra loro, gli sembrava la conclusione più ovvia. Tutto spingeva là.
Quando una domenica pomeriggio Takeshi le disse che maggio sarebbe stato un bel mese per la festa di nozze, Yui trasalì. Cercò di non darlo a vedere, neppure quando lui le domandò più o meno a quanti invitati pensava, o se preferisse la cerimonia in stile giapponese o occidentale.
Yui restò vaga, accennò al fatto che registrare i nomi al Comune e fare una piccola festa sarebbe stato sufficiente per lei. Stare al centro dell’attenzione la metteva a disagio.
Nel domandarsi il perché di quel discorso iniziato, non dal principio, bensì già da metà, Yui avvertiva la responsabilità di una dimenticanza. Si persuase che la domanda le fosse stata rivolta in precedenza, e che lei, banalmente, in quel momento fosse distratta. Fu certa di aver detto di sì.
Del resto era un sì, di questo era convinta. Eppure d’improvviso tutto correva e lei arrancava.
Dalla reazione di Hana, che entrò in soggiorno mentre ancora il discorso era in corso e colse brandelli di frasi, capì che si trattava a tutti gli effetti di una grande notizia. La bambina si precipitò ad abbracciarla e quello, più ancora del gesto di Takeshi di sfogliare il calendario in cucina e con un pennarello rosso tracciare un cerchio sulla prima settimana di maggio, la spaventò.
Fu da quel momento che sentì, più che una gioia, un disagio. Una imprecisata paura.
Takeshi le telefonò di prima mattina, aveva urgenza di sentirla per accordarsi sulla sera. Se è un cinema che sia un film di animazione, se è una cena che sia okonomi-yaki, le mani in pasta, le palette in aria e quei papponi di riso e farina che tanto piacevano a Hana.
Tuttavia il cosa mangiare era un dettaglio, perché da giorni Yui gli appariva sfuggente e quello sgusciare di misura dalle sue braccia, il posizionare sempre in un dopo la conversazione (qualunque fosse il tema), iniziavano a impensierirlo.
Due giorni prima, diretti a Ginza dove dovevano ordinare le fedi, le aveva toccato la spalla salendo in metropolitana e aveva avuto la netta impressione che Yui si fosse ritratta. Quella stessa sera, accennando a un mal di testa, era sgattaiolata via prima della fiaba per Hana. E così anche la sera successiva.
Intuiva che qualcosa accadeva, ma di qualunque cosa si fosse trattato era altrettanto chiaro che Yui non voleva parlarne.
Takeshi giustificava quella improvvisa ritrosia col fatto che anche per le cose belle serviva del tempo. Non c’era sottrazione o aggiunta che non richiedesse un lavoro di aggiustamento nel corpo. Il matrimonio si avvicinava, il trasloco, l’impacchettamento e lo spacchettamento della vecchia vita.
Il lutto, gli aveva detto una volta Yui, è come qualcosa che si mangia ogni giorno, un panino fatto a piccoli pezzi e ingurgitato con calma. Oggi l’orecchio del pane, il granello rimasto di riso, domani il giallo spaccato del limone. La digestione era lenta.
La gioia quindi, pensava Takeshi, non doveva essere una cosa poi tanto diversa.
La telefonata giunse che Yui era già in radio, in sala regia. La sera prima, durante la diretta, aveva sentito un fischio fastidioso in cuffia, ma era troppo tardi e tutti avevano deciso comunque di tornare a casa. Ora però serviva appurare la causa, sfilando e infilando i jack, calibrando i volumi, verificando da dove provenisse quello sgradevole fischio.
Il tecnico, chino sul pannello tappezzato di leve, comandi, schermi e pulsanti, sembrava vicino alla soluzione. «Questo cavo è usurato, va cambiato. Riproviamo di nuovo.»
Yui annuì e si spostò ancora in sala registrazione. Era la settima volta e iniziava a essere stanca.
«Adesso? Prova a parlare.»
«Prova prova prova.»
«Come va ora?»
«Non sento più niente!» replicò sollevata. «Finalmente… pare risolto.»
Rientrando, il cellulare riprese a vibrare.
«Se devi rispondere, fai pure, io scendo a parlare con la contabilità», disse il tecnico adocchiando lo schermo che lampeggiava sul piano della regia. «Mi allontano un momento.» Yui fece per controbattere qualcosa ma quello era già uscito spedito, con un fascicolo in mano.
Per quanto discreta come Yui aveva richiesto, si preparava una festa di nozze, i nomi trascritti ufficialmente sulla stessa facciata del foglio al Comune, le seggiole pieghevoli su cui immaginarsi vicini per sempre, un buffet in un ristorante italiano che affittava il locale per occasioni così.
Forse a Takeshi serviva sapere se aveva chiesto ai colleghi delle allergie alimentari, se il vestito di Hana era pronto, se erano arrivati i documenti necessari dal suo Comune di nascita. Se era triste per qualcosa, perché.
Eppure a Yui tutte le domande che riceveva parevano una soltanto, ripetuta e ostinata, camuffata sotto ogni altra: “Sei pronta Yui? Sei davvero pronta?”.
Il telefono rilasciò un ultimo trillo, poi si placò. Seguì la notifica di un messaggio, quindi di nuovo ammutolì.
Lesse: «Ti aspettiamo per le 19. Hana dice che vuole mangiare ancora okonomi-yaki. Che dici? A dopo comunque!».
Lo rilesse: “Yui, sei pronta? Sei davvero pronta a noi?”.
Da almeno tre giorni, nei momenti meno opportuni, le si parava davanti l’immagine della ragazzina cresciuta in cui, presumibilmente, si sarebbe trasformata un giorno Hana.
Capelli più fitti e più lunghi, annodati in una coda aggressiva. La vedeva attraversare la porta di casa, senza annunciare il ritorno, lasciando cadere il borsone a terra, all’ingresso, e la casa che rimbombava di colpo. Le vedeva addosso la divisa del liceo, le gambe che faticava a immaginare meno sottili di allora, ma tant’è. Erano di certo muscolose, perché probabilmente faceva tennis o lacrosse.
«Oggi come è andata?» domandava.
E Hana, brusca: «Sono stanca, non mi serve la cena».
E bam, porta della camera sbattuta e fine della giornata.
Poi cambio di scena.
Ora c’era Yui che, pur senza riuscire a vedersi, sapeva d’esser più anziana. Erano entrambe in cucina, lei che sciorinava il menù della cena (o forse il programma del weekend?), e Hana che aveva una smorfia di scorno sulla bocca, frasi di sprezzo per lei, proprio per lei che in origine non era famiglia. Aveva forse detto una parola sbagliata? L’aveva criticata? O magari le aveva negato qualcosa? Qualcosa a cui lei teneva?
Probabilmente non se la meritava tutta quella rabbia, ma era questione di ruoli. Quasi sempre lo era.
E poi di nuovo fondale che cambia, sipario che s’apre.
Adesso erano in un terzo luogo che non era né l’ingresso né la cucina. Si ritrovava sulle labbra la tiritera dei compiti, studia, vacci piano con i ragazzi, che una volta che lo fai poi è per tutta la vita, fidati non te lo dimentichi più, e questa gonna, Hana, troppo arrotolata alla vita (tutte le ragazzine lo fanno, anche Hana di certo lo farà), e questo rossetto troppo rosso spalmato sulla bocca, è volgare, non è adatto alla tua età.
Sulla soglia della sua stanza, alla fine, inseguendola mentre lei si divincolava: «Hana, esci? Con chi?».
«E a te, Yui? Che te ne frega?»
«Sono tua madre e…»
«Non sei mia madre, non ti devo nulla.»
La verità era che: (uno) anche ad essere Akiko non sarebbe cambiato comunque nulla, (due) non si sarebbe mai azzardata a mettersi addosso quella parola. La terrorizzava almeno quanto l’idea che le potesse venir nuovamente sottratta.
Ecco, da giorni si immaginava Hana adolescente, in lotta con loro, con Takeshi e soprattutto con lei, scene slacciate che vedevano Hana impegnata in quella guerra a priori che era farsi adulta. Era faticoso per tutti, genitori e figli, figuriamoci quanto sarebbe stato gravoso per Yui.
Già quando era rimasta incinta della sua bambina, ricordava di essersi domandata come l’avrebbe potuta affrontare da adolescente. La spaventava a morte quella fase della vita e ricordava di averlo accennato alla ginecologa mentre, alla dodicesima settimana di gravidanza, le esplorava la pancia. E la dottoressa, guardando il minuscolo esserino sulla schermata, e la faccia sgomenta di Yui, si era fatta una grossa risata.
Il tecnico in quel momento rientrò nella cabina di regia: «Che faccia scura, Yui-san. Tutto bene?».
O invece no, magari c’era da avere paura di una cosa tutta diversa. Del contrario magari: Hana tanto remissiva da rendere l’adolescenza una promessa non mantenuta. O peggio, un’occasione sprecata. Si sarebbe censurata perché Yui non era sua madre? E se avesse trattenuto quel lato tutto ribellione e accusa che era invece fondamentale a quell’età?
Questo, di nuovo, sarebbe stato tremendo e sarebbe stata tutta colpa sua, di Yui che in fondo non era famiglia.
«Senti, facciamo un’ultima prova?» disse rivolgendosi al tecnico, brusca. «Quel fischio durante la diretta di ieri mi ha reso nervosa.»
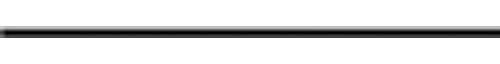
Nella settimana che seguì, ovunque le tornavano in mente quelle scene. Alla cassa quando doveva pagare un cespo di lattuga e un grappolo d’uva, in fila per il bagno in stazione, mentre premeva il pass all’ingresso dell’edificio della radio. L’assillava la sensazione più o meno costante d’essere incapace di amare Hana per bene, soprattutto in quei frangenti di tempesta.
Ecco, ecco cos’era, si disse una mattina davanti allo specchio, mentre si ispezionava la faccia. Il punto non era sposarsi, e neppure lasciare la casa. Il punto era diventare la madre di Hana.
Ricordava di averci messo almeno tre mesi a sentirsi innamorata di sua figlia. E l’aveva partorita lei, aveva avuto nove mesi per abituarsi all’idea. Figuriamoci cosa sarebbe successo con una creatura che non era sua, nella inevitabile fase in cui ti veniva contro come un ariete.
Tutta concentrata nell’ansia di essere o non essere amata a sufficienza, Yui capì d’aver tralasciato il lato più attivo della faccenda.
Era in grado di amare Hana? Sarebbe stata capace di raggiungere quel livello di imprudenza? Sgridarla? Dirle «ora falla finita»?