Yui in radio adesso teneva due programmi diurni. Aveva rinunciato a lavorare la sera, perché amava cenare in famiglia. Con Takeshi e con Hana ripercorrevano la giornata e, dopo le nozze, prese a unirsi con più frequenza anche la madre di lui.
Yui avrebbe giudicato moleste certe domande a raffica con cui la suocera la accoglieva quando rientrava e considerò, proprio come Akiko, eccessiva la sua logorrea. Eppure non gliel’avrebbe fatta pesare. Le sarebbe stata grata piuttosto, perché Yui, a parlare fuori dallo studio di registrazione, non era da tempo più brava. Amava stare in silenzio, sul bordo della casa, con la prospettiva di quel grumo di calore e bellezza che era nel centro, Hana e Takeshi, lei stessa, nelle scene quotidiane che si snodavano tutte uguali in soggiorno, in cucina o nella stanza da letto.
Quando ritrovava su quei volti amati, cedimento e stanchezza, li accarezzava persino con più piacere. Yui adorava i volti affaticati e sbattuti ma quelli a cui lo diceva, o non le credevano o la prendevano come una falsa lusinga. Sembrava una dichiarazione sottintesa: “sembri stanco, ma non sei brutto così”. C’era persino chi si infastidiva. Eppure Yui era sincera, i volti stanchi erano i più affascinanti per lei. Talvolta si domandava se non fosse stato anche grazie agli incontri a Shibuya alle quattro della mattina, al volto stravolto dal sonno, che si era innamorata così di Takeshi.
Il suo nuovo bambino, quello che un giorno sarebbe gemmato dentro di lei, lo stesso che quel primo giorno a Bell Gardia Yui non avrebbe neppure lontanamente immaginato, lo avrebbe scoperto solo da grande, che sua madre amava la fragilità. L’aveva vista nuda, precisa come una definizione del vocabolario, nelle persone intorno a lei.
Era accaduto durante quel mese consecutivo che aveva trascorso, con l’anima a pezzi, in una palestra aggrappata alla montagna, con vista sul mare. Non un mare qualsiasi, ma un oceano avanzato e poi arretrato sulla terra.
La fragilità Yui l’aveva conosciuta soprattutto dentro di sé, in ogni interstizio di quegli interminabili anni, dal marzo 2011, al giorno in cui aveva incontrato Takeshi, e infine a quello in cui avrebbe finalmente preso in mano la cornetta del Telefono del Vento e avrebbe parlato con sua madre e sua figlia.
Della propria friabilità, Yui non amava parlare. L’aveva però alla fine accettata e quello era stato il modo per ricominciare a prendersi cura di sé. La collegava alla parte più autentica di una persona, l’unica in grado di far sentire le persone vicine, partecipi delle vicende degli altri.
Se glielo avessero domandato adesso, sarebbe stata sicura. La vita consumava, col tempo creava innumerevoli crepe, fragilità. Erano però proprio queste a decidere la storia di ogni persona, a far venir voglia di andare avanti per vedere cosa sarebbe successo poco più in là.
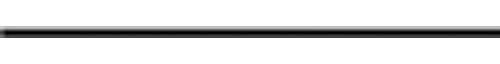
Yui un giorno avrebbe pianto, e sarebbe stato insieme un battesimo e un funerale.
Sarebbe scesa alla stazione di Yokohama per portare Hana e il loro bimbetto di un anno a vedere il Museo di Anpan-man, e quello avrebbe avuto lo zainetto da shinkansen premuto sul dorso, quello verde smeraldo e rosa che serviva il Giappone del nord-est. In un momento, il piccolino avrebbe cercato di divincolarsi dalla stretta del padre, cui stava in braccio, per lanciarsi verso le scale mobili che adorava in discesa almeno quanto temeva in salita.
E mentre arrivava il treno nell’opposta direzione, colpendo d’una sferzata la banchina che si apprestavano tutti insieme a lasciare, il bambino avrebbe gridato «Mamma!», e l’avrebbe fatto con una tale chiarezza, da lasciare tutti di stucco.
Quel giorno, senza preavviso, le sarebbe stata restituita quella parola.
Sì, il figlio di Yui e Takeshi l’avrebbe chiamata per la prima volta.
Yui si sarebbe fermata, con la bottiglietta del tè in una mano e la manina di Hana nell’altra.
«Cosa? Cosa ha detto?» avrebbe domandato al marito, in terza persona, mentre una frotta di turisti cinesi li avvolgevano come una sciarpa.
«Ha detto mamma.»
Eccola l’ultima banalità sorprendente, la migliore di tutte.
Nella confusione della stazione, con la voce disciplinata che ripeteva le direzioni, gli arrivi, i minuti di sosta e le uscite, si sarebbero fermati tutti quanti, intuendone l’importanza.
Con l’unico braccio libero, stringendo in una posa acrobatica il figlio, Takeshi avrebbe accolto anche Yui. E sarebbe stato un contagio, proprio come diceva sua madre. Perché Hana avrebbe colto di quella parola il potere, e anche lei avrebbe detto mamma, «Mamma», Mama e lo avrebbe ripetuto eccitata, come una formula magica che rallegra gli adulti e rende euforici i bimbi.
Dopo averla chiamata per anni «Yui» o «Yui-chan», arrivava «Mamma» e di lì in poi le tre parole si sarebbero sempre alternate senza un preciso motivo.
Ecco come nasceva la gioia. Era in una parola restituita, che sempre le avrebbe ricordato il prima, e avrebbe cementificato il dopo. Come quel vento che veniva a crearsi lì, proprio lì, tra i due treni che scivolavano nella stazione di Yokohama e ripartivano svelti, accorrendo in una direzione e precipitandosi in quella opposta.
Tutto tornava, bastava chiamarlo con il giusto nome.
Era possibile che nel perimetro di una stessa parola potessero convivere sentimenti tanto diversi? Si poteva usarla in un senso, senza che l’altro si trascinasse dietro come una coda?
No, probabilmente non si poteva, così come era impossibile evitare di far mangiare a Hana cioccolata senza che si inzaccherasse tutta, o che il loro bambino imparasse a camminare senza procurarsi una quantità esorbitante di contusioni.
Bisognava renderla forte quella parola, farne un nome con cui essere ripetutamente chiamata, anche trenta volte in un’ora.
Yui comprese che l’infelicità aveva sopra le ditate della gioia. Che dentro di noi teniamo premute le impronte delle persone che ci hanno insegnato ad amare, a essere ugualmente felici e infelici. Quelle pochissime persone che ci spiegano come distinguere i sentimenti, e come individuare le zone ibride che ci fanno anche soffrire, ma che ci rendono diversi. Speciali e diversi.
Glielo avrebbe confermato anche Takeshi, quella sera e per tutti gli anni a venire:
«Più vado avanti, più me ne convinco» disse. «Che siamo tutti fermi al tempo della prima parola.»