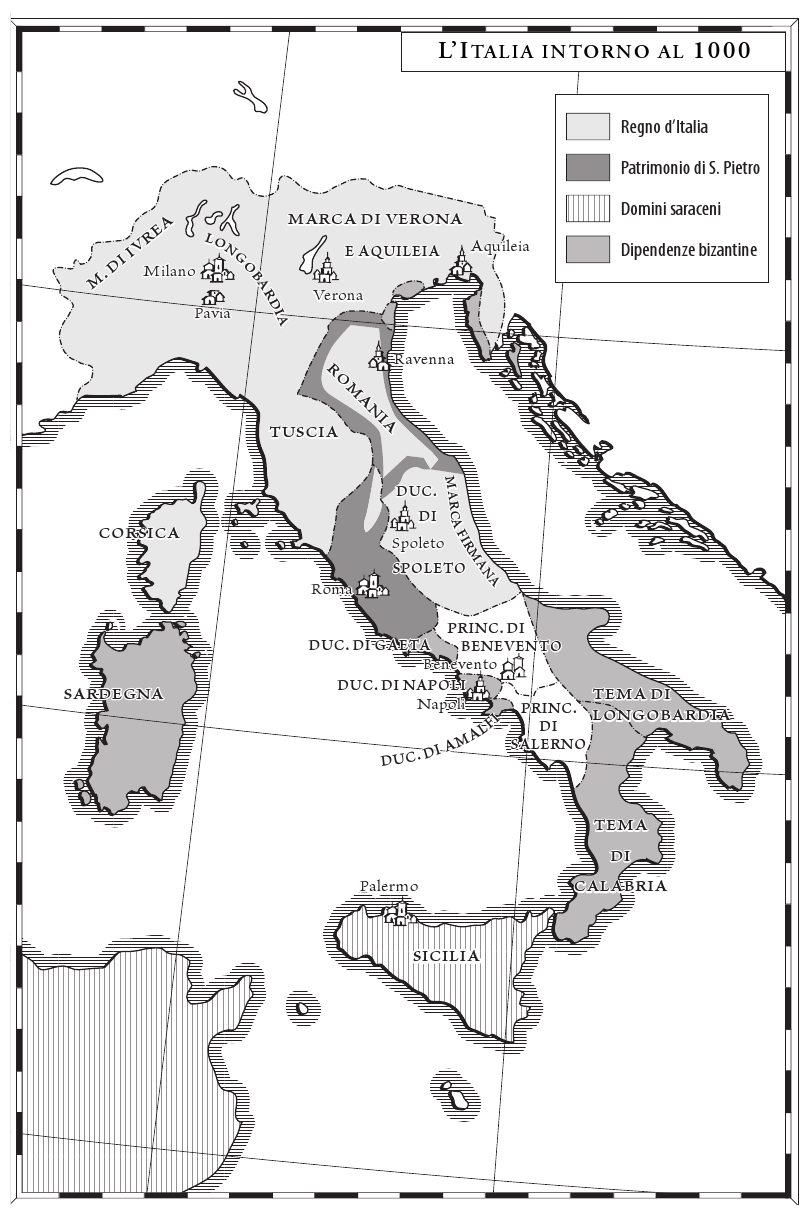CAPITOLO SECONDO
LA RIFORMA DELLA CHIESA
Quando salì al Soglio col nome di Silvestro II, Gerberto trovò una situazione abbastanza quieta. Ma solo in apparenza. Arroccati nei loro castellacci sui colli romani, i Crescenzi e i Tuscolo che, sebbene discendenti dallo stesso ceppo (quello di Teofilatto e di Marozia), fin qui si erano fatti una guerra senza quartiere, trovarono alla fine una base di accordo nella comune paura di Ottone e delle sue milizie. Essi sobillarono i popolani di Trastevere contro i tedeschi. Non fu una sollevazione, ma uno stillicidio di disordini, che alla fine costrinsero l’Imperatore e il Papa a lasciare la città. Intendevano tornarci entrambi, appena ricevuto qualche rinforzo dalla Germania, perché di milizie ne avevano poche. Ma Ottone fu colto dal vaiolo e morì a Paterno. I soldati che ne scortarono la salma fino alle Alpi dovettero aprirsi la strada sempre combattendo contro le bande di quei signorotti, che si erano prosternati ai piedi dell’Imperatore, quando questi era sceso in Italia.
Silvestro poté rientrare a Roma, ma solo per graziosa concessione di Giovanni Crescenzio, figlio del decapitato di Castel Sant’Angelo. Ci domandiamo con che animo tornò, quel povero Papa, praticamente prigioniero. E infatti l’anno dopo era già morto anche lui: avvelenato, si disse, dalla vedova del suppliziato. Crescenzio, che si era fatto acclamare Patrizio, gli nominò a successore un certo Siccone, che prese il nome di Giovanni XVII. Quanto contasse, lo dimostra il fatto che molti annalisti ecclesiastici non lo elencano nemmeno nella lista dei Papi. Durò poco, e passò la mano a un altro pupillo di Crescenzio che, col nome di Giovanni XVIII, non aspettò di essere venuto a noia al suo incomodo protettore, e si ritirò prima di questa pericolosa congiuntura, andando a seppellirsi nell’abbazia di San Paolo.
Crescenzio morì nel 1012 insieme all’ultimo suo Papa, Sergio IV. Il potere passò ai Tuscolo, che lo esercitarono in maniera anche più personale ed esclusiva. Il loro capostipite si proclamò «Senatore di tutti i Romani», che voleva essere qualcosa più di Patrizio, e suo fratello fu eletto Papa col nome di Benedetto VIII. Furono due satrapi, ma non senza grandezza. Riuscirono a propiziarsi il nuovo imperatore Enrico II, che venne a farsi incoronare nel 1013; e alla testa di un esercito ben organizzato tennero a bada non solo le dissidenze interne, ma anche il nemico esterno, rappresentato in quel momento dai Saraceni, continuamente all’assalto delle coste italiane fino a Pisa. Lo stesso Papa si dimostrò buon Generale e buon Ammiraglio. Comandò di persona le sue milizie e ottenne parecchi successi. Se si sia guadagnato altrettanti meriti come cristiano e pastore d’anime, non si sa; ma è un problema che non doveva troppo turbarlo.
Alla sua morte nel 1024 la successione al Soglio fu risolta in maniera scopertamente dinastica. Fu lo stesso suo fratello Senatore a salirvi col nome di Giovanni XIX, e nessuno obiettò, come se fosse ormai pacifico che la tiara faceva parte del patrimonio ereditario dei Tuscolo. Infatti, morto anche Giovanni, essa passò a un suo nipote, che aveva dodici anni e fu incoronato come Benedetto IX.
Un Papa ragazzo lo si era già visto con Giovanni XII. Benedetto ne ricalcò le orme dando sfogo ai suoi capricci infantili, ma ogni tanto interrompendoli per affrontare anche problemi più gravi. Questo per lo meno dicono certe cronache che gli attribuiscono decisioni coraggiose e importanti come l’indizione di due Sinodi, la deposizione dell’arcivescovo Ariberto di Milano, la canonizzazione del monaco Siracusano. Ma noi crediamo che tutto questo sia stata opera dei suoi collaboratori e che egli si sia limitato a mettervi la firma.
Comunque, è un fatto che nel 1044 il popolo alla fine si sollevò, e la situazione che ne seguì è forse la più ingarbugliata nella ingarbugliatissima storia della Chiesa. Benedetto fuggì, e i Romani elessero Silvestro III. Poi Benedetto tornò, e fuggì Silvestro. Ma intanto erano stati eletti Gregorio VI e Clemente II, mentre l’Imperatore aveva nominato un altro Papa per conto suo: Damaso II. Non abbiamo speranza che il lettore ci si raccapezzi, anche perché non ci riescono nemmeno gli annalisti ecclesiastici. Costoro elencano nello stesso periodo quattro Papi, più Silvestro III che viene considerato Antipapa.
Il caos durò due anni, fino al 1045 quando al Soglio salì, col nome di Clemente II, un Vescovo tedesco, Sigieri di Bamberg. Con lui e coi suoi tre successori, tedeschi anche loro – Damaso II, Leone IX e Vittore II –, entrò nella Chiesa un’aria nuova: quella della grande riforma che saliva dal basso dei monasteri. Prima delle vicende e lotte in cui questi Pontefici si trovarono coinvolti, è di questo spirito rigeneratore che bisogna render conto al lettore.
Sarebbe infatti da miopi pensare che i guai della Chiesa si limitassero al vertice, cioè al Papato. Se l’organismo fosse stato sano avrebbe impedito ai nobili romani di disputarsene la guida. Ciò avveniva perché il sangue era marcio. E il più grave dei mali che lo minavano era la simonia, cioè la vendita delle cariche ecclesiastiche. Esse si chiamavano «benefici», e lo erano in tutti i sensi.
Questo mercato era talmente entrato nell’uso che lo si praticava alla luce del sole, senza neanche salvare le apparenze. I Vescovati erano all’incanto in tutti i Paesi europei. E i concorrenti non mancavano perché l’investitura, oltre a forti influenze politiche, procurava al titolare terre e redditi. L’investitura insomma era anche un investimento come oggi sono le case, i titoli azionari e le aree fabbricabili. Un padre ricco e previdente assicurava l’avvenire di suo figlio comprandogli, secondo le possibilità, una diocesi o una parrocchia. A Narbona un ragazzo di dieci anni fu fatto addirittura Arcivescovo per centomila soldi. E perfino una donna onesta e pia come la madre di Ghiberto di Nogent comprò un canonicato per suo figlio undicenne.
A lucrare di questo commercio non erano solo il Papa e la Chiesa. Anche i sovrani temporali si consideravano in diritto di esercitarlo. Il Re di Francia per esempio disponeva come di sua proprietà dei Vescovati di Reims, Lione e Tours, e alla morte dei rispettivi titolari li metteva all’asta. Filippo I fece ufficialmente questa proposta a un concorrente deluso: «Lasciami incassare i soldi del tuo rivale. Poi denunzialo per simonia. Io lo condanno alla perdita del beneficio e lo rivendo a te». In Germania, per sfuggire a queste aste, molti Vescovati si proclamarono ereditari, e un Barone se ne appropriò addirittura otto da ripartire fra i suoi figli, come altrettante fattorie. Altri, per rifarsi delle spese di acquisto, saccheggiavano le chiese, vendendone i marmi e perfino le tegole.
Un’altra causa di confusione morale era il celibato. Da lungo tempo la Chiesa ne aveva fatto ufficialmente la sua regola, ribadita in vari Concili. Il matrimonio, si diceva, avrebbe fatto prevalere gli affetti del marito e del padre sullo zelo del sacerdote, lo avrebbe esposto alla tentazione di accumulare ricchezze e di creare una casta ereditaria. Malgrado queste valide ragioni, i preti avevano continuato a sposarsi. Il vescovo Raterio di Verona riferiva che tutti quelli della sua diocesi erano ammogliati. Lo era stato perfino un Papa: Adriano II. E molti sostenevano che il matrimonio era ancora il minore dei mali, perché almeno preveniva il concubinato, in cui regolarmente incappavano i sacerdoti scapoli. Il che però era vero fino a un certo punto perché molti di loro erano contemporaneamente sposati e concubini. Il vescovo Bonifacio aveva riferito a papa Zaccaria che alcuni suoi parroci si tenevano in casa «fino a cinque amanti». E il monaco Pier Damiani scrisse addirittura un Libro gomorriano per denunziare questi scandalosi costumi.
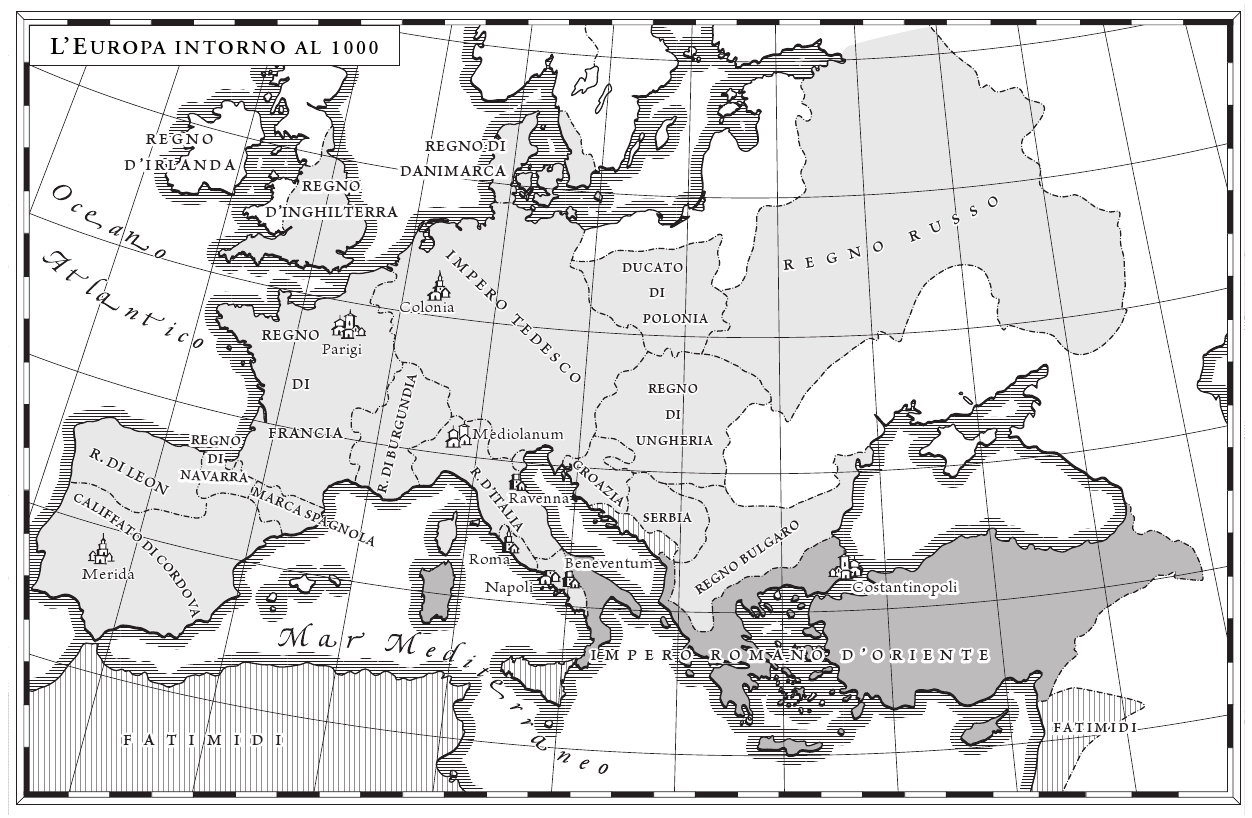
Tutto ciò era il frutto della disgregazione dello Stato. Carlomagno e i suoi primi successori avevano difeso i Vescovi e le loro diocesi non solo dai soprusi dei Signori laici, ma anche dalle proprie tentazioni. Proteggendoli, li sorvegliavano. Disfattosi l’Impero sotto l’azione centrifuga delle sue forze interne, il Clero era rimasto alla mercé dei potentati locali e delle proprie cupidigie. Specialmente in Francia e in Italia, i Vescovi versavano nella stessa situazione del Papa a Roma: ottenevano il «posto» se si facevano strumenti del partito dominante, e ne erano cacciati se vi si opponevano. E in questa politica di patteggiamento e compromessi si era formato un Clero abile, ma corrotto. In Germania andava meglio appunto perché lì, con l’Impero degli Ottoni, si era riformato, bene o male, un potere centrale laico che assicurava un certo ordine, anche se molto relativo. Ma nel suo complesso il panorama del Cristianesimo occidentale era desolante.
Lo spirito di rinnovamento e di riforma incubò nei monasteri. Anch’essi avevano sofferto del marasma politico e subìto angherie e saccheggi. Ma la regola ascetica che li governava, il loro rifiuto della mondanità, li aveva salvati dalle contaminazioni. I monaci officiavano in piccole chiese di campagna che lo stesso eremo costruiva e che diventarono un elemento fisso del paesaggio. La ruralizzazione della società li favoriva. Il gregge urbano del Vescovo, che naturalmente restava in città, si assottigliava, mentre ingigantiva quello del contado, dove si sviluppava un ideale di santità concepita come umiltà, castità e rinuncia a tutte le tentazioni del mondo.
Gli stessi nobili ne furono contagiati. Anche quando il loro istinto di preda li spingeva a saccheggiare i conventi, ne rispettavano gl’inquilini. E spesso riparavano a queste malefatte sul letto di morte, lasciando alle vittime buona parte del patrimonio. I Conti di Fiandra incoraggiarono anche con sovvenzioni un cavaliere loro vassallo, Gérard de Brogne, quando costui gettò alle ortiche l’uniforme militare per indossare il saio e fondare un monastero. Quel guerriero intrepido e autoritario portò nel sacerdozio lo stesso zelo che prima aveva impegnato nella milizia. Il suo convento fu molto simile a una caserma: non vi si faceva altro che pregare, lavorare e digiunare.
Ma a dettare il nuovo costume e a fornire un esempio di risonanza mondiale fu il monastero benedettino di Cluny. Lo fondò nel 910 Guglielmo d’Alvernia, affidandone la direzione prima al monaco Odo e poi a Odilon de Mercoeur. E non se n’esagera di certo l’importanza dicendo che nella storia della Chiesa l’avvento dei cluniacensi non è stato meno decisivo di quello dei gesuiti sei secoli dopo.
Se Cluny fosse stato solo una fuga dal mondo e una centrale di ascetismo, non avrebbe assunto tanto rilievo. Ma fu anche una scuola di pensiero e un’incubatrice di riforma. La vita, dicevano i cluniacensi, non è che l’anticamera dell’Eternità. Tutto quindi dev’essere sacrificato ai fini ultraterreni. La Chiesa, che rappresenta la comunità dei fedeli e la loro guida, non può avere altri interessi che quelli spirituali. Quelli temporali non la riguardano, e il religioso che vi si mescoli cade in peccato di simonia. Il sacerdote appartiene solo alla Chiesa, e quindi non può avere legami né con uno Stato né con una famiglia, né riconoscere altra legge che quella canonica.
Questa teoria non aveva nulla di nuovo. Ma, tradotta in termini politici, assumeva significati rivoluzionari: comportava il rinnegamento di tutto il Clero secolare. Nella Francia di Carlomagno i Vescovi erano stati funzionari del Re; nella Germania degli Ottoni erano diventati Principi e Conti come i laici, e come i laici partecipavano alla lotta per il potere. Cluny postulava il totale rovesciamento di questa linea. Secondo i suoi ideologi la Chiesa non doveva essere né amica né nemica dello Stato. Doveva semplicemente ignorarlo. Ai suoi occhi non potevano esserci né Imperatori, né nobili, né plebe, ma soltanto dei fedeli, delle cui anime essa sola era arbitra e padrona.
Dapprincipio si pensò che questo integralismo rappresentasse soltanto un astratto ideale che i monaci accarezzavano anche per trovarvi un compenso e una giustificazione delle loro quotidiane rinunce. E sottovalutandone le implicazioni politiche, molti Vescovi di Francia, Germania e Italia, favorevolmente impressionati dal fervore dei cluniacensi, ne chiamarono a dozzine come predicatori nelle loro diocesi per rianimarvi lo zelo.
Furono serviti al di là di ogni aspettativa. L’uomo medievale era intriso di religiosità. Il bassissimo livello di cultura, la vita stagnante e tribolata, ne facevano una facile preda di visioni, terrori e mistiche infatuazioni. Ai tormenti che lo perseguitavano, epidemie o carestie, reagiva con oceaniche processioni. Contro la peste e la siccità non aveva altra risorsa che il miracolo. E per propiziarselo era disposto a tutto. Si levava il pane di bocca per portarlo al monastero. A Colonia costruiva gratis la famosa cattedrale caricandosene sulla schiena i blocchi di marmo. Le chiese che sorsero allora ci sbalordiscono per le loro dimensioni anche a misurarle sui metri di oggi. Quelle di Tournai, di Caen, di Spira erano più grandi dei villaggetti in cui sorgevano. E questa sproporzione ci fornisce la plastica misura del sentimento che ispirò i costruttori. Essi non misuravano quei templi sul metro del gregge che dovevano contenere, ma su quello della Divina Maestà cui erano dedicati. Fu questo, sia detto fra parentesi, l’avvio della grande architettura occidentale, che sin allora era vissuta d’imitazione sui modelli bizantini di Ravenna.
È facile capire quale incendio provocassero, in un pubblico cosiffatto, i predicatori cluniacensi. La loro istanza di una Chiesa assoluta, sposa di Cristo, fonte di grazia e di salvezza, era fatta apposta per colpire la fantasia di quei fedeli. Il fervore aveva agito per contagio. La denunzia contro il Clero secolare era continua e spietata. E la Chiesa, anche per la sua democratica costituzione, non poté reprimerla.
Essa aveva questo vantaggio sul mondo laico: che, pur essendo organizzata a casta, era aperta a tutti. Nella nobiltà, che dava accesso alle più importanti cariche militari e civili, non si poteva entrare se non vi si apparteneva per nascita. Nel Clero, sì. Un servo non poteva diventare cavaliere; ma se imparava il latino, poteva diventare Vescovo o Papa. Il grande Gregorio VII, che fra poco avrebbe restituito alla Chiesa tutto il suo prestigio, era figlio di un contadino. La tonsura conferiva al chierico le stesse prerogative del nobile e gli schiudeva le medesime prospettive di «carriera». La sua origine proletaria ne restava cancellata, ed egli veniva sottratto alla competenza dei tribunali civili per rispondere solo a quelli ecclesiastici. Entrare nella Chiesa insomma era l’unico modo per evadere da una condizione socialmente subalterna, l’unica strada che aprisse prospettive di «promozione». Come ogni soldato di Napoleone portava nello zaino il bastone di maresciallo, così ogni più umile prete portava nel suo sacco la tiara pontificia.
Questo consentì alla Chiesa di reclutare il meglio, perché il meglio già si orientava verso di essa. L’intellighenzia non aveva altro rifugio. Un uomo di pensiero e di cultura non poteva fare strada che nei suoi ranghi. E fu così che la Chiesa, oltre a un’assoluta libertà di ricambi e a una scelta di uomini infinitamente più ricca di quella di cui disponeva il potere laico, ebbe su di esso quest’altro enorme vantaggio: il monopolio della cultura. Alla Chiesa si doveva bussare per imparare a leggere e a scrivere. E solo attraverso la Chiesa si poteva far valere i titoli di superiorità intellettuale.
La riforma cluniacense era appunto il frutto di questa democraticità della Chiesa. Essa interpretava gli aneliti di una società rurale contro l’alto Clero che l’aveva abbandonata per far causa comune col potere temporale. E trovò i suoi campioni nei quattro Papi tedeschi che si succedettero sul Soglio dal 1045 in poi.
Ma non anticipiamo. E riprendiamo il filo del nostro discorso.