L’omaggio alla Sardegna
_________________________________________________________
Ma me muddèri campa da signora a me fiddòlu cunnosci più di milli paràuli la tòja è mugnedi di la manzàna a la sera e li toi fiddòli so brutti di tarra e di lozzu e andaràni a cuiuàssi a calche ziràccu.
(Fabrizio De André – Zirichiltaggia)

Il rapporto di De André con la lingua d’acquisizione (il gallurese) ha dato vita a numerosi testi dialettali che impreziosiscono, dal punto di vista musicale e linguistico, il canzoniere deandreiano.
La prima canzone in dialetto composta dal cantautore ligure è Zirichiltaggia – Baddu tundu[1] (lucertolaio – ballo tondo), una ballata in gallurese inserita nell’album Rimini del 1978, scritto a quattro mani con Massimo Bubola. Il brano racconta di una lite che avviene tra due fratelli, del reciproco rinfacciarsi dell’eredità ricevuta dal padre e della vita matrimoniale intrapresa da entrambi.
Zirichiltaggia è solo un iniziale omaggio all’isola, presente anche in altri testi del cantautore genovese: infatti l’album successivo uscito nel 1981, Fabrizio De André (conosciuto come Indiano) è interamente dedicato alla Sardegna. Questo concept album nasce dall’esperienza del sequestro del 27 agosto 1979, avvenuto nella tenuta tempiese di L’Agnata. Dalla drammatica vicenda De André dirà di aver imparato molto e di essere cresciuto umanamente. Ne è testimonianza tangibile proprio l’album Indiano, che conferma l’amore smisurato di Fabrizio e Dori nei confronti dei sardi e della Sardegna, «dove terra e mare convivono cuciti da uno stesso destino»[2].
«Parlare con i nostri custodi mi ha offerto molti spunti, e d’altronde quando liberano un industriale sequestrato, lui ritorna alla sua scrivania, quando liberano un cantante, perché non dovrebbe tornare alla sua chitarra?».
Se il rapimento dei De André suscitò dolore collettivo, la loro liberazione accese numerose polemiche. Faber, infatti, rivelò da subito di aver perdonato i suoi rapitori e, con la sua tipica partecipazione umana verso i più deboli, affermò che i veri sequestrati erano proprio i banditi:

Ci davano del lei e chiamavano Dori «signora»: la preferivano a me, perché lei è figlia di operai. Quanto alle mie canzoni, preferivano quelle di Guccini […]. Ebbi da loro un’attenzione che non avevo mai avuto. E poi si sa, i perdenti mi hanno sempre attratto. Pensai che i veri sequestrati, in fondo, erano loro[3].

De André e sua moglie furono trattati con umanità dai carcerieri con i quali stabilirono «un rapporto inatteso, quasi primordiale»[4] che spinse i sequestratori ad accettare la proposta di liberarli da catene e cappucci, per restituire loro una parvenza di libertà.
La libertà, quella vera, arrivò dopo il pagamento del riscatto da parte del padre di Fabrizio e finalmente i due poterono riabbracciare i piccoli Cristiano e Luvi, scampata per poco al rapimento.
A dispetto di ogni previsione, il sequestro servì per rafforzare l’amore di De André per la Sardegna e, come già detto, si concretizzò in un album incentrato sul rapporto di similitudine tra il popolo sardo e il popolo indiano, preannunciato dall’immagine di copertina del pittore americano Frederic Remington, rappresentante un pellerossa a cavallo: «Gli indiani di ieri e i sardi di oggi sono due realtà lontane solo apparentemente, perché sono due popoli emarginati e autoctoni»[5].
L’album si apre con Quello che non ho, un brano con sonorità blues basato sull’elenco di ciò che il protagonista (metafora del popolo autoctono) non ha: una camicia bianca, un conto in banca, un orologio, le pistole, i denti d’oro e un pranzo di lavoro. Tutte cose che invece appartengono al suo antagonista (metafora dell’oppressore) e che quasi giustificano una naturale rivendicazione.

Era la psicologia dei miei sequestratori. Era come se dicessero: «A me non manca niente, ma perché mi devi mettere sotto il naso la villa con piscina, l’automobile, l’aereo privato? A questo punto me ne crei il bisogno»[6].

Il canto del servo pastore, secondo brano dell’album, è un omaggio alla Sardegna e alla sua natura, fortunatamente rimasta in gran parte inviolata. Il servo e la natura diventano un’unica essenza e il paesaggio circostante fa da sfondo alla sua vita trascorsa nei campi tra il cisto e il rosmarino, con un «filo di paura» dovuta all’incertezza del proprio futuro e la tristezza propria della solitudine. La canzone è ricca di significati simbolici e trasmette un’incessante sensazione di privazione: «la luna perde la lana» e «il passero la strada», a indicare lo smarrimento; «ogni angelo è alla catena» a suggerire forse una necessità d’indipendenza, tipica degli isolani; e «ogni cane abbaia» a segnalare un lamento, talvolta troppo sordo per uscire dai confini di un pascolo solitario.
Nella terza canzone, ai sardi si sostituiscono gli indiani, con una storia già ampiamente trattata nei capitoli precedenti: si narra infatti dello sterminio di una popolazione di pellerossa riportato dalle parole e dalle sensazioni innocenti di un bambino scampato al massacro presso il fiume Sand Creek. Anche in questo caso, il confronto tra i due popoli oppressi, pur nei modi e nei tempi diversi, è palese: «Gli indiani sterminati dal generale Custer, chiusi nelle riserve. E i sardi cacciati sui monti dai cartaginesi, fatti schiavi dai romani, colonizzati poi»[7].
Col quarto brano si torna in Sardegna, grazie a una suggestiva Ave Maria in limba (lingua sarda) derivata dalla tradizione popolare isolana e arrangiata dall’americano Mike Harris (sposatosi con una donna sarda) e risuonata nella basilica dell’Assunta di Carignano nel giorno dell’ultimo saluto a Faber.
Hotel Supramonte è una delle canzoni più commoventi del repertorio deandreiano, poiché rievoca in un susseguirsi di immagini poetiche, i drammatici giorni del sequestro. L’hotel di cui si parla è l’allegoria dolorosamente ironica della grotta che custodì Fabrizio e Dori lontani da occhi “indiscreti”, sui monti della sconfinata e intricata Barbagia.

La mancanza di introduzione musicale e la congiunzione di partenza creano l’effetto di un discorso già iniziato, un colloquio intimo e discreto con un’interlocutrice in cui possiamo riconoscere la compagna. Il terrore e l’incertezza sono mitigati da una dolce melodia che ha il sapore di una ninna-nanna[8].
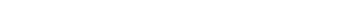
Anche Dori Ghezzi cantò la drammatica esperienza nell’espressiva Stringimi piano stringimi forte inserita nell’album Mama Dodori del 1980 e il cui titolo deriva dal nome con cui la piccola Luvi chiamava la sua mamma. Il brano, scritto da Massimo Bubola, ha molte analogie con Hotel Supramonte e richiama il periodo della prigionia: «Stringimi piano stringimi forte, fammi pensare più dolce la sorte», «Stringimi piano, stringimi dolce, toglimi il peso di questa croce», «Una mezza sigaretta in una mezza galera, ma un letto soltanto e una sola preghiera e una sola canzone e lo stesso rimpianto e chissà da dove ci stanno chiamando...».
Il testo di Franziska è stato ispirato da uno dei numerosi racconti che i sequestratori fecero a De André, una volta acquisita la confidenza adatta alla confessioni più intime. Il brano narra la storia di Franziska, giovane donna promessa in sposa a un bandito «senza luna senza stelle e senza fortuna» che trascorre la sua vita a nascondersi. Ma Franziska si stanca di aspettare il suo «marinaio di foresta» che riesce a baciare solo di sfuggita e vorrebbe potersi sposare, come anche la sua ultima sorella ha fatto. L’ispirazione per la stesura del testo, fu data dal passaggio di una ragazza a cavallo che colpì particolarmente De André e Bubola e i due autori immaginarono che potesse essere la fidanzata di un brigante. La musica e il ritmo, invece, sono strascichi di un ricordo adolescenziale di Faber che per un certo periodo ascoltò la musica dei sudamericani Los Paraguayos.
Se ti tagliassero a pezzetti, come afferma Roberto Cotroneo nel suo saggio, «è una canzone piena di valenze simboliche sul tema della libertà e della fantasia, continuamente minacciate di morte dalla nostra civiltà, ma indistruttibili nella coscienza dell’uomo»[9], e quella stessa libertà può essere espressa con la fantasia o con l’anarchia, come dirà De André in un lapsus freudiano sfuggitogli durante un concerto[10] (Signorina anarchia anziché Signorina fantasia). E nessuno potrà mai tagliare a pezzetti la personalità di un uomo, limitando la sua libertà e la sua immaginazione.
L’album si conclude con il brano Verdi pascoli, anch’esso inno alla libertà identificata, appunto, nei pascoli sconfinati. La canzone ha degli echi evidenti nella poesia bucolica, per la descrizione del paesaggio naturale. Per tornare, invece, a un’ambientazione tutta sarda, non si può non pensare a una comparazione con la tipica figura del giovane pastore affrontata dalla letteratura in Padre padrone[11] e dal cinema in Ballo a tre passi[12]: l’innocenza della giovinezza e la paura dell’isolamento sono caratteristiche universali di una condizione di asservimento e abbandono. Tale condizione è esasperata dalla vastità dei pascoli, in antitesi con il confine che li racchiude. Si può supporre, inoltre, che il brano prenda spunto dalla rituale “danza degli spettri” che i pellerossa praticavano, sognando una futura liberazione anche al di là della vita terrena.
In questo paragrafo, non a caso, si è parlato molto del paragone che Fabrizio De André era solito fare tra i sardi e gli indiani d’America: popolazioni che avevano conosciuto l’oppressione e la rivolta dei suoi uomini più valorosi, per ottenere il riconoscimento della libertà e dell’autonomia.
Sono molti altri gli aspetti comuni alle due genti: innanzitutto il forte attaccamento alle radici e la consapevolezza della loro identità culturale che innalzano a vessillo della dignità umana; l’amore per i bambini e il rispetto per gli anziani; la balentia[13] sarda e il coraggio dei giovani indiani che rubavano i capi di bestiame per dimostrare il proprio “valore”. Un altro comune denominatore tra sardi e indiani, secondo De André, è il valore assunto dalla caccia:

Attraverso la caccia, tribù diverse (gli indiani) e persone che abitano in paesi diversi (i sardi) riescono ad avere rapporti sociali. Per loro è anche uno sfogo, un modo per conoscersi, per dimenticare di essere odiati senza motivo. Conosco alcuni sardi che si odiano per sentito dire, fino a quando non si incontrano nelle battute al cinghiale[14].

Nel 1990 De André pubblica l’album Le nuvole, di cui si è ampiamente parlato nel capitolo sugli echi letterari e che contiene un brano recitato con spiccato accento sardo che dà il titolo all’opera e una canzone in gallurese, Monti di Mola.
Il brano – o meglio, la poesia – d’apertura è declamato da due voci di donne sarde: Lalla Pisano e Maria Mereu. La scelta dei due timbri isolani è legata alla ricerca di una vocalità che richiami alla mente la purezza della Terra Madre. Il pezzo si aggiudicò, al Premio Tenco, la nomina di brano dell’anno: «il mio Nobelin», lo chiamava scherzosamente De André. Nel tour iniziato l’anno successivo, sulla scena comparivano i fantocci di due donne fasciate nel tradizionale abito sardo, una delle quali (la più giovane) intenta a lavorare la lana. Durante la lettura della poesia, inoltre, su uno sfondo venivano proiettate le stelle del Supramonte e i volti degli indiani.
Monti di Mola – come veniva chiamata in passato la Costa Smeralda – fa da cornice a una storia d’amore impossibile tra un pastore del luogo e un’asina. Il loro amore è infatti contrastato da una vecchia consumata dall’invidia e si conclude infelicemente quando si scopre che i due non possono sposarsi, perché dai documenti risultano essere cugini di primo grado. Qui De André usa abilmente l’arma dell’ironia per condannare le barriere sociali e il moralismo ipocrita di cui è intrisa la società.
Nel 1992 Fabrizio De André collabora con i Tazenda: gruppo nato nel 1988 grazie ad Andrea Parodi, Gino Marielli e Gigi Camedda. Da questo interessante connubio nasce Pitzinnos in sa gherra[15], che Faber compone con Marielli e che risuonerà sul palco del Festival di Sanremo in quello stesso anno. «Fabrizio De André studiò per noi, da un librone di filastrocche orientali, per circa due settimane, e poi produsse quel “trenta, quaranta, cinquanta, mitragliatrice canta a tenore”, che rese il pezzo più comprensibile al grande pubblico e aggiunse lustro al nostro disco»[16]. De André canterà con i Tazenda anche nel brano Etta abba, chelu (Getta acqua, cielo).
L’omaggio di De André alla sua isola adottiva, si manifesta anche con Disamistade che, in dialetto, significa “disamicizia”, “faida”. Questa canzone, contenuta nell’album Anime salve (1996), tratta proprio l’argomento delicato del conflitto tra famiglie. Gli innocenti, quelli che vorrebbero porre fine alla carneficina umana che si tramanda di famiglia in famiglia, cercano conforto nella Chiesa. Ma la Chiesa, forse come quel Dio evocato nella Città vecchia, è occupata con gente d’altri paraggi e assiste inerme agli scoppi di sangue. Nel testo di questa canzone, qualcuno coglie un riferimento al sequestro del piccolo Farouk Kassam, rapito nel 1992, come per esorcizzare un’esperienza vissuta in prima persona e condannare un delitto terribile quale la privazione della libertà:
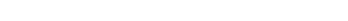
Alla liberazione del bambino disse: «Perché è come se in ogni giornata di quella prigionia ci fosse stato un posto vuoto alla nostra tavola» e qualche anno dopo scrisse in Disamistade «Un’assenza apparecchiata per cena»[17].

Nel 1996 Faber scrive insieme ad Alessandro Gennari (scrittore e psicanalista), il romanzo Un destino ridicolo e la dedica iniziale sarà: «A un luminoso bagnasciuga della Gallura dalle cui acque tranquille una vacca torse il collo a guardarci con un dentice in bocca».

Si tratta di un romanzo apparentemente leggero, che parla di tre balordi – un sardo, un genovese e un mantovano – che tentano un colpo che poi andrà a finire male. Un romanzo nato per caso, diciamo così: in sèguito a un’amicizia vecchia di vent’anni – avevo conosciuto Gennari a Mantova, nel 1975, perché la sua faccia era identica a quella di mio figlio Cristiano...[18]

Il libro, scritto nell’arco di otto mesi a ritmi di lavoro differenti (di notte Faber, di mattina Gennari e nel pomeriggio insieme), si apre con il capitolo intitolato Coriandoli a Tempio. Già l’incipit, quindi, inserisce il racconto in un’ambientazione geografica e temporale che è quella del Carnevale di Tempio, che ha il suo culmine il giorno della sfilata dei carri allegorici. La prima scena del romanzo si svolge sul vagone di un treno e i personaggi sono un sacerdote, un pastore, un medico e un venditore d’occhiali che ricorda l’ottico di Non al denaro non all’amore né al cielo. Il pastore – uno dei protagonisti principali del racconto – inizialmente assiste in silenzio al dialogo tra gli altri viaggiatori, per poi intervenire a modo suo, in dialetto. «Abbia pazienza – lo interruppe il prete, – non si esprima in gallurese, sennò la sua storia la capirò soltanto io». Il pastore si scusa, dicendo che «certe espressioni mi riesce difficile tradurle, mi riesce» perché come diceva Faber, il vernacolo è più diretto e rende più saporite e limpide anche le bestemmie. Il primo protagonista, quindi, è Salvatore: il pastore sardo che decide di emigrare in cerca di fortuna e con il sogno di realizzare una tenuta agricola che sembra la fedele descrizione dell’Agnata che Faber costruì proprio a Tempio Pausania. Entrano in gioco, nel romanzo, altri personaggi come Carlo, il protettore delle prostitute che s’invaghisce dell’unica donna che non sottostà al suo dominio e Bernard, il contrabbandiere anarchico che vuole aprire un centro internazionale di studi sull’anarchia. I tre accettano di partecipare a un furto di pellicce di valore che cambierà decisamente la loro vita, anche se non come avevano previsto. Un destino ridicolo, appunto, è quello che non dà niente per scontato e non assicura certezze.
Tra i personaggi minori, Maritza che fa perdere la testa al pappone; Alessandro (Gennari) e un giovane cantautore con un ciuffo che gli cade sull’occhio, Fabrizio. Come si è detto, c’è molto De André in questo libro e non solo per i luoghi e i personaggi, ma anche perché richiamano momenti di vita vissuta del cantautore genovese. C’è l’amico musicista (Tenco) che durante un Festival si spara al cuore lasciando un ultimo messaggio: «Ecco, la musica è finita». C’è la giovane istriana (Maritza) che piomba in casa del suo cantante preferito (De André) per «ridimensionarne il mito». C’è il monologo del cantautore che racconta di quando il padre, sul letto di morte, gli strappò la promessa – poi mantenuta – di smettere di bere.
Nel romanzo, scritto a quattro mani, non è difficile rintracciare la poetica di Faber e un omaggio alle sue “anime salve”, alla terra natìa e, soprattutto, alla sua Sardegna.
Grazie alla pregiata opera di Alfredo Franchini, veniamo a conoscenza di un episodio che ha avuto come protagonista De André e che per la proverbiale riservatezza del cantautore, non è noto ai più. I detenuti del carcere di Is Arenas di Arbus (in Sardegna) gli avevano dedicato un numero intero della loro rivista Ricominciare, nel quale analizzavano e approfondivano il significato delle sue canzoni. Un giorno, De André, al riparo da occhi invadenti, bussò alla porta del carcere e andò a conoscere quei ragazzi sfortunati che l’avevano definito «un mito».
Questa è l’ennesima testimonianza, se ce ne fosse bisogno, della dimensione umana di Fabrizio De André.

Voglio concludere questo lavoro in ricordo di Fabrizio, citando una splendida frase di Dori Ghezzi: «L’ultimo ringraziamento però va a Luisa e Giuseppe De André per averci regalato una creatura tanto straordinaria».[19]
[1] La canzone è stata tradotta in gallurese grazie all’aiuto di Paolo Paggiolu.
[2] A. Franchini, Uomini e donne…, cit., p. 13.
[3] C. G. Romana, Smisurate preghiere…, cit., p. 106.
[4] C. G. Romana, Amico fragile…, cit., p. 114.
[5] Famiglia Cristiana, 6 settembre 1981.
[6] R. Cotroneo (a cura di), Come un’anomalia…, XVIII.
[7] Famiglia Cristiana, 6 settembre 1981.
[8] M. Borsani – L. Maciacchini, Anima salva…, cit., pp. 125-126.
[9] In R. Cotroneo (a cura di), Come un’anomalia…, cit., p. 210.
[10] Arena Civica di Milano, il 16 settembre del 1991.
[11] G. Ledda, Padre padrone, Milano, Feltrinelli, 1975.
[12] S. Mereu, Ballo a tre passi, Eyescreen/Lucky Red, 2003.
[13] Valorosità.
[14] Famiglia Cristiana, 6 settembre 1981
[15] Nell’album Etta abba, chelu (di Luigi Marielli), Visa Record/Ricordi, 1992.
[16] L. Marielli, Le mie canzoni per i Tazenda, Sassari, Tronos, 2006, p. 87.
[17] A. Franchini, Uomini e donne…, cit., p. 97.
[18] Intervista con A. Podestà, l’Espresso, 19 settembre 1996.
[19] Inaugurazione Centro Studi “Fabrizio De André”, 13 dicembre 2004, Università di Siena.