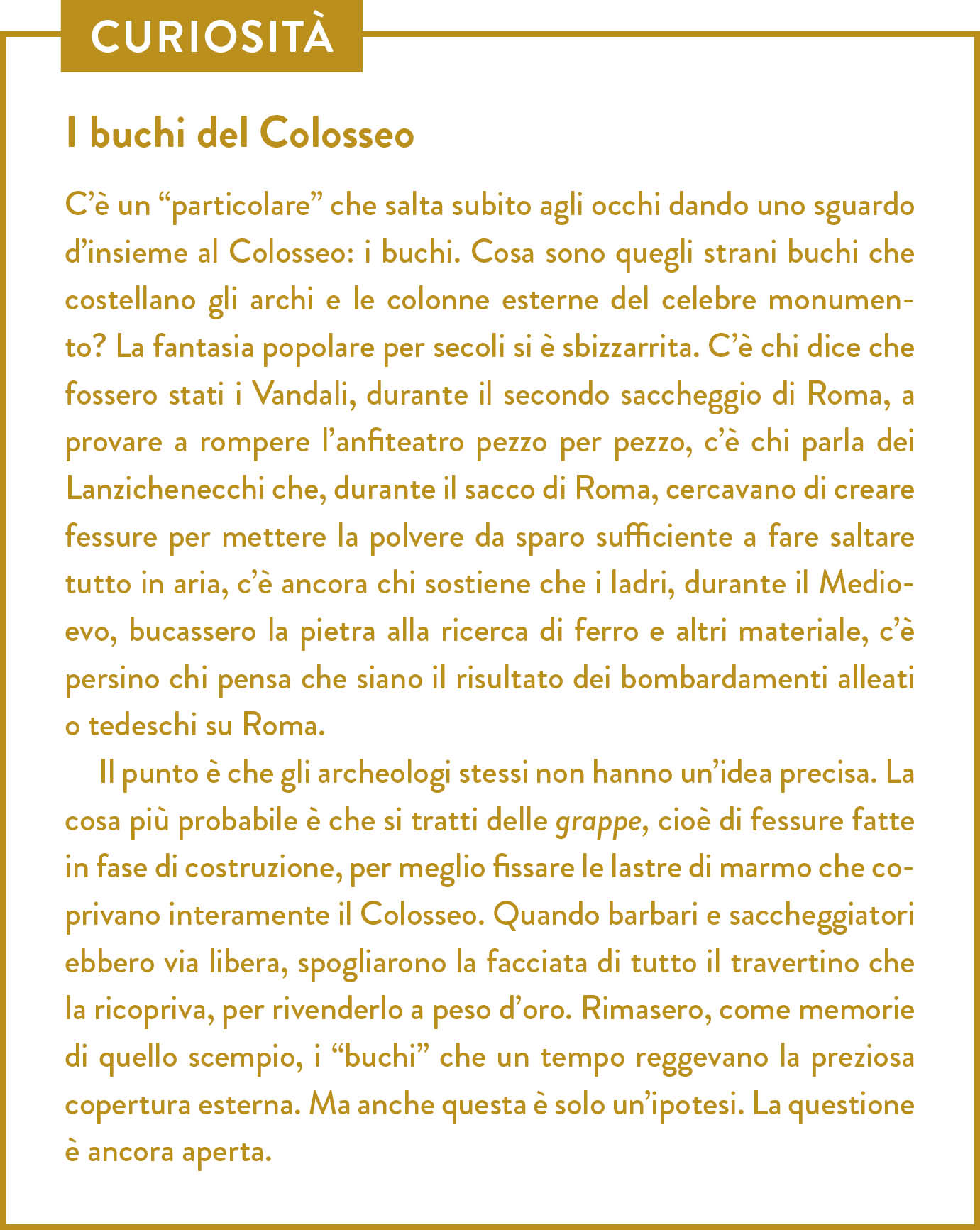UNA VISITA ALLA ROMA IMPERIALE

Nel tempo, il Colosseo ha avuto mille anime, ma è sempre rimasto l’indiscutibile simbolo della città caput mundi.
Colosseo, oltre il luogo comune
Quando si pensa alla gloria dell’Impero Romano il nostro immaginario va subito a un grande monumento, il Colosseo. Per questo è così difficile trovare qualcosa di originale da dire sul simbolo non solo di Roma, ma della romanità in generale. Un filosofo e teologo irlandese, Beda il Venerabile, nel VIII secolo d.C., cioè quando il mondo classico romano era ormai solo un ricordo e l’Urbe stessa ridotta a un grosso villaggio, scriveva: “Finché esisterà il Colosseo, esisterà anche Roma”. Goethe, quando lo vide per la prima volta, sentenziò: “Quando si contempla una cosa simile, tutto il resto appare un’inezia. È così grande che la mente non riesce a comprenderlo in sé; piccola è l’immagine che la memoria ne serba e, quando si torna a vederlo, fa l’effetto d’esser più grande di prima”. Per l’Unesco, che l’ha inserito nella sua lista ormai quasi quarant’anni fa insieme a tutto il centro storico di Roma (1980), il Colosseo fa parte di “una serie di testimonianze di incomparabile valore artistico prodotte in quasi tre millenni di storia” e che hanno avuto “un’influenza decisiva sullo sviluppo della pianificazione urbana, dell’architettura, della tecnologia e delle arti in tutto il mondo”.
L’Anfiteatro Flavio, questo il suo vero nome, viene chiamato Colosseo perché è eretto accanto a una colossale statua di Nerone, probabilmente distrutta nel primo sacco barbarico di Roma del 410 d.C. (è ancora visibile il basamento di tufo sul quale era collocata la statua). Ha una capacità di cinquantamila spettatori seduti, con ottanta file sugli spalti, rigorosamente in ordine gerarchico: più vicini all’arena l’imperatore e i senatori e poi, via via, i vari strati sociali dai patrizi fino alle classi inferiori. Viene completato nell’anno 80 d.C., quando l’imperatore è Tito, ma viene comunque intitolato al padre di questi, Flavio Vespasiano, che ha dato il via ai lavori nel 72 d.C.

Qualche informazione aiuta a capire l’unicità dell’anfiteatro, davvero un simbolo della grandezza di Roma. Cassio Dione, storico latino, racconta che più di novemila animali selvaggi furono uccisi durante i giochi di apertura. L’ovale è enorme: 189 metri di lunghezza, 156 di larghezza e 48 di altezza, con un perimetro ellittico di 524 metri. Il campo di gioco, un ovale di 75 per 44 metri, è una piattaforma costruita in legno e ricoperta di sabbia con un complesso di tunnel e ipogei dove vengono alloggiati i gladiatori, i condannati e gli animali, e con un sistema di drenaggio che garantisce una rapida asciugatura della sabbia in caso di pioggia. Nelle giornate assolate, il Colosseo ha un velario formato da circa ottanta vele triangolari, con trecentoventi funi di sostegno. Oltre alle lotte dei gladiatori, ospita anche altri generi di spettacoli: naumachie, ovvero battaglie navali fedelmente ricostruite; cacce, esecuzioni pubbliche, simulazioni di battaglie famose e giochi che ricordano la mitologia classica.

La storia dopo i giochi

Il Colosseo continua a essere utilizzato per quasi cinquecento anni, e gli ultimi giochi saranno celebrati durante il VI secolo, molto dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente, nel 476 d.C. Certo, va detto che già dopo l’editto di Teodosio che proibiva giochi pagani, il passato splendore si riduce e negli spettacoli sono quasi assenti le lotte all’ultimo sangue tra i gladiatori. Restano gli animali feroci, ma anche quelli sono sempre più rari. È documentata una grande festa nel Colosseo nel 519, con animali provenienti dall’Africa (anche se un terremoto, undici anni prima, nel 508, aveva ridotto le platee e fatto crollare un’intera ala dell’anfiteatro), ma in seguito, durante il Medioevo, l’edificio non viene più adibito a questi scopi. Diventa piuttosto rifugio, fabbrica, sede di un ordine religioso, fortezza e cava di estrazione.
La grande mole abbandonata, inoltre, non manca di creare macabre leggende nella popolazione romana. Per buona parte del Medioevo il Colosseo, forse per la sua nomea di luogo di martirio, verrà considerato una delle porte dell’Inferno, dove il diavolo seppellisce i corpi degli scomunicati. In effetti, nella realtà, briganti e ladroni sono usi seppellire i cadaveri delle loro vittime dentro o nelle vicinanze del monumento che nel frattempo è stato ricoperto da una fitta vegetazione.
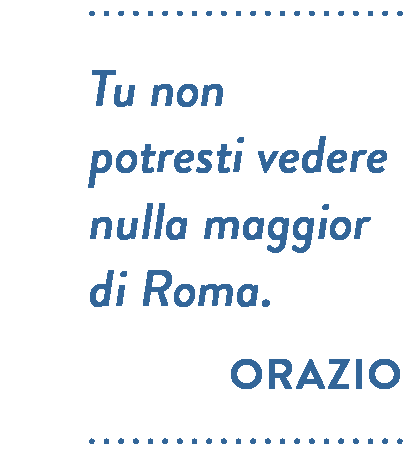
Per tutto il XV, il XVI e XVII secolo, poi, il travertino che lo ricopriva sarà riutilizzato in altre costruzioni; tra queste, per il Palazzo Barberini e il Porto di Ripetta. È in effetti durante il pontificato di Urbano VIII, al secolo Maffeo Vincenzo Barberini, che vengono perpetrate le spoliazioni più devastanti. Attenzione, però: il giro di muro più esterno, mancante a sud, non viene distrutto dalla speculazione edilizia, ma da un terremoto che, nel 1349, fa crollare questa parte del Colosseo, eretta su un’area più paludosa e meno stabile.
Lo scempio del monumento comunque continua, fino a quando non viene convertito in un santuario cristiano in onore dei prigionieri martirizzati durante i primi anni del Cristianesimo. Come per il Pantheon, è questa misura a salvarlo dal definitivo sventramento.
Oggi non si vede quasi più la chiesa di Santa Maria della Pietà al Colosseo, una piccola cappella coperta fra il fornice di due volte della cavea. Ma per secoli ha caratterizzato l’immagine dell’Anfiteatro, cristianizzandolo agli occhi dei romani. È Benedetto XIV, nel 1750, a stabilire che questo luogo diventi il cuore della solenne Via Crucis del Venerdì Santo, un evento a cui ancora oggi i papi tengono a presenziare, e che si svolge nella cornice incredibile dei Fori. Il percorso non prevede più il passaggio per l’interno del Colosseo (che è stato aperto dagli scavi novecenteschi al fine di permettere la visione degli antri sotterranei), ma resta molto suggestivo.
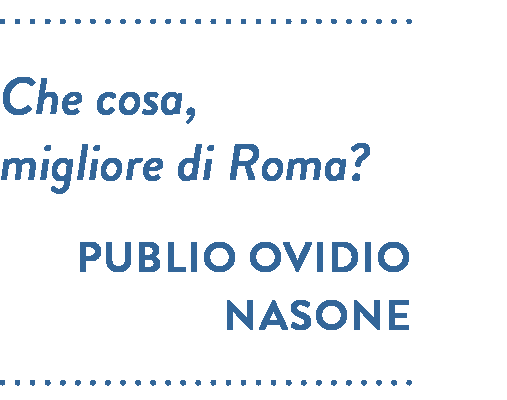
Negli ultimi due secoli, prima i papi e poi lo Stato italiano hanno avviato vari progetti di stabilizzazione e restauro, rimuovendo la rigogliosa vegetazione che aveva invaso la struttura. La facciata è stata rinforzata con cunei triangolari in mattoni nel 1807 e nel 1827, e l’interno è stato puntellato nel 1831, nel 1846 e in modo definitivo negli anni Trenta del secolo scorso. La sottostruttura dell’arena è stata in parte scavata nel 1810-1814 e nel 1874, ma è stato ancora negli anni Trenta del Novecento che gli archeologi e la soprintendenza hanno deciso di scoperchiare quasi completamente l’arena per rendere visibile il complicato intrico di cunicoli che si trova al di sotto e che veniva usato in epoca classica per facilitare l’accesso dei gladiatori, per inserire le botole da cui uscivano a sorpresa gli animali o per creare le grandi piscine d’acqua per le naumachie.