AQUILEIA, IL PORTO DELL’IMPERO

Tappa obbligata degli eserciti, avamposto difensivo, la città seppe conquistare anche un importante ruolo commerciale.
La bellezza non è sempre evidente, facile da scoprire, esposta: esiste anche una bellezza nascosta, di cui vorremmo sapere di più e che a volte riusciamo a cogliere solo in piccola parte. È il caso della storia che stiamo per raccontare. E che comincia nel II secolo a.C., quando Roma, repubblicana e non ancora imperiale, si è incamminata sulla strada che la porterà a diventare la grande potenza del suo tempo.
Messo in sicurezza, almeno temporaneamente, il confine settentrionale dalle continue minacce dei Galli, da Roma giunge l’ordine di fondare proprio in quell’area nuove colonie. Di lì a poco nascono, nel 189 a.C., Bononia (Bologna); nel 183 a.C., Mutina (Modena) e Parma; nel 181 a.C., Aquileia.
Fra queste quattro, Aquileia si ritaglia un ruolo preminente. È infatti considerata la più importante sul piano strategico sia perché tappa obbligata per gli eserciti che da Roma puntano a favorire l’espansione dell’Impero verso il Danubio, sia perché necessario avamposto per difendersi dalle incursioni, sul fronte orientale e settentrionale, delle popolazioni avversarie di Roma che premono ai confini. È così che da Aquileia, fin dalla sua fondazione, cominciano a transitare e a fermarsi regolarmente truppe ed eserciti, un viavai che porta vita e benessere alla città.
Crocevia di genti e merci, accanto alle ragioni militari, Aquileia sviluppa una florida economia commerciale: dalle sue strade passa infatti la via dell’ambra dal Baltico, e si dipana una raggiera di itinerari che conducono a Oriente, al Nord, alle Gallie. Aquileia diventa una sorta di emporio nel quale arrivano merci di ogni tipo che vengono poi trasferite verso i quattro angoli dell’Impero grazie a un efficiente porto fluviale di cui restano tuttora le tracce.

La scelta di Augusto
Intorno all’anno zero, l’imperatore Augusto, di fronte alla rapidissima crescita territoriale del suo impero, ordina una riorganizzazione amministrativa che ne faciliti la gestione. Si divide la penisola italiana in regioni e Aquileia diventa il centro di un’area chiamata “Regio X Venetia et Histria” corrispondente al territorio dell’attuale Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, cui si aggiungono una parte dell’odierna Lombardia orientale, e a est, una porzione di terra corrispondente alla penisola dell’Istria.
Se pensiamo che oggi ad Aquileia vivono poco più di tremila persone, è difficile immaginare anni in cui ne accoglieva circa duecentomila ed era la quarta città sul territorio italiano dopo Roma, Milano e Capua, e l’undicesima dell’Impero Romano. Ma è proprio di quell’epoca d’oro che stiamo parlando. Anni in cui il centro di Aquileia è un trionfo di vita: botteghe, taverne, spettacoli. Le sue ville ospitano ricche famiglie che, oltre a gestire i commerci, commissionano a grandi artisti mosaici e statue per le loro residenze. È sempre in questi anni che Aquileia diventa famosa per la lavorazione del vetro, per quella delle gemme e dell’ambra. Stiamo però per arrivare a un evento che cambierà la storia di questa città. Qualcuno, anche se non tutti concordano, lo considera addirittura la vera e propria fine di Aquileia. Ma prima di arrivarci, c’è ancora un pezzo importante da raccontare, una tessera del mosaico, viene spontaneo dire visto dove ci troviamo. Abbiamo parlato dell’Aquileia degli affari, della città nata a difesa degli interessi territoriali di Roma, ma c’è un’altra cosa che la rende speciale in questi anni ed è il fatto che molti suoi illustri cittadini, in anticipo rispetto ad altre regioni dell’Impero, si convertono al cristianesimo.
È ancora un cristianesimo contaminato da tracce di altri culti e religioni, in cui particolarmente evidente è l’influenza della comunità ebraica che risiede in città e dei mercanti ebrei in transito da Oriente. Eppure, quando nel 313 d.C. Costantino emana l’editto che prende il suo nome e chiude l’epoca delle persecuzioni nei confronti dei primi cristiani, ad Aquileia si decide molto rapidamente di edificare la basilica di Santa Maria Assunta, che rimarrà uno dei più grandiosi e significativi monumenti religiosi del periodo romanico.
Un capolavoro sotto i nostri piedi
A guardarla oggi, dall’esterno, è evidente come la struttura attuale della Basilica non sia di impronta romana ma presenti forme romanico-gotiche che ne collocano l’edificazione intorno all’XI secolo, senza contare i successivi e più recenti rimaneggiamenti. Ma a interessarci è quello che si trova all’interno: un immenso mosaico che rivestiva il pavimento della Basilica originaria coprendo una superficie enorme, circa settecentosessanta metri quadrati, e che ha quasi quasi millesettecento anni di età.
Un capolavoro realizzato con milioni di tessere colorate di pietra ma anche in pasta vitrea, ognuna delle quali è stata tagliata, sagomata e collocata delicatamente al suo posto per poter creare questo splendido tappeto di pietre. Forse più sorprendente ancora è che questo stesso tesoro sia rimasto sepolto fino ai primi del Novecento quando è stato scoperto sotto un altro pavimento realizzato in epoca medievale, una delle numerose volte in cui questa meravigliosa chiesa è stata, nel corso della sua storia, ricostruita.
I colori del mosaico, che ricopriva l’aula sud di Teodoro, uno dei tre ambienti principali che costituivano la sede vescovile eretta al tempo dell’imperatore Costantino, sono ancora vivissimi e le scene ritratte prendono spunto dalle Sacre Scritture. Su quello che può essere considerato il più esteso mosaico paleocristiano del mondo occidentale si vede per esempio Giona, che viene inghiottito nel ventre della balena. Si osserva la parabola del Buon Pastore. C’è lo scontro fra il gallo che annuncia la luce del nuovo giorno e simboleggia Cristo, luce del mondo, con la tartaruga che invece incarna le tenebre e, per estensione, il maligno. Ci sono ritratte le stagioni: ma solo l’estate e l’autunno, perché primavera e inverno sono purtroppo andate distrutte. C’è una scena di pesca: “Seguitemi, vi farò pescatori di uomini”, dice Cristo agli apostoli invitandoli e spronandoli alla predicazione cristiana.
Se ci spostiamo in un punto del pavimento, vediamo poi come, nel corso del restauro, gli esperti abbiano scelto di lasciare una testimonianza di come si presentava questa pavimentazione prima dell’intervento. Una piccola porzione lasciata intatta sulla quale non ci sono disegni ma solo figure geometriche, che ci offre così la possibilità di apprezzare lo stile e l’approccio differente di un’epoca più vicina a noi.
Ma, seguendo il filo della storia, che cosa succede dopo l’edificazione di questa chiesa? Qual è l’evento che cambia per sempre la storia di Aquileia? È una tragedia legata a un nome che ha fatto tremare i suoi contemporanei, e che ancora risuona, molti secoli dopo, nelle nostre menti. Quello di Attila, re degli unni.
Aquileia in fiamme
È il 452 quando Attila giunge in Italia con il suo esercito. Non è la prima volta che varca le Alpi, ma è la prima volta che si dirige verso Aquileia. La città è forte, molto ben difesa, e nella sua storia ha già respinto numerosi attacchi. Ma con Attila è diverso. Quando viene avvistato il suo esercito, l’intera città si appresta a difenderne le mura: si racconta che gli abitanti corrano verso di esse portando tutto quello che hanno per ostruire le entrate e impedire l’ingresso delle truppe unne. Aquileia resiste ma Attila non ha intenzione di rinunciare. L’assedio dura sei mesi e poi il condottiero si decide a sfondare le linee di difesa della città.
Narra la leggenda che a spingerlo a dare l’ordine ai suoi sia la vista di alcune cicogne che osserva, in volo sopra la sua testa, lasciare la città. Attila adesso sa che non c’è più niente da mangiare, la fame ha già vinto per lui l’ultima battaglia. Le difese vengono sbaragliate e gli unni riescono a entrare ad Aquileia: i saccheggi sono devastanti, la città viene messa a ferro e fuoco e anche la basilica di Santa Maria Assunta va in fiamme.
La forza di quelle fiamme la possiamo constatare persino oggi osservando la base di alcune colonne: è come se si fossero parzialmente sfaldate. Squagliate, come un gelato al sole.

Nonostante sia trascorso moltissimo tempo da quei giorni, tante sono le curiosità che possiamo soddisfare grazie ai numerosi reperti rinvenuti, come gli oggetti in ambra o la raccolta di gemme intagliate conservata nel Museo Archeologico di Aquileia. O come alcuni chicchi di grano, probabilmente nascosti dalla popolazione per nutrirsi e resistere all’assedio ma finiti fra le fiamme e quindi abbrustoliti. Anche se forse la testimonianza più impressionante, sempre all’interno del Museo, di quell’incendio, è un lampadario in bronzo di settanta centimetri di diametro che in origine doveva essere appeso al soffitto di un quadriportico, un grande porticato di fronte alla Basilica, ma che gli archeologi hanno ritrovato spezzato, sul pavimento, sommerso dai carboni dell’incendio. È un polycandelon, poteva cioè portare più luci, più lumi, ed è costituito da due corpi illuminanti, uniti all’epoca con catene. Sulla corona inferiore ci sono raffigurazioni cristiane come il galletto, simbolo del momento forse più doloroso della vita di Cristo, la sconfessione di Pietro seguita dal canto del gallo; e quella della colomba, simbolo del perdono e della pace. Nella parte superiore doveva esserci un’altra corona, ora scomparsa.
Gli archeologi ritengono che questo lampadario fosse già sopravvissuto a un altro saccheggio quando, quarant’anni prima, un altro popolo barbaro, i goti di Alarico, aveva attaccato Aquileia prima di procedere al famoso sacco di Roma. Ma se quella prima volta era stato recuperato e riparato, non è però riuscito a sopravvivere al passaggio di Attila.
Una fine e un nuovo inizio
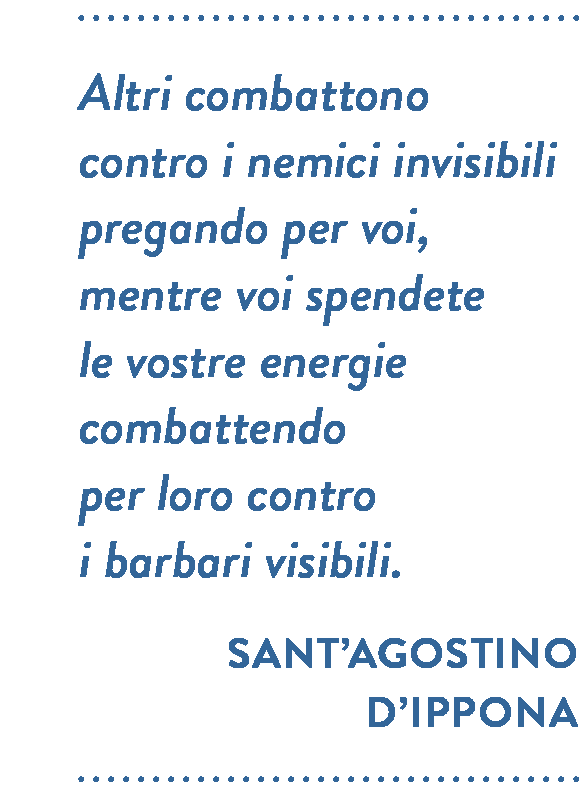
L’assalto degli unni viene spesso raccontato come l’atto finale della vicenda di Aquileia, ma a dire il vero, quello di Attila che ha cancellato la città dalla Storia è principalmente un mito. Tante prove archeologiche ci dicono infatti che le cose non sono andate proprio così: nonostante quell’incredibile trauma, la grandezza di Aquileia non finisce con quell’assedio. Diciamo piuttosto che il racconto si interrompe per poi ricominciare, questo sì, su basi completamente diverse. Molte chiese vengono ricostruite, le mura distrutte vengono riattrezzate e si erige una nuova cinta bizantina: piccoli esempi di come la città abbia continuato a vivere, a prosperare, e sia ritornata a essere un importante centro per i commerci con l’Oriente. Non dimentichiamo poi che ad Aquileia c’era non solo una delle sedi delle zecche imperiali ma anche un potente Patriarcato, ovvero una delle diocesi più influenti della penisola, con una sua indipendenza anche rispetto alla Chiesa di Roma (di cui però, naturalmente, accetta l’autorità).
La vera fine della sua gloria va collocata più avanti, oltre un secolo dopo, quando a cambiare non è tanto o solo Aquileia, quanto tutto il contesto storico e politico della penisola. L’Impero Romano non c’è più, i bizantini combattono contro i longobardi e altre città hanno preso il posto e il ruolo di Aquileia. I bizantini scelgono di puntare su altri centri più vicini alla costa come Ravenna e Grado, mentre i longobardi guardano più a nord, come a Cividale del Friuli. È in questo momento che Aquileia perde la sua importanza strategica e commerciale e gradualmente muore. Di morte naturale, diremmo noi oggi, lasciandoci circondati da queste rovine silenziose, di cui ancora rimane moltissimo da scoprire.
