RAVENNA BIZANTINA

Tre volte capitale, cuore pulsante di un regno, la città protegge e cura i suoi tesori.
Cinquant’anni prima della fine di Aquileia, nel 402, l’imperatore dell’Impero Romano d’Occidente Onorio ha trasferito la sua residenza da Milano a Ravenna, spaventato dalla minaccia di Alarico, re dei visigoti. Per questa città affacciata sull’Adriatico inizia qui un periodo cruciale e contraddittorio. Mentre il porto militare e commerciale di Classe, che aveva reso grande la città durante i secoli imperiali, diventa via via inutilizzabile a causa dell’interramento della laguna, la forza politica di Ravenna sembra però crescere a vista d’occhio.
Nel giro di pochi anni la città è tre volte capitale e, dopo la caduta dell’ultimo imperatore Romolo Augusto per mano di Odoacre (nel 476), diventa prima il centro del regno gotico di Teodorico e in seguito dell’esarcato bizantino stabilito da Giustiniano (nel 527).
Eppure, nonostante il suo glorioso passato imperiale, come Aquileia anche Ravenna è una città discreta, che nasconde con cura i suoi tesori più preziosi. Dietro ai semplici mattoni degli edifici che possiamo vedere passando per le sue strade si celano molte meraviglie di cui otto sono state dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1996.
Uno di questi tesori nascosti è il mausoleo di Galla Placidia, detta “la nobilissima” perché figlia, sorella e madre di imperatori romani e lei stessa imperatrice nel momento più critico della storia dell’Impero.
Sorella dell’imperatore Onorio, Galla Placidia viene presa prigioniera dai visigoti in seguito al saccheggio di Roma (nel 410), e concessa in sposa al re barbaro Ataulfo in un’ottica di avvicinamento tra barbari e cristiani. Dopo la morte del marito e del figlioletto Teodosio, viene data in sposa da Onorio al suo fidato generale Costanzo. Il figlio della coppia, Valentinano, sale al trono a soli sei anni e governa per i primi tempi sotto la tutela della madre.

Il Mausoleo di Galla Placidia
Nei primi decenni del V secolo, i romani vivono con sempre maggior preoccupazione l’avanzata dei goti. Per questa ragione la famiglia imperiale si rifugia a Ravenna che, all’epoca, sorge su isolotti lagunari che ne facilitano la difesa. Il vicino porto di Classe, anche se sempre meno praticabile, offre inoltre la garanzia di una via di fuga in caso di invasione.
In questa condizione drammatica in cui i romani vedono i confini del loro mondo erosi e istituzioni millenarie cadere di fronte all’avanzata dei “barbari”, Galla Placidia decide di raccogliere quanto rimasto del suo impero sotto un baluardo identitario che ne preservi la frammentazione: la fede cristiana.
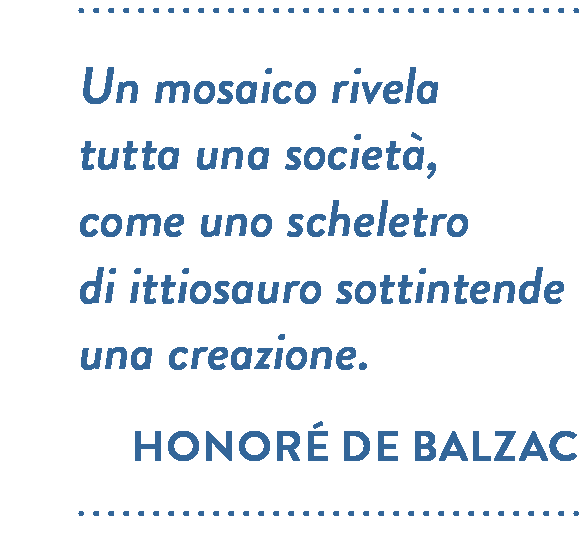
La celebrazione della fede è il motivo centrale del progetto artistico del Mausoleo che rappresenta un esempio di fusione tra lo stile tardo-imperiale e le influenze dell’arte sacra bizantina. Entrando nell’edificio, il cui esterno è in mattoni grezzi, si rimane storditi dalla lucentezza di migliaia di tessere d’oro e dalla vivacità dei colori dei mosaici, in particolare l’azzurro che domina, mantenendo intatte dopo sedici secoli le due tinte brillanti.
Oro e azzurro, i colori della divinità, segnano simbolicamente l’accesso a una dimensione ultraterrena, sottolineata dai temi dei mosaici che riguardano la vita dopo la morte. La presenza dei sarcofaghi, del resto, rivela la natura del luogo: una sepoltura imperiale che testimonia la gloria dell’Impero in declino e la speranza della resurrezione.
Secondo la tradizione, Galla Placidia avrebbe fatto costruire questo mausoleo per ospitarvi le sepolture della famiglia imperiale. Vi sono diverse interpretazioni: forse ha voluto il mausoleo per sé, per il marito e per i due figli, oppure soltanto per il marito, morto prematuramente, e per il fratello Onorio. Gli antichi sarcofaghi non hanno però iscrizioni e gli studiosi non possono stabilire con certezza se le sepolture abbiano contenuto le spoglie di qualche membro della famiglia imperiale.

Una lettura… per immagini
I mosaici del mausoleo sono un libro illustrato e denso di simboli da decifrare.
Sulle lunette laterali s’intravedono due cervi che si avvicinano a uno specchio d’acqua e due colombe che si abbeverano a una fontana. Si tratta di citazioni dai Salmi e dal Vangelo: “Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia anela a te, o Dio” (Salmi, 41-42). In questi passaggi delle Scritture l’acqua è simbolo della vita eterna che, per i cristiani, solo Dio può garantire.
Alzando gli occhi alla volta, ci si può perdere in un cielo azzurro intenso in cui brillano centinaia di stelle dorate che, per trasmettere l’illusione di uno spazio infinito, diventano più piccole e disegnano cerchi concentrici intorno al simbolo della croce, unica fonte di salvezza per una cristiana come Galla Placida.
Ai quattro angoli della volta sono invece rappresentati i simboli dei quattro Evangelisti, portavoce del messaggio di redenzione di Cristo.
Si vedono con chiarezza i quattro Vangeli anche nella libreria di san Lorenzo, rappresentato nella lunetta centrale mentre incede verso il suo martirio senza paura, fiducioso nella vita eterna. Al suo fianco lo strumento del supplizio, la graticola ardente sulla quale fu messo a morte a Roma nel 258.
Alcune fonti raccontano di come Galla Placidia, rimasta orfana a Milano, abbia avuto come padre spirituale sant’Ambrogio, allora vescovo della città. Proprio Ambrogio descrive nei suoi scritti il martirio di san Lorenzo, che la discepola avrebbe per questo deciso di far rappresentare nel Mausoleo.


Il Mausoleo di Teodorico
Appena pochi decenni dopo la morte di Galla Placidia, il mondo è cambiato completamente.
Nel 476, infatti, crolla l’Impero Romano d’Occidente e la storia della penisola entra in una fase ancora più cupa e turbolenta. Alla fine del V secolo è Teodorico, un re ostrogoto, a regnare sull’Italia, garantendo, nei suoi trentatré anni di regno, un periodo di relativa pace e prosperità.
Anche lui sceglie Ravenna come capitale e qui decide di farsi costruire un monumento funebre stupefacente che ricordi la sua gloria ai posteri.
Questo monumento ha una sua eccezionalità: è costruito interamente in blocchi di pietra d’Istria incastrati tra loro a secco. La sua copertura è poi costituita da un unico monolite di pietra aurisina, issato grazie a una rampa.

Se l’esterno del mausoleo è monumentale, l’interno racchiude enigmi ancora insoluti. Uno di essi riguarda la vasca di porfido che la tradizione riconosce come il sarcofago del re ostrogoto. È impossibile determinare se il sarcofago, trasportato nei secoli successivi nel palazzo di Teodorico, occupasse la posizione attuale. Alcuni studi, infatti, ritengono fosse inizialmente collocato all’esterno del mausoleo. Allo stesso modo non si può avere la certezza che fosse effettivamente destinato a essere la tomba di Teodorico.
L’esarcato di Ravenna e la basilica di San Vitale
Pochi anni dopo la morte di Teodorico, Ravenna subisce una nuova, radicale trasformazione. Stavolta sono i bizantini a conquistarla e a “degradarla” da capitale a esarcato, centro di una delle molte province dell’Impero bizantino.
L’imperatore Giustiniano, che ha unificato l’Italia a Costantinopoli, decide di realizzare un simbolo della gloria imperiale e del cristianesimo ancora più imponente dei capolavori nati sotto il regno di Teodorico. Nasce così una delle meraviglie assolute dell’epoca, un tesoro che tutto il mondo ci invidia: la basilica di San Vitale.
Si tratta di un edificio a pianta ottagonale coperto da una cupola. La sua architettura è sicuramente influenzata da modelli di Costantinopoli, in particolare dalle chiese dei Santi Sergio e Bacco e di Santa Sofia, di pochi anni prima. Si tratta quindi di qualcosa di nuovo per l’Italia centrale, dalle evidenti influenze orientali.
All’interno della chiesa, su ogni lato dell’ottagono, si apre un’esedra con due ordini di tre archi ciascuno. Il giro delle colonne e dei pilastri, in gran parte ricoperti dei preziosi marmi originali, incorniciano il presbiterio e l’abside, splendidamente rivestiti di scintillanti mosaici del VI secolo, tutti originali.
È questo il vero tesoro della Basilica, testimonianza dell’arte bizantina unica al mondo.
Per la gloria di Dio e dell’Impero
Dietro all’altare di San Vitale risplendono le meraviglie di Ravenna più conosciute: i mosaici dell’abside.
Siamo in piena epoca bizantina e le sottili influenze orientali del Mausoleo di Galla Placidia lasciano lo spazio al fulgore assoluto dell’arte sacra bizantina: l’oro proietta la scena al di fuori dello spazio e del tempo, in una dimensione ultraterrena. Dall’umano si passa al divino.
Cristo Pantocratore, in tutta la sua regalità, risplende al centro dell’abside, seduto sul globo azzurro dell’universo. Sul rotolo che ha in una mano ci sono i sette sigilli dell’Apocalisse mentre, con l’altra mano, porge la corona del martirio a san Vitale. Il santo indossa uno splendido mantello ricamato d’oro e di gemme: dovrebbe essere un semplice soldato romano, ma l’artista lo riveste di luce come fosse un principe orientale.
Il Cristo è ritratto con un volto giovane, senza barba, come accadeva nei primi secoli del cristianesimo, eppure non perde nulla della sua autorevolezza di imperatore dell’universo. A destra, il vescovo Ecclesio, primo promotore della chiesa, presenta il modellino della basilica a Cristo, per riceverne l’approvazione.
I mosaici di San Vitale più famosi e riprodotti sono quelli sul lato destro dell’abside che rappresentano i cortei dell’imperatore Giustiniano, grande codificatore del diritto romano, e di sua moglie Teodora.
Gli imperatori sono rappresentati in tutta la loro regalità nell’atto di partecipare alla celebrazione eucaristica con due preziosi doni: Giustiniano offre la patèna per il pane e Teodora il calice per il vino. Accanto all’imperatore è raffigurato il vescovo Massimo di cui si legge anche il nome: con questa rappresentazione Giustiniano voleva infatti rafforzare il potere del suo emissario nella provincia di Ravenna.
Gli altri personaggi del corteo imperiale, rappresentanti del potere religioso e militare, non sono identificati, anche se alcuni studiosi credono di riconoscervi il generale Belisario, artefice della conquista italiana.

Nel raffigurare il corteo di Teodora e delle sue ancelle, l’artista ha profuso una maggiore ricchezza e raffinatezza di dettagli, usando non solo tessere d’oro ma anche d’argento, madreperla e pietre dure. L’imperatrice indossa un meraviglioso diadema con fili di perle e un pettorale tempestato di gemme. Sul bordo del suo manto di porpora sono rappresentati i re magi, un richiamo all’offerta presentata a Cristo. Gli abiti delle ancelle e i veli che portano sul capo sono una testimonianza unica dell’eleganza della corte bizantina.
Nonostante sia passato poco più di un secolo dai mosaici del Mausoleo di Galla Placidia, a San Vitale, l’atmosfera e il sistema simbolico sono cambiati. I dettagli non mirano al realismo ma, piuttosto, a ottenere uno splendore ultraterreno che richiami la divinità.
Anche la tecnica esecutiva va in questa direzione: gli artisti tagliano le tessere sul posto e, seguendo il disegno sulla parete, le allettano nell’intonaco fresco, ottenendo così una superficie in cui ogni cubetto è orientato in modo diverso e riflette la luce a seconda dell’inclinazione. Per questo, se ci muoviamo mentre ammiriamo i mosaici, li vediamo scintillare: è la luce, con il suo rimando alla natura divina dell’Impero, a dominare il progetto di San Vitale.


