SAN VINCENZO, UN GIOIELLO DA RISCOPRIRE

Le pareti di una cripta rimasta sepolta per secoli tracciano un racconto per immagini del Medioevo.
L’VIII secolo è un momento cruciale per la nostra penisola; dopo una strenua difesa dei territori i longobardi devono, infatti, cedere il passo ai franchi e al sovrano Carlo Magno che, nel 774, diventa il loro re. Sono gli albori dell’epoca carolingia, che ci ha lasciato splendide testimonianze artistiche.
A questo periodo risale l’abbazia benedettina di San Vincenzo, un piccolo gioiello che si trova alle pendici delle vette delle Mainarde, in una regione attraversata dal fiume Volturno, il più lungo dell’Italia meridionale, che nasce in provincia di Isernia e sfocia nel mar Tirreno presso Castel Volturno. È forse proprio al Volturno – che autori dell’età romana come i poeti Lucano e Stazio chiamano Volturnux rapax o Volturnus celer per via della velocità delle sue acque – che possono essere fatti risalire i primi, remoti insediamenti in questi luoghi.
L’abbazia viene infatti eretta all’inizio dell’VIII secolo per volontà, si legge nel Chronicon Vulturnense, un codice miniato redatto dai monaci nel 1130, di tre nobili beneventani, Paldo, Taso e Tato, che avevano individuato questo luogo, ne comprendiamo bene la ragione, come adatto per favorire l’ascesi e una vita semplice immersi nella bellezza e nella natura. Non sono in realtà i primi a essersi innamorati del luogo: già prima di loro, in epoca tardo-romana, c’erano stati insediamenti di cui tuttora sono rimaste le tracce nei resti di una chiesa e di un’area sepolcrale del V-VI secolo d.C.

Meno di un secolo dopo la sua fondazione, l’abbazia accresce il suo prestigio quando Carlo Magno ne riconosce l’importanza strategica e ne fa un avamposto al confine tra il principato longobardo di Benevento e le terre conquistate dai franchi. Il monastero viene posto per decreto direttamente sotto la sua direzione e si vede garantiti una serie di diritti speciali fra i quali, molto importanti, alcune esenzioni fiscali e giudiziarie nonché l’autorizzazione alla comunità a eleggere il proprio abate senza alcuna interferenza da parte di altre autorità ecclesiastiche. Anche successivamente, nell’849, quando si verifica la divisione del principato tra territori soggetti a Salerno e a Benevento, il monastero di San Vincenzo al Volturno rimane un’entità autonoma, chiamata a rispondere direttamente all’autorità imperiale.
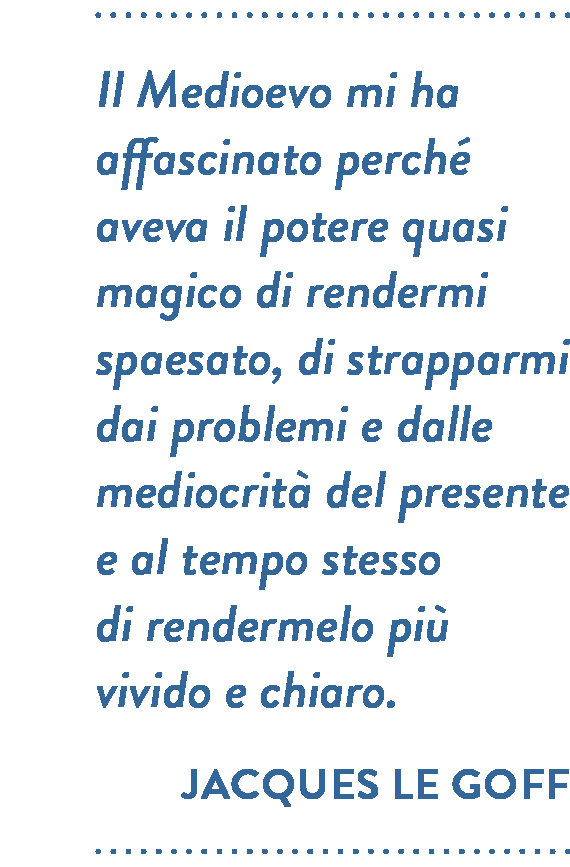
Siamo invece nell’881 quando il monastero viene attaccato dai saraceni che danno fuoco all’edificio e ne danneggiano la struttura. Molti monaci rimangono uccisi e quelli che riescono a scappare sono costretti a cercare ospitalità presso i principi longobardi di Capua. È davvero un giorno infausto per la storia di questo luogo, tanto che ancora oggi, ogni anno, il 10 ottobre si ricordano i martiri dell’aggressione saracena.
Qualche anno dopo, alcuni monaci superstiti cercano di ritornare alla vecchia struttura ma ormai è tardi: ci vorrà molto tempo prima che si ricreino le condizioni adatte a ridare vita al monastero.
Intorno alla fine del X secolo, grazie all’aiuto degli imperatori tedeschi Ottone II e Ottone III, viene ricostruito nelle vicinanze un nuovo monastero, questa volta sulla riva destra del Volturno che offre maggiori possibilità di difendersi da eventuali attacchi. È in quest’epoca che alcuni monaci redigono l’importante e già citato Chronicon Vulturnense e che si sviluppa una rete di piccoli centri nei dintorni della struttura religiosa. Sembra una rinascita, ma è proprio in questo momento che la comunità monastica entra in una fase di lento ma inesorabile declino. Un declino lunghissimo che però non rappresenta la fine di una storia se pensiamo che, dopo secoli di silenzio, l’abbazia troverà nuova vita, nel 1989, grazie al ritorno di una comunità monastica presso il convento.
La cripta ritrovata
È una storia lunghissima quella che si è sviluppata fra le rive del fiume Volturno e le aspre rocce delle Mainarde, una storia di vita ascetica e influenze politiche, che trova espressione nelle strutture abbaziali dall’VIII all’XI secolo e che varie campagne di scavo, effettuate in epoche anche molto lontane fra loro, hanno riportato alla luce.
La vera svolta, come già accaduto altrove, avviene nei primi decenni dell’Ottocento, grazie al ritrovamento fortuito da parte di un contadino di Castel San Vincenzo, sotto il terreno, di una striscia di pietra, nascosta da foglie ed erbacce, che appartiene a una parete completamente affrescata.
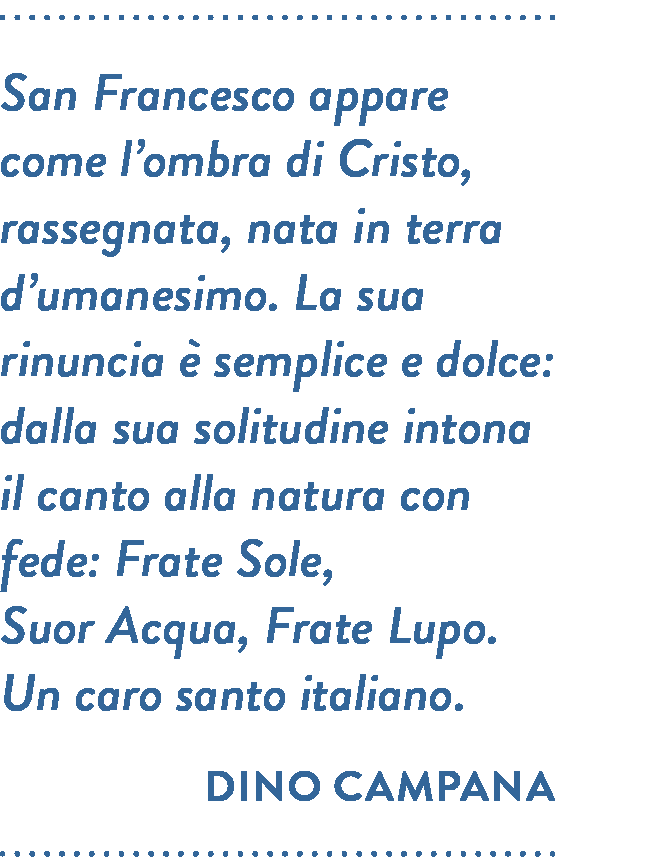
È grazie a lui se oggi possiamo ammirare la meravigliosa cripta di Epifanio, risalente al IX secolo.
Gli affreschi che decorano questa cripta, nei pressi del fiume Volturno, in una regione che è immersa nella natura e lontana dai grandi centri d’arte, sono considerati tra le testimonianze più importanti della pittura altomedievale europea. Le ragioni di questo giudizio sono varie e spaziano dalla qualità dei disegni alla complessità del messaggio, fino all’ottimo stato di conservazione garantito dal fatto che la cripta, prima di essere scoperta, è rimasta interrata e quindi preservata dagli agenti atmosferici, per diversi secoli.
È un messaggio, quello degli affreschi, non semplice, non didascalico, e sulla cui interpretazione tuttora molti esperti faticano a trovare un accordo.
La prima immagine che si vede è una mano distesa che si pensa simboleggi quella del Padre. Su tutta questa parete, la est, il tema principale è quello dell’incarnazione del Verbo in Cristo nella successione dei diversi episodi biblici: c’è l’Annunciazione della nascita, la gravidanza di Maria, la natività e poi Maria, con in braccio il pargolo, Dio che si è fatto uomo.
Il tema della parete ovest è invece il martirio, narra la storia di coloro che, a rischio della propria vita, hanno scelto di testimoniare la loro fede in Gesù Cristo. Sono raffigurati i santi Lorenzo e Stefano nel momento del loro supplizio.

Infine, gli affreschi illustrano le visioni di Giovanni l’Evangelista riportate nel libro dell’Apocalisse, come quella dei quattro angeli che “stavano ai quattro angoli della terra, e trattenevano i quattro venti, perché non soffiassero sulla terra… Vidi poi un altro Angelo che saliva dall’Oriente e aveva il sigillo del Dio vivente”.
Lasciamo la provincia di Isernia e spostiamoci adesso in quella di Campobasso, andiamo a visitare l’antico borgo di Casalcalenda che, fra ulivi secolari e campi di grano, ci racconta una storia iniziata più di duecento anni prima della nascita di Cristo.

Il patrimonio di Casalcalenda
Spostiamoci in provincia di Campobasso per visitare l’antico borgo di Casalcalenda, che ci racconta una storia iniziata oltre duecento anni prima della nascita di Cristo.
Le prime informazioni relative a Casalcalenda si riferiscono a uno scritto dello storico greco Polibio, vissuto fra il I e il II secolo a.C., il quale, narrando le vicende della Seconda guerra punica, racconta di come l’esercito romano sosti in una località che chiama Kalene, l’antica Casalcalenda, per prepararsi a uno scontro contro le truppe del temibile Annibale nascoste in questa zona. Basta guardarsi intorno per capirne la ragione: l’area è infatti ricca di acqua e la vegetazione fatta di imponenti faggi e cerri doveva garantire anche allora sia la possibilità di rimanere celati, sia una grande disponibilità di legna.

Sopravvissuta alle traversie di diverse epoche storiche, Casalcalenda si presenta oggi come un classico borgo medievale, arroccato su una collina e protetto da un sistema di mura, con un piacevole centro storico. Ma forse la vera meraviglia in questo luogo così ricco di storia deriva da una decisione presa di recente, alla fine del secolo scorso, quando l’amministrazione comunale ha scelto di trasformare in un’oasi protetta proprio quell’area in cui si ritiene si fosse fermato Annibale, vietandovi il taglio della legna e la caccia.
