LA SANTA ASSISI DI FRANCESCO E DI GIOTTO

Nel cuore della spiritualità della nostra penisola, i luoghi dove due giovani cambiarono la storia del cristianesimo e quella dell’arte.
Nel XII e nel XIII secolo, cuore del Medioevo cristiano, la penisola vive il fiorire e l’espandersi dei monasteri, con le loro meravigliose biblioteche di codici miniati e l’essenziale ruolo politico ed economico che ricoprono nella società dell’epoca. E se fino a questo momento sono stati i benedettini a dominare la scena, proprio sul finire del XII secolo nasce una figura destinata a rivoluzionare per sempre la Chiesa. Per addentrarci in quest’epoca ricca e vivace del Medioevo è quindi opportuno fare riferimento alle sue terre, ai luoghi natali di san Francesco, da cui ha preso piede un inaudito rinnovamento spirituale.
La via per Assisi è da sempre percorsa da migliaia di pellegrini da tutto il mondo. Tutto attorno, l’atmosfera è particolare, invita alla calma, all’introspezione. In alto, sulla collina, eccola, Assisi: bianca, maestosa, adagiata sull’ampia conca della valle umbra.
Ne percepiamo la grazia e la bellezza. Quante volte Francesco avrà ammirato questo stesso paesaggio? Di certo, oggi, come centinaia di anni fa, qui tutto contribuisce a rasserenare l’animo: il silenzio, la pace, l’argento degli ulivi.

Contempliamo la città dal basso, provando a immaginare di essere uno di quei pellegrini, arrivato finalmente a destinazione dopo un viaggio lungo e faticoso e con in cuore la speranza di accogliere dentro di sé un po’ della grazia di Francesco. Davanti a noi, come un porto sicuro, c’è il maestoso convento, con la sua doppia fila di alti archi che comunicano insieme forza e leggerezza, potenza e grazia. E c’è la Basilica, altrettanto inconfondibile, che ha resistito alla prova del tempo e alle devastazioni dei terremoti.
Un’architettura grandiosa, apparentemente in contraddizione con la figura del “santo poverello”, che predicava l’umiltà e l’obbedienza e viveva in povertà assieme ai confratelli. I francescani: un ordine fondato sulla carità.
Il colle del Paradiso
San Francesco, nato ricco, ha passato la vita a pregare in celle spoglie e perfino in grotte. Perché allora, appena due anni dopo la sua morte, viene posta la prima pietra di un complesso monumentale tanto imponente?
Sono molte le ragioni. La prima è la consapevolezza, già nei primi giorni del lutto, che Francesco è entrato nel cuore della gente. Si intuisce che tantissimi fedeli vorranno conoscere i luoghi in cui è vissuto e si pensa quindi a una chiesa grande abbastanza per ospitare i devoti. E poi c’è anche una ragione più politica: il papato, che del progetto sarà il principale finanziatore, vede nei francescani gli alleati ideali per rinsaldare i legami con il popolo. Francesco viene santificato con un processo rapidissimo, che dura solo due anni, e immediatamente dopo si parte con la costruzione di un luogo unico per accogliere i pellegrini.
Il progetto di questo straordinario complesso, strano a dirsi, non viene assegnato a un grande architetto. È invece il risultato della fantasia e della creatività di un frate, Elia, a cui Francesco ha affidato l’ordine da lui fondato, che viene nominato dal papato commissario di questa immensa fabbrica. Un compito difficile, basti pensare che il territorio collinare intorno ad Assisi è piuttosto impervio. Ma sarà proprio questa conformazione a ispirare a Elia un’architettura su più livelli: costruirà non una, ma due chiese sovrapposte e indipendenti. Una basilica Inferiore, la parte sepolcrale, dedicata alla tomba del santo e con un impianto ispirato al romanico umbro e lombardo. E una basilica Superiore, d’impronta più nettamente gotica, destinata alle messe solenni e alle predicazioni.
È il 17 luglio del 1228 quando si posa la prima pietra; per completare i lavori ne serviranno migliaia e migliaia, tutte provenienti dal vicino Monte Subasio e di quel colore bianco e rosa, così tipico di Assisi.
Nel 1253, venticinque anni dopo, si svolge la solenne inaugurazione di quest’opera grandiosa, eretta proprio sopra il sepolcro del Santo. È stato lo stesso Francesco a deciderne la collocazione: un colle fuori dalle mura, proprio in corrispondenza del luogo in cui tradizionalmente si svolgevano le esecuzioni capitali. Una scelta di umiltà, un gesto di vicinanza agli ultimi e ai reietti della società del suo tempo, in linea con la predicazione di una vita. E una decisione che cambierà l’anima del luogo, a partire dal nome: la valle che fino a quel momento tutti hanno chiamato vallis inferni diventerà, grazie alla presenza del corpo di Francesco, il colle del Paradiso.
Un giallo attorno al corpo di Francesco
Con il passare dei decenni, succede qualcosa di inaspettato: da una generazione all’altra, le tracce del corpo di Francesco si perdono. Il Santo scompare o, perlomeno, ci si dimentica dove si trova. Non succede per caso, c’è un motivo, preciso, urgente, ed è che dalla metà del Trecento a tutto il Quattrocento, Assisi e Perugia sono costantemente in conflitto. Scontri, attacchi, devastazioni: qualcuno, ad Assisi, temendo che i perugini possano rapire le spoglie del santo e usarle come arma di ricatto, decide di nasconderle. Ma senza dire dove. Forse quel qualcuno muore proprio negli scontri senza avere il tempo di lasciare le informazioni necessarie a ritrovarle. E, improvvisamente, di Francesco non si sa più nulla.
Ci vogliono quasi cinque secoli perché – l’anno è il 1818 – papa Pio VII ordini di cercarne il corpo. Per quasi due mesi si scava invano, senza successo. Nell’aria c’è il desiderio di arrendersi, sembra un’impresa impossibile recuperare ciò che è andato perduto da quasi sei secoli, finché, nel corso della cinquantaduesima notte di ricerche, un operaio, rotte tre lastre di travertino, ritrova a quattro metri e mezzo di profondità il semplice sarcofago di pietra dove frate Elia aveva composto tanto tempo prima il corpo di san Francesco.
,_tavola_di_san_francesco,_museo_della_porziuncola.jpg)
Il viso di un santo
A raccontarci qual era l’aspetto di Francesco sono l’occhio e la mano di un altro grande d’Italia, Cimabue, che, nato a Firenze circa sessant’anni dopo di lui, ritrarrà il Santo in un famoso dipinto. In quest’opera, realizzata nel 1280, Francesco è raffigurato scalzo, sul capo la tonsura, sulle mani, i piedi e il costato i segni delle stigmate. È certamente il ritratto di Francesco più vicino alla realtà: quando Cimabue ci lavora, la memoria del più famoso cittadino di Assisi è fresca, ci sono ancora in vita persone che lo hanno conosciuto di persona. Ma se questa immagine è considerata la più attendibile, sono state le nuove tecnologie ad aiutarci ad approfondire ulteriormente. Lo scheletro di Francesco, custodito nella cripta della Basilica Inferiore, è stato infatti esaminato varie volte, l’ultima delle quali nel 2015, regalandoci molti particolari interessanti. A partire dall’altezza che, per gli standard attuali, era ridotta: solo un metro e cinquantasei. Le orecchie erano un po’ staccate dalla testa, a sventola diremmo oggi, mentre i piedi, come quelli di un maratoneta o di un appassionato escursionista, mostravano chiari segni di logoramento. Nessuna sorpresa: Francesco era un instancabile camminatore, un viandante, lo sapevamo, è così che ce lo siamo sempre immaginato. Quanto ai suoi ultimi giorni, alle cause precise della morte, tutto lascia ipotizzare sia caduto vittima di tubercolosi.
Abbiamo molte informazioni su quest’uomo vissuto nel XIII secolo. Ma non è tutto, e altre risposte ci verranno da ulteriori esami, anche se dovremo attendere ancora un po’. Il prossimo test è infatti in programma per il 2065.
La Basilica Inferiore
Per visitare il complesso straordinario dedicato a san Francesco cominciamo dalla Basilica Inferiore che è a un’unica navata, a cinque campate, sormontate da volte a crociera. È un ambiente intimo, suggestivo, adatto alla meditazione e alla preghiera. Alzando la testa, osservando questo luogo così particolare, si può solo immaginare l’aspetto che poteva avere in origine, rischiarato dalla luce di centinaia di lampade a olio che illuminavano le azzurre volte stellate. I fumi di queste lampade accese giorno e notte hanno infatti inevitabilmente scurito soffitto e pareti, coprendo, ma in alcuni casi anche fortunatamente preservando, grazie alla componente grassa, le pitture.
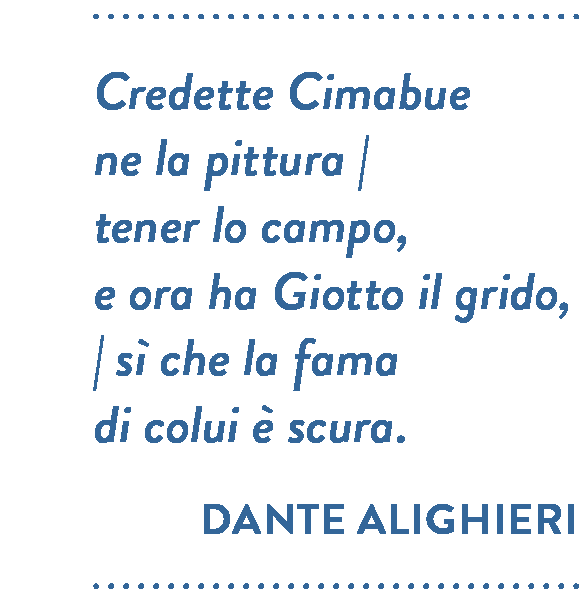
Gli affreschi presenti, oltre che di Cimabue, sono opera di altri grandi artisti dell’epoca come Simone Martini e Pietro Lorenzetti. Nelle quattro vele della volta sopra l’altare maggiore si trovano, per esempio, alcuni fra gli affreschi più celebri, le “allegorie delle tre virtù francescane”: Povertà, Castità e Obbedienza, oltre all’Apoteosi del Santo, seduto in trono tra angeli osannanti. Attribuite per lungo tempo a Giotto, oggi queste opere sono ritenute opera di un pittore non identificato, chiamato semplicemente “Il Maestro delle vele”. Fra il 1974 e il 1985 questi affreschi sono stati restaurati e, proprio in corrispondenza del transetto sinistro, i restauratori hanno lasciato un saggio, un campione di come erano scure, annerite, le pareti prima dell’intervento.
La cripta con la tomba di Francesco si trova invece a metà della navata centrale. La si raggiunge salendo due rampe di scale, in cima alle quali è difficile, anche per chi non sia un devoto del santo, resistere all’emozione. E chiara è la sensazione che al centro dell’intera Basilica Inferiore ci sia proprio questa preziosissima reliquia, il dettaglio che dà senso all’insieme.

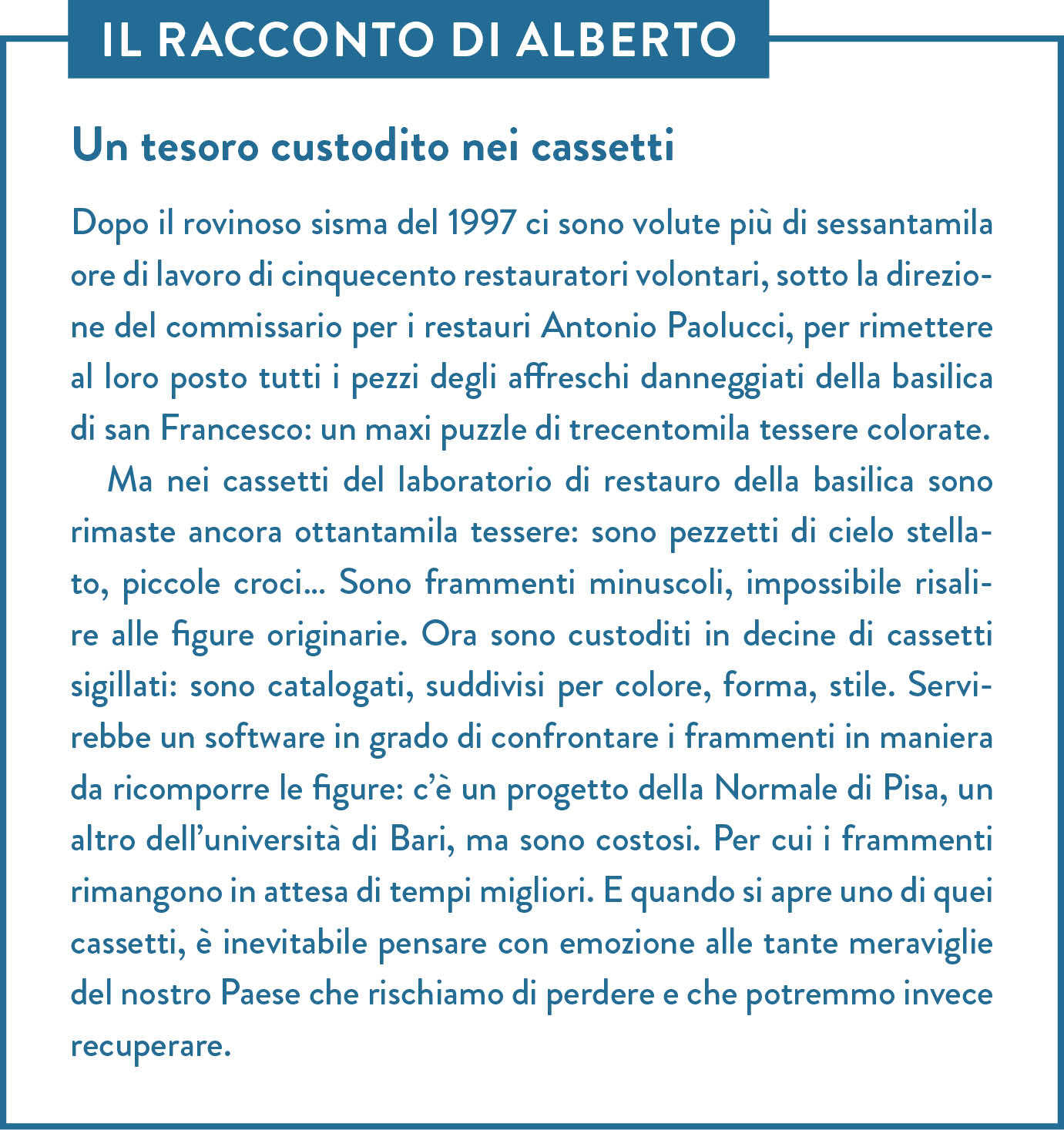
Un racconto per immagini
Abbiamo nominato il grande Giotto, ma per apprezzare la magia della sua arte dobbiamo spostarci nella Basilica Superiore che, pur se collegata a quella Inferiore, è molto diversa. Inoltrarsi in questa parte del complesso, significa infatti entrare in un altro mondo, un mondo in cui si respira un’atmosfera del tutto nuova: tanto è cupa e imponente la Basilica Inferiore, pensata come lo scrigno che custodisce una tomba, quanto slanciata e luminosa è quella Superiore. Non è un caso che proprio qui si svolgessero le predicazioni e le cerimonie solenni, che vi si radunassero le grandi masse dei fedeli.
![Citazione di Umberto Eco. Il Medioevo non aveva solo una visione cupa della vita. È vero che il Medioevo è ricco di timpani di chiese romaniche abitati da diavoli e supplizi infernali, che vi circola l’immagine del Trionfo della Morte […] Ma al tempo stesso è l’epoca in cui i goliardi celebrano la gioia di vivere, e soprattutto è l’epoca della luce.](image/98.gif)
C’è molto della visione di Francesco nel dialogo fra la Basilica Inferiore e quella Superiore: è come se la prima alludesse alla fase terrena e dolorosa della vita cui segue il tripudio di quella celeste. È francescano anche l’invito a un cammino terreno lastricato di sacrifici in vista dell’armonia della vita ultraterrena.
La Basilica Superiore, con la sua unica navata, è un ambiente dove tutto, il pavimento, le strutture architettoniche, le decorazioni pittoriche e le vetrate (non dimentichiamoci che quelle del transetto sono le vetrate originali più antiche al mondo), s’inserisce in un unico, coerente disegno. È ancora oggi un trionfo di colore e di luce, nonostante quelli che appaiono davanti ai nostri occhi siano colori “sbiaditi”, vecchi di oltre settecento anni, e sui quali è inevitabile avvertire lo scorrere del tempo.
Ma l’opera che forse più colpisce gli oltre sei milioni di visitatori che ogni anno giungono, da ogni parte del mondo, per visitare la Basilica Superiore, è stata realizzata dal grande pittore fiorentino Giotto. Proprio su queste pareti, l’artista ha regalato al mondo il ciclo d’affreschi noto come Storie di San Francesco: un affascinante racconto per immagini della vita del Santo, una sorta di biografia in ventotto scene realizzata dalla mano e dall’estro di colui che, dirà il Vasari, era “capace di ritrarre bene, al naturale, le persone vive”. Sembra una piccola lode, si trattava in realtà di una vera rivoluzione, per quel tempo: una sequenza che stupisce per la sua forza narrativa.
Ventotto scene, collegate fra loro e riconducibili a tre grandi “episodi”: la conversione di Francesco e la creazione dell’ordine, ricostruite in sette dipinti ciascuno, e l’episodio centrale, costituito da quattordici affreschi, che illustra la vita di Francesco dopo la sua morte. Nelle immagini ritroviamo non solo l’impronta della cultura medievale ma lo spirito della predicazione francescana, aperta agli umili, agli illetterati, nella quale la parola dipinta andava di pari passo con la predicazione a voce. Anche chi non sapeva leggere né scrivere poteva ricevere il messaggio: una chiave d’accesso ai significati della sua predicazione.

Il capolavoro di Giotto

Così come Francesco, anche Giotto è un grande innovatore e la sua opera, dopo secoli di figure piatte, astratte, fissate nella ieratica immobilità della tradizione bizantina, rappresenta davvero una rivoluzione. Una rivoluzione per ritrarre un santo rivoluzionario. E da qui nasce la grande pittura italiana.
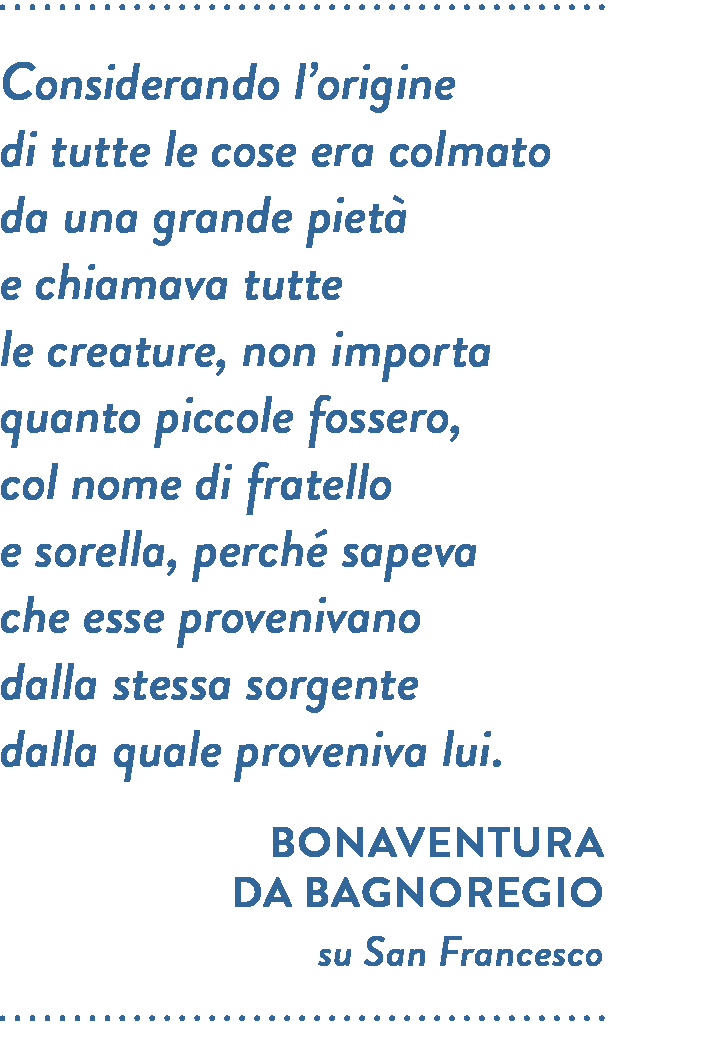
Il ciclo si dispone dall’altare verso l’ingresso e poi di nuovo indietro, in direzione dell’altare. Sono immagini, quelle di Giotto, che ritraggono paesaggi veri, così come veri sono i gesti e gli atteggiamenti dei personaggi, caratterizzati da una naturalezza e spontaneità davvero peculiari per l’epoca. Gli uomini e le donne dipinti danno la sensazione di potersi muovere liberamente, vengono addirittura ripresi di spalle, quasi Giotto si stesse divertendo a rompere le convenzioni pittoriche del suo tempo.
Più che mai Francesco appare vero, in carne e ossa, una persona semplice, decisa, amante del creato e delle creature: un santo capace di affascinare e coinvolgere tutti. Giotto con le sue immagini racconta, commuove, colpisce direttamente la fantasia popolare senza astrazioni. Dipinge un Francesco umano nelle sue debolezze, santo nella sua grandezza. Nudo, come nella scena in cui rinuncia ai beni paterni, letteralmente spogliandosi, costringendo il vescovo a intervenire per ricoprirlo con un mantello. Se ne vedono le scapole, le costole, la precisione di Giotto nel descrivere i dettagli è quasi spietata. Ma non solo: rimaniamo esterrefatti davanti alle bocche spalancate dei frati che cantano davanti al presepe di Greccio. È la prima volta nella storia della pittura in cui si vedono i denti.

Nelle immagini di Giotto non c’è ancora la prospettiva, ma c’è profondità. C’è spessore, tridimensionalità: le persone sono figure vere, inserite in uno spazio vero, e alle loro spalle compaiono elementi architettonici che contribuiscono a superare la bidimensionalità della parete. È tutto estremamente realistico: basta osservare l’assetato che si getta a terra per soddisfare la sua sete o il particolare del basto dell’asino. O, ancora, il paesaggio delle balze con alberi, entro cui si svolge la scena. L’abbiamo detto, da qui comincia la pittura in Italia.
Ma quante cose sono nate ad Assisi: oltre alla pittura, anche la letteratura nella nostra lingua inizia qui, proprio con san Francesco, che scrive una delle prime poesie in volgare, l’intenso Cantico delle creature. Arrivato fino a noi, è un inno senza tempo alla bellezza della natura e dell’animo umano.


