AMALFI, LA PRIMA CITTÀ MARINARA

Amalfi, una costa ricca di storia: dall’antichità fino alla gloria della prima città marinara.
Intorno all’anno Mille, in un periodo che vede fiorire i commerci e crescere i centri abitati, in cui la popolazione conosce un accresciuto benessere, molte città della penisola si sviluppano demograficamente ed economicamente, acquisendo un grande potere. Sono i primordi del fenomeno dei Comuni che riguarda, come vedremo, soprattutto l’Italia centro-settentrionale.
Anche nell’Italia meridionale vi sono però realtà attivissime che riescono ad accrescere il loro potere sino a guadagnare una relativa autonomia dal potere imperiale. Una di queste, Amalfi, è immersa nella natura selvatica e spettacolare della sua costa, che, non a caso, è Patrimonio Unesco, e che è stata nei secoli crocevia di popoli molto diversi fra loro. Come i tirreni, il nome con cui i greci, come abbiamo già visto, chiamavano gli etruschi, e che sono stati i primi a insediarvisi. O gli stessi greci, che poco più a nord avevano fondato le città di Paestum, l’antica Poseidonia, o di Elea, rinominata successivamente Velia dai romani. O i Fenici che qui arrivarono dai porti dell’Asia Minore, portando spezie, tessuti e conoscenze.

I commercianti scelgono come approdo questo tratto di mare per il gioco delle correnti e per la sua conformazione, interrotta da promontori e golfi. Con il passare del tempo, si sviluppano centri affacciati sul mare, una via maestra dell’antichità, percorsa da guerrieri, predatori e mercanti. È qui per esempio che gli etruschi costruiscono le loro basi commerciali.
L’odierna Amalfi è uno dei simboli di quel passato splendido. I suoi mercanti si spingeranno fino in Siria, in Palestina, in Egitto e in Marocco, fonderanno una colonia a Costantinopoli e apriranno fondachi, ovvero sedi commerciali, ad Antiochia e a Gerusalemme. E porteranno da Oriente spezie, pietre preziose e tessuti, venduti soprattutto ai ricchi principi longobardi di Benevento.
Quella di Amalfi è una potenza iniziata nel IX secolo, che esplode prepotentemente nel corso dell’XI, ed è fondata su basi solidissime, le conoscenze navali e astronomiche romane, ma è anche capace di superarle, grazie alle nuove tecniche di costruzione degli scafi.
Infatti, mentre i romani costruivano le navi a partire dallo scafo esterno per poi consolidarlo con travi interne, le navi medievali prodotte nei cantieri delle città marinare introducono una sostanziale novità: lo scheletro, costruito per primo, e sul quale viene poi inchiodato il fasciame della chiglia.
Tutto questo rende la nave più solida e contemporaneamente più maneggevole e, insieme alle nuove tecniche usate per le velature, è uno dei motivi dell’egemonia per mare di quelli che saranno i Comuni marinari italiani, le famose città marinare, nel corso del Medioevo.

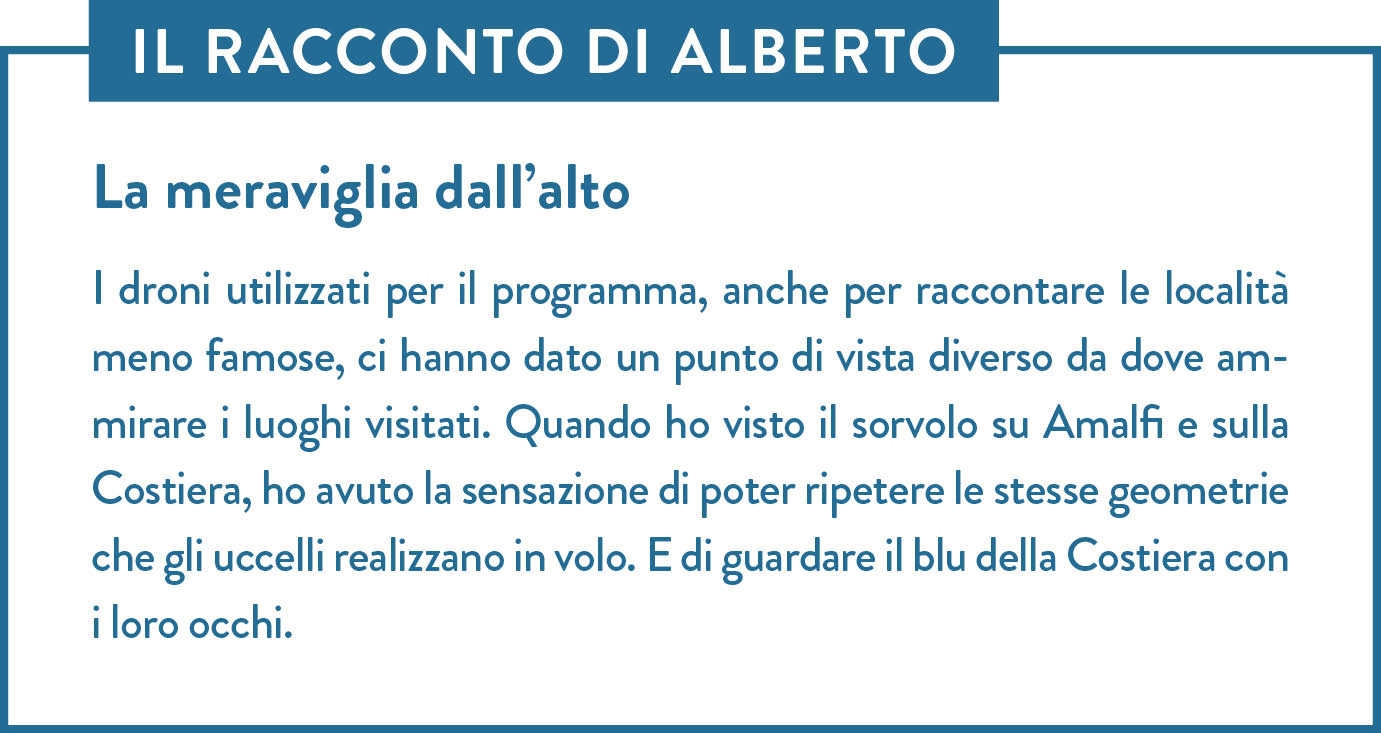
All’apice della potenza
Tra il IX secolo, in cui impone il suo predominio sul basso Tirreno, e l’inizio del suo declino, Amalfi è un importante punto di contatto tra Oriente e Occidente.
Tanta potenza, tanta voglia di espandersi, di stringere legami e alleanze commerciali, ma anche di conquistare nuove terre e nuovi mercati. Amalfi aspetta solo che la sua forza venga incanalata nella direzione giusta, e questo accade quando, nel 1095, papa Urbano II convoca la Prima crociata con l’obiettivo di liberare la Terra Santa dagli infedeli. La città vi partecipa e nel giro di pochi anni vengono fondati quattro Stati crociati in Terra Santa, che saranno difesi per due secoli.
Di quest’epoca la cattedrale di Sant’Andrea, proprio ad Amalfi, è un’importante testimonianza anche se, purtroppo, quella che possiamo ammirare oggi è la ricostruzione della chiesa successiva al 1861, quando la facciata collassò durante una violenta tempesta. Solo il campanile, edificato tra il 1108 e il 1276, è rimasto quello originale. Ma resta ancora evidente nella struttura quanto Amalfi si sentisse erede di due culture molto differenti, quella romana e quella orientale e bizantina. La chiesa nasce infatti dalla fusione di due edifici diversi, uno del IX secolo e un secondo sorto intorno all’anno Mille, per l’esattezza nel 987. Due chiese costruite una a fianco all’altra, e poi fuse in una sola.

Osserviamo, per esempio, il portale in bronzo, tutto ciò che rimane della antica facciata: al centro vediamo raffigurati due apostoli, san Pietro e sant’Andrea. Il primo, l’apostolo che evangelizzò Roma, è simbolo dell’Occidente, mentre Andrea è patrono di Costantinopoli, città in cui, secondo la tradizione, avrebbe predicato nel primo secolo, quando ancora era conosciuta col nome di Bisanzio. Le sue spoglie vennero conservate laggiù fino al XII secolo, quando furono portate ad Amalfi e il santo divenne patrono anche di questa città.
Ma le storie non finiscono qui, altre ne troviamo nel chiostro della cattedrale, chiamato chiostro del Paradiso.

Il chiostro del Paradiso
Anche il chiostro è un po’ un riassunto di tutte le culture che sono transitate in questa terra. Per cominciare, la sua stessa struttura è in stile moresco, come il campanile, mentre le colonne e i capitelli appartengono a quello che è stato definito “gotico amalfitano”. Sappiamo che, intorno al Duecento, qui sorgeva il cimitero della nobiltà locale, che doveva la sua fortuna al commercio per mare. E basta guardare le sei cappelle che qui ospitavano i sarcofaghi di cittadini illustri, per capire che i greci prima e i bizantini poi hanno avuto una grandissima influenza su questo popolo. I sarcofaghi greci che raffigurano il mito di Peleo e Teti, l’unione di Marte con Rea Silvia, e il ratto di Proserpina, probabilmente sono stati trasportati qui fin dalla costruzione del chiostro.
Ma le sorprese più grandi ce le danno gli affreschi, nei quali le figure sono tutte senza volto. Cos’è successo? Per capirlo, si deve prima di tutto dire che i volti venivano dipinti su tavolette circolari di legno, che poi venivano incastrate nell’impasto dell’affresco. Un procedimento che ha reso semplice asportarle. Da parte di chi, e perché? Forse la risposta è semplice: i ladri che, nel corso dei secoli, hanno depredato questo luogo.
Ma c’è un’ipotesi più suggestiva. Se osserviamo attentamente questi affreschi, infatti, notiamo che l’unico volto rimasto al proprio posto è quello dell’arcangelo Gabriele. Un dettaglio che ci offre un importante indizio. Per la religione musulmana, infatti, è sacrilegio raffigurare il volto della divinità eppure questo divieto assoluto ha un’eccezione: proprio l’arcangelo Gabriele. E allora, forse possiamo immaginare che le teste siano state asportate dai pirati saraceni, l’incubo delle popolazioni di queste terre per almeno cinquecento anni, in una delle tante razzie che fecero su queste coste. Non per rubarle, bensì in coerenza con la propria visione religiosa. Sarà questa la risposta esatta? Non potremo mai saperlo; quello che sappiamo è che si tratta dell’ennesimo capitolo di una storia fatta di continui scambi tra Oriente e Occidente, sulle vie del mare.
