MODENA, IL MEDIOEVO SCOLPITO NEL MARMO

Un capolavoro del romanico: il Duomo di Modena è un compendio della spiritualità e dell’immaginario medievale.
Come la gran parte dei Comuni settentrionali, anche Modena aderisce alla Lega lombarda e ottiene l’autonomia comunale nel 1135, emancipandosi dal potere vescovile. La libertà modenese è però destinata a durare poco e, un secolo dopo, Modena viene sconfitta dalla guelfa Bologna, vicina al potere vescovile, nella battaglia di Fossalta (1249). La città è riconquistata dal vescovo Alberto Boschetti, a capo del partito degli Aigoni, prima di perdere definitivamente l’autonomia comunale, consegnandosi agli Estensi nel 1288.
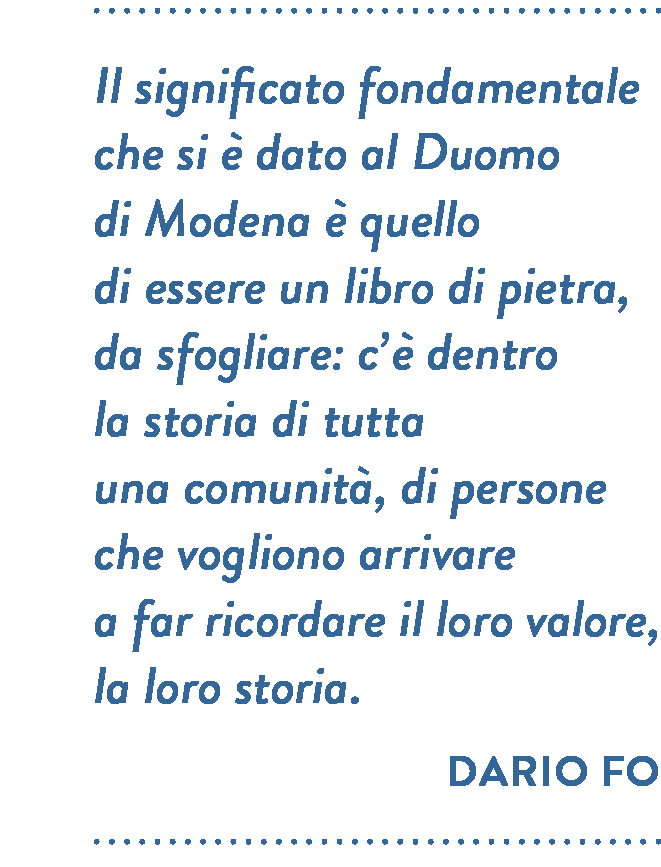
La grandezza di Modena inizia però prima di questo breve secolo di autonomia e alcuni dei suoi tesori più preziosi risalgono proprio al governo dei vescovi. Tra questi forse il più simbolico e identitario per la città è il Duomo, capolavoro del romanico.
Il duomo di Modena, la Bibbia di pietra
Una lapide murata nell’abside maggiore del duomo di Modena ci riporta la data della sua fondazione, 23 maggio 1099, e indica il nome del geniale architetto che ne ha presieduto l’edificazione, Lanfranco.
è stato più volte definito la “Bibbia di Pietra”, per il gran numero di allegorie e simboli scolpiti che ci danno l’idea del complesso di credenze e valori dell’uomo medievale.
Poco dopo l’inizio dei lavori, l’ambizioso progetto del Duomo richiede che Lanfranco sia seguito da un altro grande artista, lo scultore Wiligelmo. Diversi storici dell’arte ritengono che vi sia stata una doppia partenza dei lavori: mentre Wiligelmo inizia a lavorare alla facciata, Lanfranco, dall’altro lato della chiesa, si occupa delle absidi. A cosa è dovuta questa convinzione? Gli studiosi basano la loro intuizione sulle iscrizioni delle lapidi e su… alcuni errori di calcolo. È possibile, infatti, riscontrare sul fianco nord e sud archi irregolari, frutto di un’imprecisione dovuta a questo modo di procedere. Sono errori piuttosto frequenti nelle architetture romaniche e gotiche di quest’epoca.
Il marmo candido che riluce quando guardiamo il duomo di Modena ha origini antichissime: in gran parte è stato prelevato da una necropoli romana scoperta provvidenzialmente poco lontano dal cantiere. E la narrazione della Bibbia in immagini accoglie il visitatore sin dal suo arrivo, con le Storie della Genesi scolpite sulla facciata da Wiligelmo: quattro splendidi bassorilievi raccontano la creazione dell’uomo e il peccato originale. Altri bassorilievi, più metaforici e meno facili da decifrare, decorano l’esterno della chiesa: citiamo, tra i tanti, il putto che spegne una fiaccola sotto il piede, immagine della Morte che recide la vita, e che viene incalzato da un pellicano. Il pellicano, nel Medioevo, era considerato simbolo di Cristo a causa della leggenda secondo cui questo animale, all’occorrenza, si apriva lo stomaco col proprio becco e si faceva divorare dai suoi piccoli per salvarli dalla fame. Il bassorilievo di Wiligelmo alluderebbe quindi, metaforicamente, alla vittoria sulla morte grazie al sacrificio di Cristo.
È solo uno tra i molteplici esempi possibili per esprimere la potenza immaginifica di questi capolavori di pietra, realizzati dai più grandi artisti dell’epoca. Insieme a Wiligelmo e Lanfranco lavorano, infatti, i maestri comacini, artigiani comaschi che girano tutta Europa portando la loro perizia, organizzati in una corporazione. Due secoli dopo il duomo di Modena verrà arricchito anche dei capolavori gotici dei maestri campionesi, originari di Campione d’Italia, gli stessi la cui arte vediamo fulgidamente rappresentata nel duomo di Milano.

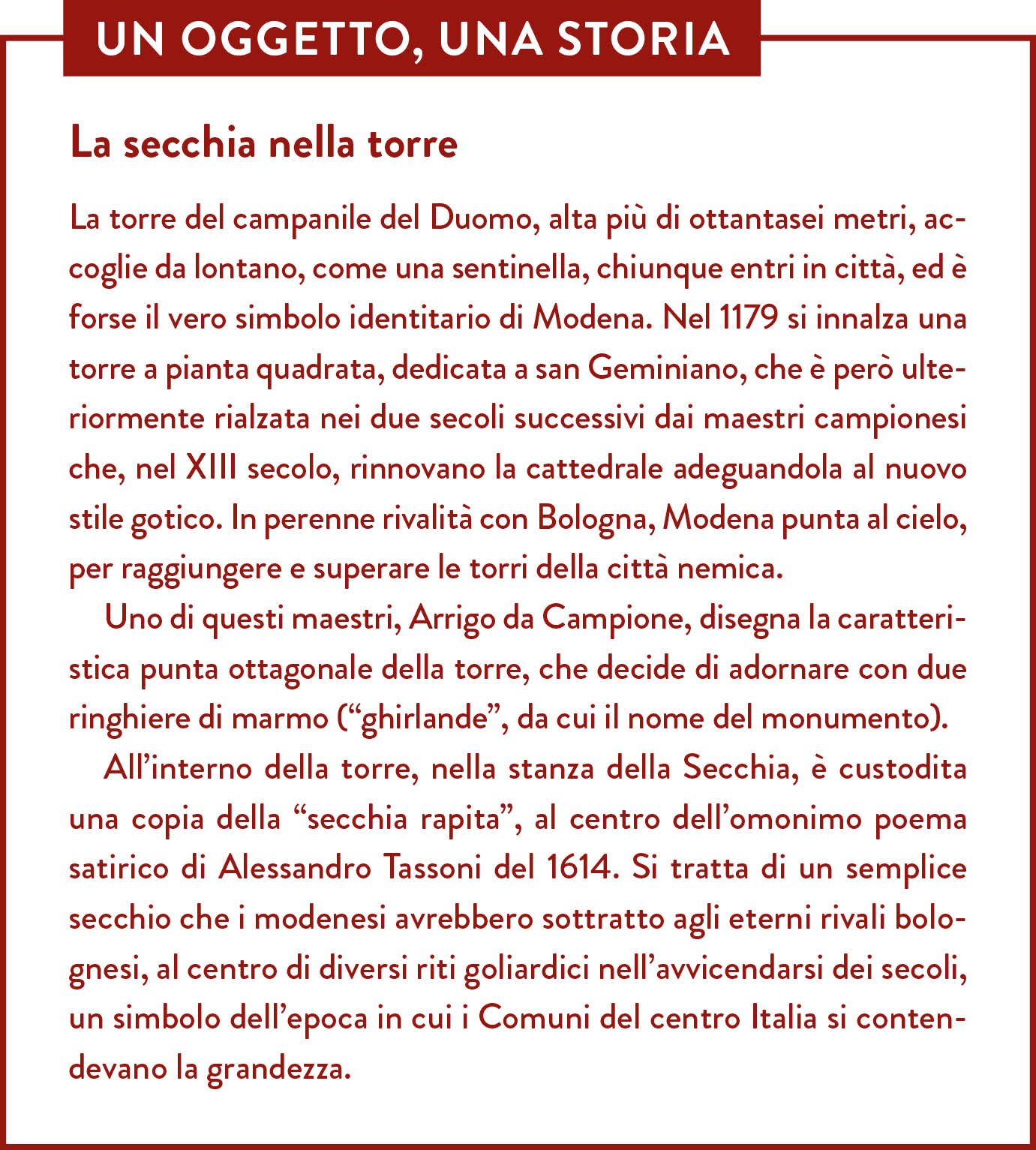
Piazza Grande
Se i valori religiosi dei modenesi sono incisi nei pregiati marmi del Duomo, i principi civici della città si esprimono nella meravigliosa piazza su cui la cattedrale si affaccia.
Il Palazzo comunale è frutto della ristrutturazione del Seicento e del Settecento che ha integrato diverse costruzioni edificate a partire dal 1046 con funzioni amministrative e politiche. Nella sala delle Bifore si può ancora vedere parte della facciata medievale precedente alla ristrutturazione.

Vicino al Palazzo c’è poi l’antica torre civica, crollata a causa di un violento terremoto del 1671 e oggi chiamata Torre Mozza.
In un angolo della piazza si può notare un grande masso di marmo, lungo oltre tre metri. Questa pietra, molto probabilmente residuo di un antico edificio romano, è detta preda ringadora (“pietra dell’arringa”) poiché, nel corso del Medioevo, è stata usata come palco per gli oratori, ma anche come pietra dello scandalo per i condannati e come luogo in cui eseguire sentenze di morte.
Piazza Grande, nel giro di pochi metri, raccoglie le funzioni civili e l’anima religiosa di un’intera città medievale, restituendoci appieno lo spirito di un mondo scomparso.
