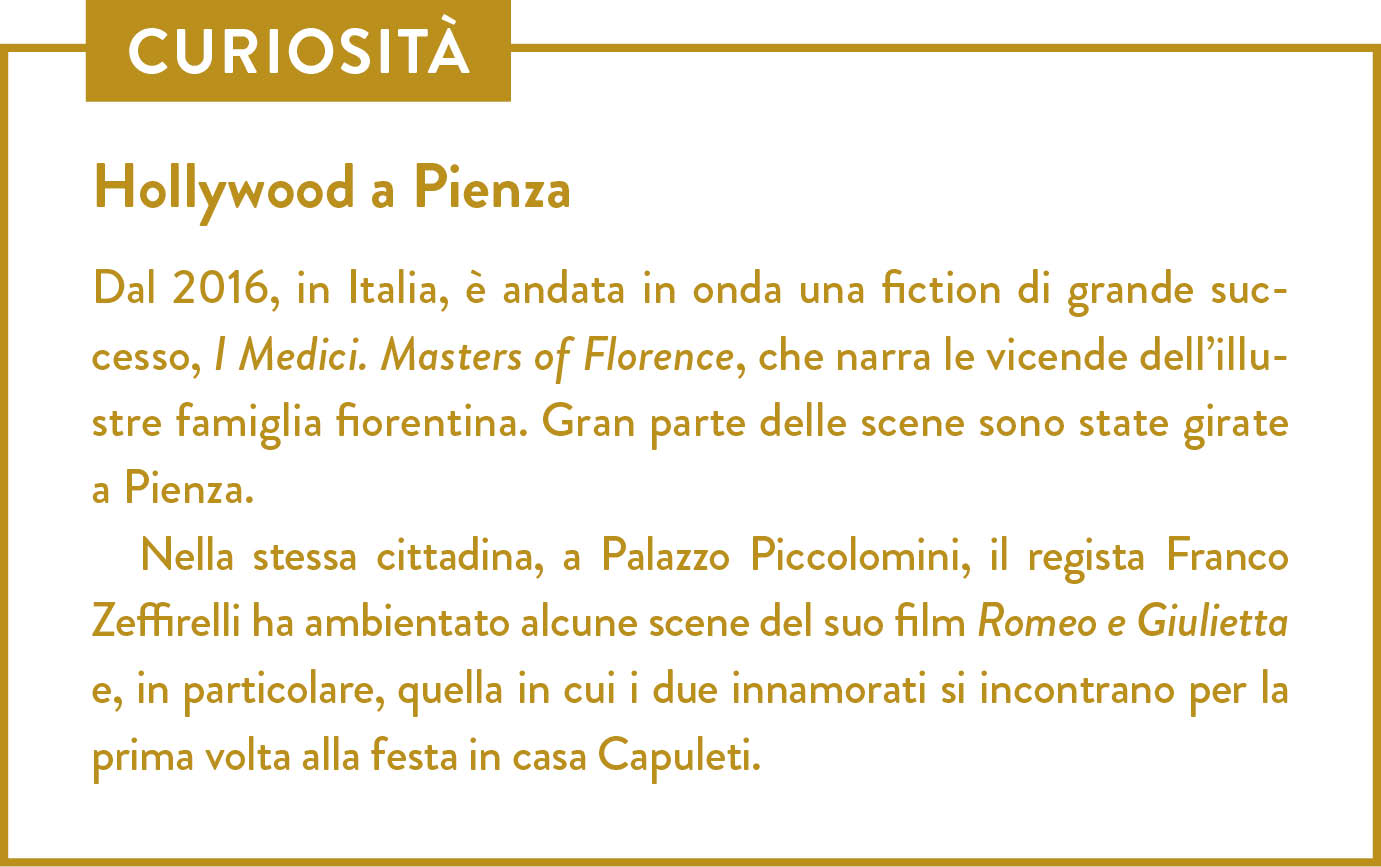FIRENZE, LA GLORIA DEI MEDICI

Non solo una città: dai palazzi del potere alle ville e ai giardini medicei, il Rinascimento giunge al culmine.
Firenze è senza dubbio la città che meglio rappresenta in tutto il mondo la gloria del Rinascimento italiano, cui la dinastia dei Medici ha consentito probabilmente la massima espressione. Tra il 1300 e il 1500, infatti, la città riveste un ruolo chiave nella politica, nella cultura e, non ultima, nell’economia. Proprio a Firenze, infatti, viene fondato nel 1397 il Banco dei Medici, che per tutto il XV secolo sarà la banca più celebre e potente, a cui si rivolgono non solo i mercanti, ma signori e sovrani.
I Medici, famiglia di banchieri, devono il loro potere proprio a questa forza economica che permette loro di appoggiare finanziariamente, per esempio, lo Stato della chiesa o la conquista di Milano da parte degli Sforza. Ben prima di diventare granduchi arrivano a detenere un potere pressoché incontrastato sulla città e sul suo contado.
Il fondatore della dinastia è Giovanni Bicci de’ Medici, ma sarà il figlio Cosimo a sconfiggere le famiglie rivali degli Albizzi e degli Strozzi: siamo nel 1434 e da questo momento l’ascesa della casata a Firenze si fa inarrestabile. Apparterranno a questa stirpe figure chiave della storia non solo italiana come Lorenzo il Magnifico e poi Caterina de’ Medici, che diventerà regina di Francia.

I patroni dell’arte
I Medici, amanti del bello e consapevoli del ruolo dell’arte nell’esaltare e nel sostenere il potere politico, investono capitali cospicui nello sviluppo culturale, artistico e scientifico della loro città. Ecco allora che, oltre a proteggere e sostenere artisti del calibro di Botticelli e del giovane Michelangelo, cambiano il volto di Firenze finanziando la costruzione di nuovi edifici, come Palazzo Medici Riccardi, e il restauro di altri più antichi, come la basilica di San Lorenzo, il cui progetto di rinnovamento viene affidato a Filippo Brunelleschi che aveva già lavorato al capolavoro della Sagrestia Vecchia.
Se Lorenzo de’ Medici (1449-1492), poeta e protettore di artisti come Antonio del Pollaiolo, Filippino Lippi e Sandro Botticelli, è il mecenate più famoso dell’epoca, al duca Cosimo I de’ Medici (1519-1574) si deve la scelta di far affrescare dal Vasari e dal Borghini la cupola di Santa Maria del Fiore con un enorme e spettacolare Giudizio Universale, in cui appaiono gli stessi committenti medicei, raffigurati tra altri noti personaggi del tempo.
Sempre Cosimo I sposta, nel 1540, la sua residenza a Palazzo Vecchio, allora Palazzo Ducale, edificato a partire dal XIII secolo e divenuto simbolo della gloria fiorentina dalla repubblica, alla signoria sino al ducato mediceo.
L’aspetto attuale del palazzo è frutto della ristrutturazione voluta da Cosimo I che, per adeguare l’edificio alle sue esigenze, chiede al Vasari di raddoppiarne il volume, aggiungendo ampie aree nella parte posteriore, mantenendo però la facciata in bugnato e pietraforte, simbolo non solo della dinastia medicea ma di secoli e secoli di storia fiorentina.

I capolavori dei Medici
È lunghissimo l’elenco dei capolavori realizzati durante il periodo mediceo e custoditi nelle Gallerie degli Uffizi e nei monumenti del centro di Firenze. Citiamo solo alcune tra queste meraviglie, attorno alle quali si è concentrata la curiosità di intere generazioni per le difficoltà della loro realizzazione.
Una di queste è la maestosa cupola di Santa Maria del Fiore che, con il suo diametro di oltre quarantadue metri per quarantatré di altezza, è la più grande cupola in muratura al mondo. È Cosimo de’ Medici a supportare, in seguito a un bando indetto nel 1418, l’ambizioso progetto del Brunelleschi che si presenta davvero avveniristico. L’architetto si propone di costruire non una, ma ben due cupole in modo che una calotta possa sostenere l’altra. Con questo stratagemma, inoltre, lo spazio tra le due cupole permette agli operai di lavorare senza bisogno di complesse impalcature. Ma ancora più particolare è la tecnica muraria usata dal Brunelleschi che costruisce i primi metri della cupola in pietra per poi disporre i mattoni a spina di pesce, secondo una tecnica usata in Oriente ma mai sperimentata a Firenze. Per anni ci si è chiesti quale fosse il segreto dell’equilibrio e della leggerezza di questa costruzione, e la Cupola è ancora al centro degli studi di architetti e storici dell’arte.
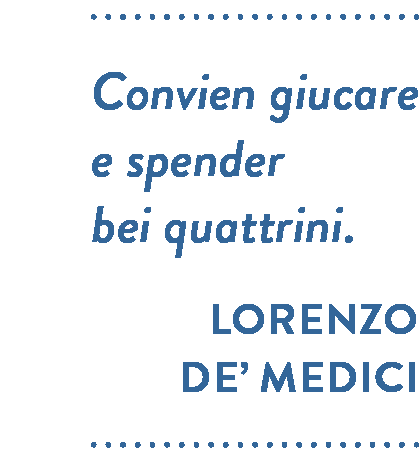
Anche su due delle sculture più famose al mondo, il David di Donatello e quello di Michelangelo, non mancano le domande. Del primo non si conosce l’anno di realizzazione, che oscilla verosimilmente tra il 1427 e 1460. La prima segnalazione storica lo vuole presente nel cortile dei Medici durante le nozze di Lorenzo il Magnifico con Clarice Orsini, nel 1469.
In questa scultura il personaggio biblico del giovane Davide è ritratto da Donatello con un corpo acerbo ma dotato di una compostezza apollinea, ai suoi piedi la testa spaventosa appena recisa del gigante Golia. Ma a ben guardare il giovinetto presenta anche i calzari alati del dio Mercurio, protettore dei commerci, e un copricapo appuntito attribuito anch’esso alla divinità greco-latina. Gli storici dell’arte hanno dibattuto a lungo su quale potesse essere l’interpretazione dell’opera senza giungere a una conclusione unanime. C’è chi ritiene che si tratti di una metafora della vittoria della razionalità sull’istinto, dell’amor celestis sull’amor vulgaris, come nell’iconografia tradizionale, e chi dissente prediligendo altre interpretazioni.
Qualche decennio dopo, la realizzazione di un altro David terrà col fiato sospeso l’intera città. Siamo nel 1501 e il giovane Michelangelo si trova davanti una vera sfida: deve scolpire la figura di David in un blocco di marmo fragile, venato di fenditure e con una forma poco adatta all’impresa.
Come spesso accade ai geni, i limiti non fanno che incentivare la creatività e il risultato raggiunto è una delle più grandi opere d’arte di tutti i tempi, simbolo universale del Rinascimento.
Addirittura, secondo il critico cinquecentesco Vasari, l’opera michelangiolesca avrebbe “tolto il grido a tutte le statue moderne et antiche, o greche o latine che elle si fossero”, tanto è capace di rappresentare la figura maschile in tutta la sua potenza e perfezione.

Le ville e i giardini medicei
Alla stregua delle maggiori famiglie nobili del tempo, anche i Medici investono nella costruzione di sontuose ville e giardini, situati perlopiù in contesti rurali vicini a Firenze. Le ville medicee nascono come luoghi destinati alla sperimentazione in campo artistico e tecnico-ingegneristico, oltre che come luoghi di riposo e svago. Si tratta di piccole regge estive, insomma, dove trascorrere le giornate in modo piacevole e da cui amministrare le aree agricole circostanti.
Le ville medicee più antiche sono quella del Trebbio e di Cafaggiolo, severi castelli di aspetto trecentesco, deputati quasi esclusivamente al controllo dei fondi agricoli.
Successivamente, nel corso del Quattrocento, Cosimo il Vecchio fa costruire edifici, come la villa di Fiesole, ancora severa nelle forme, ma in cui già cominciano a essere presenti alcuni elementi di svago, come cortili, logge e giardini.
Progressivamente, i Medici “accerchiano” Firenze con le loro ville, veri e propri microcosmi nei quali si svolgono i rituali della corte medicea e che testimoniano lo sfarzo e l’ecletticità della famiglia, alla continua ricerca di nuove soluzioni architettoniche e artistiche.
Un esempio tra tutti? I celebri giochi d’acqua della grotta degli Animali, che si trova presso la villa medicea di Castello, voluti da Cosimo I e considerati un capolavoro dell’arte idraulica del Cinquecento. Qui, secondo le testimonianze, diversi animali spruzzavano l’acqua dal becco, dalle ali, dagli artigli e dal naso, mentre una pioggia cadeva dall’alto sugli ignari visitatori, grazie alla presenza di oltre cento diffusori di piombo nascosti nelle decorazioni in pietra spugna del soffitto.

Pienza, la città ideale
Pienza, situata nella Val d’Orcia, a cinquantatré chilometri da Siena, è nota come la città di papa Pio II, al secolo Enea Silvio Piccolomini. Salito al soglio pontificio, Pio II decide di trasformare il suo umile paese natale, Corsignano, in un gioiello urbanistico-architettonico che possa sfidare la bellezza di Siena. La ristrutturazione viene affidata all’architetto Bernardo Rossellino, che, in appena quattro anni, dal 1459 al 1462, trasforma quella che verrà chiamata Pienza nella “città ideale” secondo i canoni quattrocenteschi.
Gran parte del patrimonio storico-artistico di Pienza si concentra nella suggestiva piazza trapezoidale intitolata a papa Pio II. Tra i monumenti degni di nota ci sono la cattedrale, il palazzo comunale, Palazzo Borgia e Palazzo Piccolomini. Poco distante dal centro di Pienza si trova anche il romitorio, un luogo sacro scavato nella roccia sotto la chiesa di Santa Caterina e utilizzato nel corso del Medioevo come eremo.
Tra le stanze del Romitorio si trova la cappella della Madonna del Latte, il cui culto, legato al tema della fertilità, risale probabilmente a tempi molto antichi. Fino a non molti anni fa, la cappella era meta delle puerpere, che accendevano candele di fronte all’immagine della Vergine nella speranza di avere latte abbondante.
Nel 1996, Pienza e tutta la Val d’Orcia sono state riconosciute Patrimonio mondiale dell’Umanità.