GENOVA, UNA CITTÀ DALLE MOLTE ANIME

Quarantadue palazzi nobiliari, un unico disegno: esaltare la potenza della Superba.
Per avventurarci in una delle epoche più ricche di bellezza della nostra storia, iniziamo dalla città di Genova, antica città marinara che nel XVI secolo vive il suo periodo d’oro. Tra le sue strade si va alla scoperta di una bellezza sfaccettata e molteplice, una bellezza ardua, a volte nascosta, ma molto intensa.
Di Genova si dice che è una città verticale, perché dalla costa si inerpica sulle colline, e che la sua bellezza, per citare il cantautore Ivano Fossati, “si vede solo dal mare”. È dal largo della costa infatti che riusciamo ad apprezzarne appieno il fascino, e a ricostruire la fisionomia di quartieri che è difficile abbracciare con lo sguardo percorrendo gli stretti vicoli del centro storico.
Di certo, Genova è una città che non si concede facilmente e che nel mare ha sempre trovato la sua forza: in passato, come città marinara e, più di recente, prima grazie a uno dei porti industriali più importanti del Mediterraneo e negli ultimi anni con la ristrutturazione del porto che ha cominciato ad attirare in città molti più turisti.
Tante sono le anime di questa città. C’è la Genova della musica classica, una storia che ha radici lontane e che vede fra i suoi più acclamati cittadini il grande violinista Niccolò Paganini. Genova dei grandi cantautori, come il già citato Ivano Fossati e lo straordinario Fabrizio De André, Gino Paoli, Bruno Lauzi e tanti altri. O ancora la Genova del geniale architetto Renzo Piano, capace di esportare il gusto e la creatività italiana in tutto il mondo, dal Beaubourg di Parigi all’edificio che ospita il “New York Times” nella metropoli americana.
Genova è soprattutto, storicamente, la città delle esplorazioni e dei commerci, la cui storia cambierà in corrispondenza della prima crociata che la trasformerà in una grande potenza commerciale e marittima. Non è quindi un caso che sia anche la città di Cristoforo Colombo che raggiungerà le Americhe nell’ottobre del 1492, dando ufficialmente il via all’Età moderna. Di tanto in tanto, qualcuno si fa avanti a sostenere che sia nato in Portogallo o in Spagna, in Francia o, addirittura, in Polonia: ma di recente, nuovi documenti ne hanno comprovato l’origine ligure.

Un padre della nostra letteratura, il poeta toscano del Trecento Francesco Petrarca, ha descritto Genova così: “Regale, addossata a una collina alpestre, superba per uomini e per mura. Una città speciale, la cui esplorazione porta dritti nella storia”.
In un centro urbano affacciato sul mare che si dice fondato già diversi secoli prima di Cristo, tracce di diverse epoche si incontrano nello spazio di poche centinaia di metri: dalla città medievale con il suo dedalo di piazzette e strette viuzze, i cosiddetti carruggi, alla Lanterna, che con i suoi settantasette metri è il faro più alto del Mediterraneo; dalla città rinascimentale e barocca sviluppata a partire dalla fondazione della Strada Nuova, l’attuale via Garibaldi, a quella ottocentesca e a quella contemporanea.
Tanti sono gli strati e altrettante sono le anime di questa città. Obbligati a scegliere, ci soffermeremo però sulla Genova rinascimentale e barocca, quella dei magnifici Palazzi dei Rolli, quarantadue palazzi, completamente restaurati, che, secondo il testo del riconoscimento Unesco, “costituiscono il primo esempio in Europa di progettazione urbanistica” realizzata dalle autorità cittadine con un disegno unitario e per rispondere a specifiche necessità organizzative e di rappresentanza.
Le Strade Nuove
Il “secolo d’oro” di Genova si apre nel 1528 con l’alleanza tra l’ammiraglio Andrea Doria e Carlo V, uno dei sovrani più potenti e importanti del Sacro Romano Impero. Un uomo del suo tempo, Ludovico Ariosto, nell’Orlando furioso accenna al condottiero genovese con queste parole: “Questo è quel Doria che fa dai pirati / sicuro il vostro mar per tutti i lati”.
Prima di diventare ammiraglio, Doria cresce in povertà e perde i genitori in età molto giovane. La sua sembra la storia di quello che oggi definiremmo un self-made man, che riesce a riscattarsi grazie a un misto di destrezza e coraggio. Si fa soldato, prima di terra e poi, soprattutto, di mare, combattendo inizialmente al servizio dell’imperatore Francesco I, re di Francia, poi al comando della flotta pontificia e infine, abbandonato Francesco, al fianco dell’imperatore Carlo V.
E sarà proprio negli anni successivi alla liberazione di Genova dai francesi che la città vivrà una fase di ricchezza e prosperità eccezionale e irripetibile. È in quel momento che Genova diventa per tutti la Superba, una potenza economica e commerciale, guardata da tutti con ammirazione.
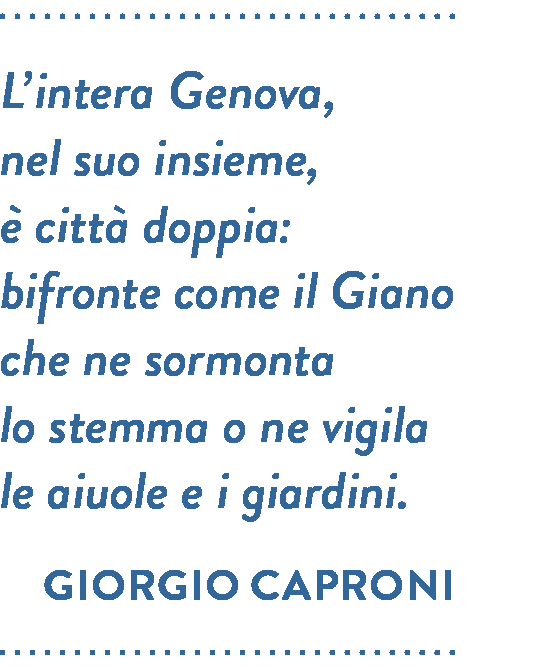
Proprio in conseguenza dell’accordo fra il Doria e Carlo V alcune famiglie aristocratiche genovesi decidono, fra il XVI e il XVII secolo, di commissionare la costruzione di una serie di dimore nobiliari, in stile rinascimentale in un primo tempo e, nei decenni successivi, barocco. Palazzi pensati ed edificati perché, con la loro eleganza, possano rappresentare la grandezza di Genova agli occhi del mondo e che entrano a far parte del cosiddetto sistema dei “rolli”, dei registri cittadini, a partire dai quali venivano scelte le residenze dove far alloggiare gli illustri ospiti in visita di Stato.
Queste regge, finanziate dalle più ricche e influenti famiglie cittadine, diventano quindi da un lato abitazioni private, e dall’altro fungono da luoghi di rappresentanza per favorire i legami con le alte autorità di Stati stranieri, che proprio all’interno di questi sontuosi ambienti venivano invitate a stringere accordi commerciali o intese politiche.
Lo illustra bene una targa, fatta apporre nel 2007 a metà di via Garibaldi dal Comune di Genova, che così recita: “Le maggiori dimore, varie per forma e distribuzione, erano sorteggiate in liste ufficiali (rolli) per ospitare le visite di Stato. I palazzi, spesso eretti su suolo declive, articolati in sequenza atrio-cortile-scalone-giardino e ricchi di decorazioni interne, esprimono una singolare identità sociale ed economica che inaugura l’architettura urbana di Età moderna in Europa”.
Le Strade Nuove, una ex zona povera, si trasformano quindi nel giro di qualche decennio nel vero quartiere benestante della città compreso fra le attuali via Lomellini, via Garibaldi e via Balbi. Diventano splendente testimonianza di un’epoca magica che ci permette, oggi, anche grazie a un’opera di restauro varata negli ultimi decenni, di apprezzare, fra gli altri, il seicentesco Palazzo Rodolfo e Francesco Maria Brignole, più conosciuto come Palazzo Rosso, e i cinquecenteschi Palazzo Luca Grimaldi, Palazzo Bianco, e Palazzo Doria Tursi, quest’ultimo forse il più impressionante e maestoso della elegantissima via Garibaldi.
Dal 2004, questi tre musei sono inseriti in un itinerario artistico chiamato appunto Musei di Strada Nuova, itinerario che possiamo anche noi provare a seguire. Un asse viario, quello di Strade Nuove, unico al mondo. Gli atri e i giardini dei suoi palazzi si intuiscono già dall’esterno, ma è necessario esplorare all’interno per apprezzare i saloni affrescati e le collezioni d’arte che queste realtà, ormai non più abitative ma museali, ospitano.
Una visita a palazzo
È curioso ma questi tre palazzi rappresentano uno dei primi esempi nella storia di gentrification, ossia quel processo che porta a riqualificare un quartiere grazie alla costruzione o ristrutturazione di spazi, edifici e aree di rilievo. Ciò che colpisce, in questa strada sontuosamente scenografica, è l’incredibile coerenza architettonica lungo i suoi quasi duecentocinquanta metri, che ne fa una sorta di galleria d’arte a cielo aperto dove ogni facciata, ogni edificio, sembra pretendere la nostra attenzione.
Questa via nata, fra il Cinquecento e il Seicento, oggi è diventata la strada bandiera della città, e anche i genovesi, non solo i turisti, vi fanno il cosiddetto “struscio” durante il weekend. È una realtà vivace in cui i bellissimi cortili sono progressivamente diventati teatri o palcoscenici per spettacoli e concerti. Come durante i Rolli days, un classico appuntamento ligure durante il quale, per alcuni giorni, gli straordinari palazzi dell’aristocrazia genovese vengono aperti al pubblico per svelare i segreti di cinquecento anni di storia della città e delle sue famiglie.

Palazzo Rosso
Abbiamo detto che la bellezza di Genova si vede pienamente solo dal mare; è anche vero che è stato il mare a portarle la ricchezza. In quest’ottica va letta la volontà degli aristocratici genovesi di costruire le Strade Nuove, tornando in qualche modo alle origini, lasciare le abitazioni in collina e avvicinarsi, palazzo dopo palazzo, a quella costa che tanta parte aveva avuto nelle loro fortune.
Palazzo Rosso, che deve il suo nome alla pietra di granito rosso con cui è stato costruito, data alla seconda metà del Seicento ed è uno dei più importanti esempi di arte barocca in città, oltre che uno degli ultimi palazzi di pregio che si innalzano sulla via Garibaldi. Racconta di Palazzo Rosso lo scrittore francese Gustave Flaubert, in visita a Genova nel 1845: “Le stanze non sono grandi come negli altri palazzi ma la manutenzione, i mosaici e, soprattutto, i quadri, lo rendono uno dei più ricchi di Genova”.
L’autore di Madame Bovary non è l’unico a rimanere affascinato dalla lucentezza dei colori, dallo scalone in marmo bianco: qualche anno dopo, anche il musicista tedesco Richard Wagner racconterà di aver trascorso qui una serata di idillio a chiacchierare sotto gli oleandri in fiore del giardino. Con la sua forma a U e i due piani nobili – pensati così perché in origine il proprietario aveva inteso dividerlo fra i suoi due eredi – Palazzo Rosso ospita oggi al suo interno dei meravigliosi affreschi realizzati dai maggiori pittori del Seicento ligure, preziosi arredi, e una prestigiosa pinacoteca che comprende quadri di artisti come Dürer, Veronese, Guercino e Van Dyck.

Palazzo Tursi e Palazzo Bianco
Restiamo sulla via Garibaldi e andiamo a Palazzo Tursi, costruito quasi un secolo prima di Palazzo Rosso da Nicolò Grimaldi, soprannominato il Monarca per la sua ricchezza. Ancora più degli altri, nati per il desiderio delle famiglie facoltose locali di mettersi in mostra, rivela una disposizione degli spazi che possiamo definire scenografica: all’ingresso, da un atrio al livello della via, si diparte uno scalone che conduce a un cortile rettangolare sopraelevato rispetto al portico e visibile dalla strada. I materiali, dalla pietra di Finale al marmo bianco di Carrara, sono stati scelti e accostati fra loro in modo da accentuare il gioco di luci e di riflessi, l’impatto visivo delle eleganti architetture. Basta che un raggio di sole si posi su queste superfici, che si tratti del chiarore del mattino o del lucore della sera, per lasciarci a bocca aperta.
L’interno ci sorprende anche con la sua offerta artistica: Palazzo Tursi infatti non è solo l’edificio della via che occupa la maggiore superficie ma fra le sue lussuose sale, ricche di opere pittoriche, conta la celebre sala Paganiniana nella quale è conservato un famosissimo violino appartenuto a Niccolò Paganini, detto il Cannone, insieme a tanti altri strumenti e cimeli riferibili al musicista genovese. Di lui parleremo ancora: il nostro giro attraverso le meraviglie d’Italia ci porterà nella foresta di Paneveggio, in Trentino-Alto Adige, dove il grande violinista andava a scegliere il legno migliore per i suoi strumenti.
Ma chiudiamo questa breve passeggiata lungo via Garibaldi con Palazzo Bianco che, adiacente a Palazzo Tursi e situato di fronte a Palazzo Rosso, viene costruito da un altro membro della famiglia Grimaldi intorno al 1530, pochi anni dopo il già citato accordo fra Andrea Doria e Carlo V. Ad affascinare fin dal primo sguardo a Palazzo Bianco è il contrasto cromatico con Palazzo Rosso e il fatto che sia nello stesso tempo il più antico ma, per certi versi, anche il più recente di questi edifici. Palazzo Bianco, infatti, quasi completamente distrutto dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale, verrà ristrutturato e, profondamente ripensato, negli anni Cinquanta, dall’architetto razionalista genovese Franco Albini che proprio con questo lavoro scriverà una delle pagine più importanti dell’architettura contemporanea, trasformando Palazzo Bianco in pinacoteca e trasferendone sculture e affreschi in altre sedi museali.
Infine, una curiosità: in pochi passi, prendendo uno qualsiasi dei vicoletti che dalla ariosa via Garibaldi proseguono in direzione del mare, ci ritroviamo subito nella Genova dei bassi, dei carruggi stretti in cui i raggi del sole faticano a passare, con panni stesi e vita di strada, e un centro storico animato e vivace che ci racconta le due nature, popolare e aristocratica, di questa città.

Cartoline da record
Se ci spostiamo nella provincia di La Spezia, incontriamo un’altra faccia dello splendore affacciato sul mare. Cinque ex borghi di pescatori, un tempo assai poveri, da alcuni decenni sono infatti entrati a far parte dei principali tour turistici del nostro Paese. Tanto che, difficile dire se sia leggenda o verità, pare fosse proprio in questi paesini che si registrava, prima dell’avvento dei telefoni cellulari e della messaggistica istantanea, il maggior numero di acquisti di cartoline del mondo.
Vero o falso che sia, Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore, insieme alla splendida Portovenere e alle vicine isole Palmaria, Tino e Tinetto, sono stati dichiarati nel 1997 Patrimonio dell’Umanità. E basta solo un’occhiata, una piccola passeggiata lungo il sentiero costiero che collega fra loro questi centri per capirne la ragione.
Casette colorate che sembrano nascere dalle rocce, stretti carruggi che portano al mare su cui si affacciano variopinti porticcioli, piccoli angoli sabbiosi fra una scogliera e l’altra, dove i turisti d’estate cercano refrigerio. Ma non c’è solo il colpo d’occhio “da cartolina”. A braccetto con la bellezza, in questo tratto di costa, apparentemente aspro e accidentato, è peculiare la capacità che l’uomo ha dimostrato di adattarsi, di modellare il territorio e di sfruttarne le possibilità grazie ai terrazzamenti che hanno permesso di addolcire e, in qualche modo, “addomesticare” le forti pendenze. È un lavoro che comincia in tempi molto remoti. Le prime informazioni riguardo Monterosso, per esempio, risalgono al 1200 circa, al 1080 nel caso di Vernazza mentre ancora precedente pare essere Corniglia, un antico borgo romano, sopraelevato rispetto al mare, e accessibile dalla costa solo grazie a una lunga, e faticosa, scalinata di 377 gradini.
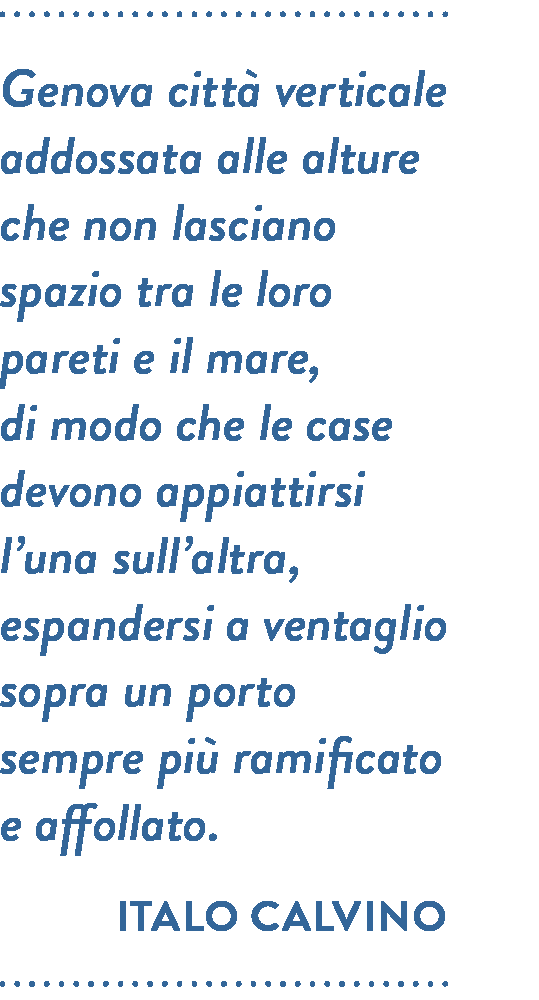
Se è bello scoprire Genova dal mare, questi borghi andrebbero scoperti da terra, visitati lentamente muovendosi lungo gli antichi sentieri che per secoli hanno rappresentato l’unica via per gli spostamenti degli abitanti e l’unico collegamento fra l’entroterra e questi piccoli centri affacciati sul mare. Gli itinerari possibili sono numerosi ed è proprio grazie a questi percorsi che possiamo cogliere la cultura del luogo. L’itinerario dei vigneti terrazzati ci racconta come le Cinque Terre, oltre che meta turistica, siano da sempre un importante produttore di vini d’eccellenza. Ma si può anche intraprendere l’esplorazione delle tracce di insediamenti che risalgono a un migliaio di anni fa, o calcare i passi dei fedeli che nel tempo hanno compiuto pellegrinaggi nei piccoli santuari di questi luoghi. Un mondo di bellezza racchiuso in qualche decina di chilometri, che va preservato anche “da noi stessi”, dall’eccessivo sfruttamento turistico. Perché questi sono luoghi fragili quanto preziosi.