IL PASSATO NEL SOTTOSUOLO

Nelle antiche case conservate dalla terra o dall’acqua, troviamo i resti tangibili del passato.
Palafitte preistoriche dell’arco alpino
Oltre che sulla pietra è possibile trovare tracce del nostro remoto passato anche nel sottosuolo, che talvolta cela impensabili tesori. Sepolti sotto metri di terra o sul fondo di laghi, in sei Paesi dell’arco alpino vi sono i resti di villaggi preistorici, gruppi di palafitte costruiti in luoghi paludosi.
L’Unesco ha riconosciuto Patrimonio dell’Umanità centoundici di questi siti, di cui i diciannove che si trovano in Italia sono dislocati in Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Le strutture palafitticole più antiche risalgono all’inizio del Neolitico e sono state identificate sul lago di Varese.
Da questi siti è possibile avere informazioni inestimabili sulla vita quotidiana dei nostri antenati. Innanzitutto, si può ricostruire la struttura delle palafitte, capanne su una base di legno poggiata su pali, che possono essere realizzate su impalcature appoggiate al terreno (palafitte su bonifica) o sospese sul pelo dell’acqua (palafitte aeree).
Ma c’è una particolarità ancora più affascinante: nelle paludi e nelle torbiere, in assenza di ossigeno, reperti come avanzi di cibo, utensili, gioielli, armi, tessuti e oggetti casalinghi possono conservarsi per migliaia di anni.
È questo il tesoro riportato alla luce dalle profondità della terra dei territori alpini, un patrimonio che ci può raccontare, con una precisione impossibile prima, la vita quotidiana di una trentina di gruppi vissuti tra il 5000 e il 550 a.C.: un’impagabile macchina del tempo che ci porta dritti al cuore del Neolitico, dell’età del Bronzo e degli inizi dell’età del Ferro.

L’abisso Ancona
Un altro tesoro del sottosuolo ci trasporta in un passato ancora più remoto, precedente alla comparsa della nostra specie sul pianeta. In provincia di Ancona, nel complesso delle grotte di Frasassi, si trova una delle più vaste cavità sotterranee del mondo mai scoperte. Le sue cifre sono impressionanti: centottanta metri di lunghezza, centoventi di larghezza e, nel suo culmine, quasi duecento di altezza. Per avere un’idea delle sue dimensioni, basti pensare che la torre di Pisa è alta circa un terzo e la Statua della Libertà, a New York, meno della metà. Non solo: è stato calcolato che questa grotta sarebbe in grado di contenere addirittura il duomo di Milano.
Muoversi al suo interno significa perdere automaticamente il senso della misura, stalagmiti di venti metri possono sembrare alte la metà o viceversa: un senso di straniamento che ci prende per via della mancanza, sottoterra, dei riferimenti ai quali siamo abituati, come alberi, case e persone. Ma chi l’ha scoperta e, soprattutto, come?
Protagonisti di questa impresa sono, all’inizio degli anni Settanta, una ventina di tecnici ed esperti del Gruppo Speleologico Marchigiano Ancona, ragazzi giovanissimi, all’epoca meno che ventenni, che vengono contattati da un loro coetaneo il quale racconta di un dirupo, un piccolo varco, largo all’incirca quanto un pallone da calcio. Si recano sul posto e verificano come da quel varco passi del vento. Allargano la fessura e, in breve, si spalanca davanti ai loro occhi un abisso indecifrabile. Provano infatti a fare luce con le torce poi, siccome non si vede niente, tirano un sasso, un vecchio trucco da speleologi. La pietra impiega ben sei secondi prima di toccare terra: sembrano pochi, ma in realtà sono tantissimi perché è il tempo che una pietra impiega per percorrere più di cento metri in caduta verticale.
I ragazzi si organizzano con corde sufficientemente lunghe e poi si calano, scoprendo che la grotta è profonda ben centoventi metri. Un gesto coraggioso, il loro, che permetterà una delle scoperte speleologiche più importanti del mondo: l’abisso Ancona, così ribattezzato proprio in onore della loro città di provenienza.
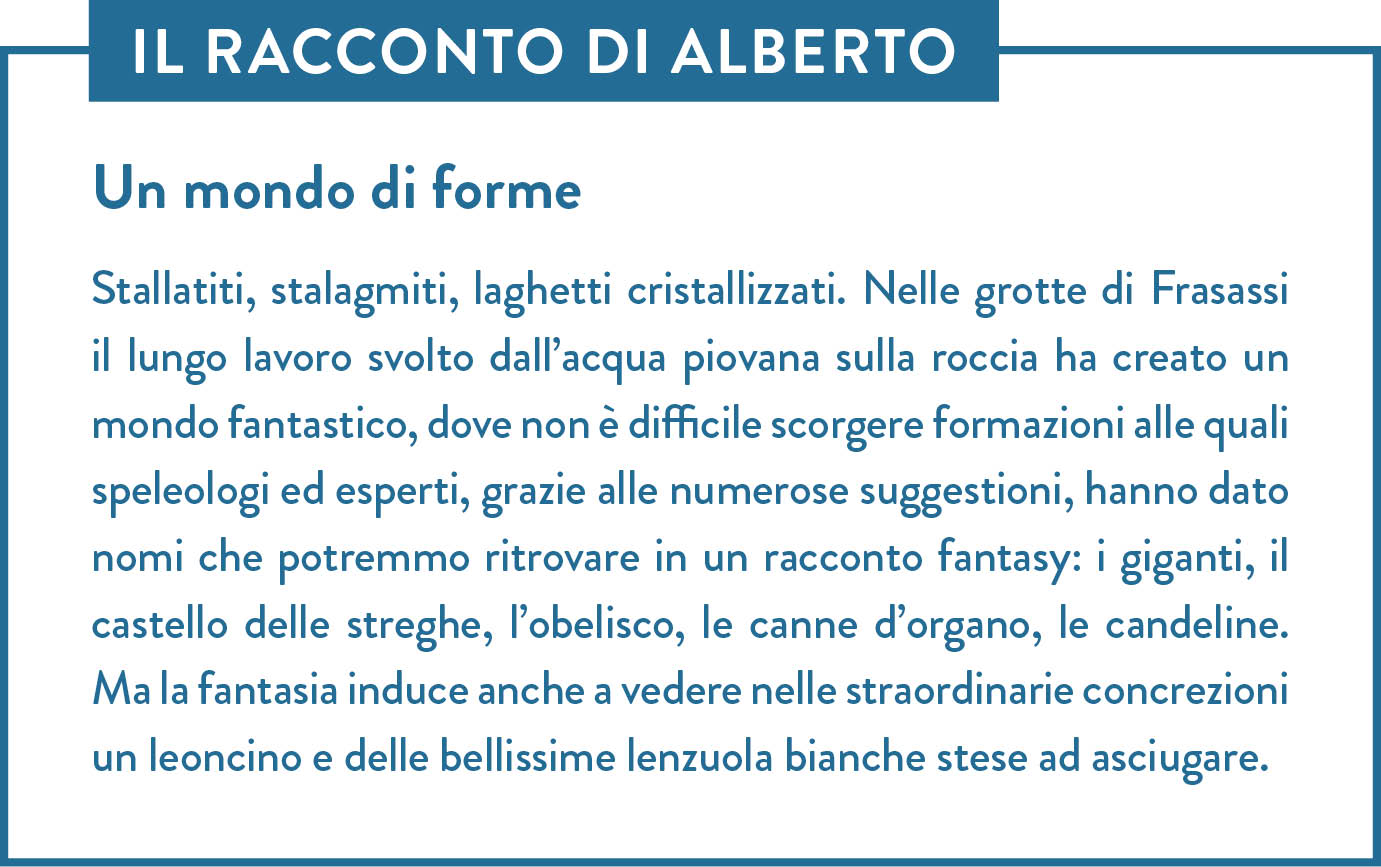
Paleolitico inferiore
Dopo aver sinteticamente raccontato come sono state scoperte, vale la pena capire anche come sono nate queste grotte: oltre all’abisso Ancona, come abbiamo accennato, ce ne sono altre impressionanti e la loro origine è antichissima.
Iniziarono a formarsi oltre un milione e quattrocentomila anni fa durante il Paleolitico inferiore. Stiamo parlando di un’epoca lontanissima in cui i grandi dinosauri si erano già estinti e in Europa faceva la sua prima comparsa l’homo erectus, l’antenato dell’homo sapiens.
A differenza di quanto si possa pensare, queste grotte non sono state scavate da un fiume sotterraneo poi scomparso. Sono invece il risultato della lenta erosione provocata dalle infiltrazioni d’acqua del vicino fiume Sentino, che oggi si trova diversi metri al di sotto del livello delle grotte, ma milioni di anni fa scorreva trecento metri più in alto. Con un processo durato decine di migliaia di anni, l’acqua proveniente dal fiume soprastante, insieme all’acqua piovana, ha iniziato a erodere le rocce calcaree di cui sono composte queste montagne, grazie a un particolare fenomeno chiamato “dissoluzione carsica” o “carsismo”. Le prime piccole fessure create dall’azione di erosione e corrosione si sono trasformate in seguito in canaletti e pozzi, e quindi in cavità via via sempre più grandi fino a quando, sotto la spinta della forza demolitrice dell’acqua, si sono verificati crolli e sprofondamenti che hanno dato forma alle grotte.

Quando il livello del fiume si è abbassato, solo l’acqua piovana ha continuato a infiltrarsi. La caverna ha quindi cominciato a “ornarsi” di meravigliose concrezioni calcaree. Poi, nel corso dei millenni, l’acqua ha creato un paesaggio fiabesco fatto di stalattiti e stalagmiti dalle forme pittoresche che sembrano non obbedire alle leggi della gravità. Alcune assomigliano a coralli rossi, altre a fiori, ognuno di noi può leggere le forme che vuole. Ma quello che è veramente incredibile è l’opera compiuta dall’acqua in questo luogo e il fatto che, nella loro bellezza, stalagmiti e stalattiti rappresentano una sorta di “calendario di pietra calcarea” che ci permette di cogliere, in un unico colpo d’occhio, il senso della lunghezza della storia della Terra e la relativa brevità di quella umana.

