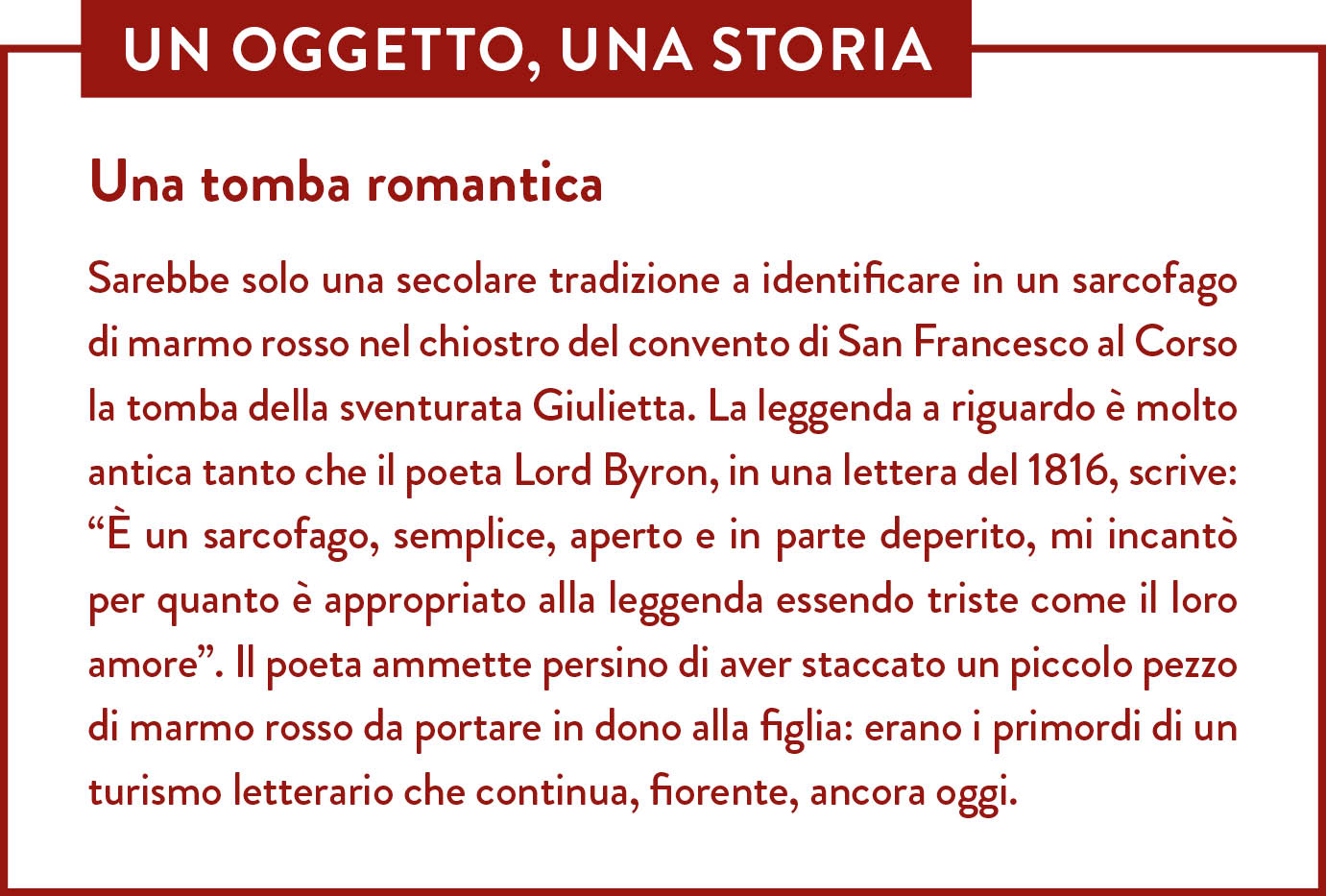VERONA, AMORE E SPLENDORE

Dalla gloria dell’Arena al fasto dei palazzi d’epoca veneziana, la città di Romeo e Giulietta è un unico grande gioiello.
Un passato glorioso
Sempre in Veneto troviamo una città talmente ricca di storia e bellezza che, nel 2000, l’Unesco ha deciso di riconoscerne l’intero centro storico come Patrimonio dell’Umanità. Parliamo di Verona che, ben prima della dominazione veneziana (dal XV al XVII secolo) conosce periodi di gloria che hanno lasciato tracce indelebili.
La città, che ottiene la cittadinanza romana nel 49 a.C., vive un’epoca di grande splendore sotto l’imperatore Vespasiano, nel I secolo. Proprio in questo periodo, avendo raggiunto il numero (notevole per l’epoca) di venticinquemila abitanti, decide di edificare l’Arena, per permettere a tutti i cittadini di assistere agli spettacoli.
Nei secoli dell’Impero Romano, Verona espande la sua potenza e accresce il suo fascino, dotandosi di numerosi monumenti di marmo che le guadagnano l’appellativo di Urbs marmorea, città di marmo.
Ma la sua gloria è solo agli inizi. La seconda epoca d’oro della città risale al dominio scaligero, in particolare alla signoria di Cangrande della Scala (XIII-XIV secolo), l’illuminato signore a cui Dante dedica la cantica del Paradiso nella sua Divina Commedia. Se la pianta architettonica della città è da attribuire alla dominazione romana, la dinastia scaligera regala a Verona la sua imponente fortificazione, il ponte scaligero e le arche scaligere, complesso funerario in stile gotico realizzato nel XIV secolo per la sepoltura dei membri della famiglia.
Nel 1405, la città giura fedeltà al doge di Venezia ma un secolo dopo, all’inizio del 1500, la situazione politica cambia e nel giro di pochi anni (tra il 1509 e il 1517) si passa dal dominio veneziano a quello di Massimiliano I, imperatore asburgico, da Carlo V di Spagna ai francesi, tornando infine, con lo scioglimento della Lega di Cambrai, alla Serenissima.
Da questo momento, fino alla devastante peste del 1630, Verona riconquista sotto il dominio veneziano la pace e il benessere perduti.

Il gioiello della Serenissima
Nel XVI secolo, come Vicenza e Padova, anche Verona entra a pieno titolo nel programma veneziano di rinnovamento urbano dei centri della terraferma, che può contare anche su una nuova e geniale generazione di artisti. A Verona, spicca tra gli altri Michele Sanmicheli, architetto a cui si devono i più raffinati palazzi di questo periodo. Ingaggiato dalla Serenissima come architetto militare, soprattutto per rinforzare le difese della città, il Sanmicheli dimostra di avere a cuore anche e soprattutto il pregio artistico delle sue opere, in un chiaro progetto di rinnovamento urbano.
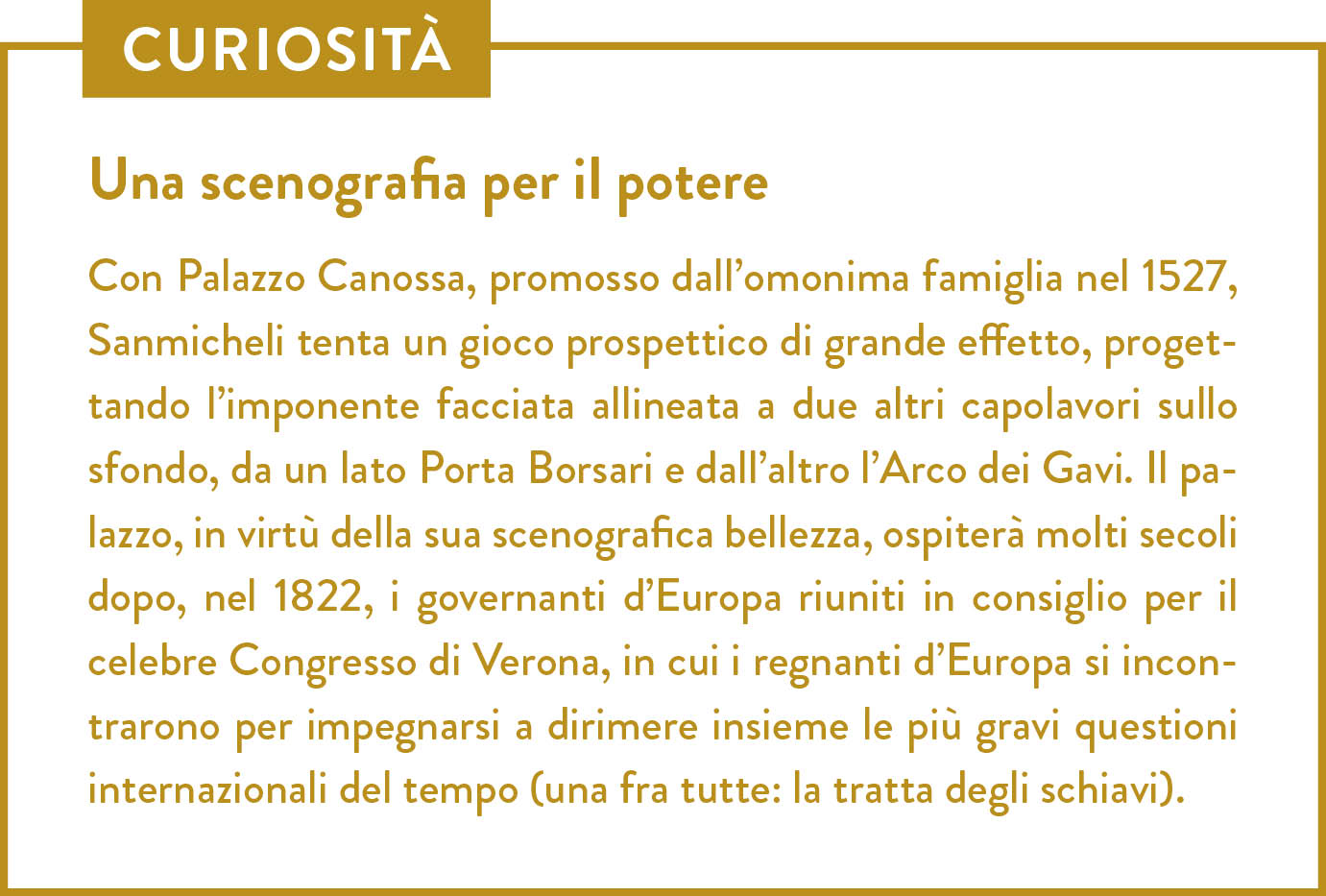
A questo artista si devono anche la maggior parte delle porte veronesi, tra cui la monumentale Porta Nuova, eretta tra il 1532 e il 1540. Di questo gioiello il Vasari, storico dell’arte cinquecentesco, sostiene che mai vi fu “opera di maggior grandezza né meglio intesa”.
Venendo dalla campagna veronese, ieri come oggi, Porta Nuova riluce del candore regalato dalla pietra bianca, mentre il lato rivolto verso la città ha il volto ruvido e severo del tufo.
I più noti e scenografici palazzi progettati del Sanmicheli sono Palazzo Canossa e Palazzo Bevilaqua che, edificati negli stessi anni, forniranno un modello ad altri edifici di poco successivi.
Dopo la morte del dell’estroso architetto, la sua eredità è portata avanti da altri artisti che ne seguono le tracce. Uno dei palazzi costruiti nella seconda metà del secolo, Palazzo dei Turchi, è protagonista di una storia curiosa. Il suo nome è dovuto alla ricca famiglia di mercanti che lo promuove eppure, come a volte capita, in un nome è racchiuso un destino.

La sua costruzione risale infatti al 1579, pochi anni dopo l’epica battaglia di Lepanto (1571), quando la flotta veneziana sconfisse gli ottomani. Il palazzo viene così arricchito da statue di personaggi turchi, parte del bottino di guerra. Ma l’odio per il nemico sconfitto è ancora troppo fresco e le statue vengono quasi subito decapitate: le teste sono esposte dai veronesi in piazza delle Erbe, proprio dove comunemente erano mostrati i condannati a morte. In questa piazza, la più antica e tra le più spettacolari della città, sorge il simbolo della gloria della Serenissima, il Leone di San Marco, issato su una candida colonna in marmo bianco.
Tra lo splendore marmoreo dei resti romani, le guglie delle arche scaligere e l’eleganza dei palazzi d’epoca veneziana, è d’obbligo per i molti turisti che visitano Verona un breve passaggio sotto il cosiddetto balcone di Giulietta, protagonista della celebre tragedia shakespeariana.
Per la verità, Romeo e Giulietta, per quanto la più celebre, non è certo l’unica tragedia dell’immortale poeta ambientata in Veneto: a Verona si svolge anche I due gentiluomini di Verona, a Padova La bisbetica domata e a Venezia Il mercante di Venezia.
Ma da dove viene questo amore shakespeariano per il Veneto? Alcuni biografi ritengono che Shakespeare abbia visitato l’Italia, e in particolare Verona, tra il 1586 e 1592, anni in cui sui suoi movimenti non si hanno dati né certezze. Purtroppo non lo sapremo mai, ciò che è invece certo è che la vicenda dei due infelici amanti Romeo e Giulietta sia totalmente fittizia: il leggendario balcone appartiene invece al palazzo di epoca medievale dove risiedeva la famiglia Dal Cappello, come indica lo stemma sulla facciata.