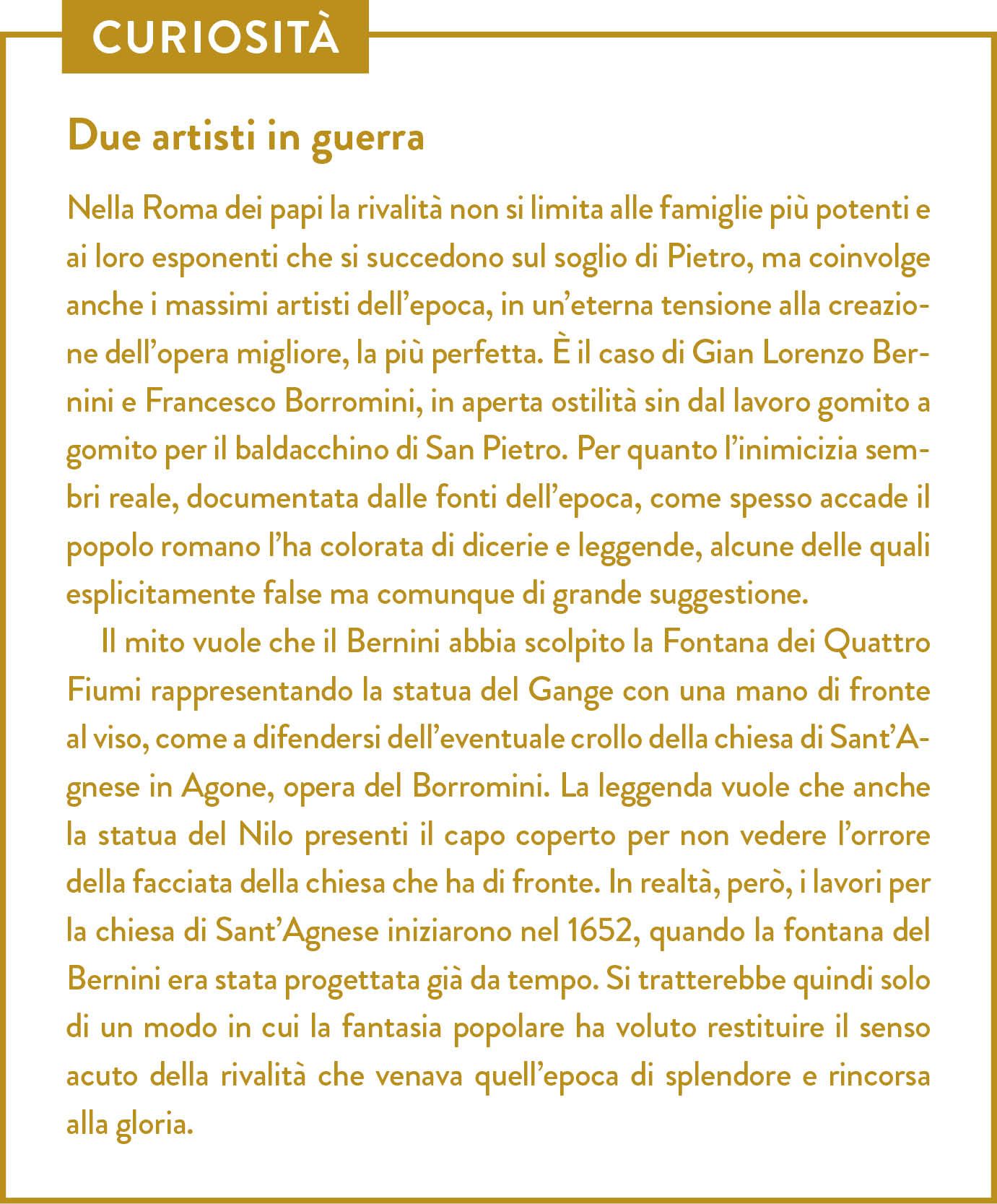UNA GARA DI SPLENDORE: LA ROMA DEI PAPI

Il potere pontificio e la volontà di metterlo in mostra ci hanno lasciato un tesoro inestimabile di capolavori.
Il simbolo del legame tra arte e potere nell’Italia del Seicento è la Roma papale, in cui i pontefici continuano la lunga storia di mecenatismo che ha reso la nostra capitale tra le città più meravigliose del mondo. La Roma del Seicento è la città in cui il Barocco trova la sua espressione più alta, perseguendo in ogni dettaglio lo stupore degli spettatori.
Quella della Roma del Seicento è però anche, e forse innanzitutto, una storia di potere.
Il secolo si apre infatti con due cruente esecuzioni, quella di Beatrice Cenci (1599) e quella di Giordano Bruno (1600) che, diversissime per motivazione e peso politico, hanno un enorme impatto sull’immaginario dell’epoca. Siamo in piena Controriforma e papa Clemente VIII regna con mano ferma, intenzionato a mantenere il potere spirituale e temporale del papato insidiato dalla Riforma protestante e dalle eterne lotte tra gli Stati che compongono la penisola.
Non sono le uniche lotte del tempo, tutt’altro: Roma è anche una città dai molti conflitti intestini, giocati tra le sue famiglie più potenti. Sono soprattutto i Farnese, i Pamphili e i Barberini a sfidarsi, in una rincorsa al primato che si misura anche in capolavori. Ognuna di queste casate riesce a portare un proprio esponente sul soglio pontificio e ognuno di questi papi utilizzerà le grandi ricchezze della Chiesa per tentare di surclassare i predecessori, stupire i contemporanei, essere ricordato dai posteri. Gli artisti migliori del tempo vengono chiamati alle corti di questi papi e pagati, anche molto, per glorificarne il regno e sottolinearne la potenza attraverso lo splendore delle loro opere.
Da questa contesa senza esclusione di colpi Roma esce impreziosita, più bella che mai.
Paolo III e Michelangelo
Per incontrare uno dei più grandi mecenati della Roma papale dobbiamo tornare indietro di qualche anno, nel 1534, quando Alessandro Farnese diventa papa col nome di Paolo III.
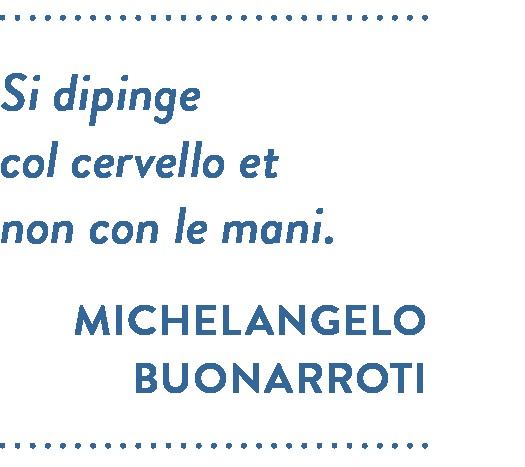
Questo pontefice, colto e amante della bellezza, una volta eletto continua con la tradizione dei suoi predecessori, impreziosendo con nuove opere i Palazzi Vaticani e l’intera città. Già quand’era ancora cardinale, aveva promosso la costruzione di Palazzo Farnese, affidata nel 1514 all’architetto Antonio da Sangallo il Giovane. I lavori però si erano interrotti in modo traumatico, nel 1527, con il terribile saccheggio della città da parte dei Lanzichenecchi di Carlo V, episodio che segnerà per sempre la storia e l’anima della città.

Quando, nel 1541, Alessandro riprende i lavori è ormai papa e può usare tutta la sua influenza per rendere il palazzo di famiglia il meraviglioso monumento che oggi possiamo ammirare. Antonio da Sangallo il Giovane, nel frattempo, è mancato e la costruzione viene affidata al genio di Michelangelo.
È sempre Paolo III a confermare a Michelangelo un altro e ancor più memorabile incarico, che gli era stato conferito dal pontefice precedente, Clemente VII: affrescare la parete della Cappella Sistina con il Giudizio Universale. Ma il nuovo papa non si ferma qui e nomina Michelangelo pittore, scultore e architetto del Palazzo Vaticano.
Con il suo precedente mecenate assiso sul trono pontificio, Giulio II, il geniale artista toscano aveva avuto un rapporto tempestoso, durato anni e interrotto da dissidi e incomprensioni. Per Paolo III l’artista, ormai anziano, con la vista e il corpo fiaccati da un vita vissuta senza risparmiarsi, dipinge il suo più grande capolavoro, il Giudizio Universale. In seguito, mentre termina i lavori pluriennali per la tomba di Giulio II, decora la cappella Paolina, voluta da Paolo III, con due magnifici affreschi, la Conversione di Saulo e la Crocifissione di Pietro.
Al mecenatismo di Paolo III si deve anche la Sala Regia del Palazzo Apostolico, destinata a ospitare le visite diplomatiche esibendo tutta la gloriosa potenza del papato.
La rivalità tra i papi è appena iniziata.
La Cappella Sistina tra splendore e censura
Il più celebre simbolo della Roma papale, che tutto il mondo ci invidia, è probabilmente la Cappella Sistina, dove ancora oggi i cardinali si riuniscono in conclave ogni volta che occorre eleggere il nuovo papa. Questa cappella, dedicata a Maria Assunta, ha preso il nome da Sisto IV, colui che ne avviò la costruzione, tra il 1475 e il 1481. Ma da quel momento in poi ognuno dei suoi successori volle dare il suo contributo, impreziosendo la cappella con le opere dei migliori artisti del suo tempo, e questo ha fatto della grande sala un vero e proprio scrigno di capolavori.
C’è un progetto complessivo dietro la Cappella Sistina: creare la più completa Biblia pauperum, cioè Bibbia dei poveri, concetto nato in epoca medievale per definire una serie di immagini tratte dall’Antico e dal Nuovo Testamento, capaci di raccontare la storia della salvezza e il messaggio cristiano anche alle menti e agli animi più semplici. L’analfabetismo non è certo un problema nella colta corte pontificia, ma rispettando questa tradizione artistica i papi daranno vita al più meraviglioso compendio della sapienza cristiana.
A firmare le storie della vita di Gesù e di Mosè sono mani eminenti come quelle del Botticelli, del Perugino o del Ghirlandaio. Per completare iconologicamente l’opera, decenni dopo, nel 1508, Giulio II affida a un giovane Michelangelo l’ardua decorazione dell’alta volta. L’artista spende quattro anni, lavorando in solitaria sulle impalcature, tra dolori e danni alla vista. Ma il risultato è eccezionale: in un colpo d’occhio mozzafiato è possibile ripercorre le storie della Genesi e dell’Antico Testamento, intervallate dalle figure di profeti e sibille che hanno preannunciato la venuta di Cristo, evento spartiacque della storia. È davvero incredibile come, più di cinquant’anni dopo, lo stesso Michelangelo torni per completare, col Giudizio Universale, lo stesso progetto, con mirabile coerenza: tra le tumultuose folle di salvati e di dannati campeggia infatti Cristo, in tutta la sua potenza, nell’esatto punto focale della cappella.
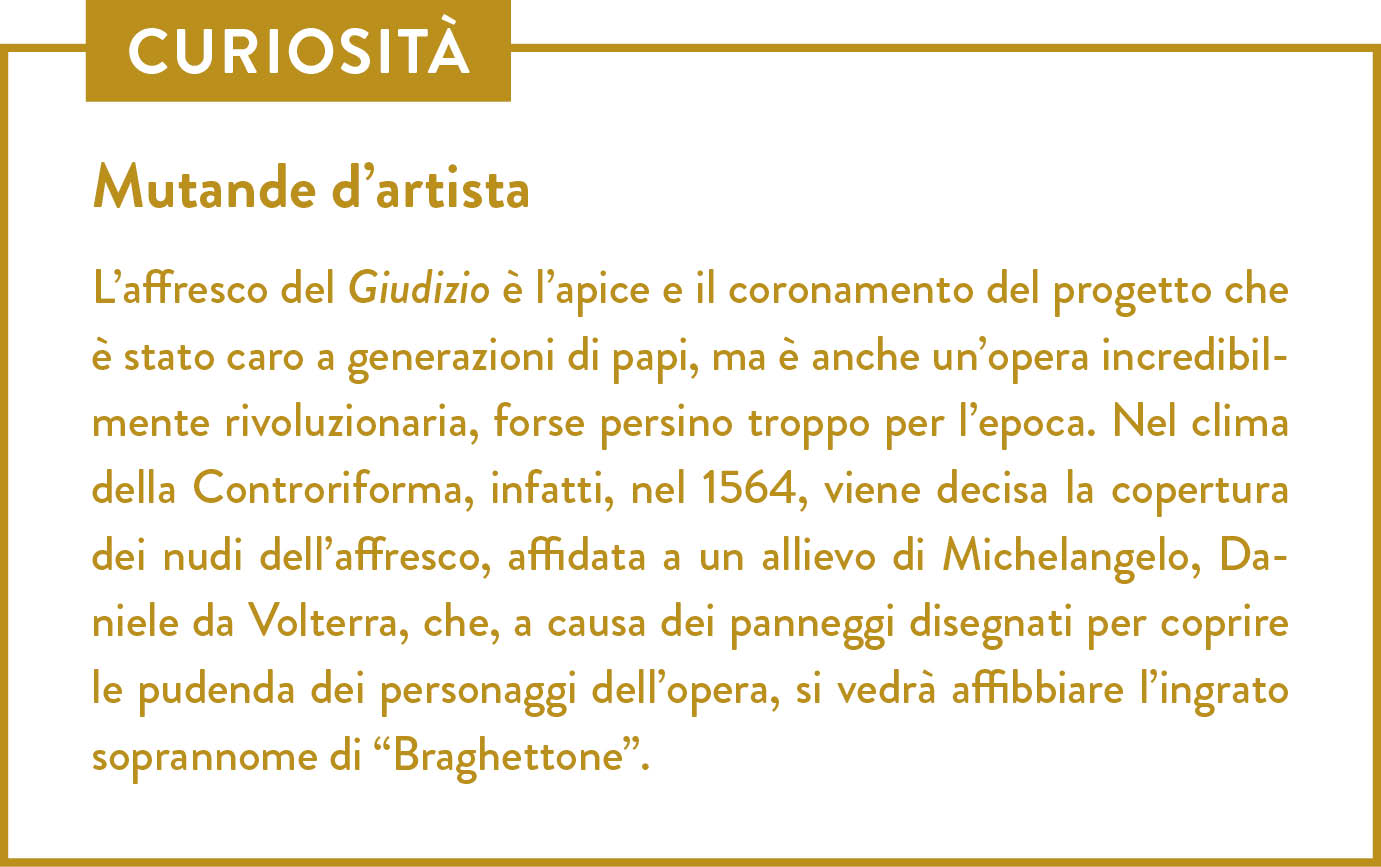
Rivalità papale: Urbano VIII e Innocenzo X
Se Michelangelo è indiscutibilmente la stella del Cinquecento romano, le meraviglie seicentesche della città sono soprattutto legate a un altro grande nome, quello di Gian Lorenzo Bernini. La fortuna di questo artista si deve, oltre che al suo incredibile talento, all’elezione di Maffeo Barberini, papa Urbano VIII, suo primo mecenate e toscano come lui. Il papa gli affida la costruzione di diverse fontane, tra cui la scenografica Fontana del Tritone in piazza Barberini e, poco distante, la piccola Fontana delle Api (simbolo araldico della famiglia Barberini) progettata inizialmente come abbeveratoio per i cavalli.

Ma il progetto che rende celebre il Bernini è quello del baldacchino che campeggia al centro della basilica di San Pietro, consacrata proprio da Urbano VIII il 28 novembre 1626. Il baldacchino, che richiede dieci anni di lavorazione, è un vero e proprio inno all’architettura barocca che coniuga imponenza e plasticità, impatto scenografico e profondo simbolismo.
Le quattro colonne tortili slanciate e decorate da motivi vegetali e dalle api (stemma dei Barberini) garantiscono leggerezza e movimento alla struttura, mente i bassorilievi rappresentano la Chiesa come madre nelle diverse fasi del parto, in bilico fra i dolori del travaglio e la gioia di una nuova nascita.
Per molto tempo si è creduto erroneamente che per realizzare il baldacchino papa Urbano VIII avesse richiesto di fondere i bronzi del Pantheon. Questa errata credenza ha ispirato il motto di spirito Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini (ciò che non fecero i barbari lo fecero i Barberini) per indicare l’immensa ambizione di questa famiglia, disposta a saccheggiare antichi monumenti romani per la sua gloria.
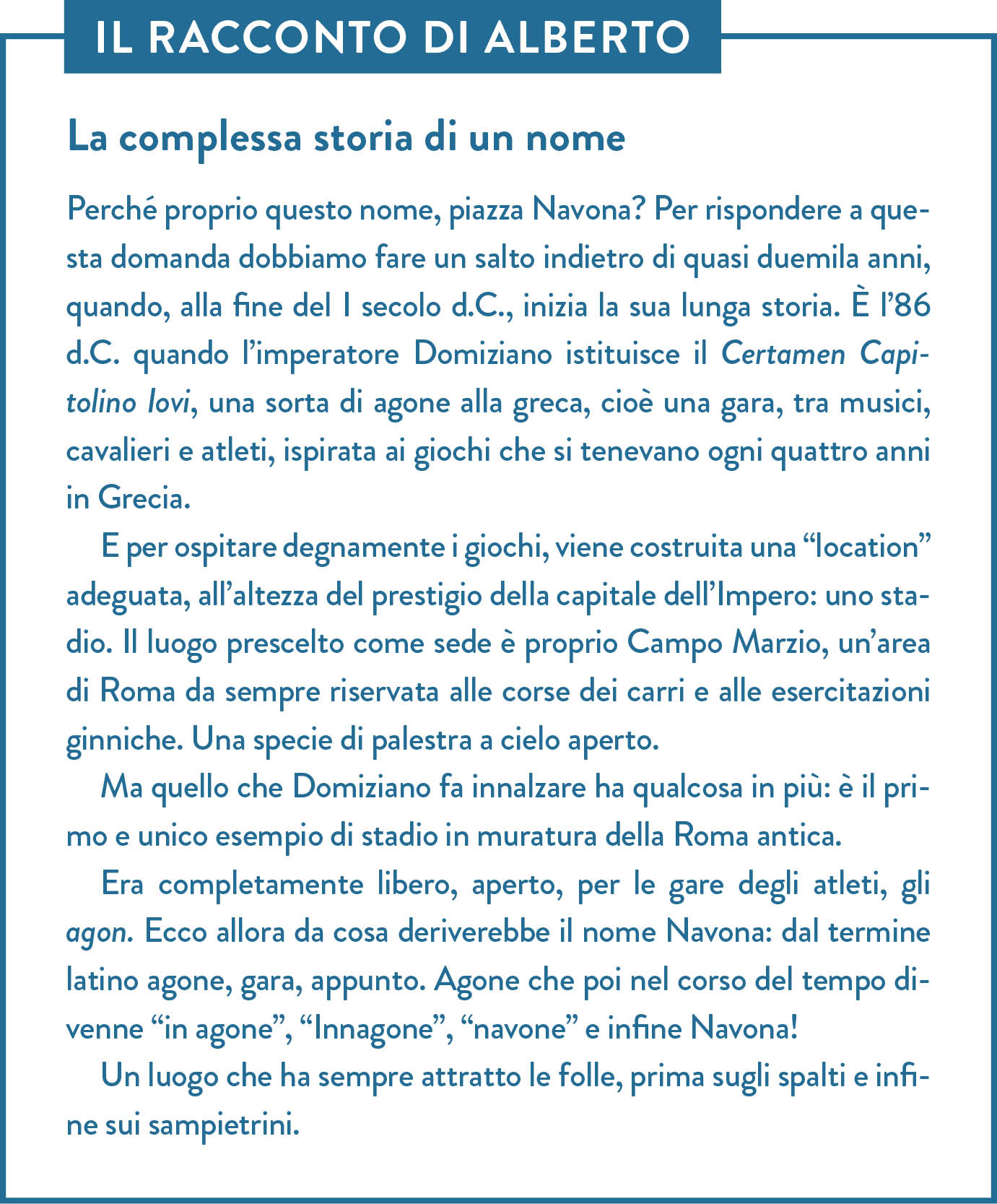
Quando, nel 1644, viene eletto papa Innocenzo X, membro della potente famiglia rivale dei Pamphili, intraprende subito un’azione legale contro i Barberini, accusandoli di arricchimento illecito durante il papato di Urbano VIII e negli anni precedenti.
Il nuovo papa non vuol essere da meno del predecessore e concentra il suo contributo artistico in piazza Navona, sede del palazzo di famiglia. Palazzo Pamphili, costruito nel 1630 su un progetto di Girolamo Rainaldi, presenta uno stile tardo cinquecentesco e, al centro, mostra con orgoglio il bassorilievo con lo stemma della famiglia Pamphili, una colomba sormontata da tre gigli.
Una volta eletto Papa, Innocenzo X decreta un radicale rinnovamento della piazza, rendendola nel tempo il gioiello barocco che oggi possiamo ammirare. È inizialmente Francesco Borromini, che aveva già lavorato come assistente architetto al baldacchino di San Pietro, ad aggiudicarsi l’incarico per l’ambiziosa Fontana dei Quattro Fiumi, ma l’astuto ed esperto Bernini riesce a subentrare al rivale. Sarà lui, nel 1651, a realizzare la monumentale fontana le cui imponenti figure maschili rappresentano quattro tra i fiumi più importanti del mondo, il Nilo, il Gange, il Danubio e il Rio de la Plata. Sopra i fiumi campeggia la colomba dello Spirito Santo, stemma del papa Pamphili ed emblema della Chiesa cattolica che regna sui quattro continenti del mondo.
In mezzo alla fontana viene eretto il massiccio obelisco (alto più di sedici metri) risalente all’epoca di Domiziano e ritrovato nel Circo di Massenzio, sull’Appia.
La forza muscolare e il dinamismo dei corpi maschili, inarcati intorno al trionfale obelisco, suggeriscono a chiunque entri nella piazza il potere concreto e politico, e non solo spirituale, della Chiesa cattolica e del suo sommo vertice, il Papa.

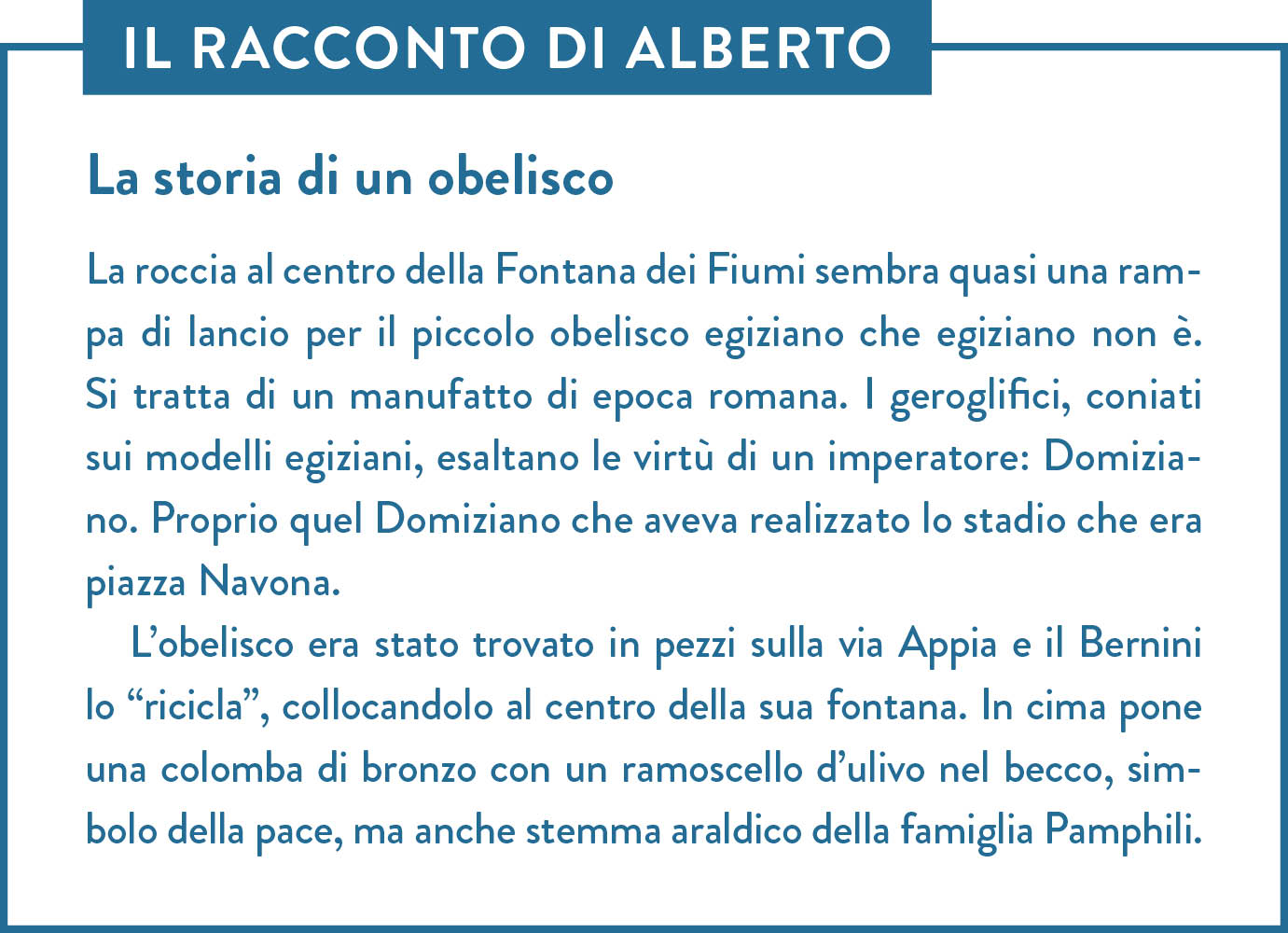
Alessandro VII e il colonnato del Bernini
L’ultimo papa della nostra storia è Fabio Chigi, eletto nel 1655 con il nome di Alessandro VII. Sotto la sua protezione il protagonista del Seicento, Gian Lorenzo Bernini, ristruttura piazza del Popolo, aggiornandone l’impianto rinascimentale e donandole l’aspetto barocco che ci accoglie oggi nella sua dinamica ariosità.
Ma l’ultima grande opera del Bernini, che costa all’artista più di dieci anni di studio e lavoro, è il colonnato antistante la basilica di San Pietro, un simbolo universale della Chiesa cattolica in tutto il mondo.
La piazza, all’epoca, è circondata da importanti edifici che non possono essere abbattuti. Nella sua nuova veste dovrà però avere una capienza sufficiente ad accogliere le moltitudini di fedeli e pellegrini: un bel rompicapo per il Bernini che si vede costretto a stracciare il suo primo progetto di forma trapezoidale, troppo rigido e inadatto alle esigenze. Senza farsi scoraggiare, anche grazie alla lungimiranza del colto committente, l’architetto ha finalmente l’intuizione geniale che porta al risultato che tutti possiamo ammirare.
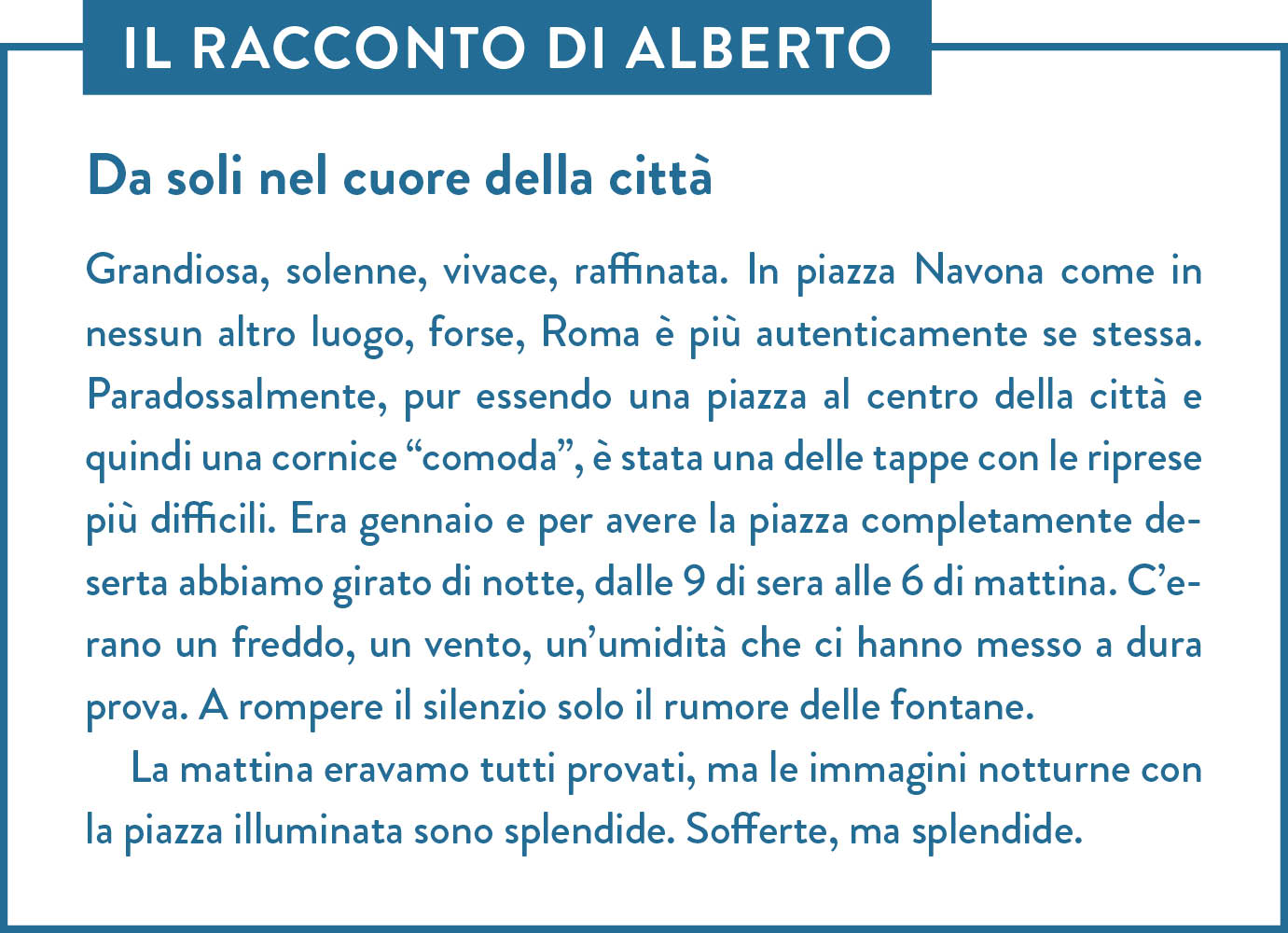

Bernini disegna un’ellisse circondata da 258 colonne che delimitano lo spazio senza però chiuderlo, permettendo le necessarie vie di fuga. L’allineamento dei due semicerchi è calcolato sui raggi dell’ellisse, il cui centro è indicato da una piastrella rotonda sul pavimento della piazza. A livello visivo questa soluzione offre imponenza e dinamismo allo stesso tempo: chi cammina per la piazza può vedere come le colonne sembrino aggregarsi e allontanarsi, in un movimento perenne.
Le forme geometriche sono inoltre pregne di simbolismo: l’ellisse indica il mondo intero, abbracciato dalle colonne che simboleggiano la madre Chiesa. Un capolavoro definitivo che da solo racconta l’ambizione universale del cattolicesimo.