IL SECOLO LUMINOSO DELLA SERENISSIMA

Tra i tanti splendori di Venezia ce n’è uno meno noto: le sue invalicabili fortificazioni.
Se pensiamo al Settecento, alla ricchezza culturale del Secolo dei Lumi, al raffinato sfarzo delle sue vesti e delle sue parrucche, la prima immagine che ci si presenta alla mente è l’eleganza di Venezia.
L’ultimo secolo della Serenissima Raepubblica, di cui abbiamo ricordato la gloria parlando di Verona e Padova, è probabilmente anche il più ricco e vivace. Nel 1797, le truppe di Napoleone prenderanno una delle più antiche repubbliche della penisola, nata nel IX secolo dai territori bizantini e arrivata a conquistare gran parte dell’Italia nord-orientale, l’Istria, la Dalmazia e le isole dell’Adriatico.
Ma intanto, per tutto il XVIII secolo, Venezia rimane uno dei più prestigiosi centri culturali e artistici dell’epoca, con personaggi del calibro di Antonio Vivaldi, che del Settecento sembra scrivere la colonna sonora, o pittori come Giambattista Tiepolo e Canaletto.
Venezia può permettersi di brillare, la grandezza del suo vasto dominio è stata consolidata nei due secoli precedenti anche grazie a un monumentale sistema di opere di difesa dislocate ai confini della repubblica.

Le opere di difesa veneziane
Nel 2017, l’Unesco ha riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità un sistema di fortificazioni composto da sei strutture, dislocate tra Italia, Croazia e Montenegro, ed erette tra XVI e il XVII dalla Serenissima per consolidare e difendere il suo potere.
L’estremità più occidentale del sistema è rappresentata dalla città di Bergamo dove la Repubblica veneziana edifica, tra il 1561 e il 1588, un perimetro di mura, sovrapponendole in parte a tratti ancora esistenti delle mura romane. Il sistema di fortificazione è articolato e vi si accede da quattro porte monumentali (le porte di Sant’Agostino, San Giacomo, Sant’Alessandro e San Lorenzo) sormontate dal Leone di San Marco, simbolo della Serenissima. Lungo il perimetro si dislocano poi quattrordici bastioni, due piani, mille aperture per bocche da fuoco e trentadue garitte, piccole strutture di vedetta di cui soltanto una è pervenuta sino ai giorni nostri.
Un’altra città fortificata, parte fondamentale di questa strategia è Peschiera del Garda, collegamento tra Venezia e i territori occidentali oltre il fiume Mincio. Qui, tra il 1551 e il 1553, i veneziani rinnovano le possenti cinte murarie in laterizio fortificandole con i cinque bastioni che ancora mostrano intatta l’impressione di potenza e sicurezza.
Infine, tra i siti italiani, vi è anche una città edificata ex novo dalla Repubblica veneziana per scopi militari: si tratta di Palmanova che, fondata nel 1593, è stata esplicitamente progettata come centro strategico per difendere Venezia dagli attacchi degli ottomani e degli austriaci. Il nucleo urbano è racchiuso da tre cinte murarie concentriche di cui solo il perimetro esterno è stato aggiunto, in un secondo momento, dagli occupanti francesi: questa struttura conferisce alla città la sua forma distintiva di stella a nove punte.
Le fortificazioni veneziane sono incredibili testimonianze dell’ingegno militare e architettonico della Serenissima che, nel XVI e nel XVII secolo, ha fatto scuola grazie ai suoi geniali architetti militari.
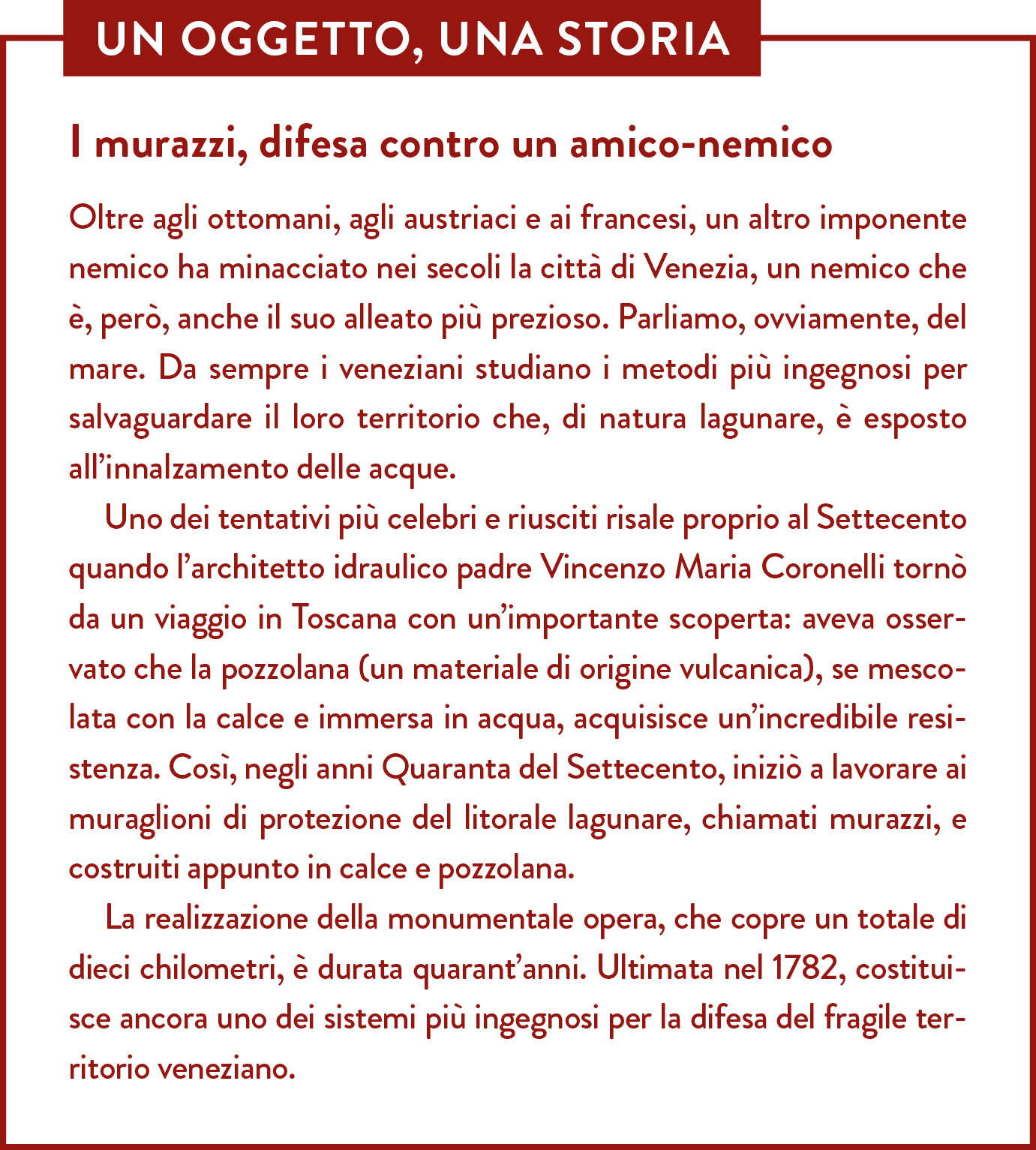
Meraviglie sul Canal Grande
Nel Settecento, negli anni in cui Vivaldi si muove in gondola per i canali di Venezia mentre Canaletto immortala la città nelle sue vedute piene di luce, l’unico ponte che sormonta il Canal Grande è quello di Rialto. Il ponte dell’Accademia e quello degli Scalzi saranno costruiti nell’Ottocento, e acquisteranno il loro aspetto attuale solo in seguito a restauri avvenuti negli anni Trenta del Novecento.

Il ponte di Rialto viene invece costruito alla fine del XVI secolo, quando la precedente struttura in legno si rivela, dopo una serie di crolli rovinosi, insufficiente a reggere il peso delle migliaia di cittadini che lo attraversano ogni giorno.
Dopo l’ennesimo crollo, nel 1551, le autorità indicono un bando per il rifacimento del ponte. Gli architetti più famosi gareggiano presentando i loro progetti: ci sono Jacopo Sansovino, Andrea Palladio, Giacomo Barozzi da Vignola, quelle che potremmo definire le archistar dell’epoca. Tutti ipotizzano per il ponte una soluzione che preveda diverse arcate.

Alla fine, però, dopo molti anni e altrettanti concorsi, è il progetto di Antonio da Ponte, nel 1588, ad avere la meglio: un ponte imponente, con un camminamento coperto, ma sostenuto da una sola grande arcata. L’opera è realizzata nel 1591 e da allora impreziosisce il Canal Grande.
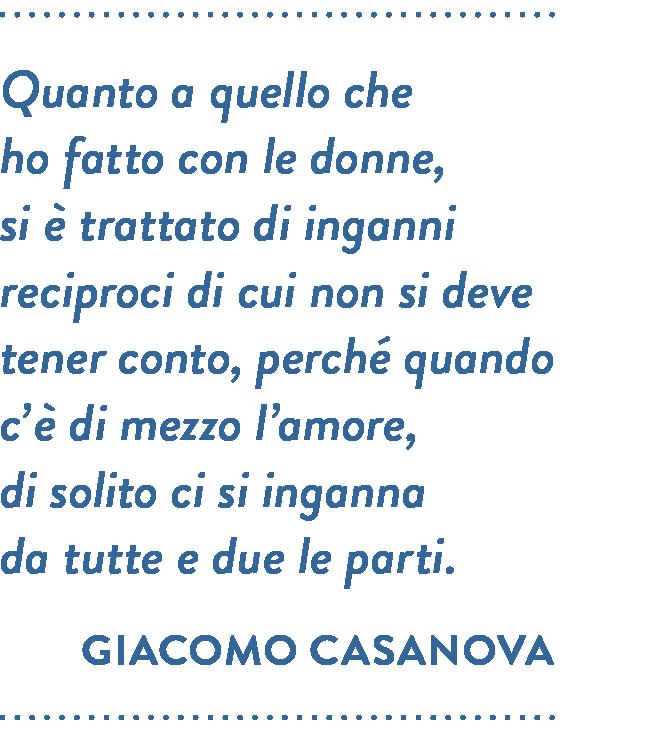
Navigando sullo stesso canale che, con la sua serpentina, taglia in due il centro di Venezia, possiamo immergerci in un mondo di antica eleganza, punteggiato dalle raffinate facciate dei palazzi, molti dei quali realizzati tra il XV e il XVII secolo. In prossimità del sestiere di Dorsoduro incontriamo però un palazzo che rappresenta l’emblema stesso del Settecento veneziano di cui ospita, infatti, l’incomparabile Museo.
Si tratta di Ca’ Rezzonico, la cui progettazione viene affidata, nel 1649, dalla famiglia Bon al noto architetto Baldassarre Longhena. Il progetto però si arena di fronte a due difficoltà insormontabili: la carenza di fondi dei Bon e la morte dell’architetto. Rimane solo la facciata, puntellata, ammirata da chiunque navighi lungo il canale, ma poco più di una quinta teatrale. Forse ammirandone la bellezza incompiuta, una famiglia originaria di Rezzonico, nel comasco, che ha recentemente acquisito lo statuto nobiliare, decide di acquistare il palazzo nel 1751 e di affidarne il completamento a Giorgio Massari.
I lavori finiscono dopo sei anni, in tempo per festeggiare l’inarrestabile ascesa sociale dei Rezzonico culminata nel 1758 con l’elezione al soglio papale di Carlo Rezzonico con il nome di Clemente XIII.
Ca’ Rezzonico è un palazzo patrizio, ma anche una dimora di mercanti. Per questo dispone di due ingressi: da quello all’altezza dell’acqua sul lato del Canale vengono introdotte le mercanzie, mentre l’altro, sul retro, è utilizzato per sontuose feste, balli e ricevimenti.
Di grande effetto è l’entrata, con lo scalone arricchito di statue e marmi. Tra le sale più belle c’è poi il salone da ballo, illuminato sontuosamente da grandi vetrate e da lampadari in vetro di Murano che esaltano, con la loro luce, gli splendidi affreschi del soffitto. Non è difficile, aggirandosi per il salone, immaginare la colta e raffinata società del Settecento veneziano intrattenersi in balli e giochi galanti.
L’amore per il teatro
La Venezia del Settecento è anche, e forse soprattutto, una città di teatro. È la casa e il teatro delle scorribande dell’avventuriero e libertino Giacomo Casanova (1725-1798), autore di testi teatrali e che nei secoli seguenti fornirà inesauribile ispirazione per romanzi e film. Ma è anche la città del commediografo Carlo Goldoni (1707-1793), ancora presente con le sue commedie sui palchi delle nostra penisola e su quelli di tutto il mondo.
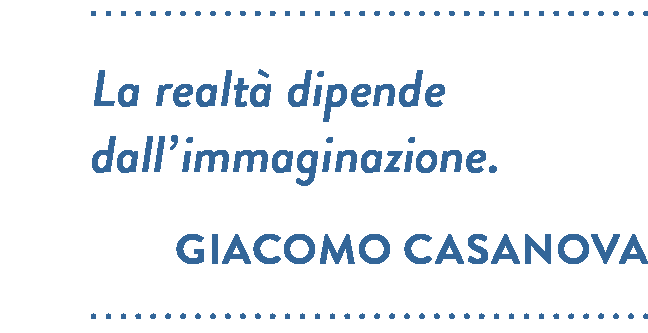
Non è un caso: a inizio Settecento, in città ci sono venti teatri per centotrentamila abitanti, un chiaro segnale della passione dei veneziani per quest forma d’arte. Il teatro più famoso, però, viene costruito solo alla fine del secolo, nell’ultimo decennio della Serenissima. Tra il 1790 e il 1792, non senza polemiche per l’immensa quantità di denaro investito, sorge La Fenice, in cui inizialmente vanno in scena spettacoli di ogni tipo, commedie, tragedie e persino balli sfarzosi come quello del 1808 alla presenza di Napoleone. Ma a quanto pare, nel nome di questo teatro, che ricorda l’uccello che sempre risorge dalle sue ceneri, si cela un destino di disgrazie: nel 1836, la Fenice è distrutta da un primo incendio. Ricostruita e resa ancora più bella dall’ingegno dei fratelli Meduna, riapre, diventando un punto di riferimento per la lirica nazionale e internazionale. Ma la sorte non ha smesso di accanirsi e, nel 1996, il teatro è nuovamente colpito da un incendio, stavolta doloso.
I veneziani, però, sono gente determinata e generosa, che ama il suo patrimonio. Nel 2003, si chiudono i nuovi lavori di ricostruzione: la Fenice, risorta ancora una volta dalle sue ceneri, splende ancora nella sua originale bellezza, simbolo dell’amore indistruttibile di Venezia per l’arte del teatro.
