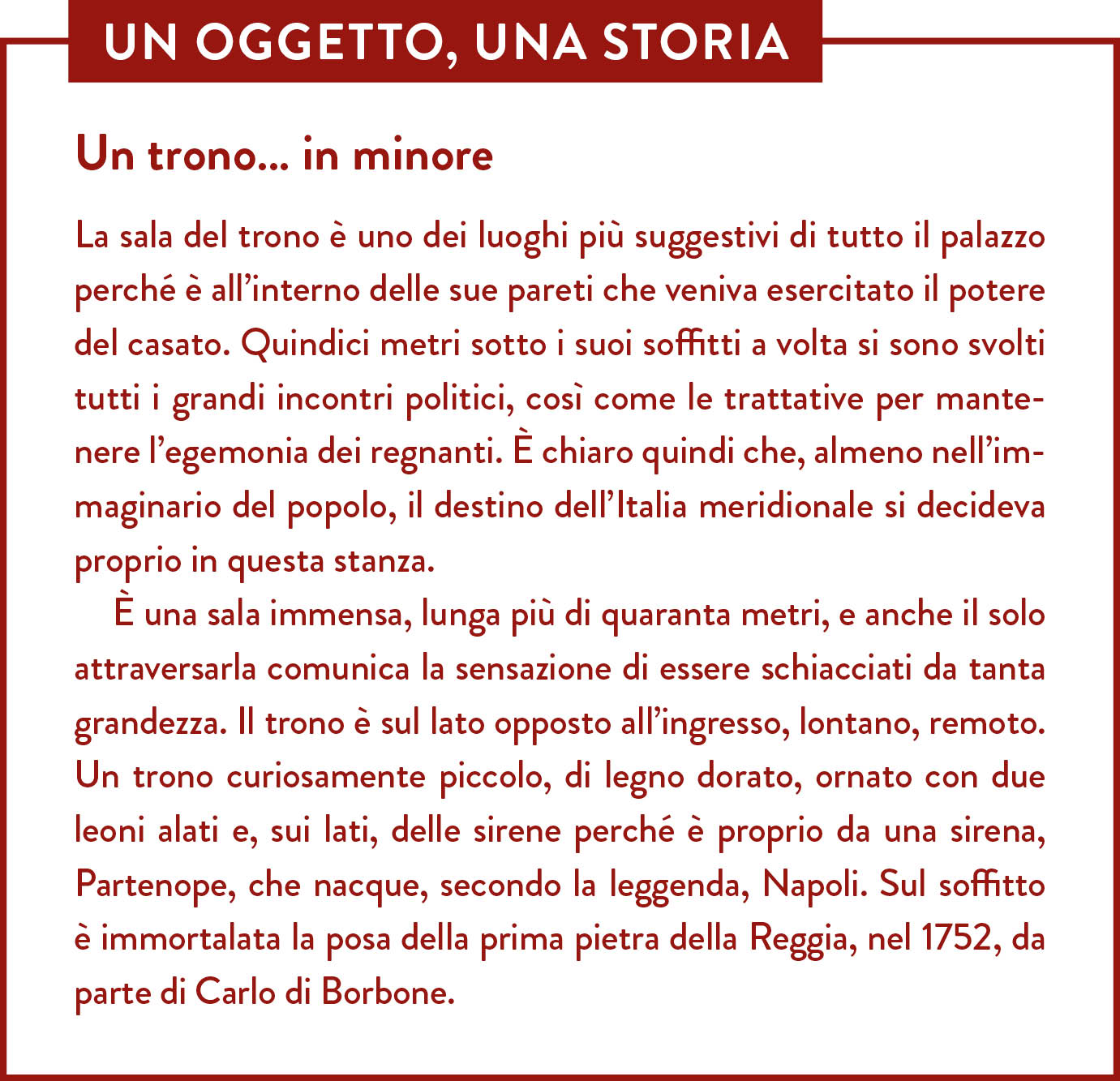IL SECOLO D’ORO DI NAPOLI

Dal Teatro San Carlo alla Reggia di Caserta, i Borbone fecero creare edifici straordinari a gloria del casato.
Anche per Napoli quello dei Lumi è, a tutti gli effetti, il secolo d’oro, il momento di massima grandezza di questa città millenaria, contesa nei secoli dalle dominazioni straniere.
Il Settecento si apre, per Napoli, all’insegna dei Lumi grazie a intellettuali come Pietro Giannone e Giambattista Vico che, con le loro opere, portano nella nostra penisola il fermento culturale proprio dell’Illuminismo. Si apre un’epoca nuova, animata da aspirazioni libertarie e riformiste.
Ma è il 1734 a segnare per sempre la storia della città partenopea: in questo anno, infatti, Carlo di Borbone, primogenito delle seconde nozze di Filippo V di Spagna con Elisabetta Farnese e già duca di Parma e Piacenza, conquista Napoli al comando delle sue truppe spagnole. È l’inizio della dinastia borbonica che regnerà sulla città per più di un secolo, fino all’Unità d’Italia.
Sotto il regno di Carlo e del suo fidato braccio destro Bernardo Tanucci, ministro illuminato, la città prospera e cresce, raggiungendo, nel 1750, una popolazione di trecentoventimila persone, al livello quindi di grandi capitali come Parigi e Londra.
Il fermento di quest’epoca abbraccia presente e passato. L’università napoletana apre nuove cattedre come quella di Economia e commercio, richiamando giovani e brillanti intellettuali, e nel contempo Napoli riscopre le sue radici avviando, proprio per volontà dei Borboni, gli scavi di Ercolano e Pompei. Ma, soprattutto, la città cresce e si impreziosisce, dotandosi della sontuosa bellezza settecentesca e rococò che chiunque, camminando tra le sue strade, può ancora riconoscere.
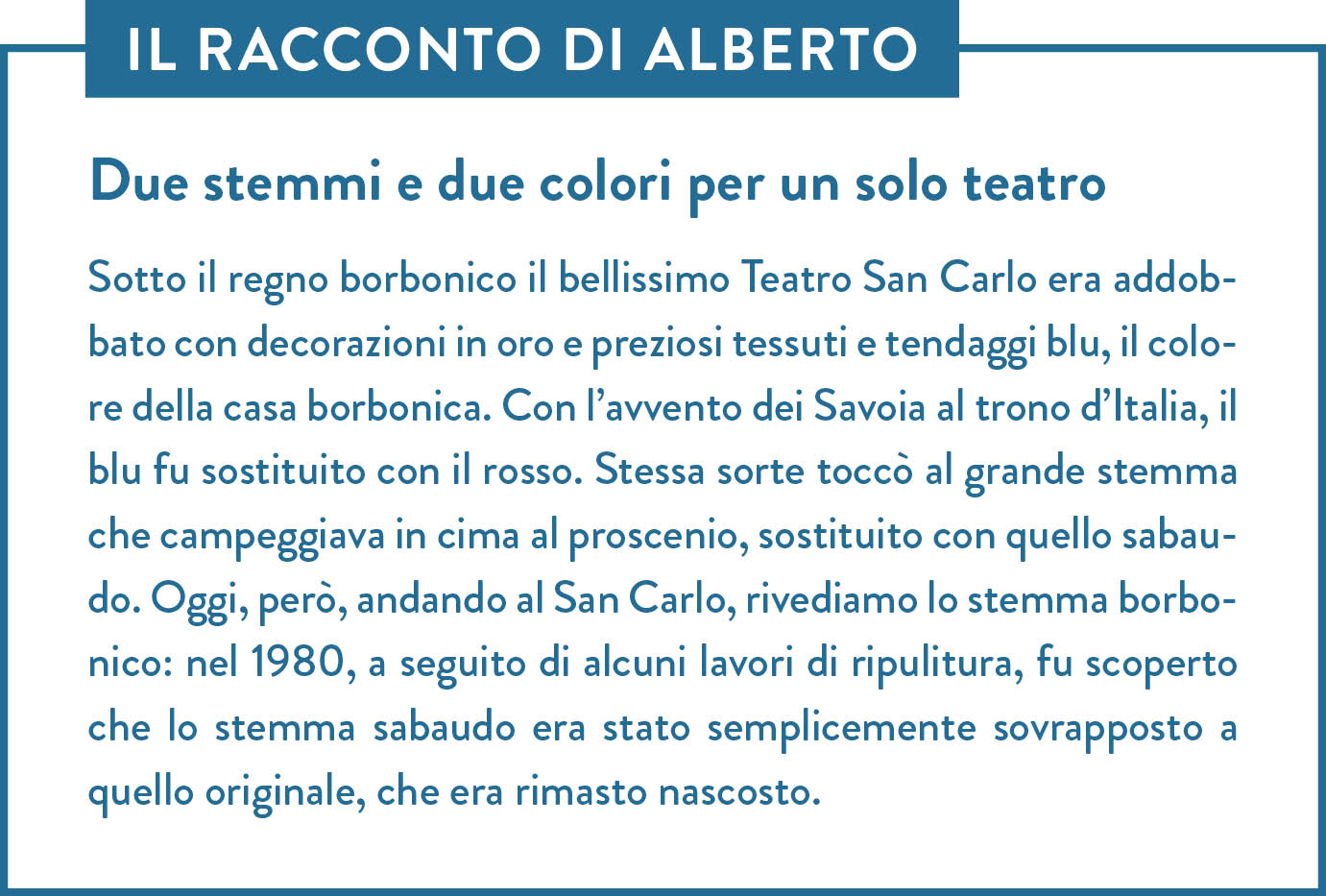
Un’impronta indelebile
I primi anni della dinastica borbonica lasciano a Napoli un’impronta indelebile. Addentriamoci nelle strade tortuose di questa antichissima città, il cui centro è stato riconosciuto Patrimonio Unesco nel 1995, per leggervi le tracce del glorioso secolo dei Lumi.
Alcuni edifici preesistenti, come la residenza storica dei viceré spagnoli, l’odierno Palazzo Reale, vengono profondamente ristrutturati da re Carlo. In questo caso il sovrano, per adeguare il palazzo alle esigenze della sua vasta e sontuosa corte, lo amplia aggiungendo nuovi corpi, tra cui l’appartamento del maggiordomo e l’appartamento dei Reali principi (Carlo e la moglie Maria Amalia di Sassonia hanno otto figli).

Per abbellire la sua residenza Carlo fa poi edificare due cortili interni, restaurare i magnifici giardini pensili e decorare la facciata con sculture marmoree e affreschi di stile barocco di Francesco De Mura e Domenico Antonio Vaccaro.
In altri casi il sovrano borbonico non si limita ad abbellire ciò che c’è, ma crea nuovi preziosi siti per la gloria della sua casata e il benessere dei cittadini. È il caso del Teatro San Carlo che il re decide di costruire, poco dopo il suo insediamento, affidando l’ambizioso progetto a Giovanni Antonio Medrano; il risultato sarà una sala larga ventidue metri e lunga ventisei, con centottantaquattro palchi disposti su sei ordini per un totale di 1379 posti.

Il teatro è inaugurato nel 1737 nel giorno di san Carlo, onomastico del re, che assiste con la sua corte all’opera di Metastasio Achille in Sciro nella grande e sontuosa loggia reale, fitta di decorazioni dorate in stile rococò.
Da quel momento il Teatro San Carlo diventa un centro tra i più importanti della lirica italiana e ospita i più grandi compositori europei dell’epoca.
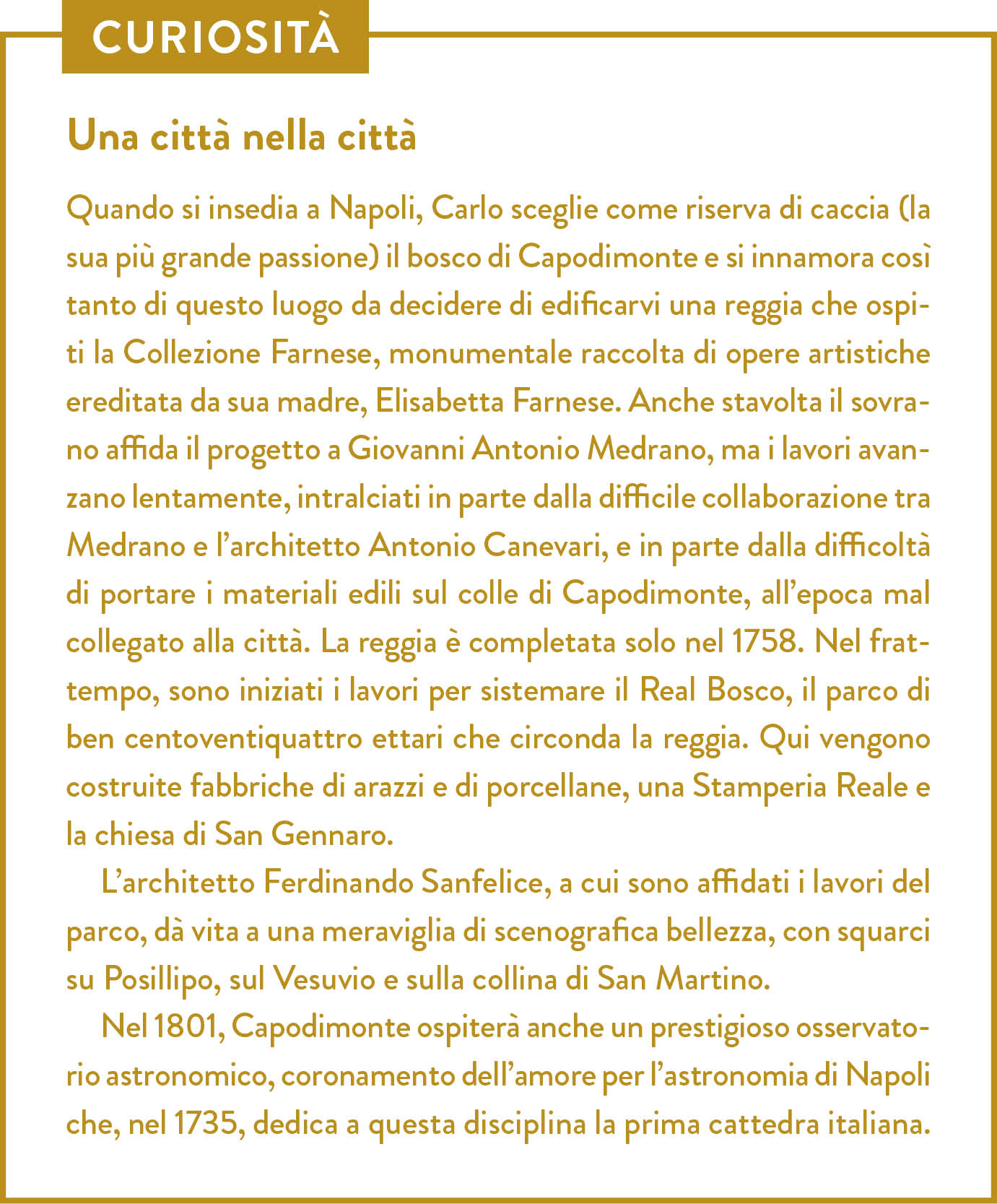
Il Principe di Sansevero
C’è una meraviglia, a Napoli, che non è da attribuire ai Borbone ma a un uomo che quasi eguaglia i sovrani in celebrità, tanto che in città è chiamato semplicemente “il Principe”. Si tratta di Raimondo di Sangro, principe di Sansevero, figura cruciale del Settecento napoletano. Gran Maestro della massoneria, Raimondo è anche inventore, alchimista e anatomista, ma soprattutto la sua fama è legata al mausoleo di famiglia, la cappella Sansevero, uno dei luoghi più suggestivi di Napoli.
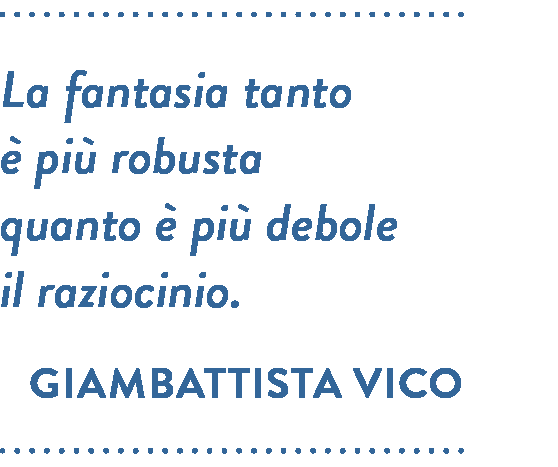
Una leggenda ritiene che la cappella sia sorta sulle rovine di un tempio consacrato alla dea egizia Iside, e questo non fa che accrescere la magia di questo luogo. Probabilmente è stata Adriana Carafa della Spina, prima principessa di Sansevero, a far costruire, nel Cinquecento, il mausoleo in memoria del figlio ucciso, insieme all’amante in un brutale omicidio passionale.
Raimondo ha rivoluzionato totalmente l’aspetto del mausoleo, avvalendosi dei servigi di grandi artisti come Giuseppe Sammartino, Antonio Corradini e Francesco Queirolo, e dando vita a un progetto complesso, ricco di significati esoterici.
Le statue rappresentanti le Virtù segnano le tappe simboliche di un cammino iniziatico dall’umano al divino, tra cui l’Amore divino, il Disinganno, il Dominio di se stessi, la Soavità del giogo coniugale, la Sincerità e la Pudicizia. Ma la scultura più misteriosa della cappella è il celebre Cristo velato, opera marmorea resa incredibile dalla maestria con cui lo scultore Giuseppe Sammartino ha saputo rendere il velo adagiato sul corpo inerme del Cristo morto. Si racconta che persino il grande Antonio Canova, vedendo la statua, abbia esclamato che avrebbe dato dieci anni di vita per poterne vantare la paternità.
Altre meraviglie sono celate nel sotterraneo della cappella dove è possibile ammirare le cosiddette macchine anatomiche, accurati modelli dell’apparato circolatorio commissionati dal Principe all’anatomista Giuseppe Salerno.
Le note conoscenze alchemiche ed esoteriche del Principe hanno alimentato una ennesima leggenda: i due modelli sarebbero stati cadaveri veri a cui era stato iniettato del piombo per mummificare l’apparato circolatorio. Inutile dire che l’ipotesi viene assolutamente smentita dall’analisi delle macchine, che rimangono comunque simbolo della raffinatezza scientifica e culturale raggiunta dai Lumi napoletani.

La Reggia di Caserta
Se Napoli è uno scrigno di meraviglie settecentesche, ve n’è una, forse la più celebre e magnifica, che dista diversi chilometri dalla città partenopea ma risale alla stessa epoca e allo stesso committente dei tesori di cui abbiamo parlato, Carlo di Borbone.
“La reggia dovrà sorgere a Caserta e dovrà essere più sfarzosa di Versailles”: è la promessa da cui parte re Carlo quando dà avvio al lungo processo che porterà alla realizzazione della Reggia di Caserta, un progetto vastissimo, che nelle intenzioni dello stesso Carlo dovrà rappresentare il centro propulsore e amministrativo del Regno. Un sogno che il re di Napoli affida a un famoso architetto napoletano, di origine olandese: Luigi Vanvitelli. È il 1752 e la sede, Caserta, viene scelta per la sua posizione favorevole: non è in città ma è facilmente raggiungibile da Napoli; è vicina alla capitale, ma abbastanza lontana dal mare per essere al riparo dalle flotte nemiche in caso di attacco.
Si iniziano quindi i lavori destinati a regalare una dimora unica al casato dei Borbone e, al mondo, un simbolo di bellezza universale del Barocco italiano. Ma, come si può immaginare, enormi saranno gli sforzi per portare a compimento un simile progetto.

Un’opera titanica
Se il prestigio di un edificio si misura anche con i numeri, quelli della Reggia la rendono molto speciale: l’edificio si estende infatti per più di sessantunomila metri quadrati, dispone di quattro cortili interni ed è di forma rettangolare, con un lato lungo duecentocinquanta metri e l’altro duecento. Il palazzo è alto più di quaranta metri e si sviluppa su cinque piani. Gli ambienti, tra stanze, saloni, teatri e cappella privata, sono più di mille. E poi? Poi si contano ben 1742 finestre, 1026 comignoli, trentaquattro scale, più di mille porte e almeno due grandi sotterranei. Un’opera titanica quindi che, come nelle richieste di Carlo di Borbone, sarà senza ombra di dubbio la residenza reale più grande al mondo.
I lavori di costruzione durano quasi un secolo, e infatti l’architetto Luigi Vanvitelli non farà in tempo a vedere la Reggia completata. Il cantiere è immenso, in alcune fasi lavorano contemporaneamente duemilasettecento operai, trecento capomastri, duecentocinquanta prigionieri turchi catturati dalle flotte borboniche in mare, trecentotrenta tra forzati e condannati dal regno dei Borbone. A completare il quadro, ecco anche gli animali esotici, dai cammelli agli elefanti, utilizzati per traportare e sollevare le enormi pietre. Uno degli elefanti, regalato a Carlo di Borbone dal sultano turco Mahmud I, assurge al ruolo di star: forte e imponente, calcherà le scene del Teatro San Carlo, durante la rappresentazione di un’opera di Pietro Metastasio, Alessandro nelle Indie.

Le scenografie di Vanvitelli
Inoltriamoci nell’edificio per andare a curiosare fra le mille e più stanze di questo tesoro dell’architettura barocca di cui, secondo le stesse parole dell’Unesco, la Reggia rappresenta il canto del cigno: l’ultima meravigliosa opera di un’idea di arte e di bellezza che ha dato la sua impronta a un pezzo di storia.
Abbiamo già accennato al fatto che Vanvitelli, purtroppo, non abbia mai visto la sua opera completata. Eppure, a partire dai suoi progetti, pare chiaro che l’aspetto attuale della Reggia ne rispecchi le idee. Il complesso si articola, infatti, come nelle volontà del suo ideatore, per più di tre chilometri lungo una strada centrale sui cui lati si susseguono vasche e fontane, e in fondo alla quale appare, magnifica e maestosa, la spettacolare cascata finale. Palazzo e parco sono un unicum, i portici dialogano con il giardino, l’interno con l’esterno, in assoluta coerenza con i dettami dell’architettura settecentesca. Sempre ispirato dal Barocco, Vanvitelli inserisce poi nella struttura una piccola magia, un effetto ottico detto “a cannocchiale”, una sorta di illusione talmente ben congegnata da darci la sensazione che fra la prima fontana e la base della cascata la distanza sia minima, nonostante a separarle siano quasi due chilometri. Illusione che poi, camminando all’interno del portico, va via via a perdersi con la cascata che, invece di farsi più vicina (visto che stiamo procedendo nella sua direzione), iniziamo progressivamente a percepire nella sua reale distanza.

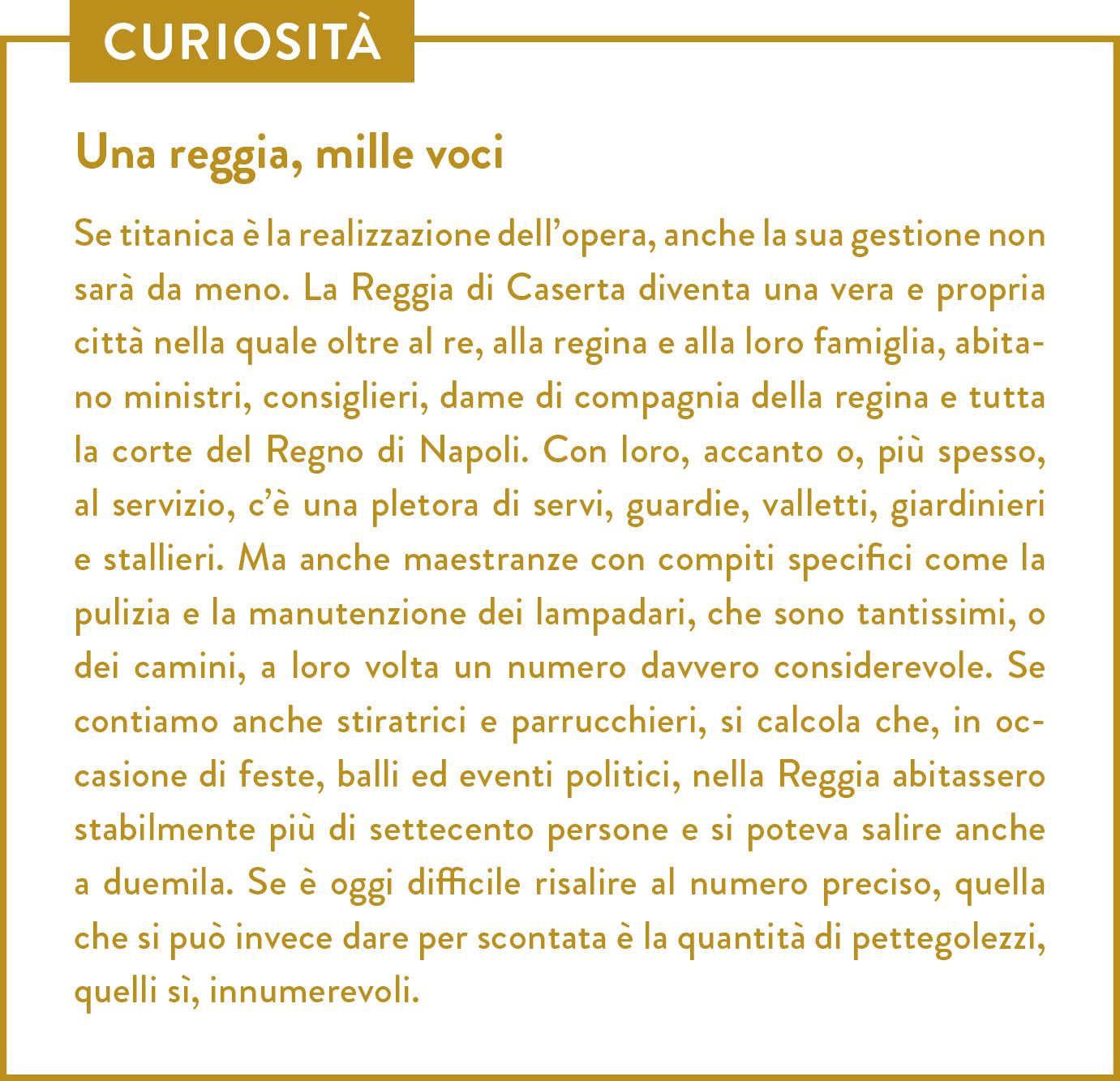
Entrando nel palazzo, su un lato dell’atrio si apre un magnifico scalone reale a doppia rampa, un autentico capolavoro di architettura tardo barocca, immortalato in numerosi film: una scenografia del potere, uno sfoggio di grandezza. Da qui passavano ambasciatori e governanti, che attendevano di essere ricevuti da uno dei sovrani più importanti del mondo. Al cenno di assenso di un delegato, salivano lentamente, e forse con una certa soggezione, i centosettantasette gradini di queste scale.
Giunti in cima, si accede agli appartamenti veri e propri, quelli in cui viveva la corte dei Borbone. Camminando fra la mobilia lussuosa sui meravigliosi pavimenti, non possiamo non immaginarci l’andirivieni di ambasciatori, cortigiani, consiglieri, militari. Obbligati a percorrere costantemente distanze notevoli: basti pensare che circa duecento metri separano il vestibolo dagli appartamenti reali.

La stanza di Francesco II di Borbone, ultimo re del Regno delle Due Sicilie, è completamente fuori misura, amplissima. In questo caso, però, a colpire non sono più le dimensioni degli spazi ma il letto a baldacchino sormontato da una corona di legno dorato. Un letto particolarmente grande per l’epoca, anche per via di una peculiarità dei membri di questa famiglia: i Borbone avevano in generale una statura superiore alla media. Se, infatti, la media di quegli anni era di circa un metro e sessantacinque, e Napoleone Bonaparte, nemico giurato dei Borbone, per esempio pare fosse alto un metro e sessantanove, sia Carlo che il suo erede Ferdinando raggiungevano quasi il metro e ottanta.
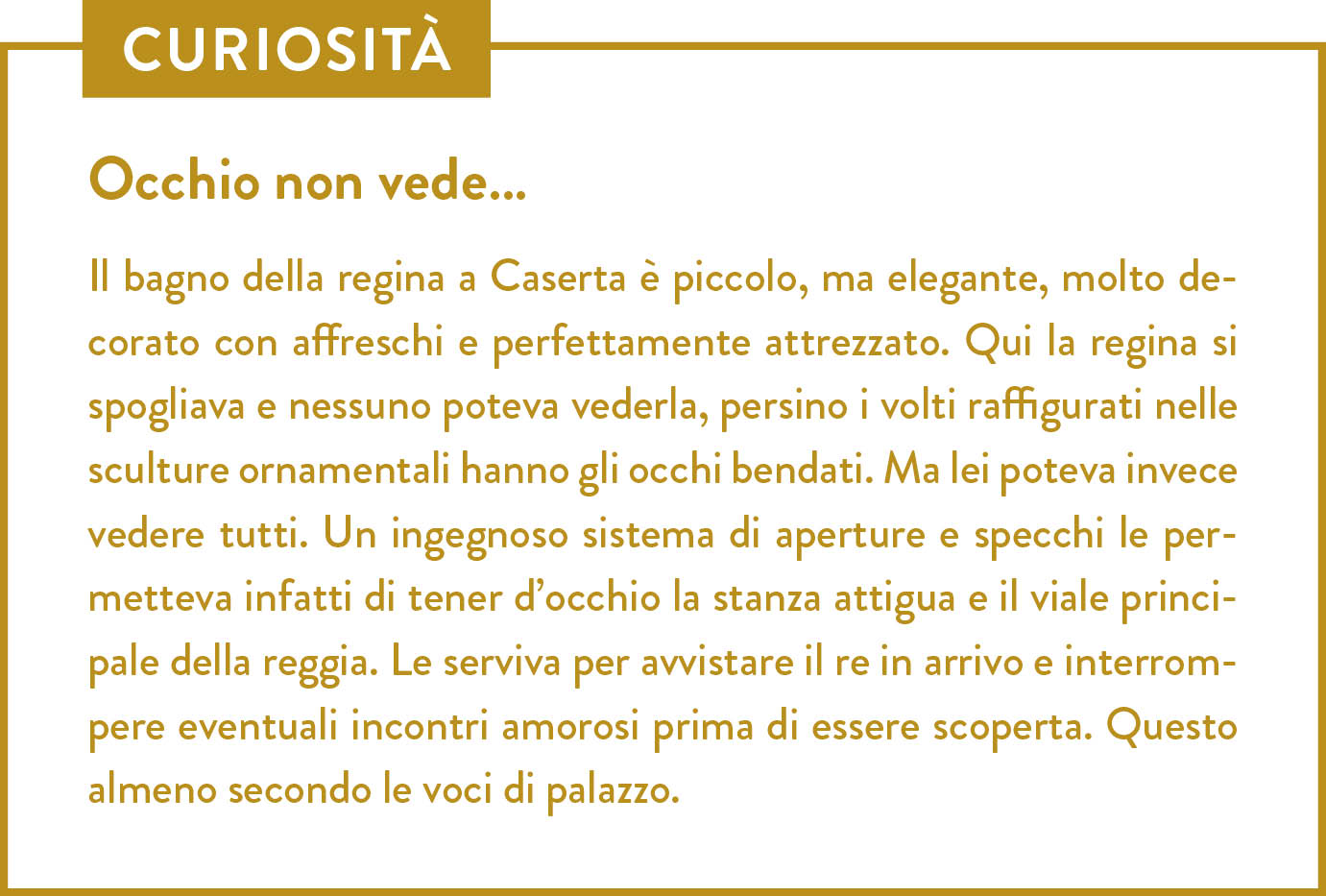
Nella Reggia di Caserta tutto doveva essere perfetto. Ma il fiore all’occhiello dei Borbone erano i servizi igienici, molto più raffinati di quelli di Versailles. È una leggenda quella secondo la quale alla corte di Francia non ci si lavava. O che il re Sole avesse fatto solo due bagni in vita sua. Sono certamente esagerazioni, ma vero è che la cura del corpo rappresentava per i Borbone una priorità. Alla Reggia c’era l’acqua corrente, una vera rarità destinata esclusivamente a re e aristocratici, ma era fredda. Solo più tardi, a metà dell’Ottocento, si sarebbe aggiunta quella calda; prima, l’acqua veniva scaldata sul fuoco dai domestici e portata fin qui per riempire la vasca del re. Ci pensava poi il camino acceso a rendere confortevole la stanza nei mesi invernali.