PARMA E LA MUSICA

Nell’Ottocento una donna al potere, Maria Luigia, crea a Parma un prodigio di bellezza.
Una donna speciale
Il secolo che porterà alla nascita dell’Italia, attraversando i moti risorgimentali, fiorisce di attività e iniziative artistiche e imprenditoriali e vibra di nuovi stimoli. È in questo contesto che entra in scena una donna speciale. Una di quelle capaci di catalizzare l’attenzione attorno a sé.
Si chiama Maria Luisa Leopoldina Francesca Teresa Giuseppa Lucia d’Asburgo-Lorena, ma tutti la conoscono come Maria Luisa d’Austria o Maria Luigia di Parma. Una donna il cui destino sarà quello di ritrovarsi al centro degli sconvolgimenti che agitano l’Europa fra Il Settecento e l’Ottocento.
Figlia dell’imperatore austriaco Francesco I, Maria Luigia, nel 1810, viene data in sposa a Napoleone Bonaparte per suggellare la pace tra la Francia e l’Austria. È il 1816 quando giunge a Parma, come duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla. Il titolo le viene conferito da Napoleone, che pensava al futuro degli eredi, ma dopo l’esilio dell’imperatore viene confermato al Congresso di Vienna. Parma inizialmente non riesce a fare breccia nel cuore di una duchessa abituata ai fasti di Vienna e Parigi: quella in cui si trova è una città minuscola rispetto alle capitali europee. Soprattutto, è una città provata dalla guerra appena conclusasi e da una povertà diffusa. Ma Maria Luigia, rimanendo fedele al suo impegno, prende per mano i propri sudditi e aiuta la città a rialzarsi. Anzi, è proprio a Parma che la duchessa trova la felicità anche sentimentale legandosi a un generale ussaro. Tanto che non se ne allontanerà mai, trascorrerà qui il resto della sua vita, amatissima dai cittadini per la sua abilità di amministratrice e per il suo impegno come mecenate.
Oltre a impegnarsi nella gestione della città, Maria Luigia ama la musica, ama l’arte. È un’ottima strumentista, suona il fortepiano e segue in maniera appassionata l’opera. Si reca spessissimo a Milano, dove assiste alle rappresentazioni del Teatro alla Scala, finanzia borse di studio per sostenere le carriere di cantanti e compositori e si impegna in prima persona per Parma dedicandosi a renderla bellissima. E regala alla città, investendo moltissimo denaro, una nuova grande biblioteca.

Maria Luigia pensa in grande e decide che il Teatro Farnese non è sufficiente per un ducato ambizioso come quello parmense. Soprattutto, non è adatto a mettere in scena le opere liriche che tanto ama. Ordina quindi la costruzione di un teatro da milleottocento posti, investendo una cifra ingente per l’epoca, forse troppo per le casse di una città come Parma, tanto che la duchessa coinvolge nell’impresa le famiglie più ricche della città. L’accordo con nobili e notabili locali prevede che, in cambio del versamento di una quota con cui contribuiscono alla costruzione del teatro, ricevano il possesso in perpetuo di un palchetto. Un beneficio di cui ancora oggi alcuni eredi si avvalgono a distanza di due secoli. Dai palchetti nelle serate importanti, è possibile spiare il palco dove siede lei, Maria Luigia, che giunge in teatro sempre all’improvviso, usando un suo ingresso esclusivo. Il suo monogramma, ML, compare ovunque, cesellato sulle maniglie di tutti i palchi del teatro, che la duchessa ha voluto bellissimo: un grande sipario dipinto, e una splendida camera acustica, cioè una sorta di cassa di risonanza fatta di tela di canapa montata su supporti di legno, che serve ad accogliere e ad amplificare i suoni della formazione orchestrale, con la particolarità di essere telescopica, cioè di poter essere ristretta o allargata a seconda del numero di musicisti in scena.
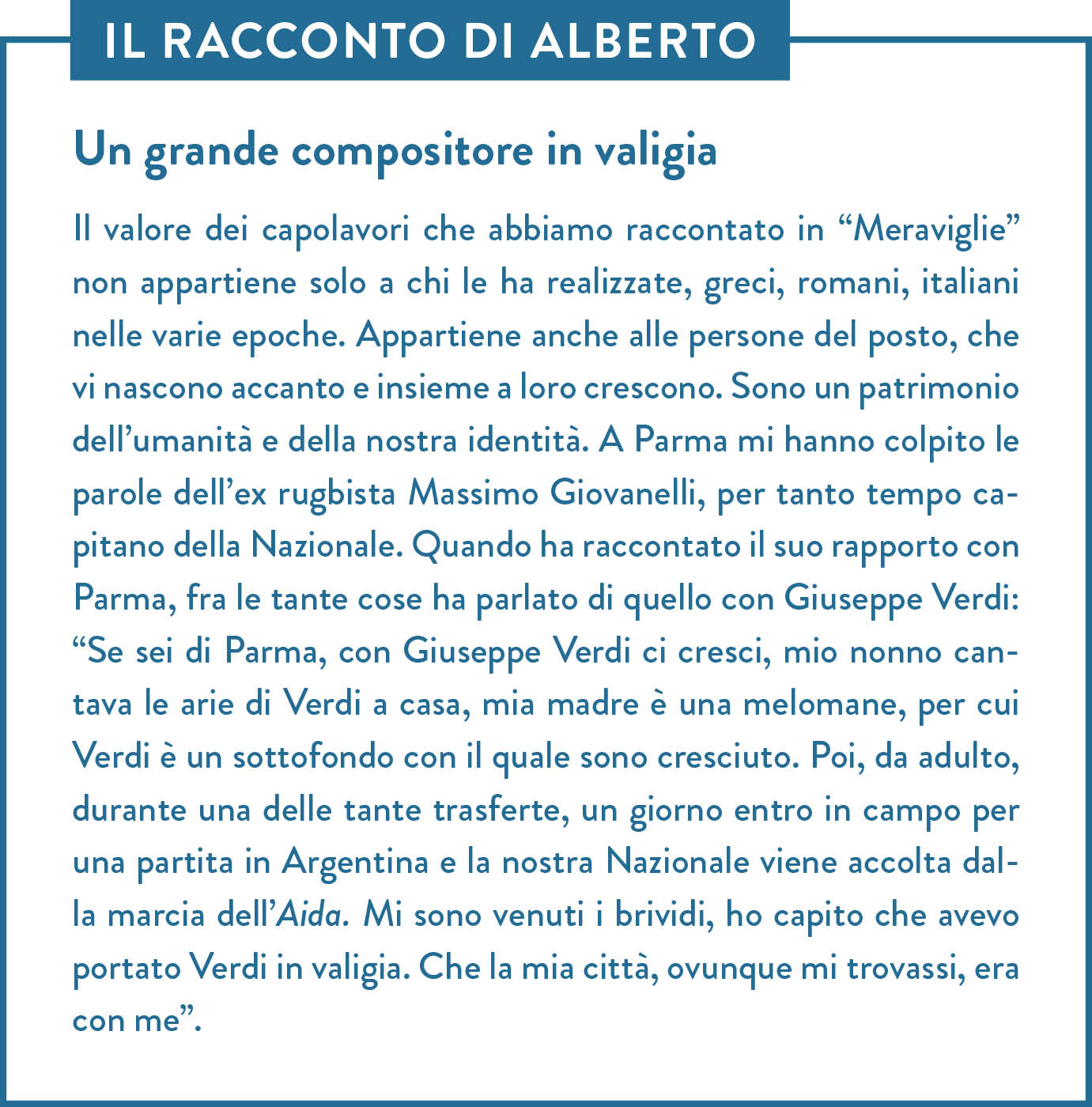
Sul soffitto e sui palchi di proscenio sono ancora oggi raffigurati i compositori più stimati dell’epoca: Giovan Battista Pergolesi, Giovanni Paisiello, Domenico Cimarosa, Ferdinando Paer, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti. Ma, e questa potrebbe sembrare una sorpresa visto che siamo a Parma, non quello del grande Giuseppe Verdi.
La ragione è presto detta: Maria Luigia ama moltissimo Bellini, sarà proprio una sua opera ad inaugurare il Teatro Ducale, ma è critica e molto fredda nei confronti di Verdi. Lo trova fin dall’inizio grezzo, grossolano, e, nonostante il crescente successo che gli arride, non cambierà mai il suo giudizio su di lui.

Nessuno è profeta in patria
Il genio musicale che tutto il mondo ci invidia è originario di queste zone. Nasce infatti a Busseto, a pochi chilometri da Parma. Verdi è orgoglioso delle sue origini e non perde occasione per definirsi un contadino della Bassa che ce l’ha fatta, che ha fatto strada. Ma appena può, grazie ai soldi di quello che diventerà suo suocero, Antonio Barezzi, Giuseppe Verdi lascia Busseto per andare a studiare a Milano.
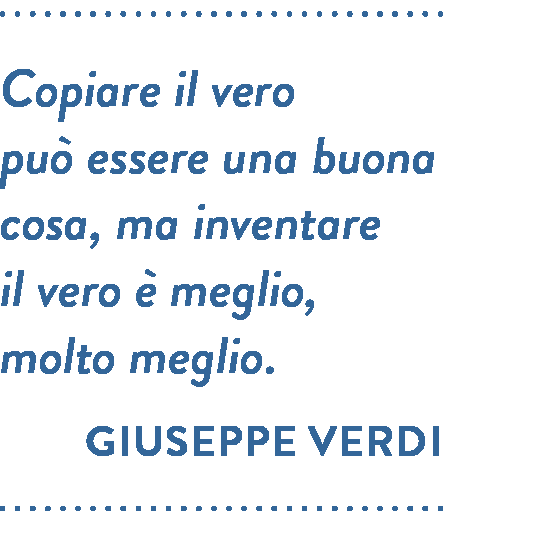
Nonostante ostenti distacco, Giuseppe Verdi proverà in molti modi a fare breccia nel cuore di Maria Luigia. Se anche la leggenda lo descrive schivo e poco interessato alla mondanità, Verdi scrive molte lettere al maggiordomo di Maria Luigia, il conte di Bombelles, per avere il permesso di dedicarle la trasposizione per piano e voce de I Lombardi alla prima crociata. Ha bisogno di un suo sì perché non sarebbe possibile dedicare alcuna composizione a Maria Luigia senza il suo permesso. Lei, però, per lungo tempo glielo nega. Finché un giorno il sospirato assenso arriva ma senza che la duchessa cambi davvero atteggiamento. La musica di Verdi le appare troppo pomposa, non sufficientemente raffinata. Eppure, I Lombardi alla prima crociata prima e Il Nabucco poi, con il coro del Va’ pensiero, diventano il primo simbolo di una nazione, quella italiana, che comincia a prendere coscienza di sé, e si prepara a ribellarsi, a muovere i passi verso l’unità.
“Viva Verdi” diventa un acronimo, uno slogan di patriottismo, di ribellione: Viva Vittorio Emanuele re d’Italia. Viva Verdi. È una svolta, tanto che, scrive Carducci, “Giuseppe Verdi co’ primi palpiti dell’arte giovine presentì ed annunziò la patria risorgente”.
Per uno dei giochi che piacciono al destino, la “musica senza scuola” di quel contadino della bassa parmense, che aveva fatto fortuna a Milano, diventerà il simbolo di una nazione, e l’inno di una grande ribellione che travolgerà tutto, l’Ancien Régime, e gli Asburgo di Maria Luigia che tanto poco aveva amato Giuseppe Verdi.
