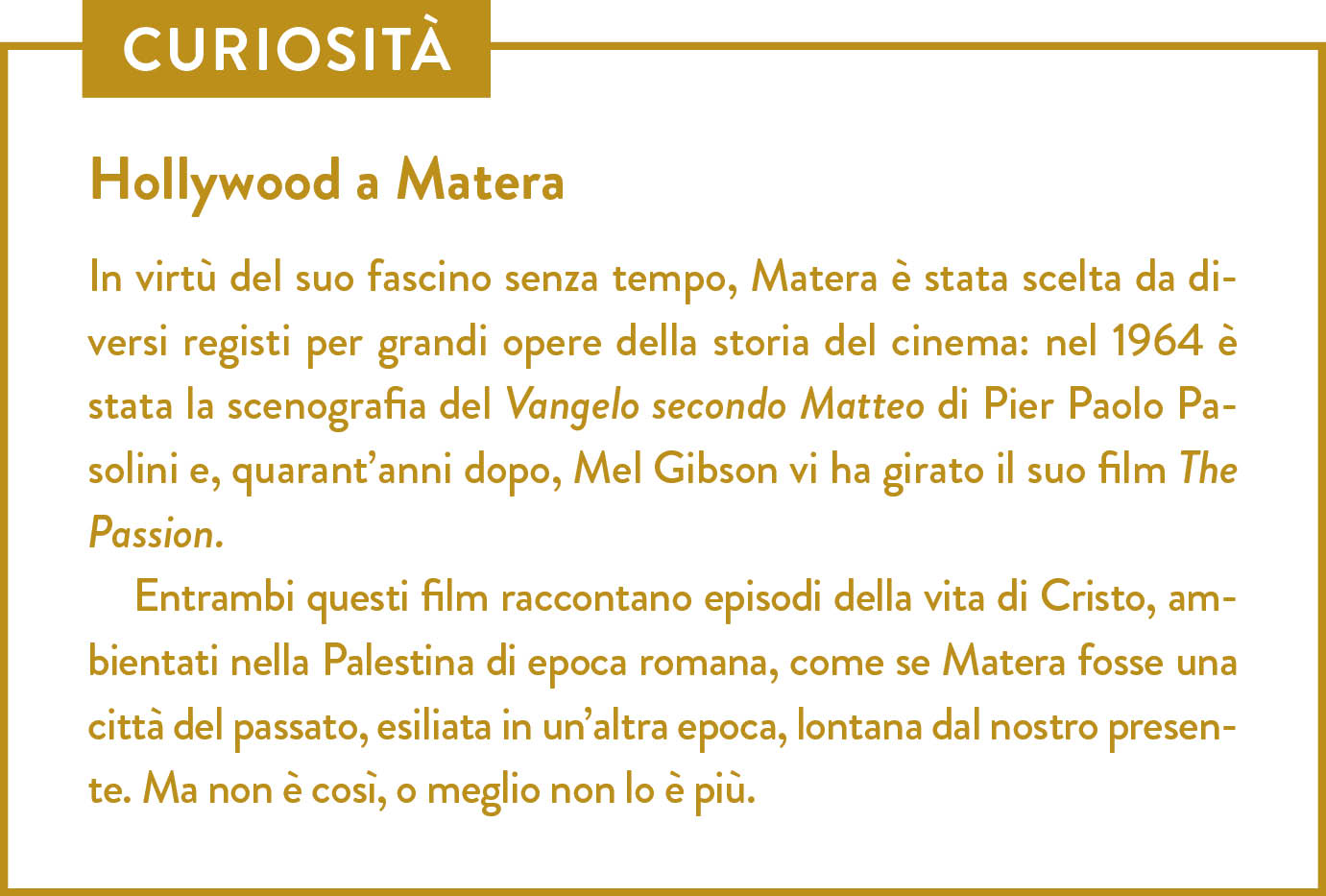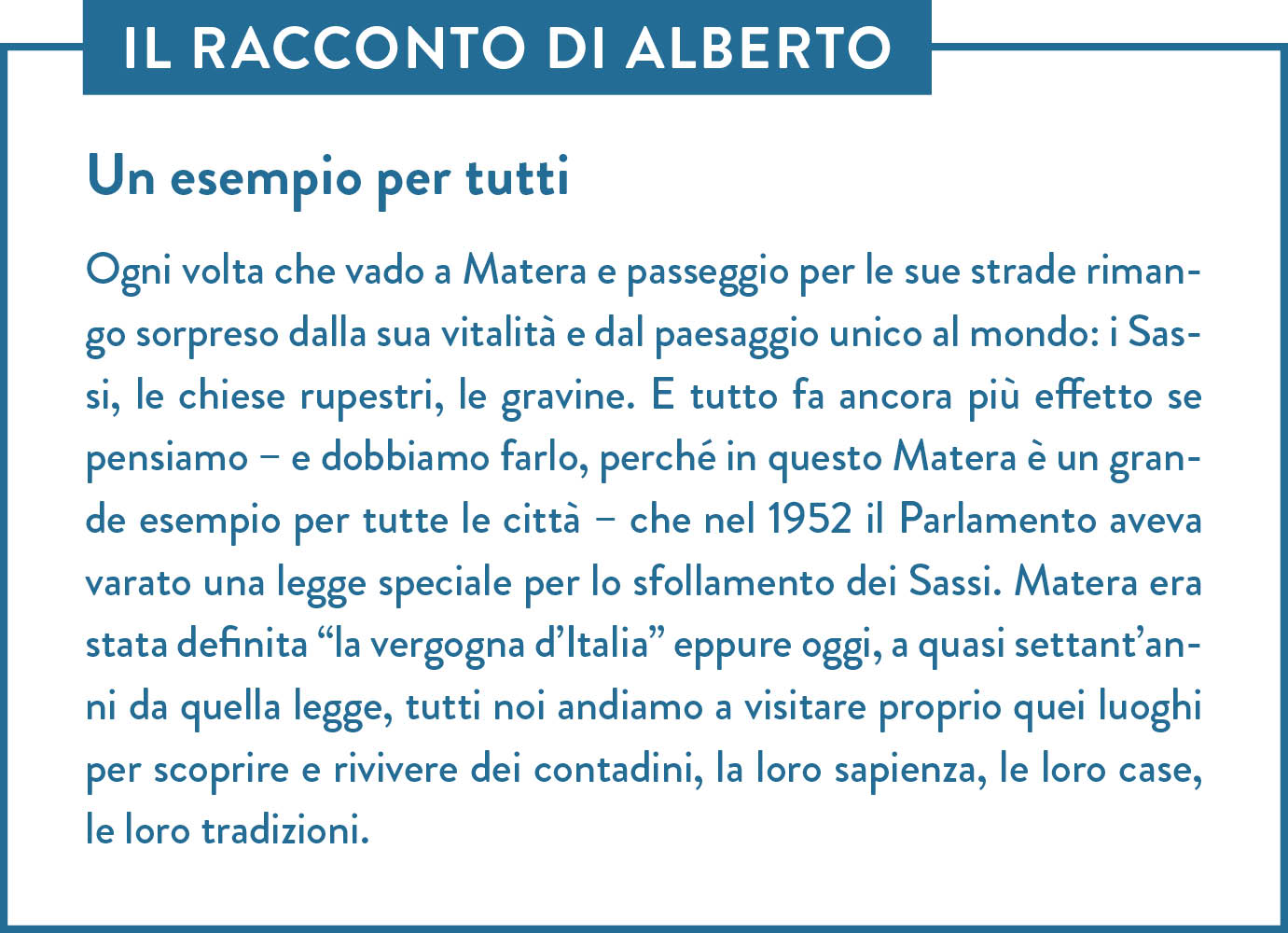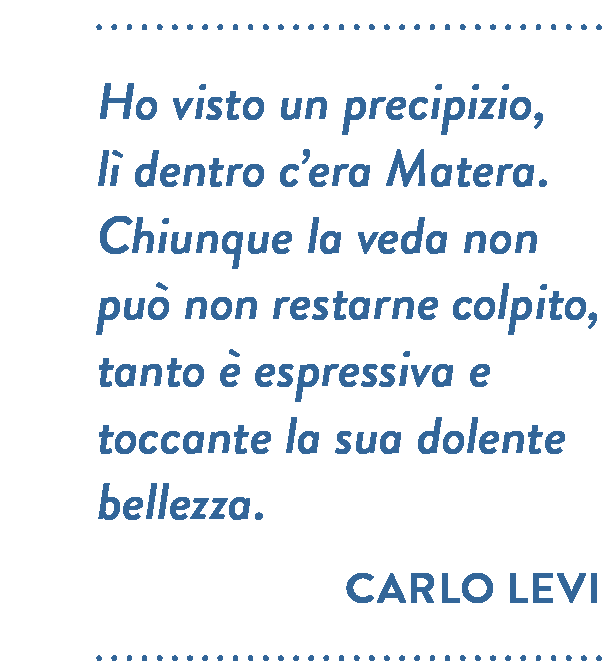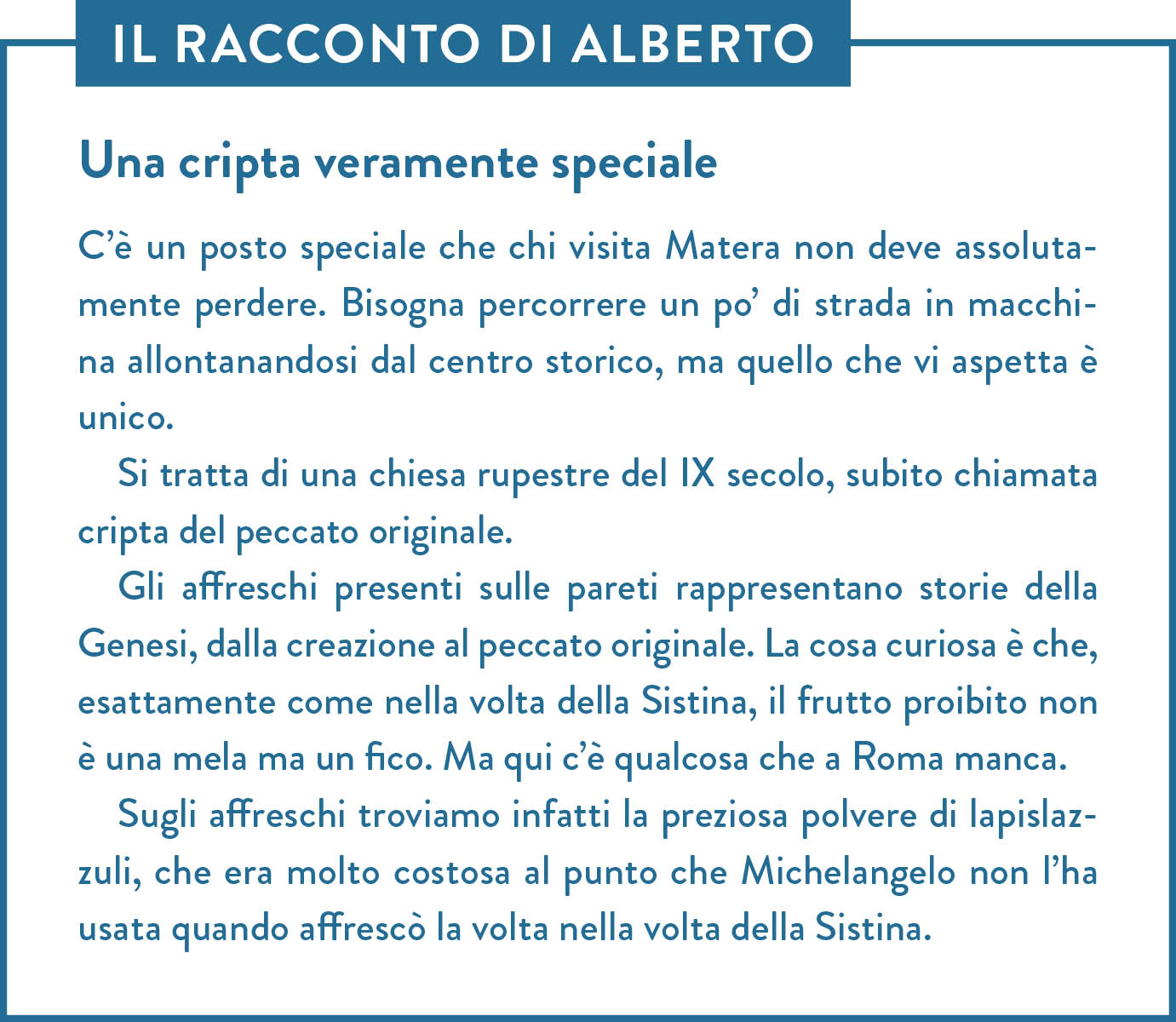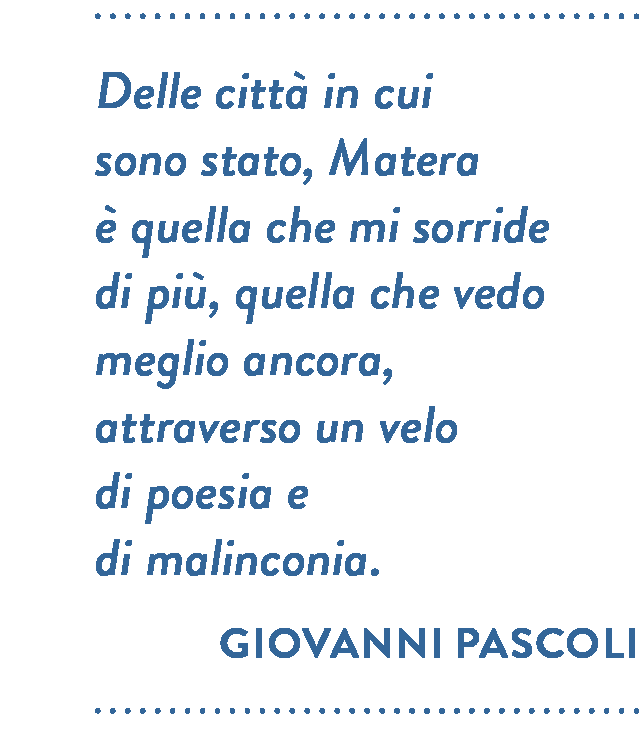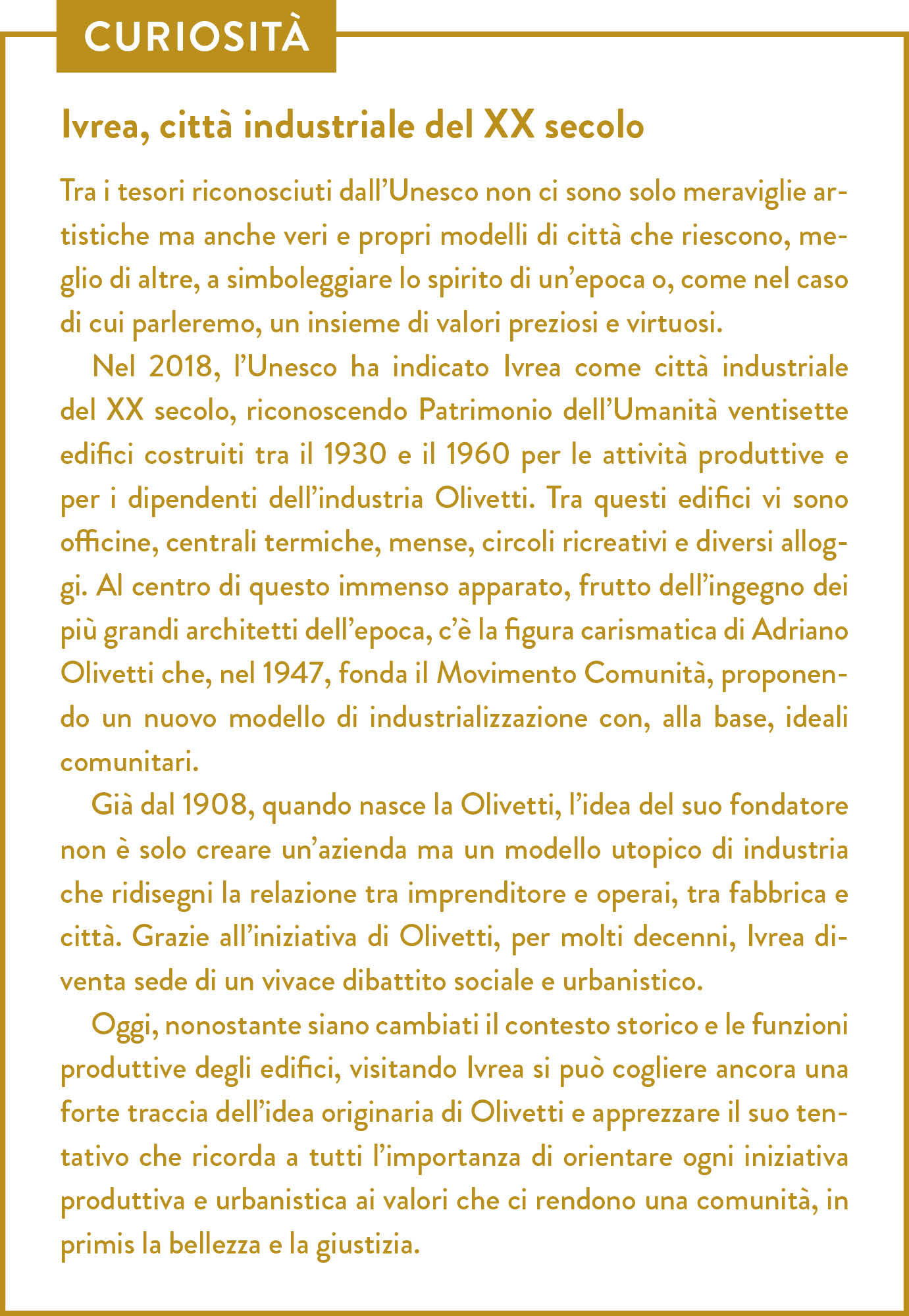RINGRAZIAMENTI
“Meraviglie” è un programma realizzato dal Centro di Produzione Rai di Napoli diretto da Francesco Pinto e sotto la guida del capostruttura Rosanna Pastore
Regia di Gabriele Cipollitti
Autori Aldo Piro, Filippo Arriva, Fabio Buttarelli (seconda edizione), Ilaria Degano (seconda edizione), Carlotta Ercolino (prima edizione), Vito Lamberti, Paolo Logli, Paola Miletich (prima edizione), Emilio Quinto
Musiche originali Giuseppe Zambon
Costumi Silvia Bazzocchi
Direttore della fotografia Enzo Calò
Responsabile della produzione Annamaria Mauro
Direttore di produzione Michele Borzacchiello
A cura di Nicoletta Zavattini
Produttore esecutivo Monica Giorgi Rossi
Montaggio Roberto Emilio, Pierpaolo Centomani, Massimiliano Maiello, Ivo Semeraro, Antonella Tina, Giacomo Di Staso
Coordinamento grafica Francesco Inglese
Effetti visivi Giorgio Capaci
Casting Graziamaria Dragani
Ufficio stampa Lorenza Basile
In redazione Daniela Franco, Giulia De Francovich, Gian Piero Orsingher, Federica Calvia, Maria Francesca Marcelli, Cristina Scardovi, Elisabetta Passiatore, Laura Pellegrini, Valerio Puppo
Organizzatore di produzione Maria Carneglia
Aiuti regista Alessandro Morbioli, Manuela Tortora
Assistenti alla regia Laura De Stefano, Mario Cesaro, Michela
Maiello, Elena Proto
Media manager Francesco Sepe
Arredatore Pierpaolo Panarese
Tecnico audio Luigi Pollice
Data manager Paco Centomani
Operatori di ripresa Fabio Testa, Riccardo Caiano, Antonio Lieto, Marcello Malaguti, Gennaro Borrelli
Surround sound editor Giuseppe Ierardi, Massimiliano Tomacelli, Michele Pignatiello
Realizzazione grafica Antongiulio Palladino, Andrea Pisano
Microfonista Pasquale Capano
Capo squadra specializzati della produzione Claudio Cantalupo, Alessandro Piccolo, Luigi Sarnataro
Macchinisti di scena Raffaele Tessitore, Alessandro Magri
Truccatore Rino Raciti
Parrucchiere Raimondo Librano
Addette ai costumi Lucia Bolognino, Patrizia Bosso
Specializzati della produzione Michele Della Volpe, Raffaele
Martino, Marco Occhiello, Piero Giansante
Per i siti “minori” e le interviste
Organizzatore/ispettore di produzione Alessandro Pisa
Operatori di ripresa Massimo Zanirato, Marco Schiappa, Luigi Cascella, Pasquale Trotta
Focus puller Andrea Orlandi
Data manager Massimo Maffei, Mariano Sgambati
Tecnico audio Michelangelo Lepore
Microfonista Antonio Iannone
Specialisti della produzione Marco Celiani, Fulvio Cellucci, Flavio Colamartini, Tommaso Garofalo, Gaetano Esposito
Supervisione tecnica al 4k Luca Del Gaudio, Ciro Punzo,
Domenico Villani
Hanno collaborato Francesco Ambrosino, Alessandro Barbero, Sergio Beneduce, Diego Bertolani, Mauro Felicori, Cinzia Leone, Roberto Rinaldi, Mario Tartaglione, Monica Tavella, Agostino Tenga,
Vincenzo Zuccaro
Ci hanno raccontato le loro emozioni Philippe Leroy, Gianna Nannini, Andrea Camilleri, Toni Servillo, Paolo Conte, Monica Bellucci, Sergio Fusetti, Andrea Bocelli, Sergio Castellitto, Uto Ughi, Riccardo Muti, Veronica Pivetti, Massimiliano Quagliarella, Gigliola Cinquetti, Gigi Proietti, Renzo Arbore, Dori Ghezzi, Paolo Fresu, Massimo Ranieri, Massimo Giovannelli, Cesare Bocci, Maria Sardaryan, Pippo Baudo, Ilvo Diamanti, Giuliano Sangiorgi
Hanno rivestito i panni di personaggi famosi gli attori Gianfranco Iannuzzo, Cesare Bocci, Giorgio Colangeli, Sergio Assisi, Christiane Filangieri, Violante Placido, Alessandro Tersigni, Andrea Giordana, Mary Petruolo, Roberto Farnesi, Ivano Marescotti, Massimo Wertmuller, Massimo Bonetti, Vittoria Belvedere, Sebastian Gimelli Morosini, Giusi Buscemi, Ludovico Girardello, Flavio Parenti
Ci ha accompagnato con la sua voce Francesco Pannofino
Un grazie particolare a Vincenza Lomonaco, già ambasciatrice d’Italia presso l’Unesco, ora presso le Nazioni Unite a Roma
Questo libro è dedicato alla memoria di Mauro Signore, uno dei “nostri”, prematuramente scomparso
Alberto Angela affacciato sul mare di Amalfi
Tharros, area archeologica, VIII secolo a.C.
Barumini, area archeologica Su Nuraxi, veduta della torre principale del nuraghe, XVI-XIV secolo a.C.
Barumini, area archeologica Su Nuraxi, XVI-XIV secolo a.C.
Dea Madre, IV millennio a.C., Cagliari, Museo Archeologico Nazionale
Alberto Angela davanti a un nuraghe, a Barumini
Guerriero, dal sito di monte Prama, prima metà del VIII secolo a.C, Cagliari, Museo Archeologico Nazionale
Barumini, veduta aerea del villaggio nuragico, XVI-XIV secolo a.C.
Bonorva, necropoli di Sant’Andrea Priu
Bonorva, necropoli di Sant’Andrea Priu, particolare di una domus de janas con il ritratto di una defunta, IV-V secolo a.C.
Valcamonica, incisione rupestre raffigurante una scena di vita quotidiana, I millennio a.C.
Grotte di Frasassi, stalattiti e stalagmiti dell’abisso Ancona
Grotte di Frasassi, l’abisso Ancona
Siracusa, isola di Ortigia, veduta aerea del castello Maniace, 1232-1239
Siracusa, grotta calcarea nota come Orecchio di Dionisio per l’insolita acustica
Siracusa, isola di Ortigia, la Fonte Aretusa.
Stromboli, il vulcano in eruzione
Etna ricoperto di neve
Tempio dei Dioscuri, V secolo a.C., Agrigento, Valle dei Templi
Cerveteri, necropoli etrusca, IX sec. a.C.
Cerveteri, veduta aerea della necropoli etrusca, IX sec. a.C.
Sarcofago degli sposi, VI secolo a.C., terracotta, Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
tomba dei Rilievi, IV secolo a.C., Cerveteri, necropoli della Banditaccia
Tarquinia, tomba dei Leopardi, 473 a.C.
Bronzo di Riace, Guerriero A (il Giovane), V a.C., Reggio Calabria, Museo Archeologico Nazionale
Ritrovamento dei Bronzi di Riace, 16 agosto 1972
Bronzo di Riace, Guerriero B (il Vecchio), V a.C., Reggio Calabria, Museo Archeologico Nazionale
Bronzi di Riace, Guerriero A (il Giovane), V secolo a.C. e Guerriero B (il Vecchio), V secolo a.C, Reggio Calabria, Museo Archeologico Nazionale
Tempio della Concordia, V secolo a.C., Agrigento, Valle dei Templi
Tempio dei Dioscuri (o di Castore e Polluce), V secolo a.C., Agrigento, Valle dei Templi
Efebo di Agrigento, 480 a.C circa, Agrigento, Museo Archeologico Regionale
Tempio di Giunone, V secolo a.C., Agrigento, Valle dei Templi
Un telamone del Tempio di Zeus, V secolo a.C. a.C., Agrigento, Valle dei Templi, copia dell’originale conservato al Museo Archeologico Nazionale
Lo scrittore Andrea Camilleri e il fotografo Robert Capa
Isole Eolie, l’isola di Vulcano vista da Lipari
Isole Eolie, veduta aerea del vulcano Stromboli
Isole Eolie, Lipari, sullo sfondo, il cratere dell’isola di Vulcano
Maschera della tragedia greca, da un corredo tombale, IV-III secolo a.C, Lipari, Museo Archeologico Regionale
Roma, veduta aerea dell’Anfiteatro Flavio o Colosseo, 72-80 d.C.
Rovine di Pompei
Statua femminile ritrovata da Alberto Angela durante un’immersione, Napoli, Parco Archeologico Sommerso di Baia
Flagellazione e danza di una Baccante, I secolo a.C. Pompei, Villa dei Misteri
La battaglia di Isso, dalla Casa del Fauno a Pompei, I secolo a.C. circa, particolre, Napoli, Museo Archeologico Nazionale
Uccello che mangia i fichi, I secolo a.C., Torre Annunziata, Villa Oplontis, o di Poppea
Tivoli, Villa Adriana, 117-138 d.C. circa le cariatidi del canopo egizio
Roma, Anfiteatro Flavio o Colosseo, 72-80 d.C.
L’imperatore Tito Flavio Vespasiano (39-81 d.C.), Città del Vaticano, Musei Vaticani
Roma, il Pantheon, II secolo d.C.
Giovani in bikini, IV secolo d.C., Piazza Armerina, Villa del Casale
Scena di caccia, IV secolo d.C., Piazza Armerina, Villa del Casale
Donna allo specchio, IV secolo d.C., Piazza Armerina, Villa del Casale
Paestum, veduta aerea del Tempio di Nettuno e del Tempio di Hera, detto anche Basilica
Tomba del tuffatore, 480-470 a.C., particolare, Paestum, Museo Archeologico Nazionale
Volta con il cielo stellato, prima metà del V secolo, Ravenna, Mausoleo di Galla Placidia
Aquileia, basilica patriarcale di Santa Maria Assunta
Borgo a Mozzano, ponte della Maddalena, detto ponte del Diavolo, XI secolo
Aquileia, basilica patriarcale di Santa Maria Assunta
L’imperatrice Teodora con le sue ancelle, 525-530 circa, Ravenna, basilica di San Vitale
Ravenna, Mausoleo di Galla Placidia, V secolo, particolare della volta
Ravenna, Mausoleo di Galla Placidia, prima metà del V secolo
Lunetta con Il Buon Pastore, V secolo, Ravenna, Mausoleo di Galla Placidia
Ravenna, Mausoleo di Teodorico, fine del V secolo
Cristo pantocratore, VI secolo, Ravenna, basilica di San Vitale, catino absidale
L’imperatore Giustiniano e il suo seguito, VI secolo, Ravenna, basilica di San Vitale
Pala di Pellegrino, 1195, argento dorato, Cividale del Friuli, cattedrale di Santa Maria Assunta
Tre sante, VIII secolo d.C., Cividale del Friuli, oratorio di Santa Maria in Valle
Cristo Pantocratore, XII secolo, Cefalù, duomo
Castel San Vincenzo, abbazia benedettina di San Vincenzo, VIII secolo
Cristo risorto tra San Lorenzo e Santo Stefano, IX secolo, particolare Castel San Vincenzo, abbazia benedettina di San Vincenzo, cripta di Epifanio
L’arcangelo Raffaele, Castel San Vincenzo, IX secolo, abbazia di San Vincenzo, cripta di Epifanio
Veduta aerea della certosa di Pavia, 1396-1507
Cerro al Volturno, veduta del borgo con il castello Pandone
Monreale, duomo, particolare delle colonne mosaicate del chiostro, fine XII secolo
Palermo, Palazzo dei Normanni, sala di re Ruggero, particolare della decorazione, XII-XIII secolo
Cristo pantocratore, XII secolo, Palermo, Palazzo dei Normanni, abside della cappella Palatina
Cefalù, duomo, XII secolo
Palermo, Palazzo dei Normanni, cappella Palatina, XII secolo
Assisi, veduta del centro storico
Cimabue, San Francesco, 1280-1290, particolare, Assisi, Museo della Porziuncola
Assisi, basilica di San Francesco, 1228
Giotto di Bondone, La rinuncia agli averi, fine del XIII secolo, Assisi, basilica superiore
Alberto Angela nella basilica superiore di San Francesco, ad Assisi
Assisi, basilica Superiore, veduta frontale della facciata, 1228-1253
Giotto di Bondone, Il presepe di greccio, fine del XIII secolo, particolare, Assisi, basilica superiore
Andria, veduta aerea di Castel del Monte, XIII secolo
Amalfi, cattedrale di Sant’Andrea, veduta dal loggiato superiore
Amalfi vista dal mare
Amalfi, la spiaggia al tramonto
Amalfi, veduta del centro storico
Amalfi, vedura aerea della cattedrale di Sant’Andrea
Siena, veduta aerea di piazza del Campo
Alle pagine 214-215: Siena, veduta aerea del centro storico
Guidoriccio da Fogliano all’assedio di Montemassi, 1330 circa, particolare, Siena, palazzo Pubblico
Val d’Orcia, veduta aerea
Pisa, veduta aerea di piazza dei Miracoli
Alberto Angela davanti alla torre di Pisa
Giovanni Pisano, pulpito, 1302-1310, Pisa, duomo di Santa Maria Assunta
Buonamico di Martino detto Buffalmacco (attribuito), Giudizio Universale, 1336-1341 circa, particolare dei dannati, Pisa, camposanto monumentale
Buonamico di Martino detto Buffalmacco (attribuito), Giudizio Universale, 1336-1341 circa, particolare dell’arcangelo Michele, Pisa, camposanto monumentale
San Gimignano, veduta della città medievale con le sue torri
Wiligelmo, Storie della Genesi, particolare con la Tentazione, Modena, cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo e San Geminiano
Modena, cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo e San Geminiano, veduta della Porta Regia dalla Piazza Grande, XI-XIV secolo
Andria, uno scorcio di cielo dal cortile di Castel del Monte
Andria, Castel del Monte, XIII secolo
Federico II di Svevia, De arte venandi cum avibus, 1260, ritratto di Federico II
Lecce, basilica di Santa Croce, 1549-1695, veduta della facciata barocca
Trionfo della Chiesa, 1391, Galatina, chiesa di santa Caterina d’Alessandria
Alberobello, una veduta dei Trulli
Michelangelo Buonarroti, David, 1501-1504, particolare del volto, Firenze, Galleria dell’Accademia
Leonardo da Vinci, Ritratto di dama o Belle ferronnière, 1495-1499 circa, Parigi, Musée du Louvre
Milano, Santa Maria delle Grazie, particolare del tamburo, 1463
Leonardo Da Vinci, Codice Atlantico, f. 70 recto, disegno di un’ala meccanica, 1478-1518, Milano, Veneranda Biblioteca Ambrosiana
Leonardo da Vinci, Ultima Cena, 1495-1497, Milano, refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie
Leonardo da Vinci, Ultima Cena, 1495-1497, particolare con Matteo, Giuda Taddeo e Simone Zelota, Milano, refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie
Giulio Romano, Zeus fulmina i giganti, 1532-1535, particolare, Mantova, Palazzo Te
Mantova, Palazzo Te, la loggia d’onore vista dal ponte sulla peschiera
Mantova, castello di San Giorgio, 1395-1406
Andrea Mantegna, Camera picta (o Camera degli Sposi), particolare della volta, 1465-1474, Mantova, castello di Sangiorgio
Veduta notturna del duomo di Urbino, 1789-1801 (su edifici precedenti)
Alberto Angela a Urbino, sullo sfondo Palazzo Ducale
Urbino, Palazzo Ducale
Alberto Angela nello studiolo di Federico da Montefeltro, Urbino, Palazzo Ducale
Raffaello Sanzio, Ritratto di Maddalena Strozzi Doni o La muta, 1507, Urbino, Galleria Nazionale delle Marche,
Raffaello Sanzio, Madonna con bambino, 1498 circa, Urbino, casa di Raffaello
Ferrara, Palazzo dei Diamanti, 1493-1503, veduta dell’arco di entrata
Ferrara, il castello Estense (o castello di San Michele) visto dal fossato
Ferrara. Francesco del Cossa, Trionfo di Venere, 1468-1470, particolare con il mese di aprile, Ferrara, Palazzo Schifanoia
Tivoli, Villa d’Este, fontana di Nettuno
Firenze, veduta di Ponte Vecchio
Firenze, cattedrale di Santa Maria del Fiore, la cupola del Brunelleschi
Michelangelo Buonarroti, David, 1501-1504, Firenze, Galleria dell’Accademia
Donatello, David, 1440 circa, Firenze, Museo Nazionale del Bargello1501-1504, Firenze, Galleria dell’Accademia
Pienza, cattedrale di Santa Maria Assunta, 1459-1462.
Cinque terre, veduta di Monterosso
Genova, uno scorcio dei caruggi
Genova, la Lanterna, 1538
Genova, Palazzo Rosso, detto anche Palazzo Brignole, 1671-1677
Genova, Palazzo Doria Tursi, particolare del loggiato superiore, 1565
Cinque terre, scorcio di Vernazza con i caratteristici terrazzamenti sullo sfondo
Vicenza, Teatro Olimpico
Vicenza, veduta notturna della basilica palladiana
Andrea Palladio, Villa Almerico Capra, detta “La Rotonda”, 1567-1605, Vicenza
Alberto Angela a Villa Almerico Capra
Padova, Orto botanico
Giovanni Antonio Fasolo e collaboratori, Scene di vita in villa, 1570, Vicenza, Villa Caldogno
Verona, la casa di Giulietta con il celebre balcone
Verona, veduta aerea dell’Arena
Verona, veduta aerea
Lago Maggiore, isola Bella
Orta San Giulio, Sacro Monte, cappella della canonizzazione di San Francesco
Michelangelo Buonarroti, tomba di Giulio II, particolare del Mosè, 1505-1532, Roma, basilica di San Pietro in Vincoli
Michelangelo Buonarroti, Giudizio Universale, 1536-1541, particolare, Città del Vaticano, Cappella Sistina
Roma, Palazzo Farnese, 1516-1546
Gian Lorenzo Bernini, baldacchino, 1624-1633, Città del Vaticano, basilica di San Pietro
Roma, piazza Navona. Alle spalle di Alberto Angela, la chiesa di Sant’Agnese, la fontana del Moro e l’obelisco
Roma, particolare del colonnato di Gian Lorenzo Bernini
Parma, cattedrale dell’Assunta e il battistero
Antonio Allegri detto il Correggio, Assunzione della Vergine, 1526-1530, Parma, duomo
Parma, Teatro Farnese, 1617-1618, la cavea in legno di abete rosso del Friuli
Noto, cattedrale di San Nicolò, inizio del XVIII secolo
Noto, Palazzo Nicolaci, soffitto del salone, 1720-1765
Noto, Palazzo Nicolaci, 1720-1765, sala del Tè
Paolo Persico, Angelo Brunelli, Tommaso e Pietro Solari, fontana di Diana e Atteone, 1773, reggia di Caserta
Veduta aerea di Palmanova, con la sua particolare struttura urbanistica
Bergamo, Porta di San Giacomo, 1592
Bottega di Canaletto, Il Canal Grande con il ponte di Rialto e il Fondaco dei Tedeschi, 1707-1750, Amsterdam, Rijksmuseum
Venezia, veduta aerea di piazza San Marco
Napoli, piazza del Plebiscito con la basilica di san Francesco di Paola
Napoli, Teatro San Carlo, 1737, veduta del palcoscenico dal palco reale
Giuseppe Sanmartino, Cristo velato, 1753, Napoli, cappella Sansevero
Caserta, veduta aerea della reggia, 1752-1845
Alberto Angela davanti alla fontana di Diana e Atteone, alla reggia di Caserta
Reggia di Caserta, 1752-1845, veduta dai giardini
La camera da letto di re Francesco II, 1815-1840, reggia di Caserta
Bacoli, lago di Fusaro, Casina del Vanvitelli, 1782
Le vette innevate del Monte Bianco
Parma, Teatro Regio, 1829, veduta della platea
Parma, piazza Duomo e cattedrale di Santa Maria Assunta, 1074-1178
Parma, Teatro Regio, 1829, il palco regio
Le colline delle Langhe
Veduta aerea del castello di Grinzane
Uno scorcio delle Langhe
Le cime del Monte Bianco tra le nuvole
Ernesto Mancastropa, La regina Margherita di Savoia inaugura il rifugio a lei intitolato sul Monte Rosa, “L’Illustrazione Italiana”, anno XX, n. 37, settembre 1893
Una cresta nevosa sul Monte Bianco
Le cime delle Dolomiti
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
L’Aquila, basilica di Santa Maria di Collemaggio, veduta della facciata, 1287
L’Aquila, basilica di San Bernardino, veduta della facciata, 1454-1472
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
Norcia, la basilica di San Benedetto prima del terremoto del 2016
Vedute di Matera
Alberto Angela a Matera
Ivrea, il primo stabilimento Olivetti negli anni Sessanta
Luca Della Robbia, Madonna con Bambino (Madonna dell’uccellino), fine del XV secolo, già Scansano, chiesa di San Giovanni Battista. L’opera è stata recentemente recuperata dopo il furto del 1971
Intervento dei Caschi Blu della Cultura dopo un terremoto
Referenze fotografiche
© Alamy/Adam Eastland Art + Architecture
© Alamy/Adam Eastland
© Alamy/Age Fotostock
© Alamy/Art Collection 2
© Alamy/DeAgostini Picture Library/Universal Images Group North America LLC
© Alamy/Giuseppe Masci
© Alamy/Granger Historical Picture Archive
© Alamy/Ivan Vdovin
© Alamy/Julian Money-Kyrle
© Alamy/Mauritius images GmbH
© Alamy/Norman Barrett
© Alamy/Paolo Gallo
© Alamy/Realy Easy Star/Giuseppe Masci
© Alamy/Rosmi Duaso
© Alamy/Sergey Dzyuba
© Alamy/Svetlana Day
© Alamy/The History Collection
© Alamy/Thierry GRUN - Aero
© Alamy/Vincent O’Byrne
© Alberto Angela
© Alinari/ANSA/Ernesto Franco Bivongi
© Alinari/Sante Castigliani
© Alinari/DeAgostini Picture Library/G. Nimatallah
© Alinari/DeAgostini Picture Library/M. Carrieri
© Alinari/Fine Art Images
© Alinari/Ministero per i Beni e le Attività Culturali
© Alinari/Ministero per i Beni e le Attività Culturali/Mauro Magliani
© Alinari/Ministero per i Beni e le Attività Culturali/Raffaello Bencini
© Alinari/Raffaello Bencini
© Barbara Ledda
© Bridgeman Images/DeAgostini Picture Library
© Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale
Flickr/Egisto Sani
© Getty Images/DeAgostini Picture Library
© Mondadori Portfolio
© Mondadori Portfolio/Akg
© Mondadori Portfolio/Archivio Arnaldo Vescovo/Arnaldo Vescovo
© Mondadori Portfolio/Archivio Lensini/Fabio e Andrea Lensini
© Mondadori Portfolio/Electa/Antonio Quattrone
© Mondadori Portfolio/Enzo Brai/Pubblifoto
© Mondadori Portfolio/Veneranda Biblioteca Ambrosiana
Pixabay/Edolilli
Pixabay/Erika Rigoni
Pixabay/Evondue
Pixabay/Rosario Esposito
Pixabay/Turkish414
© Rai – Radiotelevisione Italiana Spa
© Rijksmuseum/J.W.E. vom Rath Bequest
© Scala/DeAgostini Picture Library
© Shutterstock/Adisa
© Shutterstock/Aleksandra Suslova
© Shutterstock/Alexandr Medvedkov
© Shutterstock/Alvaro German Vilela
© Shutterstock/Andrea Izzotti
© Shutterstock/Andreyspb21
© Shutterstock/Borisb17
© Shutterstock/Canadastock
© Shutterstock/Catarina Belova
© Shutterstock/Cge2010
© Shutterstock/ChiccoDodiFC
© Shutterstock/Christianthiel.net
© Shutterstock/Damann
© Shutterstock/Davesayit
© Shutterstock/Diego Bonacina
© Shutterstock/Diego Mariottini
© Shutterstock/Dima Moroz
© Shutterstock/eFesenko
© Shutterstock/EguchiI Naohiro
© Shutterstock/Enrico Aliberti ItalyPhoto
© Shutterstock/Enrico Pescantini
© Shutterstock/Ermess
© Shutterstock/Francesco Bonino
© Shutterstock/Gabriele Maltinti
© Shutterstock/Geert Smet
© Shutterstock/Gilmanshin
© Shutterstock/GoneWithTheWind
© Shutterstock/Hetizia
© Shutterstock/Horseman82
© Shutterstock/Ilolab
© Shutterstock/Inna Luzan
© Shutterstock/Istvan Csak
© Shutterstock/Iva Vagnerova
© Shutterstock/Jackbolla
© Shutterstock/Krisztian Juhasz
© Shutterstock/Leoks
© Shutterstock/Logaen
© Shutterstock/Luca Rei
© Shutterstock/Luciano Mortula - LGM
© Shutterstock/Luigi Nifosi
© Shutterstock/Marco Rubino
© Shutterstock/Mazerath
© Shutterstock/Michele Alfieri
© Shutterstock/Milosk50
© Shutterstock/Nando Machado
© Shutterstock/Natalia Macheda
© Shutterstock/Oleg Samoylov
© Shutterstock/Oleg Voronische
© Shutterstock/Olena Z
© Shutterstock/Olgysha
© Shutterstock/Pecold
© Shutterstock/Piero Beggiato
© Shutterstock/Pio3
© Shutterstock/Rainer Albiez
© Shutterstock/Roberto la Rosa
© Shutterstock/Roman Sigaev
© Shutterstock/Rsphotograph
© Shutterstock/S-F
© Shutterstock/Saiko3p
© Shutterstock/Sasha Samardzija
© Shutterstock/Sergey Berestetsky
© Shutterstock/Sergio Monti Photography
© Shutterstock/Shoriful Chowdhury
© Shutterstock/Spatuletail
© Shutterstock/Starryvoyage
© Shutterstock/Stefano_Valeri
© Shutterstock/Tara Van Der Linden Photo
© Shutterstock/Trabantos
© Shutterstock/Valerio Mei
© Shutterstock/Visual Intermezzo
© Shutterstock/Vvoe
© Shutterstock/Yury Dmitrienko
© Shutterstock/Zvonimir Atletic
Unsplash/Benjamin Jopen
Unsplash/Giuseppe Mondi
Unsplash/Ilya Orehov
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons/Gianni Careddu su licenza CC BY-SA 4.0