TEMI E PROFILI Gender studies
Nascere femmina o maschio è un dato capace di determinare in modo indelebile la nostra esperienza del mondo, a iniziare da come veniamo cresciuti ed educati in quanto future donne o uomini attraverso un processo di attribuzione di genere a partire dal quale, ognuno di noi, negozia quotidianamente il senso della propria soggettività. Il campo di studi interdisciplinare etichettato come gender studies (“studi di genere”) si occupa proprio dei numerosi aspetti e dimensioni che definiscono il processo complesso di costruzione e di attribuzione di genere, aggiungendo alle classiche accezioni del termine genere – tipo, classe, categoria superiore alla specie, categoria formale del femminile, del maschile e del neutro – quella di riferirsi alla sfera dei significati iscritti nelle rappresentazioni, nei comportamenti, negli atteggiamenti, nelle pratiche sociali e culturali legate all’appartenenza a un sesso, inteso invece come dato genetico e biologico. Benché il termine genere abbia acquisito questo significato nel mondo accademico anglosassone a metà degli anni Settanta (e da qui l’uso anche in italiano dell’inglese gender per distinguerlo da una ulteriore accezione di “genere” (in inglese genre) come raggruppamento di opere letterarie, artistiche, musicali operato in base a caratteri comuni), è lo psicoanalista americano Robert Stoller (Sesso e genere,1968) a porre esplicitamente una distinzione tra sesso e genere, quest’ultimo definito come l’insieme complesso di “comportamenti, sensazioni, pensieri e fantasie che sono legate ai sessi e tuttavia non hanno connotazioni biologiche primarie”. È la prima volta che si separa il sesso come dato biologico dal genere come insieme di dati culturali e sociali, distinzione subito adottata dalla critica femminista ed elevata a fondamento teorico di ricerche poi confluite nei gender studies, in quegli anni volte innanzitutto a riscattare la donna da una posizione di inferiorità e, soprattutto, a dimostrare come tale posizione non sia naturale, bensì il prodotto di società e culture patriarcali, espressione con cui ci si riferisce alle strutture istituzionali dell’oppressione femminile. Queste strutture hanno prodotto e ancora producono discorsi e pratiche in cui la differenza di genere è servita a codificare significati che sono in realtà privi di relazione con il corpo e la natura del femminile, conducendo a divisioni asimmetriche delle capacità e dei tratti umani: gli uomini sono più forti, più razionali, più coraggiosi ecc. delle donne che sono invece emotive, sentimentali, dedite alla cura. È in questo senso che, ricorda la storica statunitense Joan Scott (Il genere: un’utile categoria di analisi storica, 1986), il genere va pensato come una categoria sociale imposta a un corpo sessuato costituendo “un fattore primario del manifestarsi delle relazioni di potere”. Se, come affermato da Simone de Beauvoir nell’ormai classico Il secondo sesso (1949), donna non si nasce ma si diventa, tale divenire è frutto dell’adesione, più o meno passiva o consapevole, a modelli culturali di genere, a costruzioni sociali e ideologiche che costituiscono l’interpretazione storica e culturale del dato biologico.
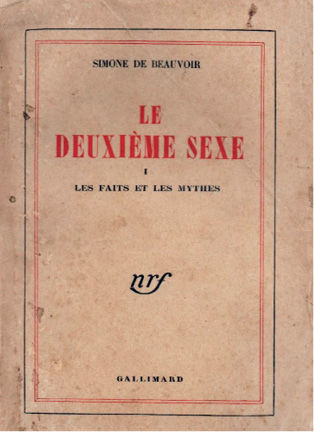
Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe. Prima edizione, 1949
Con l’uso di “genere” al posto di “sesso” si è cercato inoltre di sottolineare l’aspetto relazionale della soggettività e dell’identità. Il senso del femminile è comprensibile solo in relazione al senso del maschile, ed è riconducibile all’organizzazione sociale dei sistemi di produzione (a lavorare sono gli uomini), di riproduzione (a fare figli e a occuparsene sono le donne), e anche di rappresentazione delle identità sessuate (i cosiddetti stereotipi di genere legati spesso al corpo delle donne, utilizzato come oggetto di consumo e di sguardo voyeuristico), che permettono non solo di regolare, ma anche di comprendere le relazioni tra uomini e donne. Nell’interrogare la naturalità delle relazioni e dei ruoli di genere, i gender studies hanno così contestato le nozioni filosofiche classiche di ragione, di conoscenza e di soggetto, per rivelare i meccanismi di oppressione e di falsa universalizzazione che si celano dietro la facciata apparentemente generale e neutrale di questi concetti. Tali assunti trascendentali e universali in realtà riflettono e reificano l’esperienza di poche persone, essenzialmente maschi, bianchi e occidentali. Nell’ambito di un ulteriore campo nato grazie agli studi di genere, i cosiddetti Men’s Studies, si interroga la visione tradizionalista dell’essere uomo, con particolare attenzione alla divisione del lavoro produttivo insieme ai ruoli e alle competenze che esso implica.
Gender studies e soggettività
Le riflessioni sul genere femminile e maschile hanno dato vita ad atteggiamenti critici che, da punti di vista diversi e non sintetizzabili, negli ultimi quarant’anni hanno diversamente riflettuto sullo statuto dell’idea stessa di soggettività. Il femminismo culturale e radicale degli anni Settanta inizialmente considera il genere, e dunque il soggetto che da esso è definito, una differenza sostanziale o, meglio, “essenziale”: esiste cioè una “vera natura” femminile da sempre negata, ma in qualche modo delimitabile e, soprattutto, rivendicabile. Successivamente, studi di genere più orientati verso un “costruzionismo sociale” sviluppatisi a partire dagli anni Ottanta, de-essenzializzano il genere – non c’è alcuna vera natura da riscoprire, e non esiste qualcosa come la donna in quanto soggetto delimitabile e omogeneo – per concentrarsi sulle costruzioni e sulle rappresentazioni delle differenze di genere. Gli anni Ottanta hanno segnato la definizione di una teoria alternativa del soggetto che ha permesso di pensare in termini di pluralità e diversità, e non di unità e universalità. È lo stesso periodo in cui la riflessione femminista si allarga alle donne di colore e a esponenti della critica postcoloniale (cioé quella critica sviluppatasi dopo i movimenti di liberazione delle colonie dal giogo dei grandi imperi) che rivendicano la specificità della loro storia e dunque della loro differenza: il colonialismo dell’età moderna va pensato come un fenomeno costitutivo di quella modernità capitalistica occidentale da cui è sorto il nostro presente. Lo aveva affermato già Jean-Paul Sartre (1964): il colonialismo si è contraddistinto come un “sistema” (economico, politico e culturale) globale di dominio e di sfruttamento dei popoli non-europei che ha segnato in modo indelebile tanto la storia (e la coscienza) dei colonizzatori quanto quella dei colonizzati. La messa in questione della naturalità dei rapporti di genere si intreccia qui con la denuncia della persistenza di un “immaginario colonialista”, di un “inconscio coloniale” proprio della cultura occidentale contemporanea, entro cui il colonialismo ha generato formazioni discorsive, capace di costituire, di scrivere, narrare e plasmare soggettività socioculturali definite come altre, aliene, diverse, soprattutto come inferiori.
Insieme agli studi di genere, queste posizioni ci chiedono di considerare le categorie che utilizziamo per definire la nostra e l’altrui identità come concetti che non sono in realtà dati, trasparenti, obiettivi e neutrali, dal momento che la loro ragion d’essere obbedisce comunque a una volontà di assoggettamento dell’altro (del subalterno) colonizzato, della donna ma anche dell’uomo di colore, dello straniero. Tra le studiose più conosciute di gender studies e postcolonial, Gayatri Spivak (1942) sintetizza in modo chiaro questo processo quando sostiene che l’identità moderna occidentale si è strutturata a partire da forme insidiose di “violenza epistemica”, su una “logica cognitiva” eurocentrica, etnocentrica e patriarcale che nel suo incontro/scontro con l’altro ha sistematicamente distorto e negato le identità, le soggettività e le culture differenti.
Dall’identità alle differenze
Grazie dunque ai gender studies e alla critica postcoloniale l’idea di differenze fisse e immutabili di genere, razza o etnia concepite come divisioni che separano e differentemente valorizzano i soggetti umani viene storicizzata e sostituita dall’idea dell’esistenza di più differenze. L’utilizzo del plurale serve a indicare come i fattori che contribuiscono alla formazione e alla trasformazione della soggettività di ciascuno sono molteplici e, soprattutto, che il valore che vi associamo è sempre un dato che dipende dai contesti e dalle relazioni di potere. I termini di gender studies e postcolonial oggi indicano perciò campi di ricerche interdisciplinari che spaziano dalla linguistica alla biologia, dall’antropologia alla storiografia contemporanea, dalle relazioni internazionali alla critica letteraria. Campi in cui oggi, peraltro, si ridiscute la stessa contrapposizione tra sesso e genere a opera della critica cosiddetta queer (o post-gender) in cui si riconoscono principalmente (ma non esclusivamente) donne lesbiche e, più recentemente, individui che rivendicano un’identità transgender o transessuale. Il termine queer (“strano”, “deviato”, e di conseguenza anche “inquietante”) è stato riappropriato dalla teoria per riferirsi a un pensiero che va oltre la divisione tra sesso e genere: queer oggi è un “termine ombrello” che comprende sia la rivendicazione di pratiche sessuali culturalmente e socialmente etichettate come marginali, sia le elaborazioni concettuali che negli anni Ottanta si erano formate in seno ai più tradizionali gay and lesbian studies. Queer indica il rifiuto pratico e teorico di allinearsi e confluire in qualsiasi categoria dell’identità, la volontà di decostruire ogni posizione che affermi una divisione netta tra sesso come dato biologico, genere e desiderio sessuale finendo per comprendere entro la propria cornice analitica non solo gli studi sulle identità lesbiche o gay, postcoloniali e di genere, ma anche le ricerche su tutte quelle forme di soggettività che drammatizzano le incoerenze, le contraddizioni e le sovrapposizioni tra desideri, sesso e genere, razza e colore.