19. Diritti e democrazia

L’arrivo della nave Vlora nel porto di Bari. Il primo grande, drammatico, approdo di migranti dall’Albania sulle coste italiane, 8 agosto 1991
19.1 La questione dei diritti
“L’età dei diritti”, come l’ha definita Norberto Bobbio, trova nel Novecento una stagione particolarmente intensa, nel corso della quale sono proprio i diritti fondamentali a dare il tono ai mutamenti costituzionali. Ma il Novecento stesso è pure il tempo della loro terribile convivenza con la radicale negazione non solo d’ogni diritto, ma della stessa umanità delle persone, che ha segnato il “secolo breve” – secondo la celebre e discussa definizione di Eric Hobsbawm – e le dittature che l’hanno accompagnato. La reazione è stata affidata alle parole che, non a caso, aprono nel 1949 la costituzione tedesca, “la dignità umana è inviolabile”, le stesse che ritroviamo all’inizio della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. E questa linea di pieno recupero dell’umanità di ciascuno trova la sua manifestazione più incisiva nella frase che conclude l’articolo 32 della Costituzione italiana del 1948: “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Tra Ottocento e Novecento
Se si vuole sinteticamente indicare un tratto distintivo tra la dimensione dei diritti tipica dell’Ottocento e quella del Novecento, si può muovere dalla constatazione del fatto che al soggetto storico protagonista delle rivoluzioni dei diritti della fine del Settecento, la borghesia, si affianca la classe operaia, la cui cultura e azione pratica innovano profondamente la cultura dei diritti. Ai tradizionali diritti civili e politici si affiancano i diritti sociali, con la grande invenzione novecentesca dello Stato sociale, i “Trenta Gloriosi”, come sono stati definiti gli anni della massima espansione del modello sociale europeo. Si può notare, a questo punto, un divaricarsi della vicenda dei diritti tra l’Europa continentale e gli Stati Uniti rispetto a quel che era avvenuto al tempo delle dichiarazioni dei diritti tra il 1776 e 1789. Mentre in Europa si apriva la strada a una visione dei diritti che, soprattutto nei rapporti economici, incorporava anche una funzione sociale, la diversa vicenda storica degli Stati Uniti, dove il peso della classe operaia non è stato certo paragonabile a quello europeo, ha fatto sì che l’idea individualistica dei diritti rimanesse l’unica, o comunque quella prevalente. Con due conseguenze. Considerati prevalentemente come strumenti da usare nel proprio esclusivo interesse, senza considerare esplicitamente quello altrui o quello collettivo, i diritti vengono sempre più adoperati in modo aggressivo, determinando una loro “insularità”. Ciascuno si separa dagli altri, si ritira nella propria isola, impugna i diritti quasi come una clava. E questo spinge più d’uno ad affermare che non nei diritti, ma nella comunità, risiede l’unica salvezza per le persone. Inoltre, le crescenti pressioni del mercato hanno spinto verso una considerazione dei diritti come puri titoli da scambiare, indebolendo il profilo della loro inviolabilità. Il modello europeo ha proposto un’idea più ricca dei diritti sia nella dimensione individuale che in quella sociale, pur tenendo conto delle ovvie necessità del suo adeguamento al mutare dei tempi.
Dal diritto ai diritti
Al di là di questa specifica vicenda, la storia dei diritti è stata ovunque segnata dalle pacifiche rivoluzioni dell’ultima fase del Novecento – delle donne, degli ecologisti, della scienza e della tecnica. La libertà concreta s’incarna nella differenza sessuale, nell’attenzione per il corpo, nel rispetto per la biosfera, nell’uso non aggressivo delle innovazioni scientifiche e tecnologiche.
Da qui ha origine non una semplice rivendicazione di nuovi diritti, ma il problema della trascrizione nell’ordine giuridico di una realtà che preme così fortemente su di esso da non poter essere ignorata. Compaiono così i diritti riproduttivi e quelli genetici; i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender (Lgbt); i “communication rights”; il diritto alla protezione dei dati personali, proiettato al di là della dimensione tradizionale della privacy e che investe l’insieme delle relazioni personali e sociali, ridefinendo i rapporti tra sfera privata e sfera pubblica; il diritto all’esistenza, quasi una sintesi dei problemi e delle difficoltà del vivere, che obbliga a mettere al centro dell’attenzione il diritto al lavoro, nella versione ricca che ci viene dall’articolo 36 della Costituzione italiana, dove la retribuzione non è la contropartita per la cessione di una merce, ma la condizione per una “esistenza libera e dignitosa”. A questo articolarsi dei diritti corrisponde l’ampliarsi della lista delle inammissibili cause di discriminazione, ben visibile soprattutto nell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e che contribuisce a testimoniare un’attitudine del diritto a seguire la persona sempre più da vicino, a considerarla nella sua integralità, a farne emergere sempre più nettamente l’unicità. Il patrimonio dei diritti e l’illegittimità delle discriminazioni rendono inammissibile la pretesa di conformarsi a modelli di normalità.
Sulla scena del mondo è così comparsa una nuova rappresentazione dei diritti, nella quale la vita vera fa sentire le sue ragioni e il corpo irrompe con tutta la sua fisicità, facendo apparire sbiadita una dimensione dei diritti riferita unicamente a un soggetto astratto, ad un individuo disincarnato. Ma queste due diverse visioni possono comporsi se si guarda alla persona nella sua realtà e integralità, come fa la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (18 dicembre 2000), che nel Preambolo afferma appunto che l’Unione “pone la persona al centro della sua azione”.
19.2 Corpo fisico e corpo elettronico
Nel quadro dei diritti fondamentali vengono attratti i temi imposti dalla riflessione bioetica e dalle tecnologie elettroniche. Si tutela il corpo “fisico” affermando che tutti hanno diritto al rispetto dell’integrità fisica e psichica, vietando così l’eugenetica di massa, la clonazione riproduttiva, gli usi mercantili del corpo. Si tutela il corpo “elettronico” considerando la protezione dei dati come un autonomo diritto fondamentale, al di là della tradizionale idea di privacy. Ma anche categorie storiche vengono rinnovate. Al diritto di costituire in forme diverse la famiglia si affianca, con pari dignità, il riconoscimento del matrimonio eterosessuale. Accanto ai tradizionali divieti di discriminazione, per il sesso o la razza o la religione o le opinioni politiche, compaiono quelli riferiti all’handicap e alle tendenze sessuali. L’astrattezza del riferimento all’individuo come titolare di diritti si scioglie nella concretezza dell’affermazione dei diritti del bambino, degli anziani, dei disabili, e della rilevanza assunta dalla figura del lavoratore.
Siamo in presenza di un processo che può essere chiamato di “costituzionalizzazione della persona” e che ha via via fatto emergere una persona “inviolabile”, da rispettare in ogni momento e in qualsiasi luogo. I diritti penetrano anche nelle istituzioni “totali”, – il manicomio, il carcere – e non solo restituiscono almeno un brandello di dignità a chi è costretto a vivere in quei luoghi, ma riescono addirittura a metterne in discussione l’esistenza. I diritti dei folli scardinano la logica della separazione che giustificava i manicomi, e la predicazione e l’azione di un tenace visionario, lo psichiatra Franco Basaglia, sono all’origine di una legge (la 180 del 1978) che ne decreta l’abolizione.
I diritti, prima distribuiti tra le “generazioni” che ne scandivano l’origine storica, si riunificano così intorno alla persona e si presentano come indivisibili: non si possono riconoscere i diritti civili o politici e negare quelli sociali o quelli di quarta e quinta generazione, legati soprattutto all’ambiente e alla tecnologia, alla nuova coscienza ambientale e agli effetti delle innovazioni scientifiche e tecnologiche. Questo parlar di “generazioni”, con una terminologia identica a quella in uso nel mondo dei computer, non deve indurre a ritenere che ogni nuova generazione di strumenti condanni all’obsolescenza e all’abbandono definitivo tutte le precedenti, con una evidente forzatura che nasce dalla volontà di far diventare una scansione cronologica, peraltro controversa, in una gerarchia che attribuisce ad alcune di queste generazioni uno statuto teorico più debole, come si sta cercando di fare con i diritti sociali. Un filo tenace li lega tutti, tessuto dai principi che scandiscono, ad esempio, le partizioni della Carta dei diritti fondamentali - dignità, libertà, eguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia. Sono i principi che definiscono la posizione di ciascuno, ma pure le modalità del processo democratico. Neppure questo può essere indifferente alla concreta situazione delle persone. Il riconoscimento per tutti del diritto di voto libero ed eguale non può fare astrazione dalle condizioni materiali in cui viene esercitato. Istruzione, lavoro, abitazione diventano così precondizioni della partecipazione effettiva dei cittadini, dunque della stessa qualità della democrazia.
LETTURE
I diritti dei migranti
LETTURE
L'idea dello straniero in Italia
Diritti collettivi e nuovi soggetti
Ma accanto ai diritti dei singoli compaiono con forza crescente grandi diritti collettivi e, con essi, nuovi soggetti ai quali far riferimento. Qui il catalogo si arricchisce con inediti tratti di novità. Incontriamo i diritti dei popoli all’autodeterminazione, alla loro lingua, alla libera gestione delle loro risorse; il diritto alla tutela dell’ambiente, che richiama la necessità di uno sviluppo sostenibile; il diritto al cibo, che diventa diritto alla vita per intere popolazioni prigioniere del dramma della fame; il diritto alla conoscenza, che mette radicalmente in discussione la logica proprietaria, il copyright e il brevetto, si tratti di assicurare le medicine agli africani malati di Aids o scaricare liberamente musica da internet; il diritto del territorio, sia in termini naturali e ambientali sia come patrimonio storico-culturale, di essere rispettato e il nostro dovere di farlo; i diritti degli animali. Compare il diritto di ingerenza umanitaria, suscitando il timore che si tratti di un nuovo travestimento del diritto del più forte. Su tutti si staglia, difficilissimo ma ineludibile, il diritto alla pace.
Un quadro così ricco e impegnativo non è certo privo di ombre, che si sono accentuate mentre il Novecento si avviava verso la sua conclusione. In uno spazio divenuto globale, i diritti si dilatano e scompaiono, si moltiplicano e si impoveriscono, offrono opportunità collettive e si rinserrano nell’ambito individuale, redistribuiscono poteri e subiscono soggezioni, soprattutto agli imperativi della sicurezza e alla subordinazione di politica e diritti alla logica economica e finanziaria, cioè alla prepotenza del mercato. Il mondo nuovo dei diritti non è un mondo pacificato, ma ininterrottamente percorso da conflitti e contraddizioni, da negazioni spesso assai più forti dei riconoscimenti. Un mondo troppe volte e troppo spesso doloroso, segnato da sopraffazioni e abbandoni. E così “i diritti parlano”, sono lo specchio e la misura dell’ingiustizia, e uno strumento per combatterla. Registrarne minutamente le violazioni non autorizza conclusioni liquidatorie. Solo perché sappiamo che vi è un diritto violato possiamo denunciarne la violazione, svelare l’ipocrisia di chi lo proclama sulla carta e lo nega nei fatti, far coincidere la negazione con l’oppressione, agire perché alle parole corrispondano le realizzazioni. Lo storico appello alla “lotta per il diritto” si declina, oggi, come lotta per “i diritti”. Una lotta che non è più condotta dai soli attori storici, né soltanto nelle aree del mondo dove è nata la moderna età dei diritti.
Sintetizzando i caratteri del passaggio di millennio, si può dire che un innegabile bisogno di diritti, e di diritto, si manifesta ovunque, sfida ogni forma di repressione, innerva la stessa politica. E così, con l’azione quotidiana, soggetti diversi mettono in scena una ininterrotta dichiarazione di diritti, che trae la sua forza non da una qualche formalizzazione o da un riconoscimento dall’alto, ma dalla convinzione profonda di donne e uomini che solo così possono trovare riconoscimento e rispetto per la loro dignità e per la stessa loro umanità. Siamo di fronte a una inedita connessione tra l’astrazione dei diritti e la concretezza dei bisogni, che mette all’opera soggetti reali. Certo non i “soggetti storici” della grande trasformazione moderna, la borghesia e la classe operaia, ma una pluralità di soggetti ormai tra loro connessi da reti planetarie. Non un “general intellect”, né una indeterminata moltitudine, ma una operosa molteplicità di donne e uomini che trovano, e soprattutto creano, occasioni politiche per non cedere alla passività e alla subordinazione.
Filosofie dei diritti
Le scelte terminologiche relative alla definizione dei diritti hanno dato luogo a una molteplicità di letture. Si parla di diritti umani e di diritti fondamentali talvolta in modo sinonimico. Altre volte si distingue tra i diritti umani intesi come diritti morali e i diritti fondamentali, volendo indicare con questa seconda espressione i diritti umani riconosciuti sul piano istituzionale, quindi in quanto diritti propriamente giuridici. Così John Rawls definisce i diritti umani “diritti morali”, validi a prescindere dalla loro ratifica costituzionale e dotati di particolare urgenza (si pensi al diritto alla libertà dalla schiavitù e dalla sofferenza delle torture o alla libertà di coscienza e dalle aggressioni). Ma ancora diritti umani e diritti fondamentali sono distinti tra loro con nettezza, nel momento in cui si intende considerare questi ultimi come una categoria più ampia rispetto ai primi, perché libera da vincoli relativi al loro contenuto, cioè perché essenzialmente formale. Connesso a queste distinzioni è pure il nodo controverso del carattere assoluto oppure relativo dei diritti. Vi sono autori che nella relativizzazione dei diritti, nella disponibilità a restringerne la portata universale e l’esigibilità, con la motivazione magari di riuscire così meglio a garantirli, scorgono inclinazioni all’indifferenza e al particolarismo. Ad aggiungersi a questo quadro, già assai complesso, è infine l’eterogeneità dei diritti dell’uomo, in particolare dei diritti civili e politici rispetto ai diritti sociali.
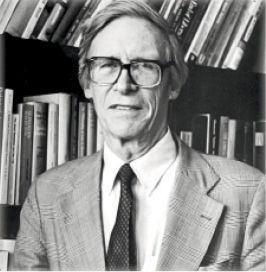
John Rawls
Le teorie dei diritti umani
Vi sono tre tipi di teorie dei diritti umani: le teorie formalistiche, le teorie sostanzialistiche e le teorie procedurali.
Le teorie formalistiche vedono nei diritti umani una categoria particolare di diritti fondamentali, comprendente i diritti soggettivi estesi universalmente a tutti gli esseri umani, indipendentemente dall’interesse o dal bene garantito e dal fatto che essi siano stabiliti o previsti dall’ordinamento giuridico. Loro caratteristiche sono l’inalienabilità e l’indisponibilità anche per il soggetto che ne è titolare oltre che per gli altri da lui, cioè persone e istituzioni.
Le teorie sostanzialistiche dei diritti umani concentrano l’attenzione, al contrario, sul momento della fondazione di questi stessi diritti, avanzando una risposta all’interrogativo concernente la loro giustificazione. Alla base è l’idea che i diritti umani siano gli strumenti giuridici adeguati alla promozione dei beni fondamentali per l’uomo che vive in una comunità politica. Accanto alla versione fondata sull’autoevidenza razionale del bene umano da tutelare anche attraverso i diritti, vi è che chi sostiene (ad esempio Alan Gewirth) una fondazione di carattere logico-deduttivo che muove dalle caratteristiche inerenti a ogni soggetto umano che agisce. In tale prospettiva i diritti si giustificano logicamente in base a un principio di coerenza, poiché vi è un requisito morale essenziale che riguarda ogni persona in quanto soggetto che agisce. Esso consiste nel riconoscimento di ogni persona come agente libero; da ciò si desume la necessità dei diritti quali ad esempio pretese alla libertà e al benessere.

Jürgen Habermas
In alternativa alle teorie sostanzialistiche, le teorie procedurali dei diritti umani corrispondono all’ambizione fondazionale affidando a un metodo formale l’onere normativo della giustificazione. La ragione ispiratrice di questo terzo gruppo di teorie è rintracciabile nell’approccio all’ideale di giustizia presentato in modo pionieristico da Rawls nel 1971 in Una teoria della giustizia. L’idea è di individuare regole di ragionamento e di deliberazione in grado, per la loro stessa natura, di offrire come esito applicativo un risultato non neutrale dal punto di vista morale. Da menzionare sono entro questo rinnovato clima culturale le due più influenti teorie dei diritti umani: la teoria costituzionalistica di Ronald Dworkin e la teoria discorsiva di Jürgen Habermas.

Ronald Dworkin
La teoria di Dworkin perviene alla giustificazione dei diritti umani attraverso l’elaborazione di un più generale concetto di diritto di tipo interpretativo e creativo. Il diritto è – a suo giudizio – interpretazione, ma un’interpretazione consegnata non alla discrezionalità giudiziaria, bensì alla capacità di giudizio propria di un giudice ideale che a fronte di casi difficili sappia dare voce e applicare i principi di giustizia, ossia rispettare i diritti soggettivi, a loro volta fondati sul dovere morale dell’eguale considerazione e rispetto per ciascuno.
Per la teoria dei diritti proposta da Jürgen Habermas i diritti soggettivi scaturiscono invece dalla stessa prassi democratica, di cui sono al tempo stesso la condizione di possibilità. I depositari dei diritti sono anche gli autori delle norme che li sanciscono. Non possiamo né presupporre diritti umani morali, né rinunciare a essi: possiamo però vederli come regole strutturali di una democrazia. Il sistema dei diritti scandisce i vincoli normativi che devono essere riconosciuti perché il discorrere democratico sia autentico.
19.3 Lo Stato costituzionale di diritto
Queste sono dinamiche reali, che si sottraggono alla critica radicale di chi, nella dimensione dei diritti, vede sempre e solo all’opera la “ragione occidentale” e una sua permanente pretesa colonialista. Un tratto distintivo dell’ultima fase della storia dei diritti, infatti, è proprio quello di un continuo superamento di confini, con l’apertura di un dialogo culturale che coinvolge le più diverse aree del mondo e che mette sempre più al centro una questione ineludibile, quella del rapporto tra diritti e mercato. Quando, nel 1999, il Consiglio europeo dà il via alla scrittura della Carta dei diritti fondamentali, la ragione di una scelta così impegnativa viene indicata nella convinzione che “la tutela dei diritti fondamentali costituisce un principio fondatore dell’Unione europea e il presupposto indispensabile della sua legittimità”. Oggi questo è un vero terreno di scontro, perché si vuole sostanzialmente sancire l’incompatibilità dei diritti fondamentali con un mercato costruito ormai come l’unica legge “naturale”.
Ma così verrebbe cancellata la forma di Stato costruita nella seconda metà del Novecento. Non più il classico Stato di diritto, ma uno “Stato costituzionale di diritto”, del quale proprio l’istituzione di uno spazio dei diritti fondamentali costituisce un connotato fondativo. Tali diritti devono essere considerati come una questione politica che riguarda direttamente il modo d’intendere la democrazia e la distribuzione dei poteri.
Una complessiva riflessione storica sul Novecento consente di mettere meglio a fuoco quest’insieme di questioni, definendo la trama dei principi all’interno della quale il tema dei diritti si è progressivamente iscritto. La prima visibile discontinuità la cogliamo nella Costituzione di Weimar del 1919, la “lunga costituzione” dove la comparsa dei diritti sociali non è solo l’allungamento di un catalogo, ma la revoca in dubbio del ruolo centrale del diritto di proprietà. L’altra coincide con il secondo dopoguerra, quando con le costituzioni italiana e tedesca non viene abbandonato lo storico fondamento degli uomini che nascono tutti “liberi ed eguali”, ma esso viene significativamente collocato in un contesto più largo, che prende il suo avvio dalla dignità e dal lavoro, nel quale torna a manifestarsi proprio quella fraternità/solidarietà che era stata messa al margine, e quasi esclusa dal quadro dei principi, che oggi, invece scopriamo più ricco, e impegnativo. Non vi è gerarchia tra libertà, eguaglianza, dignità, solidarietà: tutte, contribuiscono a costruire il quadro dei diritti anche intorno a quell’uomo degno e solidale che si presenta come la figura sociale che meglio può consentire una forte garanzia della persona in tempi che vogliono invece guardare a essa solo come un attore economico.