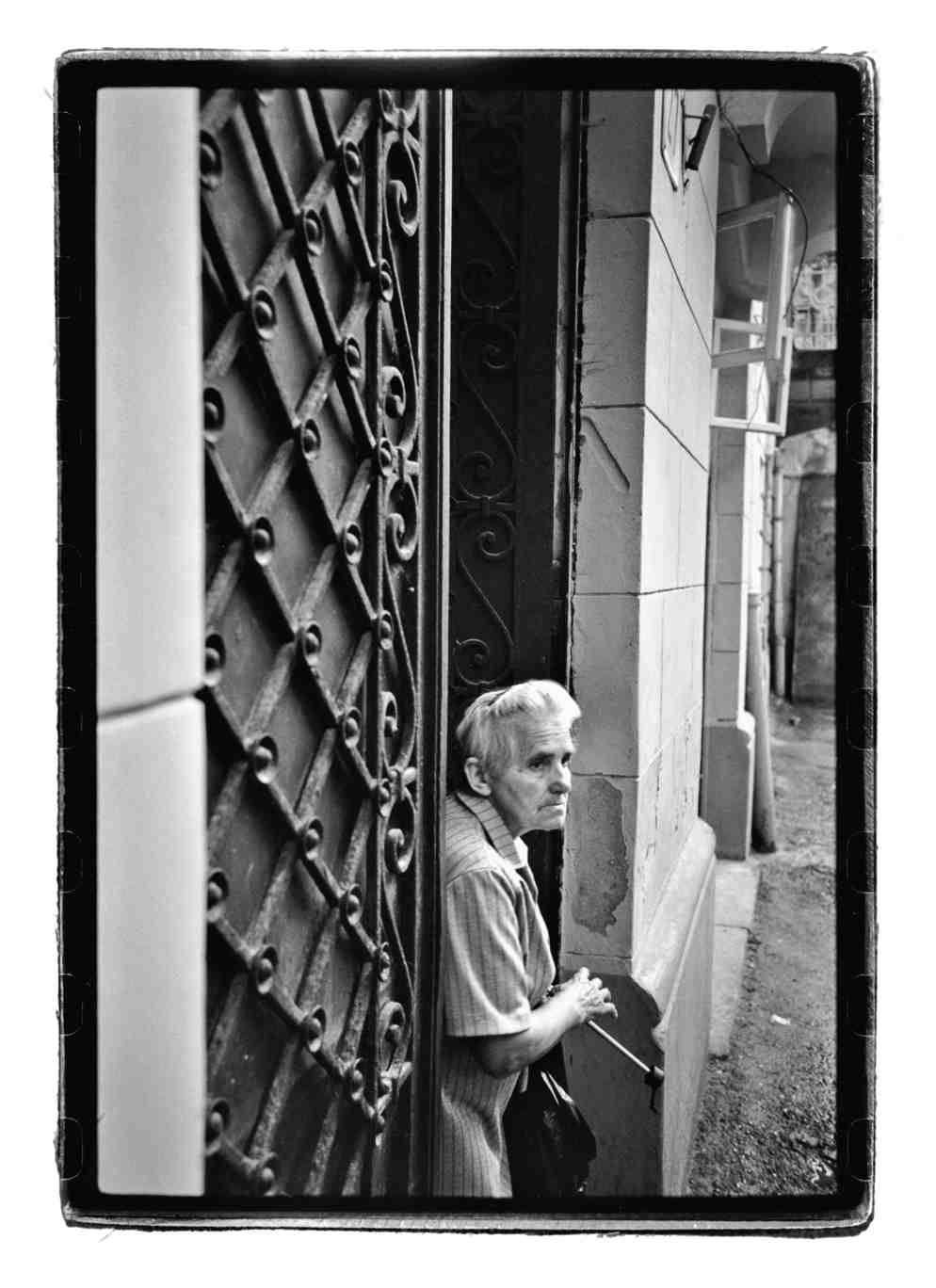
A Sidney ci volle un’intera giornata per riprenderci dallo sfasamento dovuto al cambiamento di fuso orario e di stagione. Il giorno seguente l’arrivo lo trascorremmo per lo piú a dormire, salvo qualche passeggiata sul lungomare soleggiato, alle cui spalle sorge la celebre Opera House di Sidney, che ci ricordava di essere davvero giunti in Australia. Come molti rinomati monumenti visti in fotografia – la basilica di San Marco a Venezia, Stonehenge nella pianura di Salisbury, l’ingresso di Auschwitz, il piccolo municipio di Bolechow o Magistrat, risalente all’epoca asburgica, di fronte al palazzo dove un tempo sorgeva la macelleria della mia famiglia – visto dal vivo l’edificio appariva molto meno imponente, piú a dimensione umana rispetto a come lo immaginavo. Guarda caso, il balconcino della nostra camera d’albergo dava proprio su uno specchio d’acqua prospiciente il teatro, e quel sabato, mentre io e Matt gironzolavamo per la stanza con aria imbambolata, per sgranchirci le gambe dopo tutte quelle ore di viaggio e il cambiamento di fuso orario, ogni tanto uscivamo sul balcone per accertarci che il teatro fosse ancora lí, che fossimo davvero in Australia. Incespicavamo sul tappeto e contemplavamo riconoscenti quel punto di riferimento: per quanto ridimensionato, indifferente, era lí.
Quella giornata di sabato fu davvero sprecata. Solo la domenica incontrammo le persone per le quali avevamo intrapreso quel lungo viaggio.
Nelle settimane precedenti il nostro arrivo, Jack mi aveva ripetuto a piú riprese di non essere l’unico nativo di Bolechow stabilitosi in Australia. A parte il fratello piú giovane, Bob, anche lui sopravvissuto alla guerra, c’erano altre persone «interessanti», come le definí, che desideravo conoscere: una donna un tempo amica di Frydka, un suo parente molto anziano, che, data l’età, poteva addirittura aver conosciuto mio nonno prima che questi emigrasse negli Stati Uniti, e un tale vicino di Shmiel. E cosí Jack aveva invitato tutti a casa sua a Bellevue Hills, nei pressi di Bondi Beach – a circa venticinque minuti di macchina dal nostro albergo, al centro della città. A me il nome Bondi Beach non diceva niente, ma quando gli passai il fax speditomi da Jack con le informazioni sugli alberghi e le strade, Matt rimase colpito.
«Bondi Beach!» esclamò. «È un posto famosissimo peri surfisti! Arrivano da tutto il mondo per fare surf lí».
«Be’» replicai, «siamo venuti dall’altra parte del mondo per parlare con quegli anziani di Bolechow». Fui colto dalla paura irrazionale che volesse convincermi a fare surf; alle superiori faceva parte della squadra di atletica, aveva l’hobby del paracadutismo. Ma no, trovava solo divertente l’idea che un gruppo di vecchi ebrei polacchi vivesse nel paradiso dei surfisti.
E cosí quella domenica andammo a Bondi Beach. Un taxi ci lasciò davanti al complesso edilizio dall’aspetto sfarzoso dove abitava Jack, e salimmo al suo appartamento con l’ascensore. «Guarda» disse Matt con un sogghigno ammiccante, indicando una targa di metallo affissa sulla parete, con inciso il nome della ditta costruttrice: SCHINDLER. «Siamo nello Schindler’s lift, l’ascensore di Schindler!».
Alzai gli occhi al cielo ed esclamai: «Oy vey».
Venne ad aprirci Jack in persona. Era un uomo non molto alto, dal fisico asciutto, un viso lungo dall’aspetto gioviale, velato di mestizia, il mento prominente compensato da occhi dallo sguardo malinconico e accorto. I radi capelli grigi erano accuratamente pettinati. Ci invitò a entrare. L’appartamento si presentava elegante e accogliente, inondato dalla luce che filtrava dalle vetrate a parete che si aprivano su un balcone fiorito. Le pareti del soggiorno erano color crema e celeste; in un angolo alcuni tavolini in vetro e ottone baluginavano ai raggi del sole. Si percepiva una sorta di studiata neutralità in quell’arredamento gradevole, caratteristica che avevo osservato anche nella dimora della signora Begley, con le porcellane immacolate stile anni Cinquanta e Sessanta e gli arredi di legno chiaro, la menorah «moderna» di metallo lucente. Solo ora, nell’ingresso dell’accogliente appartamento di Jack Greene dall’altra parte del pianeta, mi resi conto di una particolarità già notata nelle visite sempre piú frequenti alla signora Begley: quelle case non recavano traccia dei cimeli che si trovano, per esempio, da mia madre, le vecchie fotografie di famiglia con cornici massicce, gli antichi calamai di marmo, la menorah di ottone (come quella con i leoni rampanti di Giuda che mio nonno lasciò alla figlia), le minuscole figure di carta di due sposini posti sulla sommità della torta nuziale al matrimonio dei genitori di mia madre, nel 1928. Lí non v’erano tracce del passato europeo, della storia familiare. Erano andate tutte distrutte.
Gli stringemmo la mano ed entrammo. Ci accolsero sua moglie Sarah, una simpatica signora bionda dai modi gentili, e la figlia, Debbie, piú o meno mia coetanea, che aveva il viso grazioso della madre e presumibilmente lo stesso incarnato scuro che Jack doveva aver avuto un tempo. Rimasi colpito dal fatto che volesse assistere alla nostra conversazione, malgrado, immaginavo, conoscesse bene gli episodi che ci avrebbero raccontato il padre e i suoi amici. La capivo: anch’io un tempo non mi stancavo mai di ascoltare certi racconti.
Debbie spiegò che il marito e la figlia ci avrebbero raggiunti piú tardi. Aveva un accento ben diverso da quello americano. Non mi ero ancora abituato alla cadenza australiana – anzi, a ebrei che parlavano con quell’accento. È noto che si sono trasferiti in ogni parte del mondo, ma una cosa è saperlo in astratto, un’altra trovarsi di fronte a ebrei che provengono dai piú svariati paesi. Quelli che conoscevo da bambino si esprimevano con forte accento europeo – polacco, tedesco, russo, yiddish – o con marcata cadenza newyorkese. Ma lí eravamo in Australia, e gli ebrei della mia generazione hanno accenti australiani, esattamente come gli ebrei d’Inghilterra hanno accenti inglesi, quelli di Francia accenti francesi e quelli d’Italia accenti italiani. Il mondo è ben piú grande di quanto si immagina quando si cresce in un posto piccolo, che sia un sobborgo di New York o un villaggio della Galizia. Lo si scopre appena si comincia a viaggiare, come aveva fatto mio nonno. E come me ora.
C’era anche qualcun altro ad aspettarci a casa di Jack e Sarah, seduto al tavolo nella sala da pranzo, apparecchiato con una tovaglia di pizzo bianca, su cui io e Matt cominciammo, piuttosto goffamente, a poggiare le apparecchiature fotografiche e di registrazione. Era Bob. Lui lo conoscevo già. L’estate precedente era venuto a trovarmi a New York. Sorseggiando un tè freddo mi aveva raccontato come era scampato alla morte, con Jack e il padre, nascondendosi in un bunker sotterraneo mimetizzato dal fogliame nella foresta alle porte di Bolechow. Erano riusciti a fuggire e a rifugiarsi lí grazie a un contadino ucraino, appena prima dello sterminio definitivo del 1943. Avevano già raccontato quella storia in un libro scritto da un giornalista tedesco, Anatol Regnier (il quale «era sposato con una popolare cantante israeliana!» come piú di un australiano sottolineò non senza una certa incredulità), e poi con un documentario girato da una televisione tedesca in occasione del ritorno a Bolechow di Jack e Bob nel 1996.
Come il fratello, anche Bob non era molto alto, ma conservava un fisico atletico e asciutto. Dava l’impressione di una persona che trascorre molto tempo all’aperto, e non fui sorpreso di apprendere, di lí a breve, che ogni giorno faceva passeggiate a passo spedito sulla spiaggia. Quando conobbi Bob avevo già parlato parecchie volte con Jack al telefono, e fui colpito dal fatto che mentre questi, nato nel 1925 e quindi diciannovenne quando i nazisti lasciarono Bolechow, si esprimeva con un marcato accento ebraico polacco, Bob, nato nel 1929 e quindi appena adolescente durante la guerra, parlava come un autentico australiano. Durante quel colloquio, i diversi accenti suscitavano in me reminiscenze sempre piú profonde. Jack mi dava l’idea di un cittadino della vecchia Europa, piú tipicamente ebreo; amava infiorettare la conversazione con espressioni yiddish e talvolta ebraiche. Al contrario, man mano che approfondivo la conoscenza di Bob, avevo l’impressione che volesse liberarsi del passato. Forse la perdita dell’accento e delle sonorità un tempo caratterizzanti il suo eloquio non era solo il frutto di un processo naturale. Per di piú, non era particolarmente religioso.
Però Bob aveva mantenuto il cognome di famiglia, Grünschlag, mentre Jack lo aveva anglicizzato. I comportamenti dei fratelli possono essere alquanto contraddittori.
Quindi, in quell’appartamento di Sidney, in attesa dei due americani che anelavano di parlare con loro, c’erano Jack, Sarah, Debbie e Bob. Ma poi notammo anche qualcun altro seduto al tavolo. Era un uomo molto anziano, di ottantanove anni, di cui Jack mi aveva già accennato: Boris Goldsmith, un tempo vicino di Shmiele della sua famiglia, anzi suo dirimpettaio. Jack mi aveva avvertito che Boris era un po’ duro d’orecchi – per tutto il pomeriggio trafficò con una protesi applicata all’orecchio – nondimeno, per l’aspetto florido e i modi gioviali, mi diede subito l’idea di essere lucido e in buona salute. Indossava una giacca sportiva a scacchi nera e marrone con disegni a pied-de-poule, e quando ci strinse la mano notai un baluginio di metallo nella bocca. Era un particolare che ormai associavo all’Europa orientale.
Matt e io preparammo il registratore e tutto il resto per le nostre domande, mentre aspettavamo l’ultima ospite, Meg Grossbard, che come Jack, Bob e gli altri, al termine della guerra aveva compiuto l’improbabile viaggio da Bolechow al Nuovo Galles del Sud («Vede» mi aveva detto Jack al telefono l’anno precedente, la prima volta che mi contattò, «molti di noi avevano preso in considerazione l’idea di andare in Australia già nel periodo precedente lo scoppio della guerra. E alla fine venimmo tutti qui»). Piú tardi avrei appreso che dell’intera famiglia di Meg – ventisei persone nella sola Bolechow – solo lei, il marito e un fratello molto piú grande si erano salvati. Meg e il marito si erano stabiliti a Melbourne dove, come a Sidney, c’era un nutrito gruppo di sopravvissuti; suo cognato, Salamon Grossbard, viveva a Sidney. Dopo aver perso moglie e figli non si era piú sposato. Jack mi informò che aveva novantasei anni, e il suo stato di salute non gli aveva permesso di partecipare a quella riunione. Invece Meg era appositamente venuta da Melbourne, ed era ospite del cognato.
«Arriverà presto» mi assicurò Jack.
«Spero non tardi troppo» mi augurai.
Con espressione enigmatica, Jack replicò: «È molto piena di sé».
Ero piuttosto ansioso di conoscere questa signora Grossbard. E non solo perché Jack mi aveva rivelato che Meg (nome dal sapore cosí inglese assunto quando si era trasferita in Australia) era l’amica del cuore di Frydka, quindi la persona piú indicata per ricostruirne la personalità, visto che Jack poteva parlarmi solo di Ruchele. In realtà ero ancor piú bramoso di conoscere il signor Grossbard, anche se Jack mi aveva riferito che nell’estate del 1941 si era unito alle truppe sovietiche in ritirata, e certo non poteva sapere cosa accadde alla famiglia di Shmiel; era rimasto in Unione Sovietica tutto il periodo dell’occupazione tedesca di Bolechow, dove la moglie e il figlioletto trovarono la morte.
Avevo le mie ragioni per desiderare cosí ardentemente di conoscere questo signor Grossbard. Nato nel 1908, apparteneva alla generazione precedente a quella di Jack, Bob e Meg, che dopo tutto erano stati amici e compagni di scuola delle figlie di Shmiel, le scomparse cugine di primo grado di mia madre. Il millenovecentotto era anche l’anno di nascita della sorella minore di mio nonno, Neche, Jeanette, condannata ad andare in moglie al cugino; ma lei era morta da lungo tempo, sembrava appartenere al passato remoto, al mondo delle storie e delle leggende familiari, tanto che quando appresi dell’esistenza del signor Grossbard mi sembrava impossibile pensare che lei avrebbe potuto essere ancora viva. Quest’uomo cosí anziano era l’ultimo cittadino di Bolechow della generazione di mio nonno ancora in vita. Proprio come era accaduto con la signora Begley, quando avevo cominciato a fantasticare che potesse aver sentito parlare o persino aver conosciuto di persona qualche membro della scomparsa famiglia Jäger, ora mi figuravo che quest’uomo cosí vecchio avesse incontrato da bambino qualcuno dei piccoli Jäger, forse all’istituto Barone Hirsch, o al cheder, la scuola ebraica, o magari giocando per le strade polverose della cittadina; se avesse ricordato anche solo un nome – di mio nonno, magari, o dell’incorreggibile zio Julius, o magari di Jeanette – ciò li avrebbe non solo restituiti al presente, per quanto fugacemente, ma per me avrebbe assunto un significato ben piú prezioso. Se i miei viaggi alla ricerca della famiglia di Shmiel andavano considerati una sorta di missione di recupero, motivata dal desiderio di riscattare dal passato alcuni frammenti di quelle individualità, allora, se avessi avuto la possibilità di parlare con il vecchissimo signor Grossbard, con quel viaggio in Australia avrei dissepolto dall’oblio anche una parte dell’esistenza di mio nonno.
Questa era la mia segreta speranza. Se con Meg Grossbard fosse andata come speravo, forse sarei riuscito a persuaderla a presentarmi il cognato.
Aspettavamo l’arrivo di Meg radunati nella sala da pranzo di Jack e Sarah, seduti attorno al tavolo con la tovaglia di pizzo. Sarah l’aveva imbandita con tazze e piattini, pronta a servire il dolce e il caffè. Nel frattempo Jack aveva cominciato a esaminare le fotografie che avevo portato, vecchie istantanee di famiglia e le foto scattate nel viaggio a Bolechow.
«Sai» mi rivelò, «a quel tempo ogni cittadina di quella regione aveva un nomignolo in yiddish».
«Nomignoli?» ripetei stupito.
«Certo» confermò (usava questa parola enfaticamente, annuendo con vigore, come anche l’intercalare «esatto», che pronunciava con lieve inflessione polacca).
«Per esempio» mi spiegò, «noi eravamo soprannominati le lumache di Bolechow».
«E perché?» domandai.
«Perché Bolechow era un tale dedalo di stradine serpeggianti e di sobborghi che bisognava strisciare dappertutto!» rispose con un sorriso, divertito da quel ricordo.
«Sobborghi?» chiesi sorpreso. Ero sconcertato; avevo sempre pensato che Bolechow fosse poco piú di un villaggio. Quando la visitammo, ci parve che non si estendesse molto oltre la Rynek, la piazza centrale, da cui si diparte la strada principale che arriva a Striy e prosegue in direzione nord, e quella che conduce al cimitero. Scoprimmo cosí che avevamo visto solo una piccola parte della città. Era molto piú grande di quel che pensavamo.
«Certo» confermò Jack. «Per esempio» proseguí, mentre osservava un’istantanea scattata in Ucraina due anni prima, «c’era una bella zona nota come la Colonia tedesca. Ed esisteva anche una colonia italiana. Un’altra zona si chiamava Bolechow Ruski».
Io e Matt ci scambiammo un’occhiata e scoppiammo a ridere al pensiero che in quel piccolo villaggio ci fossero delle colonie. Anche Jack rise.
«Sí, eravamo importanti!» si vantò. Il modo in cui pronunciò quella frase mi evocò un ricordo cosí vivido di mio nonno che mi venne un groppo alla gola.
Jack continuò: «Invece Lwów era chiamata Lemberger pipick» rivelò con un sogghigno.
«Pipick?». In yiddish significa «ombelico».
«Sí. Perché quella città aveva una piazza, una rynek, esattamente al centro, era come un ombelico! Dolina si chiamava Dolina hoise. Hoise significa pantaloni. Aveva solo due strade, come le gambe di un pantalone».
Tacque qualche istante. Conoscevo da lungo tempo i nomi di quelle città, e le avevo sempre considerate semplicemente come luoghi legati a certe epoche, ai miei antenati. Adesso, d’un tratto, sembravano animarsi, le immaginavo attraverso le descrizioni di persone che vi erano vissute e che ricordavano ancora quegli assurdi e affettuosi nomignoli.
Mentre Jack stava spiegando il significato di Dolina hoise, suonarono alla porta e la signora Grossbard fece il suo ingresso.
Era completamente diversa da come me l’ero figurata. Era una donna minuta, nonostante il portamento rigido ed eretto, dai capelli rossicci con ciocche ramate, pettinati all’indietro in un’acconciatura piuttosto elaborata, e dava l’impressione di essere allo stesso tempo scontrosa e riservata. Indossava abiti scuri che mettevano in risalto la capigliatura dai colori accesi: una camicetta di seta nera, un maglione violetto. Vistosi orecchini d’oro adornavano i penduli lobi. Jack la salutò con un bacio sulle guance.
«Ti presento Daniel Mendelsohn» si rivolse a lei indicandomi; quindi fu la volta di Matt: «Anche lui è il signor Mendelsohn» aggiunse con un sorriso.
«Sono felicissimo di conoscerla» esordii. «Mia madre è la cugina di Frydka».
«Sí, lo so» replicò, sfilandomi davanti e accomodandosi al tavolo. La sua attenzione fu subito attratta dalle fotografie. Il volto serio, cominciò senza indugio a esaminare le istantanee che Matt aveva scattato in Ucraina: un’anziana donna a L’viv, che faceva capolino da una porta aperta quel tanto che basta per farvi passare una mezuzah 8, che un tempo certo vi era affissa;un vecchio nella piccola piazza di Bolechow con una capra al guinzaglio.
Mentre indugiavo in cerca delle parole adatte, notai che la rilassata atmosfera di tranquille reminiscenze che aveva caratterizzato il primo quarto d’ora di quella strana rimpatriata aveva perso la sua levità, facendosi pesante. A quanto pareva non ero l’unico a cui la signora Grossbard metteva soggezione. Mi chiesi quali vicende private, risalenti a sessant’anni prima, si celavano dietro i saluti cortesi con cui era stata accolta. Lo avrei scoperto sei mesi dopo.
Quella donna, da cui dipendeva il recupero di Frydka dal completo oblio, che opponeva una certa indefinibile ma palpabile resistenza, mi intimoriva. Istintivamente cercavo di rabbonirla, un po’ come facevo da ragazzo con la quarta e ultima moglie di mio nonno, quella donna scontrosa, con il braccio tatuato e l’espressione perennemente seria, di cui avevamo soggezione.
A un certo punto la signora Grossbard si voltò verso di me e mi porse una fotografia tirata fuori da una busta di plastica. Ritraeva Frydka, la graziosa ragazza scomparsa da lungo tempo, in posa in uno studio fotografico, con un sorriso appena accennato e una babushka. Non avevo mai visto quella foto, rimasi sorpreso dalla marcata rassomiglianza con mia madre. Sarà stato per la soggezione, ma quando la signora Grossbarsme la diede spiegando: «Questa è Frydka Jäger» replicai stupidamente, come a sottolineare qualcosa per lei importante, «è la cugina di mia madre». Mi sogguardò con espressione severa e ribatté: «Sí, lo so, era mia amica» dando impercettibile risalto alla parola «mia».
Mi indicò la busta e aggiunse: «Ho solo poche fotografie di Frydka». Spiegò che non erano le sue; appartenevano a una comune amica, una ragazza che si chiamava Pepi Diamant.
«Di-AH-mant» lo pronunciò.
«Lei morí, ma le fotografie si sono salvate» commentò con voce inespressiva. «Ritrovai l’album dopo la guerra, quando tornai a Bolechow, e presi qualche foto – le sue, le mie e quelle di Frydka».
Compresi che intendeva: le foto in cui comparivano Pepi, lei e Frydka (il nomignolo di Pepi, come appresi piú tardi quello stesso pomeriggio, era Pepci, pronunciato PEP-shuh). Stranamente Meg non mi mostrò subito quelle foto miracolosamente preservate. Ne riuscivo a intravedere qualcuna attraverso la busta di plastica, istantanee che ritraevano un gruppo di ragazze in abiti estivi, in posa davanti ai cancelli di un parco, in costume da bagno sulle rive di un lago, in giacche invernali col vitino da vespa, sugli sci.
Al di là del tavolo, seduto tra Jack Greene e Bob Grünschlag, Boris Goldsmith stava osservando altre fotografie; era chiaro che tutti aspettavano l’inizio di quella sorta di intervista di gruppo. Ignorandoli, la signora Grossbard cominciò a raccontare: «L’ultima volta che vidi Frydka – allora potevamo ancora circolare liberamente – fu nel febbraio del ’42. L’ultima volta...». La voce le mancò. D’un tratto tacque, e per la prima volta mi guardò negli occhi. «Lei ha un aspetto molto ariano» mi apostrofò in tono vagamente accusatorio.
Mi colse alla sprovvista. «Davvero?» replicai, lievemente divertito.
«Sí» incalzò. «È molto importante, sa? Noi poco o niente, tutti noi. Perché chi aveva un aspetto come il suo aveva una possibilità di cavarsela».
Cosa replicare? Presi una fotografia appartenuta a mio nonno, in cui Shmiel, con i capelli bianchi e l’espressione stanca, e Ester, robusta, con il seno prosperoso e un vestito stampato, affiancano con fare protettivo Bronia, che doveva avere circa dieci anni. La posai sul tavolo davanti alla signora Grossbard, che subito la raccolse delicatamente. Per la prima volta la rigidità, la resistenza, sembrarono dissolversi, e annuendo impercettibilmente mormorò: «Sí. I suoi genitori».
E per la prima volta sorrise.
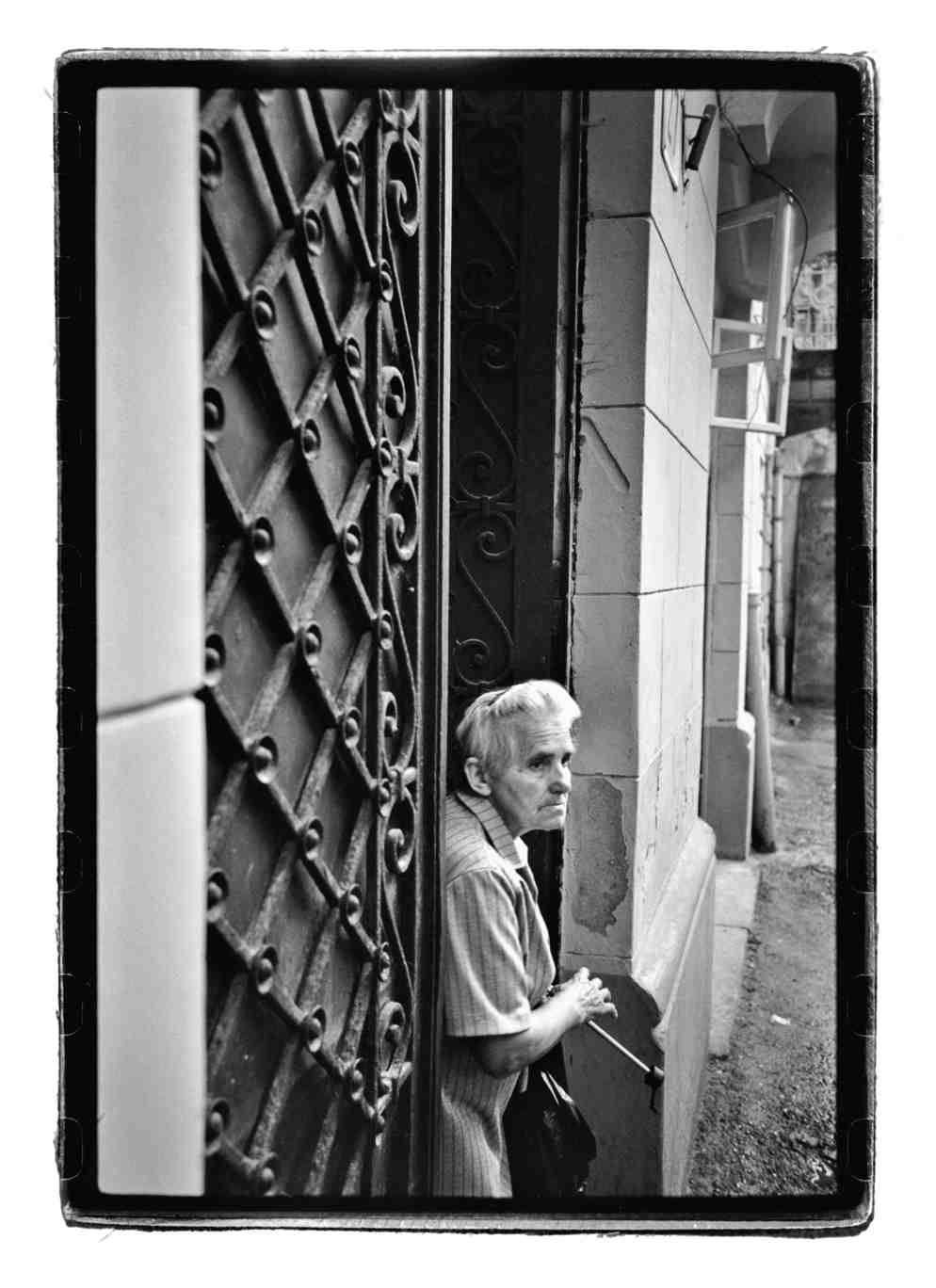
Quel giorno fu particolarmente fruttuoso. Quando ripenso a quello strano viaggio in Australia, lo considero un momento culminante, non solo perché apprendemmo numerosi particolari su Shmiel e la sua famiglia. Siamo abituati a fare affidamento sulle fotografie senza ricorrere alla memoria; basandoci solo sulle immagini siamo diventati incredibilmente pigri. «Com’era tua madre?» ci chiede qualcuno; «Aspetta, ti faccio vedere» rispondiamo, e corriamo a prendere un album di fotografie. «Ecco, guarda, eccola». Ma se non si hanno fotografie della propria madre, di altri congiunti, o persino di noi stessi prima di una certa età? Come descrivere lei, loro, se stessi? Solo quando conobbi Meg Grossbard, quella domenica pomeriggio, cominciai a riflettere su questo aspetto; mi resi conto di quanto fossi superficiale, persino sconsiderato, a viaggiare per il mondo per parlare con quei sopravvissuti, gente che non aveva letteralmente potuto salvare altro che se stessa, portandomi dietro il ricco campionario di fotografie che la mia famiglia possedeva da anni e che avevano popolato i miei sogni, esaminate con attenzione maniacale, raffiguranti volti che per me non avevano alcun reale significato emotivo. Per quelle persone, invece, rievocavano come d’incanto il mondo e la vita cui erano stati strappati tanto tempo prima. Quanto ero stato stupido e insensibile. Quando la signora Grossbard disse: «Erano i suoi genitori» compresi che non si stava limitando a confermare l’identità di quelle persone: era un modo per comunicare l’emozione di trovarsi davanti volti che non vedeva da sessant’anni e che considerava scomparsi per sempre, fisionomie in grado di rievocare la sua perduta giovinezza. «Questi erano i genitori della mia amica». Probabilmente reputava inopportuna l’inaspettata intromissione nella sua vita di un giovane americano che le mostrava foto della sua amica del cuore e dei suoi genitori, lontani parenti a lui sconosciuti, chiedendole di sceglierne una, come fossero carte in un mazzo, quando lei stessa non possedeva fotografie dei propri genitori. E cosí quella foto studiata infinite volte sin dall’adolescenza, improvvisamente mi fece comprendere la strana situazione in cui si venivano a trovare le persone a cui anelavo porre domande, ricche di memoria ma povere di ricordi, al contrario di me.
Il significato delle immagini – come possano costituire un divertimento per alcuni, e suscitare una profonda, persino sconvolgente commozione per altri – è il tema di uno dei passi piú celebri della letteratura classica. Nell’Eneide, il poema epico di Virgilio che per quanti sono sopravvissuti a catastrofiche distruzioni riveste un particolare significato, l’eroe, Enea, è un giovane principe troiano scampato all’incendio di Troia (la cui celebre guerra è narrata nell’Iliade di Omero, opera piena di vorticosi, intricati aneddoti). Dopo aver perso i suoi cari e gli amici, dopo aver visto la propria città annientata, un’intera civiltà scomparsa, Enea si mette in viaggio per il mondo in cerca di un luogo in cui ricominciare una nuova esistenza. Prima di fondare Roma, Enea, sconvolto, arriva a Cartagine, nell’Africa settentrionale, anch’essa fondata (come apprendiamo nel I libro dell’Eneide) da esuli braccati e disperati guidati da Didone, di cui Enea si innamora ma che poi abbandona, spezzandole il cuore. Giunti nella nuova città brulicante di vita, Enea e un compagno girovagano per le strade, colmi di ammirazione di fronte agli edifici e ai monumenti appena eretti. All’improvviso, in un tempio imponente, i due uomini sono attratti da un dipinto raffigurante scene della guerra di Troia. Per i cartaginesi quel conflitto era semplicemente un motivo decorativo, un soggetto idoneo ad adornare le mura di un tempio; per Enea, naturalmente, riveste ben altro significato, e davanti a quell’immagine che narra la sua vita scoppia in lacrime e proferisce un doloroso, celeberrimo verso, che impregnerà tanta parte del tessuto della civiltà occidentale da ritrovarsi ovunque: è diventato il nome di un gruppo musicale, di siti web e blog, il titolo di un’opera, di un romanzo di fantascienza, di una rivista, di un testo accademico. Contemplando i tragici avvenimenti della sua esistenza raffigurati sulle mura di un tempio in una città sconosciuta, estranea alla guerra che aveva cancellato la sua famiglia e la sua città, Enea esclama: «Sunt lacrimae rerum», «Si versano lacrime sulle sventure».
Le parole di Meg: «Questi erano i suoi genitori» me la riportarono alla mente, come accade ogni qual volta mi trovo di fronte alla terribile discrepanza tra il significato di immagini e storie interessanti, edificanti o tutt’al piú estremamente commoventi, ma di cui non ho esperienza, e quello che invece rivestono agli occhi di persone come quelle che avevo davanti, per le quali quelle stesse immagini e storie rappresentavano la loro vita. Nella mia mente, quel verso in latino è una sorta di didascalia che ammonisce in modo pregnante sulla distanza incolmabile creata dal tempo. Loro vissero lí, noi no. Vi sono lacrime per le nostre disgrazie; tutti, per una ragione o per l’altra, piangiamo.

«Lei morí, ma le fotografie si sono salvate» aveva detto la signora Grossbard con una punta di ironia, caratteristica che la contraddistingueva, come avrei scoperto nei giorni seguenti. In quel frangente ricordai la storia delle fotografie della signora Begley, il modo in cui le aveva recuperate. Fu il giorno che mi raccontò della sua giovinezza, di sua madre e del tentativo di salvare i suoceri, i cui cadaveri aveva visto portare via su un carro.
«Una vera Rebecca, un’autentica bellezza semitica. Come posso spiegarle?».
Quindi, impugnando il bastone e puntellandosi con il gomito sul bracciolo della poltrona dallo schienale rigido, si issò in piedi a fatica e si avviò lentamente verso la camera da letto, e senza proferire verbo mi fece segno di seguirla. Si fermò davanti a un comò. Dal soggiorno avevo notato spesso dozzine di fotografie stipate su ogni superficie disponibile, che ritraevano il figlio e i nipoti. Il ripiano immacolato del comò era ricolmo di fotografie molto vecchie. Le raccolse e me le passò una per una, fugacemente, indicandomi le persone ritratte, riponendole poi con cura. Mi mostrò i suoi genitori, i cui volti, a essere onesti, non ricordo bene; quel giorno del 2002 ero convinto di avere ancora parecchie occasioni per osservarli e chiedere di loro. Cosí non vi posi la dovuta attenzione, né prestai troppo ascolto ai suoi racconti, e ora che cerco di richiamarli alla mente rammento vagamente la figura di una donna attraente con una stola di pelliccia, e una vecchissima fotografia che ritraeva un anziano signore con l’espressione seria, vestito di nero, l’aria di un rabbino, o forse questa impressione era dovuta al copricapo tondo dalla foggia orientaleggiante che indossava, tipico di uomini di una certa età e di un determinato periodo storico.
Però ascoltai con estremo interesse il racconto di come era tornata in possesso di quelle antiche fotografie di famiglia risalenti alla sua adolescenza, a Rzeszów e Cracovia; mi ero infatti chiesto come fosse riuscita a conservarle dopo la rocambolesca fuga dalla sua confortevole casa in via 3 Maggio, dove la Gestapo si era acquartierata. Quando ripose accuratamente l’ultima fotografia, le chiesi se le aveva portate con sé, magari nascoste nella fodera del cappotto, durante la fuga con il bambino, passando da un nascondiglio all’altro, cambiando di continuo identità.
«Achhh!» esclamò la signora Begley, lanciandomi un’occhiata risentita. «Certo che no. Crede forse che fossi pazza? Venga, le racconto come andò».
Tornammo lentamente nel soggiorno. Prese di nuovo posto sulla poltrona e mi narrò l’intera vicenda. Dopo la guerra, quando si riuní al marito, il famoso medico di Stryj che, come molti suoi colleghi, era stato precettato dall’esercito sovietico in ritirata nel 1941, fu contattata da una persona che aveva preso possesso della sua abitazione, la casa che non ero riuscito a individuare nella giornata trascorsa a Stryj, l’estate precedente.
«Costui mi disse di aver trovato un pacco di mie fotografie» spiegò la signora Begley, «e se desideravo averle avrei dovuto mandare del denaro a un certo indirizzo».
A quel punto fece una smorfia, con un’espressione che tradiva un certa ironia.
«E cosí feci per un po’. Mandavo dei soldi e lui mi spediva una, due fotografie».
Mi astenni dal fare commenti. Cercavo di immaginare quanto sarei stato disposto a pagare per riscattare il mio passato.
«Ma alla fine mio marito si arrabbiò, ne aveva abbastanza, e cosí smisi».
Rimase un attimo in silenzio, mentre lo sguardo saettava sulle mensole zeppe di fotografie di Louis e della sua famiglia.
«E adesso, come vede, ho tante fotografie» concluse.
A casa di Jack Greene le fotografie di Shmiel, Ester e Bronia servirono ad allentare la tensione, e la conversazione sulla famiglia scomparsa del mio prozio divenne d’un tratto vivace e alquanto caotica. Per lunghi anni, non sapere praticamente niente di loro era stato motivo di frustrazione. Adesso, invece, avvertivo un certo abbattimento per il motivo opposto: non riuscivo a stare dietro a quella girandola di informazioni. Non sapevo a chi prestare ascolto, dove piazzare il microfono del registratore, captavo brani di conversazioni che arrivavano da ogni parte; mi volsi verso Matt con espressione angosciata, mentre i quattro anziani superstiti di Bolechow ciarlavano tra loro, e mi lamentai: «Sto perdendo tutto».
Jack Greene stava dicendo: «Ricordo gli Jäger, ricordo Shmiel Jäger, ricordo Itzhak Jäger – lo sapevi che si stabilí in Palestina nel 1930?».
«Sí» risposi, «lo sapevo». Itzhak, il fratello a cui mio nonno era piú affezionato, come mi aveva rivelato mia madre, era stato trascinato via da Bolechow con i due figli piccoli dalla moglie, fervente sionista, per stabilirsi in Medio Oriente. Dal lato opposto del tavolo Boris Goldsmith sorrideva, cercando di farsi udire.
«Ricordo» disse «che fu il primo a possedere una radio in città. Era grande – con le mani mimò una grossa scatola – con una lunga antenna».
Aveva una pronuncia gutturale, mi ricordava tanto mio nonno.
«Aveva un’antenna molto alta» continuò Boris. «Eppure non si sentiva... Fu anche il primo ad avere il telefono».
La prima radio, il primo telefono. Un pesce grosso in un piccolo stagno. Mentre Boris rammentava quei particolari, per me fondamentali perché confermavano l’idea che mi ero fatto di Shmiel, nella mia memoria fecero capolino i frammenti di un’altra storia di elettrodomestici e status sociale, anche se il ricordo preciso riaffiorò solo quando tornai a casa e chiamai mia madre. «Mio padre regalò a zio Izthak e a zia Miriam un frigorifero, il primo di Haifa» mi rammentò mia madre in quella telefonata. «Non lo avevano, e quando finalmente la zona dove vivevano fu servita dall’energia elettrica, mio padre ritenne che avessero bisogno di un frigorifero e glielo spedí. Izthak e Miriam divennero famosi in città!». Ma quel pomeriggio in Australia non ricordai questo aneddoto.
«E cosí lei lo conosceva bene?» domandai a Boris Goldsmith.
«Lo conoscevo molto bene!».
A quel punto non seppi piú cosa domandare. Questa fu la singolarità di quel viaggio: alla fine eccomi lí, a conversare con persone che li avevano conosciuti bene, persino intimamente, e non sapevo da dove cominciare. Mi sentivo come davanti a una porta chiusa, con un voluminoso mazzo di chiavi: quale scegliere? Mi rendevo conto di quanto fossi impreparato. Cosa si può conoscere di un individuo? Come descrivere una personalità, un’intera esistenza? Farfugliando, posi a Boris Goldsmith un’altra domanda.
«Che tipo di persona era?».
Boris parve sorpreso.
«Una persona ordinaria» rispose lentamente. «Faceva il macellaio. Possedeva due automezzi. Trasportava la carne da Bolechow a Lwów».
Macellaio, gli automezzi, Lwów. Questo lo sapevo già, o avrei potuto supporlo. Mi sentii impotente.
«E conosceva Ester?» gli chiesi sempre farfugliando.
«Oh, certo... Ero spesso ospite da loro. Abitavano proprio dall’altra parte della strada, di fronte. Io vivevo lí prima che si trasferissero...».
Aveva abitato proprio di fronte a loro! In quell’attimo ricordai l’emozione provata diciotto mesi prima, a casa di Pyotr e Olga, quando quest’ultima aveva esclamato: «Znayu, znayu», «li conoscevo, li conoscevo». Allora non avrei mai sperato di incontrare un giorno qualcuno che li conosceva ancora meglio. E ora eccomi lí, e tutto quel che riuscii a dire fu: «Ricorda quando andarono ad abitare lí?».
Boris scosse il capo dispiaciuto, e rispose: «Non ricordo. È passato cosí tanto tempo».
Pronunciò le parole cosí tanto tempo come fosse l’inizio o la fine di una favola. Seguí qualche attimo di silenzio, poi Boris proseguí.
«La casa c’era già. Quando vi si stabilí cominciò a ristrutturarla. La trasformò. Poi acquistò due autocarri Studebaker. Era uno spedizioniere, era in società con un certo Schindler».
Lanciai un’occhiata a Matt, che sorrise.
Boris continuò: «Quando nel 1939 arrivarono i russi gli sequestrarono gli automezzi, e lui andava nelle campagne a comprare bestiame per il governo».
Bestiame. Mio nonno avrebbe pronunciato: bastiame.
«Comprava bestiame per il governo?» ripetei. Era un particolare interessante: mi ero sempre chiesto come tirasse avanti durante i due anni di dominio sovietico, tra il 1939 e il 1941.
Bob interloquí: «Per il governo, perché in quel periodo fu assunto dal governo».
«Fu assunto dal governo!». Boris assentí con il capo, confermando ad alta voce: «Sí, i comunisti!».
In seguito mi capitò di leggere la testimonianza di un sopravvissuto relativa agli anni dell’occupazione sovietica: la liquidazione e la nazionalizzazione di tutte le attività commerciali; le imposte insopportabilmente elevate, la disintegrazione della moneta polacca, lo złoty, con il conseguente esaurimento della liquidità, le file davanti ai pochi negozi, le inaspettate deportazioni notturne in Siberia di «controrivoluzionari borghesi» – insomma, il sistema sovietico si rivelò un illusorio miraggio. Leggendo tutto ciò cercavo di immaginare cosa dovette significare per Shmiel andare nelle campagne a comprare bestiame per il governo, lui che anni prima aveva rinunciato a vivere negli Stati Uniti, per cercare di ricostituire le fortune della famiglia. La liquidazione dell’antica attività, il sequestro dei due Studebaker, l’assunzione da parte di qualche anonimo funzionario sovietico dell’incarico un tempo ricoperto dal presidente del consorzio dei macellai e, infine, l’assegnazione di un mortificante lavoro umile – per quanto, almeno, inerente all’attività già esercitata. In effetti, solo dopo aver appreso da Boris quell’informazione cominciai a considerare Shmiel come un macellaio, una persona la cui fonte di reddito dipendeva dagli animali, come già per generazioni di suoi antenati. Quando, nella mia infanzia, mio nonno si fermava da noi, capitava che io o mia madre lo accompagnassimo con la station wagon al centro commerciale piú vicino dove, tra il negozio di un barbiere e una farmacia, c’era una macelleria kasher. Questa botteguccia, un bugigattolo sempre spaventosamente freddo per gli spifferi che filtravano dagli infissi decrepiti, zeppo di confezioni di plastica contenenti fegato e carne imbottita, apparteneva a due fratelli con i quali, una volta arrivati lí, mio nonno passava ore a conversare in yiddish. Mi chiedevo spesso perché ci andassimo pur non dovendo comprare niente; fu solo quando Boris disse «andava nelle campagne a comprare bestiame per il governo» che compresi perché mio nonno si recava lí: non solo per conversare in yiddish, ma per parlare dell’attività commerciale di famiglia.
Ascoltando Boris mi sovvenni di un particolare. Se Shmiel a un certo punto si era stabilito nella casa di fronte a quella di Boris Goldsmith, allora l’abitazione che avevamo visitato a Bolechow, l’antica casa degli Jäger del lotto 141 dove adesso vivevano Stefan e Ulyana, non era, come credevo, quella in cui aveva vissuto la sua famiglia prima dell’ultima, fatale destinazione, qualunque essa fosse. Volevo accertarmene, cosí domandai a Boris:
«Quando si trasferí lí aveva già le quattro figlie?».
Boris parve sorpreso. «Aveva tre figlie» rispose. «Io ne ricordo tre».
«Be’» esitai, «erano quattro, ma...».
«Non mi sembra che fossero quattro. No, non credo proprio...».
Boris prese la fotografia di Shmiel, Ester e Bronia, che, passata di mano in mano, era arrivata davanti a lui. Raccolsi altre foto, mi sporsi sul tavolo verso di lui e indicandole elencai: «Lorka, Frydka, Ruchele e Bronia». Dalla parte opposta del tavolo, all’improvviso Meg Grossbard saltò in piedi.
«E Bronia!» esclamò. «Si!» soggiunse con un sorriso.
Ma Boris non era convinto. «Io ne ricordo solo tre» insisté. «Sono sicuro che aveva solo tre figlie».
A quel punto Sarah Greene commentò con un sorriso: «Be’, lo sapranno, dopo tutto erano loro parenti!».
Scoppiarono tutti a ridere. Temevo di offendere Boris con la mia insistenza, lasciando intendere che non mi fidavo nella sua memoria.
Da parte sua, Boris lasciò cadere il discorso, tagliando corto in tono burbero: «Era macellaio. Non ricordo la sua famiglia».
«Ricorda che aveva un fratello emigrato in Palestina?» domandai.
«Non conosco suo fratello» rispose bruscamente Boris. «So solo che aveva una famiglia».
Per cambiare argomento chiesi ai presenti se a quel tempo a Bolechow vi fossero altri Jäger. Mio nonno mi aveva detto di avere dei cugini che vivevano in città – del ramo Jäger, presumevo, imparentati con sua zia Sima, nella cui tomba mi ero casualmente imbattuto al cimitero di Bolechow.
«È quello che ho appena chiesto a Jack» esclamò la signora Grossbard, voltandosi verso di me. «Nella rynek c’erano degli Jäger. Erano gli zii di Dusia Zimmerman... i fratelli di sua madre, una Jäger. Avevano un negozio di dolciumi, una cukierna».
Si rivolse a Jack in polacco, chiedendogli la parola equivalente in inglese. Sarah Greene suggerí: «Un caffè?».
Meg protese la mano ben curata, scuotendo il capo:«No, no, no, no».
Nel corso di quel pomeriggio mi resi conto che quella negazione ribadita per quattro volte era un intercalare a cui ricorreva quand’era irritata per le inesattezze altrui. Aveva una voce ferma, il tono grave.
«Non un caffè, scusate» specificò. «Non c’erano caffè».
Scoppiarono tutti a ridere, non so se per l’irritazione palesata da Meg o per l’assurda idea che in un villaggio come Bolechow ci fosse qualcosa che somigliasse a un caffè.
«Conoscevo Frydka sin da bambina» mi rivelò Meg. «L’ultima volta la vidi nel ’41, quando potevamo ancora circolare liberamente per le strade. Non ho mai saputo cosa ne fu di lei. Non ne ho idea. Ma Lorka la incontrai nel gennaio o nel febbraio del 1942, a casa di un’altra amica, con il suo ragazzo».
Sono abituato alle distorsioni e ai contorcimenti della sintassi della lingua inglese quando è inquinata dal polacco, ma non capii a chi era riferito l’aggettivo «suo».
«Il fidanzato di chi?» domandai a Meg.
«Il fidanzato di Lorka» rispose. «Si chiamava Yulek Zimmerman. Fu l’ultima volta che la vidi; Yulek aveva una sorella piú piccola, amica mia e di Frydka».
Mi spiegò che all’inizio del 1942, prima che agli ebrei di Bolechow fosse proibito di uscire dalle loro abitazioni, Meg era andata a trovare Dusia Zimmerman, e lí trovò il fratello maggiore di Dusia, Yulek, con Lorka Jäger, la sua fidanzata.
Quindi aveva un ragazzo, presi mentalmente nota.
Mentre Meg si dilungava nel racconto (che mi avrebbe ripetuto qualche giorno dopo, quando superate le difficoltà mi recai da lei e dal vecchio signor Grossbard), mi sforzavo di ricordare dove avevo già sentito il nome Zimmerman. In ultimo mi sovvenne: nel secondo giorno passato a Bolechow un anno e mezzo prima, alcune donne anziane che avevamo fermato per strada ci avevano detto di non conoscere nessuno Jäger, ma di ricordare la famiglia Zimmerman; non avevo chiesto ulteriori particolari, pensando che quella famiglia non avesse alcun legame con noi.
«Cosí vi conoscevate sin da bambine?» chiesi a Meg, riferendomi a Frydka.
«Oh sí, siamo cresciute insieme».
«Quindi conosceva anche le altre sorelle».
«Certo» rispose con una smorfia. «Un po’ meno la piú piccolina, ma le altre...».
La voce le morí in gola e si abbandonò a un mesto sorriso. «Andavo spesso a trovarle a casa» aggiunse dopo qualche attimo. «Era una famiglia deliziosa, erano tutti estremamente cordiali».
Dopo un momento di silenzio, proseguí: «Ricordo che avevano una casa a un solo piano, ma spaziosa».
Provai di nuovo quella sensazione frustrante di sconcerto – per certi versi, ero arrabbiato con me stesso. Lei li aveva conosciuti intimamente, e io non riuscivo a formulare le domande adatte a stimolare la sua memoria, per rievocare il vissuto di quella famiglia scomparsa. Le chiesi di parlarmi di Ester, specificando che di lei non sapevamo praticamente nulla.
«Be’» rispose scrollando le spalle, «cosa posso dirle? Era una persona cordiale, amabile, e... come dire... non posso aggiungere altro, perché la vita...».
Per qualche istante calò il silenzio; poi, con un risolino, Sarah se ne uscí con una battuta: «Sarà stata come tutte le altre madri ebree!».
Meg reagí. Avevo già notato che non gradiva lasciare agli altri l’ultima parola; come tutti – me compreso, naturalmente – voleva mantenere il controllo della conversazione di cui era la protagonista.
«No, no, no, no» esclamò. «Era una persona cordiale, aveva un carattere allegro. Suo marito lo vedevo di rado, era quasi sempre fuori, ma lei era sempre in casa».
La frase «come tutte le altre madri ebree» mi fece balenare un’idea. Forse avrei dovuto cominciare a considerare i miei parenti scomparsi semplicemente come persone ordinarie, e non come icone ingiallite dal tempo. Decisi di provocare la signora Grossbard.
«Dunque» le dissi, «lei ha conosciuto quelle ragazze sin da bambine, e poi da adolescenti. Erano in buoni rapporti con i genitori o si lamentavano?».
Parve confusa, come se non riuscisse a capire a cosa miravo.
«Senta» replicò lentamente, «eravamo molto giovani quando scoppiò la guerra...».
Infatti. L’archivio di Stato polacco mi aveva mandato una copia del certificato di nascita di Frydka: 22 ottobre 1922. Non aveva ancora diciassette anni quando iniziò il conflitto, nemmeno diciannove quando i sovietici si ritirarono dopo l’invasione tedesca, e probabilmente ventuno quando morí – se era attendibile la voce secondo la quale era fuggita nella foresta per unirsi ai partigiani dei fratelli Babij nel 1943, circostanza naturalmente non appurabile con certezza. Sapevo bene che quelle ragazze erano molto giovani quando scoppiò la guerra, ma il riserbo di Meg di fronte alla mia richiesta di parlarmi di Frydka adolescente era sospetto. Avevo la sensazione che volesse nascondere qualcosa.
Come scoprii in seguito, non mi sbagliavo.
A quel punto Bob Grünschlag interloquí: «Chi oserebbe lamentarsi dei propri genitori?» esclamò con un sogghigno.
Nella risata generale che seguí, colsi una frase di Meg bisbigliata a Jack: «Non ricordo esattamente quando Frydka... Era con Tadzio Szymanski? Era con Tadzio?».
In parte per la mia ignoranza dei nomi polacchi, un po’ per il modo quasi irriconoscibile in cui lo pronunciò, non compresi bene quel nome.
Cosí chiesi chi fosse quel Tadzio o Stadzio Szymanski.
«No, no, no, no» si affrettò a dire Meg con voce ferma. Da giovane doveva essere una donna autoritaria, mi venne da pensare. Poi addolcí il tono, come per dare a intendere che si trattava di una figura di secondaria importanza.
«Frydka era in rapporti amichevoli con un tale, che lei non conosce, Jack lo ricorderà». Lo sguardo di Meg si perse oltre Bob, al quale disse: «Tu non sai niente».
Jack la corresse: «Ciszko Szymanski».
«Sí. Ciszko» ripeté annuendo.
Lo pronunciò Chissko. Domandai di nuovo di chi stavano parlando.
«No, no, no, no. Niente».
«Niente?».
«Stavo cercando di ricordare un ragazzo non ebreo» minimizzò Meg, chiaramente infastidita.
«Qualcuno usciva con un ragazzo non ebreo?» insistei.
«No, aspetti» tagliò corto Meg. «No, no, no, no. Questo non si deve sapere».
Jack rise, e indicandomi disse: «Vedi? Stai scoprendo qualcosa, qui!».
Risero tutti eccetto Meg. Avevo la sensazione, vaga ma inequivocabile, come avviene per intuizioni del genere, di essermi imbattuto in un vecchio pettegolezzo.
Meg mi chiese: «Conosce quella commedia americana dove si dice “Non so nicht?”». Naturalmente la conoscevo: Gli eroi di Hogan, la divertente sitcom ambientata in un campo di prigionia nazista trasmessa negli anni Sessanta, nella quale compariva un personaggio, l’obeso sergente Schultz, che sebbene in combutta con i prigionieri di guerra americani, adorabili buffoni, insisteva sempre con il suo Kommandant che lui era innocente e non aveva visto niente, ripetendo in continuazione «Non so nicht!», battuta che produceva invariabilmente un effetto comico.
«Be’» proseguí Meg, quando risposi annuendo.
Ma lí non eravamo in televisione. Non si trattava di una commedia. La vicenda che mi voleva tenere nascosta era la ragione per cui avevo percorso in aereo quindicimila chilometri, deciso a parlare con lei.
«Cosí a Frydka piaceva quel ragazzo non ebreo» incalzai.
«Non lo so, non c’ero» s’incaponí Meg.
«Sarebbe stato un avvenimento, no?» commentai.
Bob, gongolante all’idea di punzecchiarla un po’, colse la palla al balzo: «Sarebbe stato un grande avvenimento!». A quella battuta Meg reagí con un sorriso acido.
«Questo è un eufemismo. L’eufemismo dell’anno» replicò con un filo di voce. Tuttavia si ostinava a negare che Frydka Jäger avesse preso una cotta per quel ragazzo cattolico, una vita fa, quando quella storia d’amore avrebbe fatto scalpore; e comunque, ormai, a chi interessava piú? La moglie di mio fratello Andrew non è ebrea; la consorte di Matt è di religione greco ortodossa. Per un attimo mi chiesi cosa stesse pensando Matt riguardo a quella rivelazione.
Meg si era intestardita. «Non lo so, non ne fui testimone».
«Non le sto chiedendo di testimoniare» ironizzai. «Ma era la sua migliore amica, deve averle confidato qualcosa».
Meg rispose con un sospiro: «No, no, questo accadde durante la guerra, non prima. Dio non voglia! Una cosa del genere non sarebbe mai potuta accadere prima della guerra».
Quella frase, naturalmente, era un’ammissione in piena regola. Fino a quel momento Frydka era solo il volto di una ragazzina su qualche fotografia; adesso cominciava a delinearsi una personalità, una storia. E cosí amava un ragazzo polacco e ne era ricambiata, pensai tra me con un sorriso.
Convinto che fosse quella la storia inedita da raccontare a mia madre, ai suoi cugini, ai miei fratelli, non appena fossi tornato a casa, mi appoggiai allo schienale della sedia e decisi di cambiare argomento, per non correre il rischio di alienarmi del tutto le simpatie della signora Grossbard, che non aveva certo un’espressione allegra. Fu allora che Jack, protendendosi in avanti all’altro capo del tavolo, a voce alta rivelò: «Lascia che ti dica una cosa. Quel ragazzo perse la vita a causa di Frydka».
«Un momento» dissi. «Come hai detto?».
Jack abbassò il tono della voce. Avevano smesso tutti di parlare e si erano voltati a guardarlo. Lui mi fissò e ripeté, scandendo le parole, come a sottolinearle.
«Il ragazzo... perse... la vita... per causa... sua».
Per qualche istante nessuno fiatò.
«Puoi spiegarti meglio?» gli domandai.
«Be’, vedi» cominciò, «queste tre ragazze si erano unite al gruppo partigiano dei Babij, aiutate da tre amici. Tre ragazze di Bolechow: Frydka, Dunka Schwartz, e la terza era... la sorella dei due giovani che scamparono alla morte con i Babij, Ratenbach».
Non avevo idea di chi fossero, ma non lo interruppi. Aspettai che continuasse.
«Quei tre giovani presero a ben volere le ragazze» proseguí, «le aiutarono a rifugiarsi nella foresta dove si nascondevano i Babij. La foresta sorgeva dalle parti di Dolina, circa quattrocento ebrei si erano uniti ai partigiani».
Annuii: già un anno prima, al telefono, aveva accennato a quella storia.
«Naturalmente anche noi ci rifugiammo nella foresta, io Bob e mio padre. Cosí perdemmo i contatti. Quando tornammo, venimmo a sapere che quei tre ragazzi erano stati...».
Fece un gesto energico con il palmo della mano destra verso il bordo del tavolo, come a demarcare una zona.
«... erano stati portati in un campo fuori Bolechow e uccisi» concluse.
«Perché avevano aiutato le ragazze» dedussi. «Perché avevano aiutato le ragazze» confermò. Ecco una vicenda da raccontare, pensai.

Comunque appresi il resto della storia di Frydka e di Ciszko solo quando mi recai in Israele, a Stoccolma e a Copenaghen. Quel pomeriggio, a Sidney, non tornammo piú sull’argomento: era evidente che la signora Grossbard non avrebbe rivelato altro, anche se avessimo insistito. Chiesi invece di precisare la cronologia degli avvenimenti durante l’occupazione nazista.
«In che giorno arrivarono i tedeschi?» domandai.
Presero a borbottare, finché Meg disse, piú a se stessa che agli altri: «Il 1º luglio del 1941. Fu allora che vidi le prime pattuglie, li vidi arrivare».
Aggiunse che tre settimane dopo giunsero alcune unità fasciste ungheresi, che si fermarono due mesi.
«No» interloquí Jack, «rimasero solo qualche settimana, poi furono sostituiti dagli slovacchi».
Bob ricordava che i tedeschi erano arrivati a settembre, al che Jack replicò che «ufficialmente» i tedeschi erano arrivati il 1º luglio, ma erano stati preceduti da reparti ungheresi che avevano varcato le montagne, ed erano rimasti «alcune settimane».
Non ero particolarmente interessato alle date precise. «Quale fu il primo avvenimento saliente?» chiesi. Cercavo di farmi un quadro di quei primi momenti che precedettero gli orrori, uno sfondo in cui inserire Shmiel. Cosa ricordavano, com’era la situazione.
«Innanzitutto» rispose Jack «gli ucraini cominciarono ad ammazzare gli ebrei. Sai, chi aveva conti in sospeso...».
«Vedi» interloquí Bob «se ce l’avevi con gli ebrei, li uccidevi. Ti faccio un esempio. Dopo la ritirata dei sovietici, quell’estate del ’41, un sacco di giovani ebrei reclutati dai russi tornarono a Bolechow. Gli ucraini li aspettavano sul ponte, li guardavano negli occhi, e se reputavano che qualcuno fosse ebreo lo gettavano nel fiume. E poiché sotto il ponte era pieno di massi, puoi immaginare cosa accadeva».
Annuii, anche se, non avendo mai assistito a simili eventi, trovavo difficile figurarmi la scena.
L’accenno al fiume, lo stesso dove Frydka aveva fatto delle scampagnate – nel frattempo Meg mi aveva mostrato tutte le fotografie dell’album di Pepci Diamant che ritraevano le ragazze con gli sci, in costume, che facevano capolino con espressioni divertite da cespugli sulla riva di un lago, i capelli legati con dei fazzoletti – mi suscitò un ricordo da lungo tempo dimenticato. Il Sukiel, il fiume che attraversava Bolechow, dove da ragazzo mio nonno andava a pescare trote, era già stato teatro di scene terrificanti. Mio nonno mi aveva raccontato una storia risalente alla prima guerra mondiale. La cittadina si trovava proprio nel mezzo degli eserciti austriaco e russo, e veniva continuamente bombardata; durante i cannoneggiamenti lui, i fratelli e le sorelle – tutti eccetto Shmiel, già al fronte a combattere per l’imperatore – trovavano riparo nei boschi intorno alla città. Poiché alle volte quei terribili bombardamenti avevano luogo di notte, la madre aveva loro ordinato di legare le scarpe al collo prima di andare a letto, cosí nell’eventualità di una fuga precipitosa non avrebbero perso tempo a cercare le scarpe. Una notte, non avendo seguito il consiglio della madre – morale della favola: bisogna sempre prestare ascolto ai propri genitori – mio nonno non riuscí a trovare le scarpe mentre cadevano le prime bombe; scappò a piedi nudi, e insieme a Ruchel, Susha, Itzhak, Yidl e Neche, si precipitò sulla strada; ora, per raggiungere il bosco dovevano attraversare quel fiume, il Sukiel, ma l’acqua ribolliva per le bombe e lui si bruciò i piedi.
Una volta un bombardamento durò quasi un’intera settimana, poteva continuare mio nonno, e per chiarire questo punto cominciava un’altra storia. Erano rimasti intrappolati nella foresta per diversi giorni, terrorizzati all’idea di tornare in città, e per mangiare la sua famiglia e un gruppo di concittadini erano stati costretti a cacciare conigli. Accompagnava la storia con uno sguardo significativo, sapevo bene a cosa alludesse: quella di un animale cacciato non è carne kasher. Mio nonno veniva da una lunga schiatta di macellai ebrei; erano ben consapevoli di questo, «Ma quando è in gioco la vita, Dio perdona!» se ne usciva a quel punto...
Cosí quella notte si era lessato i piedi nell’acqua bollente del Sukiel. Ma la storia non finiva qui. Dopo una pausa a effetto, riprendeva il racconto. «Quella notte, un mio compagno di scuola morí bruciato nel fiume». Ancora adesso, al pensiero di quella parola, «bruciato», mi vengono i brividi. Chi può dire se fosse vero? «Quando tornammo in città, giorni dopo» concludeva, «trovammo la casa semidistrutta».
Ripensavo a questi racconti mentre Jack e Bob rievocavano la scena degli ucraini che scaraventavano gli ebrei giú dal ponte, i primi giorni di quel periodo terribile, oppure sulla riva del fiume, come aveva precisato Jack, mentre li uccidevano con le armi da fuoco.
«Ti ricordi quando ammazzarono Gartenberg?» chiese a suo fratello.
Bob annuí. «Sí, ricordo».
Recordo.
«Fu sotto il ponte» specificò Jack.
«Quello fu solo l’inizio» chiosò Bob.
Quel pomeriggio, per la prima volta, mi feci un quadro preciso della prima Aktion. Desideravo scoprire piú particolari possibile. Fu allora che Ruchele trovò la morte.
«La prima Operazione dei tedeschi» cominciò Bob, che voleva chiarire la differenza tra lo sterminio organizzato dei nazisti e le vendette casuali e private opera di alcuni ucraini, gente che viveva fianco a fianco congli ebrei «come una grande famiglia», per usare l’espressione di una gentile, anziana donna ucraina incontrata a Bolechow, «ebbe luogo il 28 ottobre del 1941».
Meg annuiva, il capo chino sul tavolo, l’espressione assorta. Poi, lentamente e distintamente, scandí: «Era un martedí».
Bob continuò: «Ne rastrellarono tra i settecento e i...».
Jack e Meg lo interruppero all’unisono: «Mille» precisarono.
«Mille» ripeté Bob. «Li rinchiusero per circa trentasei ore nel Dom Katolicki, il centro della comunità cattolica; i tedeschi bevevano sul palco, li costrinsero a genuflettersi, si ubriacarono e cominciarono a sparare nel mucchio. E dopo trentasei ore li caricarono su degli autocarri e li portarono fuori città, in un campo a Taniawa, dove avevano fatto scavare una fossa, e li uccisero tutti».
Questo mi raccontò Bob quella domenica, giorno del compleanno di mio nonno, quando Matt e io incontrammo i sopravvissuti di Bolechow. Alcuni giorni dopo, parlando da solo con lui, Bob mi disse: «Io ne ricordo settecentoventi, ma gli altri dicono che erano mille. Credo che avessero messo un’asse sulla fossa, li facevano salire sopra e sparavano. Con dei mitra, forse, non lo so. Ognuno cita un particolare diverso, a seconda di quel che ha sentito dire o di quel che ricorda».
«Come rastrellarono la gente durante la prima Operazione?» volli sapere. In famiglia circolava la storia di una certa lista in cui compariva Shmiel.
Bob rispose: «I tedeschi erano coadiuvati dalla milizia ucraina, i primi tempi avevano redatto una lista. C’erano i nomi degli ebrei piú in vista: dottori, avvocati, uomini d’affari. Volevano demoralizzare la città eliminando le personalità di spicco».
«E i tedeschi come avevano fatto a stilare questa lista?» domandai. «Come raccolsero quelle informazioni?». Erano appena arrivati, non potevano conoscere Bolechow e i suoi abitanti.
Bob spiegò che i collaborazionisti ucraini indicavano i nomi, le professioni e le abitazioni. «Credo che la lista comprendesse 140 o 160 nomi» affermò, «e se non trovavano le persone a casa, come accadde con mio padre, rastrellavano quelli che trovavano per strada».
«Avevano una lista, e Shmiel vi compariva» mi aveva detto una volta mio cugino Elkana; come avesse appreso questa notizia è ormai impossibile appurarlo. Doveva trattarsi della stessa lista di cui parlavano Bob e Jack. Eppure ero pressoché certo che Shmiel non fosse stato catturato durante la prima Operazione. Da Israele zia Miriam anni prima mi aveva scritto di aver sentito dire che Shmiel era stato ucciso nel 1944, con una delle figlie, dopo che si erano uniti ai partigiani; a un raduno di sopravvissuti dell’Olocausto mio fratello Matt aveva conosciuto un tale che aveva assunto il nome di Shmiel, una consuetudine di alcuni partigiani. E Jack, nel nostro primo colloquio telefonico, un anno prima, mi aveva riferito che a quanto ne sapeva lui solo Ruchele era stata catturata nella prima Operazione. Cosí conclusi che se Shmiel era su quella lista («cosa molto probabile», a sentire Jack) quel giorno, quando tedeschi e ucraini avevano bussato alla sua porta, non doveva trovarsi a casa.
«La gente a Bolechow mi ritiene un uomo ricco» si era vantato in una lettera. Se era cosí, alla fine questo gli si era ritorto contro.
Quel giorno a Sidney volli sapere come fu catturata Ruchele.
«Sfortuna» rispose Jack, pensieroso. «Vedi, c’erano quattro ragazze amiche intime. Ruchele e altre tre. Tre su quattro morirono quel giorno. Immagino che si siano incontrate da qualche parte – si erano date un appuntamento, poi vennero catturate e portate via».
Ascoltando quel racconto pensavo alla fotografia di Ruchele in mio possesso: una formosa ragazza bionda sorridente, con i capelli crespi dei Mittelmark ereditati dalla nonna, simili a quelli che avevo da adolescente. Una fanciulla graziosa, dolce, «tranquilla», secondo la descrizione di Jack. Nell’ottobre del 1941 aveva sedici anni...
Ma questo accadde in seguito. Adesso volevo saperne di piú di quella giovinetta che il mio interlocutore settantottenne aveva frequentato per almeno diciotto mesi piú di sessantaquattro anni prima. Quando gli avevo chiesto di descrivermi Shmiel, Boris aveva risposto: «Faceva il macellaio». Avevo sbagliato a non prepararmi le domande giuste, credendo stoltamente che fosse possibile farsi un’idea di qualcuno semplicemente domandando: Com’era? Certo, non sapeva granché; del resto, se qualcuno mi chiedesse di descrivergli un vicino di casa che quarant’anni fa viveva di fronte, probabilmente potrei solo rispondere: Faceva l’ingegnere, era una famiglia molto simpatica. E allora, cosa potevo aspettarmi? Inoltre la signora Grossbard, che serbava reminiscenze molto piú nitide degli altri, si mostrava troppo gelosa dei ricordi di Frydka per condividerli liberamente con me; era questo il motivo della freddezza, della peculiare reticenza avvertita sin dall’inizio. Poi, quando era venuta fuori la storia di Frydka e di Ciszko Szymanski, mi aveva come sbattuto la porta in faccia, era diventata sospettosa sui motivi che mi spingevano a porre tutte quelle domande, quasi temesse che il mio desiderio di conoscere i fatti, la ricerca di un dramma in grado di animare le vite altrimenti perdute di quelle persone, riducesse la sua Frydka a un pupazzetto, una marionetta.
Cosí, sino a quel momento il tentativo di riportare in vita gli scomparsi era fallito. Però avvertivo distintamente che Jack comprendeva il mio desiderio; bisognava solo trovare il momento giusto per farlo parlare. Molto incisivo nelle conversazioni, è invece all’antica in fatto di cortesia. Non interrompe mai l’interlocutore, ed è pronto a scusarsi quando si rende conto di aver sbagliato un nome o una data (al contrario, non ho mai sentito la signora Grossbard scusarsi, anche perché sembra che ricordi perfettamente). Questo suo riserbo, supposi, lo rendeva riluttante a entrare nei particolari della sua relazione con Ruchele, cosí feci in modo di parlargli da solo, il pomeriggio seguente, sempre lí da lui. L’ambiente era tranquillo – Sarah era uscita, aveva lasciato il dolce e il caffè – e la conversazione fu piacevole.
Rievocò i primi ricordi che serbava di Ruchele, risalenti ai quattordici anni, quando la incontrava alle riunioni serali alla Hanoar Ha Zioni, l’organizzazione sionista. «Si riuniva tutte le sere» mi spiegò. «Era organizzata per età, facevo parte di un gruppo di coetanei, e lei stava con ragazze della sua età».
«Ragasse» pronunciò. A quanto pareva, per gli ebrei adolescenti di Bolechow gli incontri della Hanoar rappresentavano la maggior occasione per socializzare. «In Europa» proseguí Jack «il pranzo principale era a mezzogiorno. La sera si mangiavano solo dei panini, e poi si andava agli incontri alla Hanoar. Direi che d’inverno le riunioni duravano, diciamo, dalle cinque e mezza alle dieci, d’estate dalle sette e mezza otto fino alle dieci. Ogni giorno, e il sabato dall’ora di pranzo fino a sera. Sapete, andavo a scuola con il treno, frequentavo la scuola superiore a Stryj, dovevo studiare, la giornata era impegnativa. Ma quelle ore alla Hanoar erano le piú piacevoli. Giocavamo, ballavamo le horas 9, si tenevano conferenze, cose del genere. Probabilmente conoscevo già le Jäger, ma è da allora che ne conservo memoria».
«Com’era?» domandò Matt.
Jack sorrise; dopo qualche attimo rispose: «Era bionda, a me piacevano le bionde. Era una bellissima ragazza, aveva capelli lunghi, come si chiamano quei...
(con la mano mimò dei boccoli che cadono sul collo)
«... e aveva le trecce. Mi sembra che avesse gli occhi verdi, uno (a quel punto portò l’indice e il pollice vicino all’occhio socchiuso, come a indicare una piccola quantità) con una spruzzata di castano.
«Insomma» concluse «era la mia cotta da adolescente, come si diceva, il mio amore, ne ero molto preso».
Domandammo come si conobbero.
Jack ci raccontò una storia divertente. «Non ero il primo ragazzo» ci spiegò. «C’era un tale che usciva con lei, piú grande di me di un anno, anche lui andava a scuola a Stryj. Mundzio Artman. Era un giovanotto molto religioso e il sabato non si recava a scuola – andava via il venerdí, restava fuori il fine settimana e tornava il sabato sera. Cosí mi disse: «Senti, bada a lei il sabato». Be’ è quello che feci! Lei si raffreddò nei suoi confronti e io mi infervorai. Avevo quattordici anni, forse tredici, eravamo coetanei».
«Quando a Bolechow si usciva, alla fine degli anni Trenta, che si faceva?» chiedemmo.
«Per lo piú ci si incontrava alla Hanoar, e comunque i ragazzi non erano separati dalle ragazze, facevamo tutto insieme. Discutevamo, parlavamo. Naturalmente era molto piú matura di me. Lo capii in seguito. Vedete, a me la scuola non piaceva. Be’, non ero portato allo studio!».
Rise bonariamente, con un velo di autocommiserazione. Quando disse «allo studio» sorrisi. Anni dopo questa conversazione, il figlio della signora Begley mi confidò che per lui la parte piú ostica della grammatica inglese erano le preposizioni.
«Mi ricordo» proseguí Jack, «quando portai la pagella alla fine dell’anno. Ruchele era lí sul treno, o forse a scuola, a controllare i miei risultati. Non vi dico la sua delusione quando li vide! Credo che alla fine si sia un po’ raffreddata nei miei confronti...».
Matt era di buon umore. «Voleva un dottore!» scherzò. Anch’io ero contento, ma per un’altra ragione. Mi era molto piaciuta l’espressione «piú matura di me». Conferiva a quella ragazza, di cui adesso posseggo una fotografia, una certa consistenza. Significava che aveva le idee chiare in fatto di ragazzi; probabilmente aveva un’elevata opinione di sé. Dopo tutto era una Jäger.
Domandai a Jack se Ruchele andava bene a scuola.
Jack rispose con un mesto sorriso: «Questo non lo so. Ma suppongo che Frydka fosse la piú intelligente, perché fu l’unica a frequentare le superiori. Forse i genitori decisero che solo lei doveva continuare gli studi. Forse Ruchele era brava a scuola ma Shmiel a quel tempo non poteva permettersi di mandare tutte e due alle superiori».
Rimase per qualche attimo in silenzio, poi aggiunse, come a giustificare Shmiel: «Le tasse scolastiche erano alte. E poi c’erano le spese di viaggio, i libri, le divise...».
Le divise le avevo viste. Tra le fotografie che il giorno prima Meg aveva tirato fuori dalla busta di plastica accuratamente piegata ce n’era una, tra le piú vecchie, recante la data del 1936, quando le ragazze avevano quattordici anni: ritraeva Meg, Frydka e Pepci Diamant davanti a uno steccato un giorno d’inverno. Tutte e tre indossavano pesanti cappotti invernali scuri a doppiopetto con il collo di pelliccia, abbottonati con le cinte, stivaletti bassi e berretti scolastici. I visi paiono giovanili e delicati, quello di Frydka reca ancora qualche traccia delle rotondità infantili. In questa foto appare piú grande rispetto a un’altra mostratami da Meg, un’istantanea che apparteneva a Pepci («che morí, mentre il suo album sopravvisse» mi ripeté una seconda volta esibendomi lafoto), in cui Frydka è stesa a pancia in giú, il braccio destro piegato davanti, il mento appoggiato sul dorso della mano, mentre con l’altra tiene aperto (guarda un po’) un album di fotografie. Ha lo sguardo intenso rivolto verso destra, gli occhi lievemente all’insú. C’è qualcosa di teatrale, di studiato nella foto; è ancora una ragazza, ma già in posa. Le guance sono tonde, mentre nelle altre foto di Meg – l’istantanea che reca la data del 1940, dove Frydka ha un fazzoletto legato attorno al capo, stile babushka, gli occhi scuri e lo sguardo sereno, assorto, fisso sull’obiettivo; le foto di gruppo dove Frydka, Mege l’amica scomparsa Pepci Diamant sono intente a sciare, nuotare, o in posa – Frydka appare già una splendida ragazza: alta, di carnagione scura, il fisico slanciato, con un lampo divertito negli occhi.
«Cosí Ruchele non andò alle superiori» stava dicendo Jack. «A quel tempo frequentava la terza media, e poi cominciò ad apprendere rudimenti di sartoria».
A Jack non lo dissi, ma quelle notizie le avevo desunte dalle lettere di Shmiel, come quella in cui aveva scritto:
Mi sento molto solo qui e i fratelli della cara Ester sono inaffidabili, non ho niente a che spartire con loro, pensa che non hanno voluto aiutare Lorka ad avviarla al mestiere di fotografo.
Non sto qui a dirvi, miei amati, quel che dicono persino gli estranei, che ho i figli migliori e piú raffinati di Bolechow; che vantaggio me ne viene? La cara Frydka ha finito le superiori, mi costa una fortuna e chi l’aiuterà a trovare lavoro? La cara Ruchele ha finito le medie con ottimi risultati e nell’ultimo anno ha cominciato a studiare per diventare sarta...
«Quando frequentava le superiori Frydka andava in treno a Stryj» proseguí Jack. «Era alta; sapete, le ragazze me le ricordo...».
Alzò una mano e disse: «Aspettate, vado a prendere una borsa».
Lo osservai divertito, mentre usciva di corsa dal soggiorno per tornare dopo qualche secondo con una vecchia valigetta mal ridotta, e mimò Frydka, da lungo tempo defunta, che correva a prendere il treno con la cartella.
«Vedete, portavano tutte la cartella cosí» spiegò, facendo qualche passo nella stanza, tenendo la valigetta bassa di lato, come fosse pesante, «perché era piena di libri. Ma Frydka era alta, era una ragazza energica, e camminava cosí».
Poggiò la cartella sul petto e sorreggendola con un braccio ci sfilò davanti con passo deciso, imitando Frydka.
«Era sempre tra le prime a scendere dal treno, e la portava cosí».
Ma Frydka doveva aspettare. Ora volevo sapere di Ruchele, la ragazza tranquilla ma volitiva, ben consapevole del ragazzo che faceva per lei: un giovane destinato a farsi strada nella vita, probabilmente come suo padre.
«Per quanto tempo sei uscito con lei?» chiesi a Jack.
«Un anno e mezzo, due» rispose.
«Che ricordo hai dei suoi genitori? Li vedevi spesso?».
Jack assunse un’espressione divertita. «Certo! Non dimenticare che ci conoscevamo tutti. Era poco piú che un villaggio. Conoscevo i genitori, le sorelle. Ma non ci parlavo, non mi sono mai fermato a conversare con loro... Avevamo tutti un nomignolo».
Il giorno prima mi aveva parlato dei soprannomi delle altre città; adesso se ne usciva con quelli delle persone.
«Il król!» esclamò all’improvviso. «Avevo una zia, la sorella di mia madre, che chiamava Shmiel Jäger il król – il re. Credo che stravedesse per lui».Trovavo difficile pensare che Shmiel potesse suscitare emozioni diverse dal dolore.
Jack proseguí, ridacchiando tra sé: «Parlava sempre di lui. Il re questo, il re quello. Il król. Forse era per il suo aspetto. Era il presidente del consorzio dei macellai, sapete, i macellai erano riuniti in un consorzio, e lui ne era a capo. Vendeva carne kasher, naturalmente, e ogni famiglia ebrea comprava quella che poteva permettersi».
Pensai a quanto avrebbe fatto piacere a mio nonno sentire quel ragazzo di Bolechow parlare in quei termini di Shmiel.
«Vedi» continuò Jack, «mio padre era benestante, ma non si sognò mai di acquistare un’automobile, nemmeno un cavallo col carretto. Invece Shmiel Jäger... A Bolechow c’erano solo due macchine, e una apparteneva a lui».
Ma ancora non volevo parlare di Shmiel; dovevo prima esaurire il discorso di Ruchele. Tirai fuori la sua fotografia, appartenuta a zia Sylvia, che gli avevo inviato per posta elettronica mesi prima, dopo quella lunga conversazione telefonica; una foto del suo passato, non del mio, speditagli senza riflettere sull’impatto emotivo che avrebbe suscitato in lui.
La prese teneramente e sorrise.
«Sí, me l’hai mandata. Era proprio cosí, una splendida fanciulla. Guarda il sorriso. Aveva un sorriso meraviglioso. Era proprio cosí nel ’39. Aveva un bellissimo cappotto, con il colletto di pelliccia».
Inconsciamente portò la mano al collo.
«Quando la vedesti l’ultima volta?» gli chiedemmo.
«L’ultima volta che la vidi fu a Yom Kippur nel 1941» rispose. «Stavamo pregando fuori dalla shtiebl».
Shtiebl: erano anni che non sentivo quella parola. Era una piccola shul, una casa di preghiera, di solito uno scantinato, una parte di un edificio piú grande. Forse con un certo disprezzo mio nonno chiamava cosí la sinagoga di Lubavitch dove si recava a pregare nell’ultimo periodo della sua vita, una casupola nell’Ottava strada di Miami Beach; vi andava non perché gli piacesse Hasidim, tutt’altro, ma perché era l’unica shul nei paraggi di casa sua, la casa dove alla fine si uccise.
«Stavamo pregando fuori dalla shtiebl» stava dicendo Jack, «sul retro c’era un giardino confinante con quello di una sua amica, Durst. Yetta Durst. Fu lí che vidi Ruchele».
Non fu la prima volta che pensai: «Ogni nome che cita di sfuggita è una persona, un individuo con una propria vita. Forse Yetta Durst aveva una cugina, uno zio a New York. Magari un figlio o un nipote di quella persona, un uomo o una donna di una quarantina d’anni, avrebbe cominciato le ricerche della scomparsa Yetta Durst, che infine lo avrebbe condotto in Australia, per incontrare Jack Greene...
«Yetta Durst» ripeté Jack, perso dietro i ricordi. Quando pronunciò di nuovo quel nome percepii un’ombra di soddisfazione: era lieto di rammentarlo.
«Vidi Ruchele, ricordo che arrivò mentre stavo pregando, ero fuori, pregavo fuori e lei giocava nel giardino con quella ragazza... o forse sapeva che mi avrebbe trovato lí».
Matthew chiese: «E cosa le dicesti?».
«Non molto» rispose Jack dopo un attimo di esitazione.
Era assorto.
«Non ricordo... Non ci eravamo lasciati, ma il rapporto si era allentato. Io ero ancora molto coinvolto, ma lei no. Sono convinto che desiderasse un ragazzo piú maturo. È quello che interessa di piú alle ragazze. Era Yom Kippur del 1941. Fu l’ultima volta che la vidi. E poi, sapete, quattro settimane dopo ci fu la prima Operazione. Venne uccisa quattro settimane dopo» concluse Jack.
È difficile da spiegare, ma in quel momento trovai strano che si parlasse della sua morte. Avevo la sensazione di cominciare appena a conoscerla.
Ho cercato spesso di immaginare cosa le accadde, per quanto puntualmente mi scontri con l’esiguità delle fonti di cui dispongo. In che misura si può conoscere il passato di coloro che sono scomparsi nel nulla? Si possono leggere libri, parlare con chi c’era, studiare le fotografie, recarsi nei posti dove quelle persone vissero, i luoghi degli avvenimenti. Qualcuno può rivelare: avvenne quel tal giorno, mi sembra si sia incontrata con delle amiche, era bionda.
Ma, inevitabilmente, sono solo approssimazioni. Sono stato a Bolechow, ma oggi la città è del tutto diversa, molti edifici sono scomparsi, altri irriconoscibili, l’operosità che la caratterizzava negli anni Trenta cancellata da sessant’anni di ristagno economico e povertà sotto il giogo sovietico. Quella da me visitata conserva solo una vaga somiglianza con il luogo dove Ruchele passò le ultime ore della sua vita. E se anche esistesse una fotografia della città, per dire, risalente al 28 ottobre 1941, giorno in cui Ruchele fu catturata, potrebbe suggerirmi l’esatta percezione di quel che vide mentre la portavano al Dom Katolicki? Non credo (ignoriamo che strada percorse, se procedesse a capo chino o si guardasse intorno nel tentativo di lanciare un’ultima occhiata alla città; se fosse consapevole che non l’avrebbe piú rivista). Insomma, cosa vide. E che dire degli altri sensi? L’aria di Bolechow aveva un suo odore particolare, per i reagenti chimici usati nelle concerie – ce n’erano oltre un centinaio, ci è stato riferito. Cosí, mentre Ruchele procedeva verso la morte, avvertiva quel sentore intenso? Qual è l’odore di mille persone terrorizzate condotte alla morte come bestie? E l’odore di una sala dove mille persone terrorizzate sono state rinchiuse per un giorno e mezzo, senza servizi igienici, con la stufa accesa, i corpi di decine di morti, trucidati con raffiche di mitra, e una donna in travaglio? Non lo saprò mai. E i rumori? Un testimone può aver scritto o raccontato: «La gente gridava e piangeva, suonavano il pianoforte», ma in vita mia l’urlo piú tremendo che abbia sentito fu quello del mio fratellino Matt quando quasi quarant’anni fa gli ruppi il braccio; a essere onesti in realtà non ne ricordo il suono, rammento solo le grida; e il pianto piú disperato fu quello udito al funerale di un amico morto troppo giovane, ma sospetto che l’intensità dei lamenti dei bambini feriti, per quanto gravemente, non sia la stessa di quelli di uomini di mezza età a cui vengano cavati gli occhi, o siano costretti a sedere su stufe roventi; e, ugualmente, lo strepito prodotto da una sessantina di persone in lacrime a un funerale non è lo stesso di quello di mille persone terrorizzate in attesa della morte. In realtà, se leggessimo una descrizione degli avvenimenti della prima Operazione a Bolechow, ci rappresenteremmo le immagini e i suoni sulla scorta di quanto visto al cinema o alla televisione, vale a dire quelli prodotti da persone pagate per ricostruire al meglio delle loro capacità – sulla base di letture, sopralluoghi, ispezioni, avulsi da esperienze personali – gli eventi nel modo piú realistico possibile: in ultima analisi, nient’altro che una semplice approssimazione.
Dunque esiste anche il problema della rappresentazione delle altre percezioni sensoriali.
Qualcuno potrebbe obiettare: Be’, questi dettagli non sono fondamentali. Basta conoscere i fatti, tramandarli per non dimenticare. Ma il mio intento, almeno in parte, sin da quando mi misi sulle tracce dei miei parenti scomparsi, è sempre stato quello di acquisire anche il minimo particolare ancora conoscibile che li riguardasse, l’aspetto fisico, la personalità e, naturalmente, le modalità della morte, ammesso che esistesse ancora qualcuno in grado di dirmelo; tuttavia, piú parlavo con le persone, piú mi rendevo conto di quanto in realtà ciò fosse impossibile; in parte perché nessuno ha osservato certi particolari – il colore del vestito, che strada percorsero – che quindi rimangono inconoscibili; e quand’anche vi fossero dei testimoni oculari, la memoria può giocare degli scherzi, elidere ricordi eccessivamente dolorosi o modificare una realtà troppo cruenta da accettare.
Penso sia importante essere consapevoli di questo anche mentre cerchiamo di figurarci ciò che accadde a Ruchele e agli altri, cosa che non possiamo fare veramente.
Allora, cosa può essere accaduto quel giorno? Sebbene nell’ottobre del 1941 la situazione fosse spaventosamente critica, gli omicidi di massa non erano ancora stati messi in atto. È quindi possibile che quel martedí Ruchele si fosse data convegno con delle amiche. Esce dalla casa paterna, a un piano, dipinta di bianco, forse promettendo alla madre, Ester, una corpulenta, affabile signora, che non sarebbe stata via a lungo. Percorre via Dlugosa diretta verso la Rynek. Forse da lontano scorge le amiche, le saluta con un cenno della mano e s’incammina verso di loro. Poi, all’improvviso, un tramestio, un accorrere di ucraini e di tedeschi, cani che abbaiano, ufficiali sconosciuti che sbraitano, ordinano di incolonnarsi agli altri, di andare di qui e di là. Le tre amiche sono spaventate, ma almeno sono insieme. Adesso procedono con un gruppo di ebrei verso il Dom Katolicki, dove erano solite recarsi a vedere i film.
Ma a questo punto la mente si blocca, è inutile fingere di poter immaginare le sofferenze di Ruchele Jägerin quel giorno e mezzo che seguí. Anche se mi sono fatto un’idea su ciò che accadde in quelle trentasei ore, non c’è modo di ricostruire le sue emozioni. Per prima cosa, nessun sopravvissuto la vide (decenni prima, qualcuno aveva detto a mia madre che le ragazze erano state violentate e uccise dai nazisti. Ruchele venne stuprata nel Dom Katolicki? Impossibile dirlo, oggi). E comunque con gli scarsi frammenti della sua personalità recuperati dall’oblio, è impossibile immaginare il suo stato d’animo, ricostruire il vissuto anche di un solo secondo di quelle ore.
Eppure un tentativo va fatto. Anche supponendo che Ruchele non venne picchiata, violentata o uccisa in quelle trentasei ore in cui insieme ad altre mille persone venne rinchiusa nel Dom Katolicki, certamente è possibile farsi un’idea di quel che provò una ragazza sedicenne dell’epoca, di buona famiglia, costretta ad assistere a uccisioni, torture e violenze di ogni tipo. Per esempio, l’episodio che Jack raccontò a me e Matt quel giorno che parlammo da soli con lui, la scena del rabbino da lei conosciuto sin da bambina, a cui vengono cavati gli occhi, incisa una croce sul petto e infine costretto a danzare nudo con un’altra giovane donna terrorizzata...
Qual è la fonte di questa come di altre informazioni?
A Bolechow, Olga ci aveva riferito un particolare che aveva sentito raccontare: la piramide umana.
Jack ci disse che al rabbino venne incisa una croce sul petto, ma non ne fu diretto testimone (durante quella conversazione gli domandai come facesse a sostenere con certezza che Ruchele era morta nella prima Operazione). Gli chiesi stupidamente se aveva assistito alla sua cattura. Reagí con una torva risata. «Se l’avessi vista non sarei qui a parlare con voi!». E allora come faceva a saperlo? «Perché dopo» rispose lievemente spazientito «era scomparsa».
In seguito Bob Grünschlag mi raccontò una storia incredibile. Il giorno che cominciò la prima Operazione sua madre venne prelevata a casa, mentre il fratello maggiore fu catturato nello stesso posto dove si nascondevano Jack e Bob, in un fienile. Bob e Jack non furono scoperti; il forcone impugnato dal tedesco che rastrellava il fienile affondò a pochi centimetri dal viso di Bob. Alla fine era sgattaiolato via dal nascondiglio e con l’aiuto delle tenebre si era spinto fino al Dom Katolicki per vedere cosa vi accadesse. Lui e Jack lo chiamavano D.K., pronunciandolo day-kah.
«Si diceva che avessero catturato gli ebrei per deportarli in qualche campo di lavoro. E poiché era fine ottobre, quindi già inverno, pensai di portare degli indumenti di lana a mia madre, e cosí li feci preparare dalla domestica. Sapevamo che li avevano radunati nel D.K., il circolo. Cosí ci andai».
Ma Bob fu riconosciuto da alcuni ragazzi ucraini – fuori dall’edificio s’era radunata una folla, tutti cercavano di guardare dentro (tra loro v’era un tale che conobbi due anni dopo quella conversazione con Bob) – e dovette scappare a casa.
Comunque, gli indumenti di lana erano inutili.
Quindi Bob non aveva avuto modo di constatare con i propri occhi cosa stesse accadendo. E allora come facevano a sapere – come trapelarono quelle storie?
Bob mi spiegò che una loro vicina, la signora Friedmann, era miracolosamente sopravvissuta, grazie all’intercessione di una donna ucraina che aveva persuaso i tedeschi a liberarla. «Uscí dal D.K. e venne a casa nostra ventiquattro o trentasei ore dopo» spiegò Bob «e ci raccontò cosa era accaduto. Aveva visto mia madre lí dentro, e mio fratello. Sapete, avevano catturato prima mia madre, quindi lei non sapeva che mio fratello era lí, fin quando la signora Friedmann non glielo disse».
Smise di parlare, seguí qualche attimo di silenzio. Forse entrambi stavamo pensando che per la madre sarebbe stato meglio non sapere che suo figlio maggiore, Gedalje – sicuramente lo stesso nome del nonno paterno, il Gedalje Grünschlag che appare pomposamente nell’elenco dei commercianti della Galizia del 1891 – era destinato a morire nel D.K.
Dopo qualche attimo, Jack interloquí: «Era la stessa sala dove nemmeno otto mesi prima ero andato con Ruchele a vedere dei film».
Quindi, alcuni episodi li apprendemmo dai racconti della signora Friedmann. Per comprendere l’orrore che mia cugina Ruchele Jäger dovette provare durante le ultime trentasei ore della sua vita, sarà sufficiente il resoconto fatto dalla signora Friedmann ai Grünschlag. Il rabbino con la croce incisa sul petto, l’osceno episodio del rabbino accecato costretto a danzare con la ragazza nuda mentre qualcuno suonava il pianoforte, e lo stesso rabbino accecato, mutilato, gettato nelle fogne del D.K.
Ma è possibile apprendere particolari ancora piú precisi su quel che accadde nel circolo cattolico. Quella che segue è la traduzione di un documento che mi procurai dallo Yad Vashem nell’estate del 2003, pochi mesi dopo il viaggio in Australia, quando mi recai in Israele per incontrare altri «ex cittadini di Bolechow» (come si chiamano tra loro) segnalati dagli amici australiani. Si tratta della trascrizione di una testimonianza di tale Rebeka Mondschein, redatta in polacco e rilasciata il 20 agosto 1946 a Katowice, Polonia, dove la signora Mondschein si era trasferita dopo la guerra. All’epoca, quando gli avvenimenti erano ancora vivi nella memoria, i ricordi ricchi di particolari destinati a essere cancellati dal tempo, aveva ventisette anni. Ecco quel che riferí sulla prima Operazione:
Martedí 28 ottobre 1941 alle dieci di mattina arrivarono due macchine da Stanisławów, e si diressero verso il municipio della città. In una c’erano uomini della Gestapo con le camicie nere. Nell’altra ucraini con camicie gialle e berretti con le tese larghe. Questi ultimi subito dopo andarono a Taniawa per scavare una fossa profonda. In mezz’ora venne assegnato un ucraino a ogni uomo della Gestapo, e ogni coppia aveva una lista stilata nel municipio.
Sulla lista c’erano i nomi degli ebrei piú facoltosi e intelligenti. Gli uomini della Gestapo indossavano uniformi da combattimento. La gente pensava che stessero rastrellando uomini da destinare ai campi di lavoro. Dopo due ore avevano catturato tutti quelli che figuravano sulla lista. Tra questi c’erano: i rabbini Landau e Horowitz; il dottor Blumental; Landes, Isaak; Feder, Ajzyk; Frydman, Markus; il dottor Leon Frydman; Chief Dogilewski, sua figlia, saltò giú da una camionetta in movimento malgrado fosse incinta di quattro mesi e scappò. Erano in tutto 160 persone.
Il capo della Gestapo, il famigerato Krüger, arrivò da Stanisławów. Si fermò nel municipio per una mezz’ora e poi andò via. L’Operazione fu coordinata dall’ufficiale della Gestapo Schindler. Fu impegnata anche la milizia. Alle dodici cominciarono a rastrellare la gente nelle case e per le strade. Quando gli uomini della Gestapo uscivano dalle case, una folla di ucraini si riversava nelle abitazioni vuote per razziarle, mentre gli ebrei venivano condotti nella piazza della città. Gli uomini della Gestapo, i membri della milizia ucraina e numerosissimi giovani ucraini civili, tra cui ragazzi di dieci anni, davano la caccia agli ebrei. I prigionieri vennero tradotti nel Dom Katolicki al Campo Wołowski. Li fecero inginocchiare e sdraiare a faccia in giú. Molti si erano portati dietro vestiti pesanti, zaini e oggetti di valore,convinti di essere stati catturati per essere spediti nei campi di lavoro. All’ingresso del Dom Katolicki un uomo della Gestapo ordinò loro di lasciare tutti gli oggetti di valore e il denaro, minacciandoli. Addosso alla moglie di Abeg Zimerman, che dovette spogliarsi come tutti nella sala, furono trovati dei soldi. Fu ammazzata sul posto. Accaddero molti incidenti della stessa natura. Dopo un tentativo di fuga dalla finestra, in realtà l’unico, Ajzyk Feder venne ucciso.
Nella sala vennero radunate novecento persone. Erano tutti ammassati l’uno sull’altro. Molti morirono soffocati. Alcuni furono uccisi sul posto, con le armi da fuoco o con colpi sulla testa sferrati con mazze e bastoni, proprio lí nella sala.
Isaac Landes era talmente sfigurato che, in seguito, quando il dottor David Landes, suo figlio, esaminò uno a uno 29 cadaveri di persone uccise nel Dom Katolicki che erano stati portati al cimitero, non lo riconobbe.
Le persone venivano malmenate senza alcuna ragione; per esempio Schindler, in un accesso d’ira, spaccò una sedia sulla testa di Cyli Blumental per divertimento, sfracellandole il volto. Soprattutto i rabbini erano oggetto di violenze. Il corpo del rabbino Horowitz fu letteralmente fatto a pezzi. Uno degli uomini della Gestapo ordinò al rabbino di salire nudo su una sedia e declamare un discorso in lode della Germania. Quando disse che la Germania è grande, l’uomo della Gestapo lo colpí con un bastone di gomma, gridando: «Stai mentendo!». E poi urlò: «Dov’è il tuo Dio?». Nella sala al centro della folla la moglie di Beni Halpern stava partorendo, e in preda alla disperazione cominciò a urlare. Un uomo della Gestapo le sparò, ma la ferí soltanto, cosí le sparò ancora. Il corpo rimase lí fino al 30 ottobre. Anche il chimico Kimmelman morí in quella sala. Szancia Reisler, la moglie dell’avvocato Friedmann, venne costretta a ballare nuda su corpi nudi. A mezzogiorno i rabbini furono portati fuori e non si è saputo piú niente di loro. Si dice che furono gettati nelle fogne.
La gente fu tenuta in quelle condizioni dal 28 al 29 ottobre senza cibo né acqua. Alle 16.00 furono tutti portati con degli autocarri nei boschi di Taniawa, 8-10 chilometri da Bolechow. Circa ottocento persone furono trucidate lí. Avevano piazzato un’asse di legno a cavallo di una fossa,costringevano le persone a salirvi, sparavano e queste cadevano giú; alcuni erano gravemente feriti, altri piú lievemente. Ducio Schindler riuscí a scappare la sera. Si arrampicò su un albero, aspettò la fine dell’esecuzione e il riempimento della fossa. Ci raccontò tutto. Il giorno seguente, il 30 ottobre 1941, il sovrintendente Köhler ordinò allo Judenrat [il Consiglio ebraico designato dalle autorità naziste per agire come intermediario tra i tedeschi e la comunità ebraica e far eseguire i loro ordini] di pulire la sala del Dom Katolicki e portare i ventinove cadaveri al cimitero.
La Gestapo chiese il pagamento delle munizioni impiegate.
Lo Judenrat fu costretto a pagare. Oltre a ciò, pretesero tre chilogrammi di caffè solubile per le spese di manodopera.
Quindi sappiamo cosa accadde, anche se non è possibile ricostruire con certezza il destino di Ruchele. Molto probabilmente venne catturata dopo mezzogiorno di martedí 28 ottobre, mentre passeggiava per le strade della città con le sue amiche. Quindi fu condotta nel Dom Katolicki, dove verosimilmente fu testimone di alcuni degli eventi sopra descritti – anche se va considerato che agli ebrei fu ordinato di sdraiarsi sul pavimento e rimanere a faccia in giú, e coloro che non lo fecero furono per lo piú uccisi sul posto, quindi forse è piú corretto dire che, anziché essere testimone di quegli eventi, Ruchele udí spari, grida, strepiti, insulti, il suono del pianoforte e uno scalpiccio di piedi che improvvisavano una goffa danza sul palco.
È possibile che la sedicenne Ruchele trovò la morte lí, come alcuni altri. È anche possibile che fosse lei la ragazza nuda con la quale il rabbino, le cavità oculari sanguinanti, fu costretto a danzare sul palco, o a giacere sul suo corpo. Preferisco pensare che non sia cosí. E comunque, se dopo quelle trentasei ore fosse stata ancora viva, sappiamo che verso le quattro del pomeriggio del 29 ottobre, un mercoledí, dopo aver trascorso il giorno precedente, la notte e la mattina in uno stato di inimmaginabile terrore; dopo aver pianto in preda alla fame e alla sete e, senza dubbio, urinandosi addosso, poiché nessuno può resistere un giorno e mezzo senza espletare i propri bisogni, stremata, affamata, terrorizzata, insudiciata dalle sue deiezioni (situazione spiacevole persino da evocare col pensiero, un’esperienza penosa, profondamente umiliante per chiunque, ma che va tenuta in considerazione se si intende ricostruire cosa le accadde realmente), venne portata a Taniawa – è impossibile accertare se percorse a piedi quei pochi chilometri o se fu caricata su un autocarro – dove, dopo un’attesa ancor piú orribile, obbligata ad assistere alla morte di persone conosciute, gente che da sempre (be’, da sedici anni) aveva incontrato, allineate su una tavola di legno e abbattute sopra la fossa: dopo aver visto tutto ciò, venne inevitabilmente il suo turno di salire nuda sull’asse – è impossibile conoscere i pensieri che le attraversarono la mente negli ultimi istanti di vita, anche se viene spontaneo immaginare che pensasse al padre, alla madre, alle sorelle, a casa; ma forse («Lei è un sentimentale» mi apostrofò una volta la signora Begley, tra lo sprezzante e l’indulgente), forse, in un attimo fugace, pensò a Jakob Grünschlag, il ragazzo con cui era uscita per un anno e mezzo, con i capelli scuri e il sorriso caldo – e lí, sospesa sull’asse di legno, o forse sul bordo del fossato appena scavato, già colmo di cadaveri, nella fredda aria ottobrina, attese la morte. Sí, faceva freddo; sappiamo che era nuda, e per il gelo e il terrore di certo tremava. E intanto, mentre aspettava il suo turno, risuonavano in continuazione le raffiche dei mitra (chi aveva avuto la sventura di essere catturato si augurava un’altra morte. «Un colpo alla nuca, i tedeschi lo chiamavano il “colpo di grazia”» aveva ricordato la signora Grossbard il giorno che incontrammo i vecchi abitanti di Bolechow. Fece il segno della pistola con le dita della mano puntate sulla nuca. «Non posso pensarci. Quando sono turbata non riesco a ricordare»).
Insomma: le esplosioni roboanti delle armi da fuoco,il freddo, i brividi. Infine toccò a lei; avanzò con gli altri sull’asse di legno. Probabilmente la tavola si incurvava sotto il peso, forse oscillava: un movimento ludico, del tutto fuori luogo. Un’ennesima raffica. La sentí? Oppure a quel punto la mente freneticamente attiva non la captò? O, al contrario, l’udito, pronto a percepire quel suono, non aspettava altro? Chi può dirlo? Sappiamo solo che il morbido corpo di sedicenne – ormai, mi auguro, privo di vita, anche se è risaputo che alcuni caddero nella fossa ancora vivi, con un tonfo soffocato, finendo sui corpi dei loro concittadini, caldi, sanguinanti, imbrattati di escrementi – rotolò nella tomba. Questa è l’ultima immagine di lei, che mai nessuno vide.
E molto probabilmente tutto ciò accadde perché il giorno prima, a mattino inoltrato, era uscita di casa per fare una passeggiata con le sue amiche, tre compagne di scuola.
Jack ci informò che solo un sesto della popolazione ebrea perí quel giorno. (Solo...). Ma tra questo, tre delle quattro amiche.
Avevo notato che il verbo usato invariabilmente da Jack per le vittime dell’Olocausto è perire; al mio orecchio ciò conferiva alla sua conversazione uno spessore elevato, una risonanza biblica. Kill e dead, «uccidere» e «morto», sono vocaboli di origine germanica; la concisa finalità di quei sintetici monosillabi, in tedesco come in inglese, Tod come dead – non lascia spazio all’immaginazione. Perire, d’altro canto, dal verbo latino pereo, che letteralmente significa «passare attraverso», esprime un significato piú ampio; ha sempre evocato nella mia mente possibilità ben maggiori del mero evento della morte – ciò trova conferma nel mio vecchio dizionario di latino: «Spegnersi, non approdare a nulla, svanire,scomparire, perdersi; Trapassare, essere ucciso, perire; Spirare, perdere la vita, morire... Smarrire, fallire, sprecare, sciupare; Perdersi, andare in rovina, distruggersi». Dopo tutto quel che ho appreso parlando con gli anziani sopravvissuti di Bolechow, quando mi riferisco a coloro che persero la vita preferisco usare il verbo perire.
«Tre delle quattro ragazze perirono quel giorno» aveva detto Jack.
«Quindi lo sapevi» dedussi.
Non rispose subito.
«Be’, loro lo sapevano... Mio padre era membro dello Judenrat, cosí gli chiesi cosa era accaduto alla famiglia Jäger, e lui mi disse che una delle figlie era morta. E poi scoprii che era Ruchele».
Me lo raccontò nel nostro primo incontro, quando ci trovammo riuniti attorno al tavolo del soggiorno. Il giorno dopo, quando io e Matt tornammo a trovarlo,mi dette una versione lievemente diversa.
«L’Operazione ebbe luogo il martedí. La sera mio padre tornò dopo una riunione dello Judenrat. Mentre era lí, avevano prelevato mia madre a casa. Temeva di essere catturato, si era nascosto e quella sera tornò tardi. E cosí, non ricordo se la sera stessa o la mattina dopo, cominciai a interrogarlo: «Chi hanno preso?» gli chiesi, «E gli Jäger?». E lui rispose: «Una delle figlie».Al che domandai: «Quale?». Non lo sapeva, o forse non volle dirmelo... non so nemmeno se fossero al corrente che uscivo con lei. E due o tre giorni dopo mi mandarono da mia zia... be’, potete immaginare come mi sentivo dopo la perdita di mia madre e di mio fratello».
Non seppi cosa dire.
«Cosí rimasi qualche giorno da mia zia. Ricordo che la sera – forse il pomeriggio, o chissà, la notte – tornai a casa deciso a scoprire la verità: «Hanno preso una delle Jäger: chi?». «Ruchele» mi risposero. Fu un altro trauma. Quella notte non chiusi occhio, ricordo che mia zia, non sapendone il motivo, pensava che fosse per il dolore della perdita di mia madre...».
Rimase un attimo in silenzio, quindi proseguí.
«Ricordo che ogni ora, ogni ora e mezza, mia zia veniva in camera e si sincerava: «Ancora non dormi?». Pensavo a Ruchele, fu l’ennesimo shock».
Per Shmiel, Ester e le tre figlie rimaste, il destino di Ruchele era, fino a quel momento, la piú grande catastrofe delle loro esistenze. Non sapremo mai quel che passarono nei giorni seguenti la prima Operazione di Bolechow (Shmiel nel 1941 era ancora vivo, e dovette contribuire con del denaro quando lo Judenrat raccolse la somma richiesta dai nazisti all’inizio di novembre di quell’anno, come a dire che dovette pagare la pallottola o le pallottole che avevano posto fine alla vita di sua figlia). E ora so che per un breve periodo, tanto tempo fa, nella casa della zia di Jack Greene c’era qualcun altro che soffriva per Ruchele. Mentre Jack continuava il suo racconto, quel pensiero mi dava conforto.
«Vedete, sapevo che una delle figlie era perita» ripeté, «ma non sapevo chi».
Questa fu l’ultima cosa che appresi su Ruchele Jäger.

Nella parashat Noach ci troviamo ad affrontare un problema tristemente noto: l’uccisione di bambini innocenti. La parashat Bereishit, un racconto in apparenza incentrato sulla Creazione, si conclude con la consapevolezza di un Dio in preda al disgusto perché «la malvagità dell’uomo era grande sulla Terra», sentimento che lo porta – sono stati numerosi i commenti in merito a tale constatazione, anche abbastanza veementi – a «pentirsi» di aver creato l’essere umano («Cosa sta a significare ciò?» si chiede Friedman. «Se Dio conosce il futuro, come può pentirsi di un evento già accaduto?»). Come sappiamo, lo sconforto del Creatore è di breve durata, poiché subito dopo egli dichiara che «sterminerà» l’umanità, gli animali, rettili e uccelli.
La causa della collera di Dio, la natura del peccato che suscita il suo disgusto, è enunciata all’inizio della Noach. La terra, come Dio afferma in Genesi 6,11, è stata corrotta (vatishacheth); era corrotta (nish’chathah) – la parola ricorre anche nel verso seguente – perché ogni mortale aveva corrotto la sua vita (hish’chith). Qual è esattamente la natura di questa «corruzione»? Rashi nota che la radice consonantica del verbo ebraico sh-ch-th, ripetuta cosí di frequente in questi versetti, indica idolatria (in Deuteronomio 4,16, quando Dio ammonisce il suo popolo a non creare idoli per evitare di divenire creature corrotte, compare lo stesso verbo), e ancor piú suggerisce una eccessiva immoralità sessuale. Egli commenta cosí il versetto «tutta la carne a suo modo si era corrotta»: «Persino gli animali domestici, le bestie e gli uccelli avevano rapporti con esseri di specie diverse».
La natura della corruzione, quindi, ha a che fare con l’imprevedibile mescolanza di categorie che dovrebbero rimanere distinte, idea ossessivamente ricorrente nella religione ebraica, come appare sempre piú chiaro man mano che si procede nella lettura della Torah, dall’atto originale della Creazione universale, descritta come processo di separazione e divisione, al meticoloso risalto dato nei libri successivi, come nel Levitico, alla differenziazione delle cose in generi e specie, per esempio la distinzione dei prodotti caseari da quelli a base di carne, degli asciugamani a strisce rosse da quelli a strisce azzurre. E nelle istruzioni date a Noè per la costruzione, l’equipaggiamento e il carico dell’Arca, Dio ordina che le coppie di animali destinate a ripopolare la Terra dopo il Diluvio (quel secondo atto della Creazione) siano «della stessa specie» – indicazione che Rashi cosí commenta: «Quelle che rimasero fedeli alla propria specie, e non si corruppero».
La punizione per questa particolare forma di corruzione rispecchia perfettamente la natura del peccato, dal momento che il Diluvio scatenato da Dio ha l’effetto di cancellare la distinzione esistente tra le cose: quando si aprono le cataratte e l’oceano sommerge la terra, scompaiono le montagne e le configurazioni tipiche del paesaggio; quando infine esse riappaiono – cosí com’era accaduto all’inizio della parashat Bereishit, quando Dio per la prima volta separa l’acqua dalla terraferma – siamo indotti a pensare che si tratti di una seconda Creazione. Il legame tra peccato e punizione, altro esempio dell’ossessione presente nella Noach sul profondo legame esistente tra gli opposti, viene evidenziato da una significativa peculiarità della struttura verbale del testo: quando afferma «farò venire il diluvio di acque sulla Terra, per distruggere ogni carne» la parola che Dio pronuncia èmash’chitham, che, come il termine «corrompere», deriva dalla stessa radice sh-ch-th. Nella Noach, la punizione letteralmente si conforma al peccato.
Data la preoccupazione ossessiva della Torah per la divisione, la separazione, la distinzione e la purezza, ciò che sorprende nel racconto dell’annientamento della Creazione operata da Dio con il Diluvio è la decisione di distruggere «tutta la carne». La parola «tutta» appare problematica, poiché implica che degli innocenti periranno nel disastro, dal momento che in quella definizione si presume siano inclusi, per esempio, bambini e persino neonati – che ben difficilmente possono essersi macchiati del peccato di commistione di specie. Sorprendentemente, visto che in altri frangenti sa manifestare grande umanità, Friedman non si mostra affatto turbato dalla inquietante circostanza che Dio possa uccidere degli innocenti; si sofferma invece sulla «purezza» e la perfezione di Noè per mettere in risalto l’apertura mentale degli autori di questo racconto: «Ed è importante che una storia scritta da ebrei evidenziasse le virtú di chi ebreo non era...»; invero, questo brano è stato citato in occasione di certi dibattiti per sostenere la teoria dell’esistenza di una categoria di persone chiamate i Giusti tra le nazioni, vale a dire gentili che cercarono di salvare gli ebrei durante la seconda guerra mondiale – uomini come Ciszko Szymanski, sul quale avrei scoperto molto. D’altro canto, Rashi si confronta, per quanto cursoriamente, con le sinistre implicazioni della Noach. Il suo unico commento al versetto «per distruggere ogni carne che ha alito vitale sotto il cielo» è il seguente: «Dovunque alligni la promiscuità, si verifica una catastrofe che travolge buoni e cattivi». Ciò sembra implicare o che il peccato espresso dalla radice sh-ch-th corrompe tutti, anche chi ha un legame esilissimo con esso, persino chi è vittima della contaminazione delle specie; o che sono i colpevoli, attraverso il loro peccare indiscriminato, a cagionare anche la punizione degli innocenti – interpretazione che ha il pregio di esonerare Dio da ogni responsabilità.
Ma bisogna pur dire che nessuna di queste spiegazioni appare soddisfacente quando si abbandonino le astrazioni dei commentatori biblici e ci si soffermi a riflettere, per esempio,su quale atrocità rappresenti la morte di un bambino, per annegamento o in qualsiasi altro modo. Anche dopo aver riflettuto sull’interpretazione di Rashi è difficile non percepire, vista la costante preoccupazione della Torah di mantenere le distinzioni tra le cose, che la strage indiscriminata di innocenti e colpevoli nel racconto del Diluvio universale appare come una soluzione insolitamente affrettata e inquietante insomma, non kasher. Ma forse, in alcuni casi – quando si devono realizzare piani su vasta scala, come la riorganizzazione del mondo – la capacità di tenere a mente tutti i dettagli, di operare determinate distinzioni, diviene controproducente.
«Qualcuno sa con certezza quando perirono Shmieled Ester?» domandai dopo circa un’ora e mezzo di quella conversazione il giorno dell’incontro di gruppo. Ormai avevo adottato la parola usata da Jack, perire.
Meg rispose che secondo lei fu nella seconda Operazione.
Jack assentí: «Sí, lo credo anch’io, nella seconda Operazione. Dopo non li vidi piú». Poi però aggiunse:«Ma non ne sono certo».
Chiesi se qualcuno li aveva visti nei mesi intercorsi tra le due Operazioni.
«Dopo la prima Aktion» rispose Bob «ovviamente, sapete, la vita era cambiata. Eravamo costretti a portare una fascia sul braccio».
Annuii. Tra le istantanee di Meg ve n’era una eloquente, di certo scattata in quel periodo: Pepci Diamante un’amica in strada – Meg l’aveva identificata come una Flüchtling, i profughi delle zone circostanti riversatisi in città quando i tedeschi dilagarono in Polonia – con al braccio una fascia bianca con la stella azzurra di David. In questa foto le due ragazze sorridono. Mi chiesi chi l’avesse scattata, come pure cosa avesse pensato Pepci Diamant quando l’aveva inserita nell’album fotografico che, come sappiamo, le sopravvisse.
Jack spiegò: «Dopo la prima Operazione non si andava... non si usciva piú per le strade. Si poteva circolare solo in determinati orari, un’ora o due al giorno».
«Lo Judenrat» aggiunse Bob «doveva procurare la manodopera e tutto il resto, è cosí che andava. E naturalmente...»
(Mi chiesi perché avesse detto «naturalmente» a quel proposito, supposi che alludesse semplicemente alla sfortuna degli ebrei).
«... in quel periodo ci fu un’alluvione».
«Un’alluvione?» ripetei stupito. Per un attimo pensai a un’espressione metaforica. Un mare di disgrazie, un mare di guai, roba del genere.
Invece si riferiva a una vera alluvione. «Cominciò a piovere a dirotto» proseguí Bob, «tutti abbandonarono i campi e ci fu un improvviso rincaro dei prezzi dei generi alimentari. Eravamo ridotti alla fame. Nella primavera del 1942 un sacco di ebrei stava morendo – non un paio a settimana, ogni giorno moriva qualcuno. Morivano di fame».
Pensai a Shmiel e a Ester, alle tre figlie sopravvissute, asserragliati nella loro casa bianca in preda all’angoscia e al terrore. Nelle lettere spedite a mio nonno, al cugino Joe Mittelmark, a zia Jeanette e a suo marito,Shmiel si lamentava continuamente della penuria di denaro, delle spese da sostenere per far studiare le figlie, della difficoltà di acquistare un nuovo autocarro. E adesso, il periodo della Pasqua del 1942, ovviamente non c’era nemmeno lo straccio di un lavoro e la gente moriva di fame. Come si può tirare avanti, mi ero sempre chiesto, quando non esiste piú alcuna attività economica? Era impossibile; si moriva di fame.
Meg disse sommessamente: «Dopo la prima Operazione non si parlava altro che di cibo. Io mi sognavo il pane. Non i dolci: il pane».
Matt chiese: «So che è una domanda stupida e ridicola, ma... posso chiedere una cosa?».
«Certo» risposero tutti.
Matt voleva sapere cosa si provava, che atmosfera si respirava in città in quei giorni dopo la prima Operazione. Avevo notato che mentre io volevo scoprire i fatti, gli eventi in sé, il loro ordine cronologico, a lui interessava la sfera emotiva.
«Voglio dire» spiegò, «alcuni vostri familiari erano stati uccisi, era certo terribile. Quando vi incontravate per strada, in quel periodo, quando vi imbattevate in qualcuno durante le ore in cui vi era permesso di uscire, di cosa parlavate, dicevate frasi del tipo: “Mi dispiace, ho saputo di tua madre”, insomma, ne parlavate?».
A me non sarebbe mai venuto in mente di porre una simile domanda.
Meg rispose: «Si parlava solo di una cosa».
Jack si lasciò andare a un riso mesto, e corresse: «No, di tre».
Meg non rise ma raccolse la battuta di Jack.
«Sí» annuí, «di tre cose: cibo, cibo e cibo».

Mentre i quattro sopravvissuti discorrevano del periodo tra le due grandi Operazioni, io mi sforzavo di assemblare le informazioni apprese in quel momento con quelle già in nostro possesso. Zia Miriam – che trent’anni prima mi aveva scritto di aver parlato con alcuni sopravvissuti da lungo tempo morti prima che cominciassi a porle delle domande, con ogni probabilità piú vicini alle vicissitudini dei miei parenti, e di certo con ricordi piú nitidi – riteneva che Ester e due delle figlie fossero morte nel 1942, il che significava durante la seconda Operazione. Mi aveva scritto che la figlia maggiore si era unita ai partigiani ed era stata uccisa con loro: si trattava di Lorka, e questa voce aveva trovato riscontro con quanto rivelatomi dai sopravvissuti di Sidney. Invece, riguardo a Shmiel e a un’altra figlia, Miriam aveva sentito dire che erano morti nel 1944, mentre il gruppo di Sidney era pressoché certo che Shmiel, Ester e Bronia, la figlia minore, fossero stati catturati durante la seconda Operazione.
Da queste informazioni ricostruii con una certa approssimazione gli avvenimenti: Lorka si era rifugiata nella foresta con i partigiani, molto probabilmente con il gruppo Babij, come tutti sostenevano. Riguardo agli altri, a Miriam era stato detto che Ester e due figlie erano morte nel 1942, mentre in effetti erano morte entro il 1942: Ruchele nell’ottobre del 1941, nella prima Operazione, Ester e Bronia nel settembre del 1942, nella seconda. Forse effettivamente Frydka era morta nel 1944, come sosteneva la voce citata da Miriam – dopo essersi unita ai partigiani, come ipotizzava il gruppo di Sidney (in ogni modo, concordavano tutti sul fatto che nel 1943, prima dello sterminio definitivo, fosse ancora viva).
Rimaneva solo Shmiel; qualunque fosse stato il suo destino, nel 1944 era ormai lontano anni luce dal mondo del 1939, quando scriveva lettere dalle quali promanava ancora stentorea la sua voce fiera, disperata, spavalda, fiduciosa, spossata, confusa. Mentre ascoltavo le reminiscenze del gruppo australiano, mi chiedevo cosa fosse accaduto a zio Schmiel.
Secondo Jack era stato preso nella seconda Operazione, perché in seguito nessuno l’aveva piú visto. Ma è pur vero, come mi aveva ricordato Meg, che in quel periodo vigeva il coprifuoco: molti non furono piú visti dopo la seconda Operazione, ma ciò non implicava necessariamente che non fossero ancora vivi. Eppure, se Shmiel era sopravvissuto alla seconda Operazione, Frydka, che Jack vide regolarmente dopo (si recava spesso a casa sua, nel frattempo trasformata in un lager, luoghi dove venivano assembrate persone costrette ai lavori forzati) ne avrebbe certamente parlato, e in tal caso lui lo avrebbe ricordato. Ma avendo incontrato spesso Frydka nel novembre del 1942, quando ormai erano tutti imprigionati in qualche lager – o già morti, o nascosti da qualche parte o deportati nel ghetto di Stryj – Jack aveva l’impressione che Shmiel fosse perito nel settembre del 1942, con la moglie e la figlia minore. Quindi forse l’informazione di zia Miriam non rispondeva alla realtà. Forse era solo una pia illusione (e in realtà, come mi ricordò Bob quando lo incontrai qualche giorno dopo quella riunione di gruppo, durante tutto il periodo dell’occupazione la gente spariva di continuo, non solo inseguito alle operazioni organizzate. «La gente veniva presa a caso, imprigionata e portata via» mi disse «come accadde al padre di Shlomo Adler, e quando la madre si mise a cercarlo, presero anche lei, con suo zio»). Quindi forse Shmiel venne catturato nel corso della seconda Operazione, o magari, semplicemente, un giorno sparí. Forse il vecchio partigiano di Washington si era sbagliato. Forse aveva assunto il nome di qualche altro Shmiel Jäger.
In quel pomeriggio a Sidney, mentre Jack e gli altri sopravvissuti di Bolechow parlavano mi convincevo sempre di piú che Shmiel, Ester e Bronia avessero trovato la morte nella seconda Operazione, la piú terrificante.
«Quando cominciò la seconda Operazione?» domandai.
«Nell’agosto del 1942» rispose Bob.
Ma Meg lo corresse, adagio ma con decisione: «Settembre. Il 4 settembre, il 5, il 6».
«Giusto» concordò Jack.
«È vero, scusate!» fece ammenda Bob.
«E cosí Shmiel, Ester e Bronia morirono in quell’Operazione» ricapitolai.
«È molto probabile» convennero tutti, «perché in seguito degli Jäger si videro solo Frydka e Lorka, che lavoravano già in uno dei campi di lavoro lí in città. Per questo, probabilmente, sopravvissero alla seconda Operazione».
«Lavoravano nella Fassfabrik, la fabbrica di barili, insieme agli Adler» precisò Jack.
Degli Adler sapevo che erano scampati due cugini: Shlomo e Josef, stabilitisi entrambi in Israele. Avevo saputo che Shlomo si considerava una sorta di leader dei sopravvissuti di Bolechow: scriveva email, organizzava in Israele incontri annuali. Era il piú giovane dei superstiti; dopo l’assassinio dei genitori, aveva appena tredici anni, si era nascosto con Josef. Scoprii che era oggetto di battute affettuose da parte degli altri per la passione dimostrata nei raduni dei sopravvissuti sempre piú sparuti di quella città, un tempo polacca. Sono convinto che dietro questo investimento emotivo si celi il desiderio di conservare un legame con i propri genitori, persi in tenera età. Comunque, in un certo qual modo Shlomo era diventato la voce ufficiale degli ebrei di Bolechow scampati; era stato lui a contattare mio fratello Andrew, dopo aver visto le registrazioni delle immagini girate nel nostro viaggio a Bolechow, che Elkana, il cugino israeliano, aveva mostrato a tutti; e fu lui a dissuaderci dall’idea di far erigere un monumento in memoria degli eccidi, sostenendo che gli ucraini avrebbero rubato i mattoni e le pietre.
Questo avvenne nell’autunno del 2001. Nell’estate del 2002, la stessa in cui Bob Grünschlag passò da New York e venne a gustare un tè freddo a casa mia, ricevetti una chiamata da Shlomo Adler, che mi preannunciava il suo arrivo a New York. Era ansioso di conoscermi. Ci incontrammo a casa mia in un pomeriggio afoso; erano presenti anche i miei genitori, a loro volta bramosi di conoscere quell’uomo della loro stessa generazione, che aveva conosciuto i parenti di mia madre a Bolechow. Si fecero le presentazioni: quando apprese che insegnavo lettere antiche, tutto imbaldanzito recitò ad alta voce il verso di una poesia in latino – credo fosse di Virgilio – imparata ai tempi di scuola a Bolechow una vita prima. Non ne ricordava piú il significato. Ci sedemmo tutti. Mentre gli mostravo le fotografie scattate nel viaggio a Bolechow nel 2001, indugiò davanti a quella che ritraeva il municipio, il ratusz, il Magistrat. «È qui che ebbe luogo la seconda Akcja» disse indicando la foto, usando la parola polacca per «Operazione». Shlomo è un uomo piuttosto robusto, con la corporatura solida da camionista; ha un volto affilato simile a un falco e parla gesticolando, il tipo di persona che ti punta il dito in faccia per chiarire il proprio punto di vista. Un tipo cosí non lo vorresti certo avere contro, pensai quel pomeriggio quando lo conobbi. Per questo rimasi sorpreso quando indugiò con il dito a mezz’aria davanti alla foto del municipio, alle cui spalle sorgeva la macelleria gestita da intere generazioni di Jäger, fin quando ve ne furono i discendenti. Nel Magistrat fu ammassata la metà degli ebrei di Bolechow ancora in vita dopo la prima Operazione, circa duemilacinquecento persone, in quei primi giorni di settembre del1942. Da lí le cinquecento persone sopravvissute alle uccisioni indiscriminate avvenute nel cortile del ratusz furono condotte alla stazione, caricate su vagoni e deportate a Belzec. Insomma, rimasi sorpreso quando, indicando la fotografia di quel pittoresco edificio scattata da Matt, quest’omone grande e grosso iniziò a tremare: prima il dito, poi la mano, quindi tutto il braccio venne scosso da brividi cosí violenti che mia madre, mossa a compassione, cercò di rassicurarlo: «Non si preoccupi, le prendo un bicchiere d’acqua». Dopo qualche minuto Shlomo riacquistò il controllo e si scusò: «Perdonatemi,lí sono successe cose tremende...».
«Quindi Frydka e Lorka lavoravano nella Fassfabrik con gli Adler» stava dicendo Jack. Molto probabilmente, a quel punto erano gli unici parenti di Bolechow sopravvissuti.
Pur non concordando sul giorno in cui ebbe inizio la seconda Operazione, tutti i presenti nel salotto di Jack convennero sul fatto che fu di gran lunga l’evento piú raccapricciante e devastante occorso agli ebrei di Bolechow.
La storia ce ne spiega il motivo. Tra la fine dell’estate e il principio dell’autunno del 1941, quando ebbe luogo la prima Operazione, subito dopo l’invasione nazista della Polonia orientale, e la fine dell’estate del 1942, quando fu messa in atto la seconda Operazione,gli intenti e i metodi dei tedeschi, signori assoluti dei territori occupati, il cosiddetto Generalgouvernement, erano mutati. In tutti i territori sottoposti dell’Europa orientale, nella tarda estate e nell’autunno del 1941, le squadre speciali delle SS, le famigerate Einsatzgruppen, ivi distaccate per sterminare gli ebrei, agirono piú meno come avevano agito i tedeschi e i collaborazionisti ucraini nella prima Operazione di Bolechow, in cui avevano perso la vita un migliaio di ebrei: li portavano nelle foreste, nelle forre o nei cimiteri, luoghi fuori mano dove erano state scavate delle fosse, spesso dagli abitanti stessi, e li uccidevano sul posto. Ma questo metodo di eliminazione degli ebrei si era dimostrato troppo traumatico per i membri delle Einsatzgruppen. In uno dei testi piú autorevoli sui campi di sterminio della Polonia orientale – i campi della morte della cosiddetta Operazione Reinard, Treblinka, Sobibor e Belzec – l’autore, Yitzhak Farad, spiega che «l’esposizione prolungata da parte dei membri dell’Einsatzgruppen allo sterminio di donne, bambini e anziani produsse un trauma psicologico cumulativo su alcuni di essi e si registrarono persino casi di collassi nervosi». A sostegno di questa affermazione, ormai attestata, Arad cita il resoconto di un testimone oculare riguardante la visita che il Reichsführer Heinrich Himmler fece a Minsk nella tarda estate del 1941, dove il capo delle SS assistette all’uccisione con arma da fuoco di un centinaio di ebrei – un decimo, vale la pena di ricordare, di quelli uccisi a Bolechow nella prima Operazione:
Quando cominciarono a sparare Himmler divenne sempre piú nervoso. A ogni raffica abbassava lo sguardo... Accanto a lui c’era l’Obergruppenführer von dem Bach-Zelewski...Von dem Bach si rivolse a Himmler: «Reichsführer, questi erano solo cento... Osservi gli occhi degli uomini di questo commando, guardi come sono profondamente scossi. Questi uomini sono finiti».
Arad nota che la parola tedesca da lui tradotta con«finiti» è fertig, il cui significato, come sappiamo, è anche «pronto», nell’accezione in cui la usava mio nonno,guardando la quarta moglie, la sopravvissuta di Auschwitz, mentre facevano i bagagli per la rituale vacanza estiva a Bad Gastein, la località termale austriaca dove inspiegabilmente insisteva per recarsi ogni anno: «Also, fertig?». «Allora, pronta?».
Poiché gli sfortunati uomini delle SS erano fertig, finiti, a causa degli estenuanti compiti cui erano sottoposti nell’estate del 1941, bisognava escogitare un metodo alternativo per risolvere la questione ebraica. Cosí si idearono le camere a gas.
Arad cita la deposizione rilasciata da Rudolf Höss, il comandante di Auschwitz, al processo di Norimberga:
Nell’estate del 1942, non ricordo la data precisa, fui improvvisamente convocato dal Reichsführer delle ss Himmler, che mi ricevette senza il suo aiutante. Himmler disse: «Il Führer ha ordinato che la questione ebraica sia risolta una volta per tutte e che siano le ss a portare a termine il compito. I campi di sterminio attualmente esistenti non sono in grado di portare a compimento le imponenti Operazioni previste...».Poco tempo dopo, Eichmann venne ad Auschwitz e mi rivelò i piani operativi che interessavano le varie nazioni coinvolte. Discutemmo modalità e sistemi per porre in essere lo sterminio. L’unica soluzione era usare il gas, data l’assoluta impossibilità di liquidare con armi da fuoco l’enorme numero di individui che sarebbero affluiti, senza contare il fardello troppo pesante da sopportare per gli uomini delle ss incaricati di occuparsene, soprattutto per la presenza di donne e bambini tra le vittime...
Per preservare il sistema nervoso degli uomini delle SS, alla conferenza di Wannsee, tenuta il 20 gennaio del1942, si stabilí che gli ebrei del Generalgouvernement, ammontanti (secondo stime tedesche) a circa 2.284.000persone, dovevano essere liquidati principalmente in campi di sterminio appositamente destinati a tal fine:Treblinka, Belzec, Sobibor. Questa Operazione venne poi battezzata Operazione Reinhard, in onore e memoria di Reinhard Heydrich, nominato da Hitler Protettore della Boemia e della Moravia, assassinato a Praga nel maggio del 1942. Heydrich, dicono, amava il violino.
Tutto ciò appartiene alla documentazione storica. Cito questi scarni dettagli documentari solo per spiegare perché la seconda Operazione di Bolechow, quella in cui Shmiel, Ester e Bronia persero la vita, almeno secondo i sopravvissuti di Sidney, fu radicalmente diversa,molto piú incisiva e violenta della prima.
La seconda Aktion di Bolechow fu cosí diversa perché rientrava nell’Operazione Reinhard.
«La seconda Operazione fu la piú imponente» affermò Bob. «Vi persero la vita duemila persone».
Seduta accanto a lui, lo sguardo fisso davanti a sé,con voce salmodiante e scandendo lentamente le parole, Meg lo corresse: «Duemilacinquecento».
«Li portarono a Belzec» continuò Bob.
«Sí» confermò Meg.
«Furono deportati a Belzec, al campo di sterminio»precisò Bob.
Questo lo sapevo già, naturalmente. La mia piccola città di Belz.
«Nelle vicinanze della cittadina, no?» lo sollecitai.
«Be’» rispose Bob «diciamo centocinquanta, centosessanta chilometri. Sai, è subito dopo Lwów».
«E questo avvenne nel settembre del ’42?».
«Loro dicono settembre, io ricordo agosto» rispose scanzonatamente Bob.
«Bob!» lo richiamò Jack. «È scritto nei libri di storia tedeschi».
«Posso solo dire quello che ricordo» replicò bonariamente Bob. «Non so quel che affermano gli storici».
Mi compiacqui della tenacia di Bob Grünschlag di fronte all’insistenza del fratello – e, ancor piú, davanti all’ostilità di Meg; denotava una qualità che avevo percepito in lui, il segno di un carattere energico e coriaceo dopo anni passati al sole di Bond Beach. Forse era la litigiosità tipica del fratello minore. Anche se nel caso specifico ero certo che avesse torto, condividevo la sua diffidenza verso i libri di storia, ben sapendo come sia facile cadere in errore, per quanto in buona fede – l’occhio che salta una riga nella trascrizione di un verso da un foglio di carta sbiadito – per non parlare di imprecisioni piú gravi, cosí frequenti, vista la fallacia della mente che ricorda in modo inesatto persino informazioni recenti, perché dobbiamo renderle compatibili con le nozioni acquisite in precedenza, costituenti per noi la verità storica.
Naturalmente è importante distinguere la tipologia degli errori – convenire sugli eventi importanti, per dirla con Bob. Malgrado ciò, le piccole sviste, una volta individuate, hanno l’effetto di turbarci, per quanto giustificabili siano; inevitabilmente, ci inducono a chiederci quali altri errori, prevedibili o insignificanti, possano celarsi nelle storie e, ancor piú, nei testi ai quali spesso concediamo un credito assoluto nel tentativo di ricostruire i «fatti». Tanto per citare un esempio, nel libro di Yitzhak Arad v’è un’«appendice A» in cui sono elencati i particolari delle deportazioni degli ebrei polacchi a Belzec riguardanti l’Operazione Reinhard tra la fine dell’estate e l’autunno del 1942. Quando aggiunsi questo libro alla mia biblioteca sull’Olocausto, costituita in gran parte, soprattutto all’inizio, su suggerimento di mio fratello Andrew («I padroni della morte è un libro imperdibile» mi raccomandò, e io seguii il suo consiglio, poiché dopo tutto anch’io appartengo alla categoria dei fratelli minori), diedi un’occhiata a questa appendice rigorosamente particolareggiata, cercando il nome Bolechow. Cosí scoprii che dalla città di Bolechow, appartenente alla contea di Stryj, vennero deportati duemila ebrei, informazione di cui ero già in possesso, che concorda con i racconti e le testimonianze dei sopravvissuti. I prospetti di Arad forniscono anche i dati delle deportazioni di massa dal terzo al sesto giorno dell’agosto del 1942. Evidentemente era questo che Bob ricordava, anche se Meg era certa che la seconda Operazione avesse avuto luogo il 4, il 5 e il 6 settembre; e, come vedremo tra breve, un altro sopravvissuto aveva affermato pubblicamente, appena quattro anni dopo l’Operazione, che fosse avvenuta il 3, il 4 e il 5settembre. Considerata la prevalenza delle testimonianze, mi sono convinto che l’imponente Operazione ebbe luogo in quei primi giorni di settembre, e suppongo che Arad sia in errore quando parla di agosto (niente di piú facile, considerando la vasta mole di dati riguardanti «settembre» che stava gestendo). Sono cresciuto ascoltando storie, ho trascorso anni negli archivi, so (tanto per fare un esempio) che la voce «Kornbuch» in realtà designa una donna il cui vero nome era Kornblüh, avendolo appurato da numerosi sopravvissuti, per cui non mi sconcerta questa discordanza tra testimonianze orali e fonti scritte, tra i dati acquisiti attraverso le conversazioni e le informazioni elencate e raggruppate in appendici di studi autorevoli. Dopotutto, se vi collegaste in rete al sito dello Yad Vashemper cercare gli Jäger di Bolechow nel database contenente i nomi delle vittime della Shoah, apprendereste –
o meglio, credereste di apprendere – che ci fu una ragazza di nome Lorka Jejger della quale si riferisce quanto segue:
Lorka Jejger nacque a Bolechow, Polonia, nel 1918 da Shmuel e Ester. Era nubile. Prima della seconda guerra mondiale viveva a Bolechow, Polonia. Durante la guerra era ancora a Bolechow, Polonia. Lorka morí nel 1941, a Bolechow, Polonia. Questa informazione si basa sulla testimonianza di suo cugino, sopravvissuto dell’Olocausto, rilasciata il 22/05/1957.
In realtà queste informazioni sono tutte errate. Innanzitutto, come sappiamo dal suo certificato di nascita, Lorka nacque il 21 maggio 1920 e, secondo numerose testimonianze di sopravvissuti, nell’inverno del 1942 era ancora viva. Inoltre, potrei aggiungere, praticamente tutte le informazioni della stessa fonte, la banca dati centrale dello Yad Vashem, riguardanti «Shmuel Yeger» (o «Ieger») e «Ester Jeger» (e le tre figlie che il database attribuisce loro: «Lorka Jejger», «Frida Yeger», e «Rachel Jejger») sono errate, dall’ortografia dei cognomi ai nomi dei genitori («Shmuel Ieger nacque a Bolechow, Polonia,nel 1895, da Elkana e Yona», errore che, pensai la prima volta consultando questi dati, cancella dalla storia la mia bisnonna Taube Mittelmark e con lei le liti fraterne che probabilmente portarono alla decisione di Shmiel di lasciare New York nel 1914 e di tornare a Bolechow) alle date di nascita e morte. A meno che, come nel mio caso, non si abbia un interesse personale che spinga ad acquisire nuove informazioni, non si sarebbe mai scoperto che i dati concernenti quelle sei persone disponibili nel database dello Yed Vashem sono quasi del tutto errati.
Insomma, sono abituato alle discrepanze tra i fatti ei «documenti», e non mi sorprendo piú di tanto. Ma so che per alcuni ciò può risultare inquietante.
In ogni modo, come Bob mi fece notare, sugli eventi importanti concordavano tutti. Durante la seconda Operazione si verificarono episodi raccapriccianti.
Bob mi raccontò in seguito che lui, Jack e il padre scamparono alla seconda Operazione perché quest’ultimo, capo dello Judenrat, era stato avvertito, e si erano rifugiati nel nascondiglio costruito dopo la prima Operazione.
«Ci nascondevamo dietro una doppia parete nel fienile» mi rivelò quando l’incontrai da solo. «Lo costruí un falegname ebreo dopo la prima Operazione. Vedi, sapevamo già che ci sarebbe stata una nuova Operazione,perché in altre città le Operazioni erano già cominciate qualche settimana prima. Il giorno prima papà venne a casa e ci avvertí: “È prevista per domani”. Cosí la notte ci nascondemmo, prima dell’inizio dei rastrellamenti. Andarono casa per casa, catturarono gli ebrei per le strade, nei campi. Poi li radunarono alla stazione, li caricarono sui carri bestiame e li deportarono a Belzec. Belzec era un campo di sterminio – solo un campo di sterminio».
Sapevamo entrambi cosa significasse. Una volta scesi dai convogli, a Belzec si finiva direttamente nelle camere a gas.
Le irruzioni, i rastrellamenti nelle case e nei campi: i Grünschlag non ne furono testimoni oculari, naturalmente. Come aveva detto Jack: «Se l’avessi visto con i miei occhi sarei morto anch’io». Eppure, grazie alla particolare ubicazione del nascondiglio, vennero a conoscenza di certi episodi accaduti nei tre giorni della seconda Operazione.
«Sentimmo che li conducevano ai treni» raccontò Bob «perché abitavamo lungo la strada che conduceva alla stazione. Percorrendo via Dolinska, dopo una svolta a destra vi si arrivava dritti. Li fecero passare di lí, per caricarli sui carri bestiame. Sentimmo i tumulti, gli strepiti, le grida e tutto il resto. Uscimmo solo quando tutto era già finito, e può immaginare com’era il nostro stato d’animo».
No, in realtà non potevo. Tuttora non posso. Ho provato piú volte a immaginare, a compenetrarmi nell’esperienza vissuta da zio Shmiel, Ester, Bronia quando vennero catturati, spintonati, trascinati via dalla casa bianca a un piano di via Dlugosa, l’abitazione ristrutturata quando vi si erano trasferiti, e poi costretti a percorrere il breve tratto fino al cortile del municipio, dove aspettarono per giorni fin quando non li obbligarono a scarpinare fino alla stazione ferroviaria. Jack e Bob serbano vividi ricordi di rumori, pianti, gemiti e urla dei duemila ebrei di Bolechow sopravvissuti ai primi giorni dell’Operazione, mentre venivano condotti ai treni; ma tutto ciò per me è impossibile da immaginare, perché non ho mai sentito il rumore prodotto da duemila persone in marcia verso la morte.
Eppure, per quanto sia opportuno evitare la tentazione di fantasticare, «immaginare» e poi «descrivere»vicende completamente avulse dalla nostra esperienza,almeno è possibile conoscere alcuni avvenimenti occorsi in quei tre giorni di settembre in cui ebbe luogo la seconda Operazione, sulla base dei resoconti di testimoni oculari. Naturalmente queste descrizioni non ci permetteranno mai di «sapere cosa provarono Shmiel,Ester e Bronia», poiché non v’è alcun modo di ricostruire le loro esperienze soggettive, nondimeno ci permettono di farci un’idea – imprecisa, certo – di quel che dovettero subire, visto ciò che accadde. Posso consultare, comparare e collazionare le fonti disponibili, tracciare un quadro verosimile e ricostruire gli ultimi giorni di zio Shmiel, sua moglie e le figlie, ma certo non potrò mai sapere come sia andata.
Tra le varie testimonianze di alcuni dei quarantotto sopravvissuti di Bolechow, ne ho scelta una a caso, rilasciata il cinque luglio del 1946 da tal Matylda Gelernter,di anni trentotto – nata quindi a Bolechow lo stesso anno del cognato di Meg e della zia di mia madre, Jeanette.La deposizione, rilasciata a Katowice, riguarda gli eventi accaduti in città durante la seconda Operazione:
Il 3, il 4 e il 5 settembre del 1942 ebbe luogo la seconda Operazione, stavolta senza liste: uomini, donne e bambini furono prelevati nelle case, nelle soffitte, nei luoghi dove si nascondevano. Furono catturati circa 660 bambini. Molti vennero uccisi nella piazza di Bolechów e nelle strade. L’Operazione cominciò nel pomeriggio inoltrato di mercoledí e si protrasse fino al sabato. Il venerdí circolò la voce che fosse conclusa. La gente decise di uscire dai nascondigli ma il sabato l’Operazione riprese e quel giorno le vittime furono molto piú numerose dei giorni precedenti. I tedeschi e gli ucraini davano la caccia soprattutto ai bambini. Li afferravano per le gambe e ridendo fracassavano loro la testa contro i bordi dei marciapiedi, cercando di ucciderli con un solo colpo. Altri li scaraventavano giú dalle case, e i corpicini si sfracellavano al suolo. Gli uomini della Gestapo si vantavano di aver ucciso seicento bambini e l’ucraino Matowiecki (era di Rozdoły, vicino Żydaczowy) affermava con fierezza di aver ucciso da solo novantasei ebrei, la maggior parte dei quali bambini.
Il sabato i cadaveri furono radunati e caricati su vagoni,quelli dei piú piccoli infilati dentro sacchi, portati al cimitero e gettati in una fossa. Backenroth, un membro dello Judenrat di Bolechów originario di Wełdzirz, telefonò da Drohobycz. Disse che martedí sarebbero arrivati «ospiti».Ma gli stessi ucraini di Bolechów, senza aspettare la Gestapo, prima di sera cominciarono a catturare e a uccidere ebrei. Io, con mio padre e mio figlio (di nemmeno due anni) andammo di corsa da un nostro conoscente ucraino, che aveva promesso di nasconderci. Ma non ci fece entrare. Tornammo a casa e ci nascondemmo in una nicchia. Il bambino aveva sete, piangeva in silenzio, perché era abituato a stare nascosto a causa delle altre Operazioni. Anche quando spararono a un ebreo proprio davanti al nostro nascondiglio, si spaventò ma rimase zitto.
Nella soffitta della casa accanto mia madre, mio fratello e mia cognata si nascondevano con un neonato di pochi mesi.Quando gli uomini della Gestapo e gli ucraini fecero irruzione nella soffitta del vicino, cercarono di scappare, scesero le scale ma giú c’erano altri uomini della Gestapo e ucraini seduti a ubriacarsi con acquavite di ciliegia che avevano trovato in cantina. Erano cosí intenti a bere che non fecero caso a loro, e quindi tornarono subito su. Ma il bambino cominciò a piangere. Mia cognata non aveva latte o altro per tranquillizzarlo. Lo coprí con un cuscino, e il bimbo morí soffocato. In quel periodo numerosi ebrei lavoravano nelle fabbriche. Anche loro furono rastrellati e condotti nella piazza della città, nei pressi del municipio. Su indicazione dei capi squadra delle fabbriche i piú abili furono rilasciati. Gli altri vennero uccisi poco dopo, lí in piazza e per le vie della città. I muri e le strade erano letteralmente ricoperti di sangue. In seguito furono ripuliti con l’acqua prelevata dal palazzo comunale. Alla signora Grynberg accadde un fatto tremendo. Gli ucraini e i tedeschi irruppero in casa mentre era in travaglio. A nulla valsero i pianti e le suppliche dei presenti: fu trascinata via con indosso solo una camicia da notte e scaraventata in un bidone dell’immondizia nel cortile del municipio davanti a una folla di ucraini che raccontavano barzellette e la beffeggiavano, mentre lei partoriva. Il neonato le venne strappato dalle braccia con tutto il cordone ombelicale e scaraventato a terra. Fu calpestato dalla folla. Lei si rimise in piedi, perdeva sangue, rimase per ore poggiata al muro del municipio, finché fu portata via con tutti gli altri alla stazione ferroviaria dove la caricarono sul convoglio diretto a Belzec.
La notte seguente l’Operazione gli ucraini depredarono le case. Andavano a piedi nudi. Tra l’altro, cercarono di forzare la serratura della nicchia dove eravamo nascosti. I nostri cuori si fermarono, eravamo come morti. Il mio bambino non fiatò. Nell’Operazione – settembre 1942 – che durò tre giorni, furono uccisi tra i seicento e i settecento bambini etra gli ottocento e i novecento adulti. La settantenne Krasel Streifer venne ammazzata nel suo letto, perché immobilizzata. Morí anche mia suocera, Jenta Gelernter, di settantuno anni. Fu tirata fuori dal letto in camicia da notte; non le permisero di vestirsi. Le spararono nei pressi del municipio perché non riusciva a camminare velocemente. Il resto degli ebrei catturati, all’incirca 2.000, furono tradotti a Belzec. Durante il viaggio, la signora Stern riuscí a saltare giú dal treno. Ci disse che molti erano fuggiti cosí. Disse anche che a una fermata intermedia, non ricordo quale, introdussero aria rovente nei vagoni e molti morirono bruciati o soffocati. La gente era tormentata dalla sete, particolarmente penosa era la situazione dei bambini, che morivano di fame e di sete. Alcuni per dissetarsi bevevano urina. La signora Stern balzò giú dal treno lasciandosi dietro una figlia di quattro anni. Anche lei era stata scovata nel rifugio dove si era nascosta, tradita dal pianto e dai gemiti del figlioletto di due anni. Quando si resero conto che tedeschi e ucraini erano vicini al nascondiglio, quelli che erano con lei le dissero che il bambino avrebbe fatto rivelare la loro presenza. Allora mise un cuscino sul piccolo; furono comunque scoperti, ma nel frattempo il bambino era soffocato.
Le Siczowcy ucraine [unità paramilitari che coadiuvavano le SS] giunte appositamente da Drohobycz aiutarono i tedeschi nella seconda Operazione. Durante la marcia verso la stazione ferroviaria di Bolechów, da dove furono tradotti a Belzec, gli ebrei erano costretti a cantare, soprattutto la canzone La mia piccola città diBelz. Chi non si univa al canto veniva percosso a sangue sulle spalle e sulla testa con il calcio dei fucili.
Questa è una descrizione sommaria di quel che accadde durante la seconda Aktion, un microcosmo dell’Operazione Reinhard – il cui scopo principale, come si evince dalle testimonianze, era rendere il Generalgouvernement completamente Judenrein, ripulendo dagli ebrei i territori occupati prima del decimo anniversario dell’ascesa al potere di Hitler, avvenuta nel 1933, anche se esisteva la finalità ben piú concreta di risparmiare agli uomini delle SS i traumi psicologici derivanti dalle uccisioni di bambini dell’età di Bronia, donne indifese, persone estremamente affabili e cordiali come zia Ester. Probabilmente non era altrettanto traumatico ammazzare un quarantasettenne come zio Shmiel, un uomo che, dopo tutto, aveva a sua volta imbracciato il fucile per combattere in nome del suo imperatore. Sin dalla prima telefonata di Jack Greene, quando cominciai a figurarmi la morte di Ruchele Jäger – e a studiare la letteratura sull’Operazione Reinhard – mi sono spesso chiesto se chi la uccise premendo il grilletto del mitra, appollaiato a poca distanza dall’asse di legno sospesa sulla fossa, ebbe poi qualche contraccolpo emotivo, ipotesi comunque davvero poco realistica. Ma ritengo che il momento dello sparo sia un particolare fondamentale; abituati a considerare lo sterminio in termini di «operazioni», «Aktionen» e camere a gas, espressioni alquanto astratte, non ci soffermiamo a pensare che c’era sempre qualcuno che presiedeva alle uccisioni (e ciò è ancora piú evidente nel caso di armi da fuoco, dove il legame tra il dito che preme il grilletto, il proiettile, la vittima e la decisione di dare la morte, appare estremamente chiaro e diretto). Ritengo sia altrettanto importante cercare di immaginare – stavo per dire «ricordare» – quel momento, nel tentativo di recuperare almeno un frammento della personalità o delle sembianze anche di una sola vittima, di una ragazza sedicenne completamente scomparsa dalla storia fin quando i viaggi per il mondo ci hanno permesso di incontrare chi un tempo la conobbe.
Questa, quindi, è una parziale ricostruzione degli eventi che caratterizzarono la seconda Operazione.
Ma prima di descrivere la morte di Shmiel, di Estere di Bronia, mi sembra doveroso cercare di immaginarli da vivi.
A questo punto, conosciamo già qualcosa di Shmiel.In realtà, dopo aver parlato con Jack e gli altri, mi sono fatto un quadro abbastanza chiaro. Per esempio, me lo immagino quel giorno, negli anni Trenta, quando fu scattata una delle fotografie che conosco cosí bene: a passeggio nel centro della città – un tempo, nei territori dominati dall’imperatore Franz Joseph, si chiamava Ringplatz, Rynek per le sue figlie, le quattro splendide fanciulle venute al mondo dopo la grande guerra, e che di conseguenza sono e si considerano polacche – me lo figuro attraversare la Ringplatz, la Rynek, mentre si reca alla sua bottega, il presidente del consorzio dei macellai, alto, in qualche modo sempre piú alto di quanto uno possa rammentare, elegantemente vestito con un completo col panciotto, un abito come quello indossato in un’altra fotografia che mi rimane di lui,risalente al 1930, che lo ritrae su un marciapiede, l’andatura decisa. Mi pare di averlo davanti, con un vestito simile, o anche con quello che sfoggia nella fotografia inviata ai familiari in occasione del suo quarantaquattresimo compleanno, nell’aprile del 1939, dove posa accanto al suo autocarro con gli autisti della sua ditta, due fratelli, un prospero commerciante con tanto di sigaro e orologio d’oro da taschino. Me lo vedo davanti, alto (anche Frydka, la secondogenita, era slanciata), florido, in atteggiamento appena sussiegoso, che procede tranquillo, sempre pronto a fermarsi per salutare conoscenti, con un accenno di superbia, tipica della sua famiglia, vestigia di tempi fiorenti ormai andati,quasi fosse un król, un sovrano, il nomignolo segretamente affibbiatogli, un po’ affettuosamente, un po’ per celia; naturalmente ne è a conoscenza, in questa cittadina si sa tutto di tutti, ma non se ne cura. Anche perché in fondo lusinga la sua vanità: in fondo era stato lui a decidere di restare in quella città quando ebbe la possibilità di emigrare, proprio per la volontà di essere un macher, un pesce grosso in un piccolo stagno. E quindi, perché non godersi quell’appellativo, il król, incurante del tono della voce con cui viene pronunciato? Eccolo lí, a passeggio, quel che si dice un grosso calibro, un uomo a cui piaceva farsi notare, che desiderava crearsi una posizione nella propria città, che molto probabilmente ritenne fino alla fine la migliore decisione mai presa quella di lasciare New York per tornare a Bolechow.
In seguito le cose si complicarono; a questo periodo difficile appartiene lo Shmiel delle lettere, una figura sempre vivida seppure un po’ appannata, comunque grandiosa, un uomo d’affari di mezza età con la chioma prematuramente ingrigita, fratello, cugino e mishpuchah dei suoi molti corrispondenti a New York i quali, man mano che passava il tempo, si era ridotto a supplicare,minacciare, persuadere, persino pateticamente, mentre era alla disperata ricerca di un modo per salvare la sua famiglia o, almeno, una figlia, la cara Lorka (perché proprio lei? Perché era la maggiore? La favorita? Impossibile saperlo).
Comunque, attraverso le sue lettere è possibile ascoltare la sua voce. Di Ester invero rimane poco, ormai – e questo anche perché anni fa a Miami Beach non volli mai parlare con la timida Minnie Spieler, che ben trent’anni dopo scoprii essere la sorella di Ester, poiché non la ritenni mai cosí interessante da informarmi su di lei. Dopo aver parlato con tutte le persone ancora in vita che conobbero zia Ester, per quanto non direttamente, posso affermare che di lei non è rimasto quasi nulla,salvo qualche istantanea e una caratteristica della sua personalità, la grande affabilità e cordialità (quando medito sull’annientamento della sua vita – annientamento parrà parola eccessiva, ma la uso nel senso etimologico piú pieno, ridurre a niente – non posso fare ameno di pensare che se non le fosse toccata quella sorte sarebbe potuta morire, per dire, di cancro al colon in un ospedale di Lwów, nel 1973, a settantasette anni, anche se oggi è difficile immaginare una cosa simile, visto che scomparve cosí giovane, talmente tanto tempo fa da sembrare appartenere a un passato remoto. Avrei potuto conoscere anche lei, come tutti i misteriosi anziani che durante la mia infanzia comparivano alle riunioni di famiglia; e le quattro ragazze, cristallizzate in un’eterna giovinezza, sarebbero state le «cugine polacche» di mezza età a cui io e i miei fratelli negli anni Settanta, d’estate, saremmo andati a fare visita. Quando gli espressi queste considerazioni, dopo qualche attimo di riflessione Andrew commentò: «Sí, questo significa che l’Olocausto non è un evento ormai passato, i suoi effetti si avvertono tuttora»).
Insomma, di zia Ester è rimasto qualche raro frammento, un volto che ho osservato spesso dall'alto, durante i viaggi che ho intrapreso per scoprire qualcosa di lei,di una donna vissuta per quarantasei anni prima di scomparire all’inizio di settembre del 1942. «Era molto affabile, molto cortese» mi disse Meg quel pomeriggio a casa di Jack e Sarah Greene. Qualche giorno dopo, quando dietro mia insistenza acconsentí a incontrarmi da solo a casa del cognato, le chiesi di spiegarmi come passava il tempo una casalinga affabile e cortese di Bolechow, nel periodo precedente la guerra che sconvolse tutto.
Meg si fermò a riflettere, prima di rispondere.
«D’inverno» cominciò «le notti erano molto lunghe. Spesso a casa mio padre giocava a carte con gli amici. Le donne invece lavoravano all’uncinetto o a maglia. Per lo piú ricamavano. Era il loro passatempo. I miei genitori giocavano anche a bridge e a scacchi.
«La casa degli Jäger era sempre molto pulita» aggiunse dopo un attimo.
Al termine della conversazione ripeté quel che mi aveva riferito qualche giorno prima sulla madre da lungo tempo scomparsa di Frydka Jäger, la sua cara amica: «Sua madre era una persona amabile. Frydka aveva preso da lei il carattere allegro». Durante questo secondo e ultimo colloquio Meg menzionò la personalità di Ester solo di sfuggita (ormai ho la certezza che sia impossibile recuperare particolari significativi su di lei, aneddoti vividi;d’altra parte, chi non ricorda le madri dei compagni di scuola come donne gentili e allegre?), perché in realtà stava parlando di Frydka.
«Frydka era come la madre» affermò Meg quel giorno. «Lorka era un po’ piú... era diversa».
«Diversa in che senso?» la incalzai.
Meg non rispose subito.
«Sembrava diversa, era diversa».
«Ma diversa come?». Disperavo di poter recuperare anche solo qualche frammento della personalità di Lorka, qualche dettaglio concreto in grado di farla emergere dall’anonimato.
«Come posso descriverla?» rispose Meg, allargandole braccia in un gesto esasperato, prima di aggiungere:«Aveva un altro carattere. Era diversa da Frydka. Non si somigliavano. Non sembravano nemmeno sorelle. Ruchele somigliava piú a Frydka. Ma Lorka sembrava... diversa».
Al quel punto desistetti. In definitiva, cosa si può dire di un individuo?
Quindi era estremamente problematico ricostruire la personalità di Ester. Probabilmente trascorreva le sere d’inverno a giocare a carte con gli amici, lavorava a maglia o a uncinetto; di certo teneva la casa come uno specchio. E a quanto pareva aveva un carattere espansivo. Era molto affabile, molto gentile, allegra. Comunque, questa descrizione è stata possibile, almeno in parte, grazie al ricordo di una donna anziana, che aveva trascorso l’adolescenza a Bolechow.
E Bronia? Anche dell’amatissima figlia minore, la piú piccola delle cugine di mia madre, non sappiamo pressoché nulla. In un certo senso, ciò dipende dalla sua tenera età: aveva appena dieci anni quando scoppiò la guerra, nemmeno tredici quando la seconda Operazione pose fine alla sua esistenza. Era troppo giovane per essere candidata al lavoro forzato, cosa che ad alcuni consentiva di vivere un po’ piú a lungo,in alcuni casi almeno fino all’Operazione successiva,un lasso di tempo comunque sufficiente per prendere la decisione di rifugiarsi nel campo partigiano dei fratelli Babji, anch’esso poi annientato, o nascondersi, come avevano fatto Jack, Bob e altri, e cosí riuscire a sopravvivere. Ma Bronia era troppo piccola, e le poche persone ancora vive nel 2003 che la conobbero non potevano che ricordarla come una ragazzina qualunque:è cosí che sono costretto a descriverla.
«Ricordo anche Bronia» mi disse Jack dopo la lunga rievocazione di Ruchele. «Era una bambina, la incontravo per strada e la salutavo: “Ciao, Bronia!”».
Era commovente il modo in cui pronunciava la parola «ciao»; vi era una nota di allegra quotidianità, un sapore demodé. La parola stessa – pur essendo solo la traduzione del termine polacco – rievocava il ricordo di un’epoca ormai scomparsa. Sorrisi.
Anche Jack sorrise. Bronia aveva quattro anni meno di lui, era coetanea di Bob, aveva solo dieci anni quando scoppiò la guerra. «Ruchele era nata nel ’25, credo a settembre, e Bronia, a quanto ricordo, era del 1929. Stava giocando nel cortile sul retro, io ero dietro il recinto e la salutai, “Ciao Bronia”. Era una bambina dolce, ancora molto infantile, giocava con i balocchi».
Forse fu quella dolcezza infantile a suscitare il sorriso di Meg quando venne menzionato il suo nome, il giorno della riunione dei sopravvissuti di Bolechow, mentre mostravo loro la fotografia che la ritraeva insieme ai genitori. «E Bronia!» aveva esclamato, il viso improvvisamente radioso. Eppure, quando qualche giorno dopo la incontrai da sola, avvertii la sua frustrazione per non riuscire a ricordare niente di lei – nemmeno di averla incontrata e salutata un giorno per strada.
«La piú piccola non la ricordo» aveva scandito adagio, nel soggiorno di casa del cognato. «Bronia. Ci ho provato, ho scavato nei miei ricordi, inutilmente. Lorkala ricordo, l’ho vista crescere, e Ruchele girava per casa. Ma Bronia niente... non ne conservo memoria, non so perché. Era appena una bambina».
Dopo qualche attimo aveva aggiunto: «Dovevo averla vista di sicuro, quando lei mi ha mostrato la fotografia l’ho subito riconosciuta. Ma non riesco...» e la voce le era mancata.
Bronia. In quell’unica, nitida fotografia che conservo di lei, risalente al 1939, quando doveva avere sui dieci anni, indossa un grembiulino scuro, calzini bianchi, e scarpe Mary Janes. Sorride. I suoi genitori, che al contrario di lei leggevano i giornali, hanno un’espressione ben piú grave.
Questo fu tutto ciò che riuscii a scoprire dei miei parenti scomparsi dopo aver parlato con il gruppo di australiani.
Probabilmente, ecco quel che accadde loro:
Il 3, il 4 o il 5 settembre del 1942, la porta di casa venne abbattuta (non mi figuro certo i tedeschi e gli ucraini bussare educatamente all’uscio: verosimilmente con il calcio dei fucili fracassarono l’uscio della casa dipinta di bianco). Per qualche ragione – molto probabilmente perché erano al lavoro alla Fassfabrik – Lorka e Frydka non erano in casa; trovarono Shmiel, Ester e Bronia e li trascinarono in strada (furono malmenati? Presi a calci? Colpiti con il calcio dei fucili? Chi può dirlo?) dove ci attendeva una moltitudine urlante e atterrita, in preda alle lacrime; vennero condotti al Magistrat, il ratusz, il municipio accanto al quale da generazioni sorgeva la macelleria della famiglia Jäger.
Nel cortile sul retro furono ammassati insieme a duemilacinquecento ebrei; quando mi figuro la scena, non posso scartare l’ipotesi che almeno uno, se non tutti e tre,non sopravvisse a quei giorni terribili. Per esempio, Bronia poteva essere tra i novantasei ebrei della cui morte si vantava il tronfio ucraino, per la maggior parte, come sappiamo, bambini. Forse fu scaraventata giú da una finestra; forse un miliziano ucraino la prese per le gambe e le fracassò la testa contro lo spigolo del muro del palazzo comunale, facendo schizzare intorno la materia cerebrale, e con essa la sua personalità, che nessuno, sessant’anni dopo, riuscirà a ricordare in alcun modo. O forse Ester, all’epoca una donna robusta, camminava troppo lentamente quando li trascinarono via, oppure, chissà,quel giorno era a letto indisposta, e per impazienza o solo per divertimento un tedesco o un ucraino sparò a quella donna grassa e malata, lí nel letto.
O forse un collaborazionista ucraino che quel giorno coadiuvava l’Operazione riconobbe Shmiel Jäger nella folla, magari era anche lui macellaio (come, per esempio, il padre dell’anziana Olga che avevamo conosciuto a Bolechow), membro del consorzio locale, e nutriva da tempo risentimento verso il mio prozio, gli si avvicinò e lo colpí con la pistola o con il calcio del fucile, o semplicemente gli sparò alla testa.
O anche, ipotesi ben peggiore, in qualche altra parte del corpo. «Ci si augurava di capitare nelle mani dei tedeschi» mi aveva confessato Meg quel giorno che finalmente mi concesse di parlarle da sola, «mi creda. I tedeschi ti concedevano quel che chiamavano il «colpo di grazia», il Gnadekugel – infine si era ricordata la parola
– ma gli ucraini miravano all’addome, si rimaneva feriti anche quarantotto ore prima di morire. Una morte lenta, terribile».
O non andò cosí. Forse, in qualche modo, la zia e lo zio di mia madre e la cuginetta sopravvissero a quelle ore. Nel qual caso, sappiamo, furono costretti a marciare per la città fino alla stazione ferroviaria, dopo giorni di terrore passati nel cortile del municipio, risuonante di urla, percosse, crani di bambini fracassati, il teatro di scene raccapriccianti come quella della signora Grynberg, immobile e scioccata con la materia fetale sanguinante tra le gambe. Passando davanti alla casa con la doppia parete dietro la quale erano nascosti Jack e Bob, Shmiel, frastornato com’era, forse a quel punto alzò lo sguardo e riconobbe l’abitazione di Moses Grünschlag, un uomo della sua stessa generazione, di certo suo conoscente, anche lui cosí dedito agli affari da recarsi di rado alla shul, con i fratelli in America, come il fratello di Shmiel, che probabilmente in quel momento stavano malinconicamente trascorrendo gli ultimi giorni di vacanze a Far Rockaway, New York. A Jack e Bob giungevano i pianti,le strida, i gemiti (e i canti), forse anche di Shmiel, Estere Bronia, costretti infine a salire su un carro bestiame.
Ero già stato a Bolechow quando parlai con i quattro sopravvissuti di Sidney, e quindi ero in grado se non di immaginare come erano andate esattamente le cose, almeno di figurarmi il teatro delle sofferenze che dovettero patire i miei parenti, di rappresentarmi gli edifici davanti ai quali sfilarono in quell’ultima marcia per le strade della loro città. Dal cortile del Magistrat li portarono per via Dolinska, la strada che a sud conduce a Dolina; dopo circa duecento metri dovettero girare a sinistra per la Bahnstrasse, la via polverosa, lunga circa ottocento metri, che porta alla stazione ferroviaria. Avevo percorso quel tragitto: non era certo una passeggiata.
E dopo? Dell’estenuante ultimo viaggio, le ore o le giornate passate sul treno, nel soffocante, angusto vagone merci, è possibile apprendere alcuni dettagli dal racconto di Matylda Gelernter, che riuscii a procurarmi a Gerusalemme: particolari a lei riferiti da una certa signora «Stern», la stessa che si era vista costretta a soffocare il figlio di due anni nel nascondiglio in cui si era rifugiata. Scoperta e tradotta sul carro bestiame, in qualche modo riuscí a saltare giú dal treno – non prima di aver perso un altro figlio, forse uno dei bambini che aveva cercato di saziare la sete bevendo la propria urina – ed èper questo che oggi sappiamo quel che accadde su quello stesso treno che portò Shmiel, Ester e Bronia a Belzec.
Nel cercare di ricostruire gli ultimi giorni di vita dei miei tre parenti, ho tenuto conto che la descrizione di Matylda Gelernter è probabilmente piú superficiale,non avendo vissuto in prima persona quell’esperienza,del racconto sicuramente piú dettagliato della «Stern»,che pone invece l’accento su eventi di cui era stata testimone. Consapevole di ciò, ho consultato altre fonti riguardo agli eventi occorsi nei convogli merci impiegati nell’Operazione Reinhard per trasportare i prigionieri nei campi di sterminio, in quella tarda estate del 1942. Non parafraserò tali fonti, non cercherò di «descrivere»quel che avvenne, preferisco lasciare la parola alla testimonianza di un sopravvissuto, citato da Arad:
Nel vagone dove mi trovavo erano stipate piú di cento persone... È impossibile descrivere le condizioni tragiche di quelle carrozze chiuse e soffocanti. Era come un’enorme cloaca. Cercavano tutti di farsi largo per posizionarsi nei pressi di qualche spiraglio da dove filtrava un po’ d’aria .Giacevamo tutti in terra. Individuai una fenditura tra le assi del vagone, e ci infilai il naso per respirare. Il fetore era insopportabile. La gente defecava in ogni angolo del vagone...La situazione peggiorava sempre piú. Imploravamo i ferrovieri di darci qualche sorso d’acqua. Promettevamo grandi ricompense. Alcuni pagarono 500, anche 1000 złotys per un bicchiere d’acqua... Io ne diedi 500 (piú della metà del denaro che avevo) per una tazza d’acqua – circa mezzo litro. Mentre bevevo una donna, il cui figlio era svenuto, mi aggredí. Continuai a bere. Non riuscivo a staccare le labbra dalla tazza. La donna mi morse la mano con tutta la forza che aveva, voleva che le lasciassi un po’ d’acqua. Non feci caso al dolore. Avrei sopportato qualsiasi cosa per un altro sorso d’acqua. Ma lasciai qualche goccia, e vidi il bambino bere. Le condizioni peggioravano. Erano appena le sette del mattino, ma il sole aveva già surriscaldato la vettura. Gli uomini si tolsero le camicie e rimasero a petto nudo. Anche alcune donne si tolsero i vestiti, lasciando indosso solo gli indumenti intimi. Giacevamo stremati, ansimanti, scossi come da brividi di febbre, le teste ciondolanti nel disperato tentativo di respirare un alito d’aria. Alcuni erano in preda alla piú totale disperazione e non si mossero piú.
Questo resoconto, come quello della «Stern» raccolto da Matylda Gelernter, lascia intendere che ciò che si trova nei musei, i manufatti, gli oggetti, possono darci solo una vaga idea di quel che realmente accadde; per questo è quasi vano cercare di immaginarlo. Oggi è possibile vedere con i propri occhi quei carri bestiame, conservati nei musei; ma nell’epoca dei reality show non si può fingere di credere che essere rinchiusi in una specie di scatola – esperienza oltremodo spiacevole per alcuni – equivalga a rimanervi dopo essere stati costretti a soffocare il proprio bambino e a bere la propria urina perla disperazione, esperienze che i visitatori di quei musei ben difficilmente possono aver fatto di recente.
In ogni modo, non si può scartare l’eventualità che Shmiel, Ester e Bronia non sopravvissero al viaggio nei vagoni merci. Seppure arrivarono vivi, dalle testimonianze dei pochi sopravvissuti, e dagli stessi criminali in seguito processati, sappiamo cosa accadde.
Una volta giunti a destinazione, i convogli si fermavano sul binario di raccordo che finiva nel campo di Belzec. In pochi minuti («da tre a cinque», come dichiarò in seguito un macchinista polacco) i vagoni venivano svuotati del carico di ebrei vivi e morti. Boccheggiando, frastornati, insudiciati del proprio o altrui luridume, Shmiel, Ester e Bronia scesero barcollanti dal carro e vennero condotti nell’«area di accoglienza». Qui probabilmente udirono il discorso di un ufficiale tedesco, forse persino del comandante del campo, Wirth, con cui venivano accolti i prigionieri: veniva detto loro che quella era solo una tappa in attesa di un ulteriore trasferimento, e per ragioni d’igiene dovevano fare il bagno ed essere disinfettati, prima di venire tradotti ad altra destinazione. Se Shmiel o Ester credettero a quelle parole non lo sapremo mai; ma considerata l’ingenuità manifestata dal mio prozio solo tre anni prima,convinto che una lettera al presidente «Rosiwelt» avrebbe permesso a lui e alla sua famiglia di emigrare in America, prenderò in considerazione la possibilità che, come la maggior parte delle persone, fosse riluttante a credere al peggio; poteva quindi essere tra coloro, come sappiamo dalle testimonianze di un ufficiale tedesco, che applaudirono Wirth dopo il discorso comminato agli ebrei storditi e incrostati di deiezioni davanti al binario di Belzec, con il quale li aveva rassicurati che gli oggetti di valore, da depositare su un bancone, sarebbero stati loro restituiti dopo il trattamento di disinfezione. È anche possibile, per quanto tutt’altro che certo, che gli occhi di Shmiel si posassero per un attimo sul seguente cartello:
Attenzione!
Togliere ogni indumento!
Tutti gli oggetti personali, a eccezione di denaro,
oggetti preziosi, documenti e certificati,
devono essere deposti a terra. Denaro, oggetti
preziosi e documenti devono essere depositati
all’ingresso. Le scarpe devono essere raccolte,
legate a paia e lasciate ove indicato.
Se vide questo cartello, è verosimile che il tenore della scritta – non dissimile, tutto sommato, da quello di analoghi segnali posti all’ingresso di piscine e docce di località termali europee, come a Jaremcze, dove il padre di Shmiel, trent’anni prima, era improvvisamente deceduto – lo tranquillizzò.
Comunque sia, se le cose andarono come di consueto, quel giorno ai primi di settembre del 1942, periodo della piú intensa attività di «stanziamento» di ebrei a Belzec, Shmiel venne separato dalla moglie e dalla figlia e portato nelle baracche per spogliarsi (gli uomini venivano gasati per primi). Senza dubbio si tolse gli indumenti insudiciati; forse indossava il cappotto scuro e la camicia che sfoggiava nell’ultima fotografia che ci rimane di lui, una piccola istantanea di forma quadrata dietro cui aveva scritto Dezember 1939, l’unico cimelio giunto a noi della sua vita durante l’occupazione sovietica. Qui appare molto invecchiato... Come sappiamo era piuttosto alto, forse era stato percosso durante la marcia verso la stazione di Bolechow; è piú che probabile che,quando si tolse scarpe e calze, avvertisse forti dolori; naturalmente bisogna considerare lo shock subito, a cui si sommava l’orrore per la separazione da Ester e Bronia (ebbe l’opportunità di salutarle? Forse erano già separati nel carro bestiame, forse già da Bolechow erano capitati in vagoni differenti). D’altra parte, considerando la sua indole, probabilmente trovarsi in un ambiente organizzato e istituzionalizzato venne da lui interpretato come un segno di buon auspicio. Forse, pensò tra sé, il terrore del raduno nel cortile del municipio, la marcia perle strade della città verso la stazione, l’attesa, il terrificante viaggio in treno, era tutto alle spalle.
Dagli spogliatoi nelle baracche il nudo Shmiel Jäger,un uomo alto con occhi azzurri e capelli bianchi, venne condotto con gli altri attraverso il passaggio relativamente stretto noto come Schlauch, un condotto di un paio di metri e lungo una dozzina. In parte delimitato da assi e filo spinato, collegava le aree di accoglienza nel Campo 1 di Belzec alle camere a gas e alle fosse dove venivano seppelliti i cadaveri, nel Campo 2. È molto probabile che, da uomo schivo, cercasse di coprire le nudità con le mani (simili alle mie e a quelle di mio nonno, ma squadrate e ricoperte di una peluria scura) mentre si trascinava quasi trotterellando lungo lo Schlauch.
Per il settembre del 1942, quando ormai Shmiel, Estere Bronia erano quasi certamente morti nelle camere a gas – erano ben poche le probabilità che quell’uomo di mezza età, che dimostrava piú anni dell’età anagrafica, la sua pingue moglie o la bambina fossero stati selezionati per i gruppi di lavoro, prigionieri ebrei che pulivano le camere, rimuovevano e seppellivano i cadaveri dopo la gassazione – le vecchie camere a gas di Belzec, in legno,erano state demolite e sostituite da ambienti piú solidi e spaziosi, in calcestruzzo grigio. Dopo aver percorso il condotto, Shmiel si avvicinò a quest’edificio e salí a passo strascicato i tre gradini che immettevano all’interno,larghi circa un metro, davanti ai quali troneggiava un massiccio vaso da fiori e un cartello che recava la scritta BADE-UND INHALATIONSRÄUME, «stanze da bagno e inalazione». Entrando in quel solido edificio di recente costruzione, si sarebbe trovato davanti un corridoio scuro, largo un metro e mezzo, alla fine del quale si aprivano le porte che immettevano nelle camere a gas.
È possibile che persino a quel punto fosse ancora convinto di trovarsi in stanze da bagno e inalazione. Entrò. Secondo la testimonianza di un tedesco addetto al campo di Belzec, le stanze avevano «un aspetto luminoso e accogliente», erano dipinte di giallo o di grigio,colori che conferivano agli ambienti un che di istituzionale e rassicurante. I soffitti erano piuttosto bassi – due metri, a un uomo dell’altezza di Shmiel potevano provocare un senso di claustrofobia – ma forse non vi badò, persino allora pensò di dover semplicemente fare una doccia disinfettante. Dopo tutto dal soffitto pendevano le cipolle della doccia. Se anche notò la porta mobile sul retro dal lato opposto all’entrata, attraverso la quale dieci minuti dopo sarebbe stato trascinato il suo cadavere, probabilmente non vi prestò attenzione.
Tuttavia, dopo che zio Shmiel fu introdotto a forza con altri millenovecentonovantanove ebrei in questa accogliente camera a gas dal soffitto basso, dipinta di giallo, è difficile credere che pensasse ancora di doversi sottoporre a un trattamento disinfettante. A quel punto viene aperto il gas, e la mia ricostruzione termina qui; adesso è solo, in attesa della morte, né io né altri (eccetto i millenovecentonovantanove o giú di lí che si trovavano con lui) possono accompagnarlo lí dentro... Lo stesso destino sarebbe toccato a Ester e alla piccola Bronia, che di lí a breve avrebbero salito gli stessi gradini, sarebbero entrate in una delle camere per intraprendere il medesimo viaggio (diversamente da Shmiel, erano state costrette a una sosta nelle baracche dove i Friseur, i barbieri, rasarono le loro scure chiome).
Non possiamo seguirli sin lí. Posso solo affermare,con ragionevole certezza, che in una di quelle camere, in un determinato momento di un certo giorno di settembre del 1942, anche se il giorno e il momento precisi non si potranno mai sapere, le vite di mio zio Shmiel e della sua famiglia, di Samuel Jäger, fratello di mio nonno, erede e riorganizzatore delle attività imprenditoriali che una mirata politica matrimoniale di generazioni di Jägere Kornblüh avevano accresciuto, autore delle lettere spedite in America tra il gennaio e il dicembre del 1939, un quarantasettenne padre di quattro ragazze, persona che teneva all’eleganza, per certi versi un pezzo grosso nella cittadina dove lui e i suoi antenati erano sempre vissuti,e la moglie, donna estremamente affabile e cortese, e una bambina che non ebbe il tempo di crescere, a cui un settantottenne oggi residente a Sidney, Australia, ricorda di aver rivolto un saluto, «Ciao, Bronia!», da dietro un recinto, cessarono di esistere. Un uomo, una donna e una bambina vissuti fino a quel giorno sapendo che la loro terza figlia e sorella maggiore, una ragazza di sedici anni cui era stato attribuito il nome in memoria della zia paterna, morta, si diceva, una settimana prima delle nozze, era stata freddata con una raffica di mitra sul ciglio di una fossa. Uno zio, una zia e una cugina che nel momento in cui udirono lo strano sibilo del gas avevano una nipote e una cugina mai conosciuti, che Shmiel educatamente cita in qualche lettera («Saluti e baci da me, dalla mia cara moglie e dalle mie bambine, a te, alla cara Gerty, alla cara bambina e a tutti i parenti»). Avevano una nipotina nel Bronx,New York, una graziosa biondina di undici anni con l’apparecchio per i denti che nella prima settimana di settembre del 1942 si era appena iscritta alla prima media, mentre il suo futuro marito, all’epoca tredicenne, della cui famiglia si sarebbero perse le tracce, si era iscritto alla terza media, e in classe giocava con un adolescente che tutti chiamavano Billy Ehrenreich, nome della famiglia che lo aveva accolto, un profugo tedesco che un giorno avrebbe raccontato a mio padre di aver «perso» quattro sorelle, parola che mio padre, all’epoca solo un ragazzo,non era in grado di capire appieno. In quella camera inalarono l’aria avvelenata e nel giro di qualche minuto le vite di Shmiel Jäger, Ester Schneelicht Jäger e Bronia Jäger, vite inconoscibili di cui rimane traccia solo in poche fotografie sbiadite e in qualche frase, «Lo chiamava il król, il re, era una donna molto affabile, era ancora una bambina, giocava con i balocchi» e molte altre cose vere su di loro, che non si possono piú sapere, cessarono di esistere.
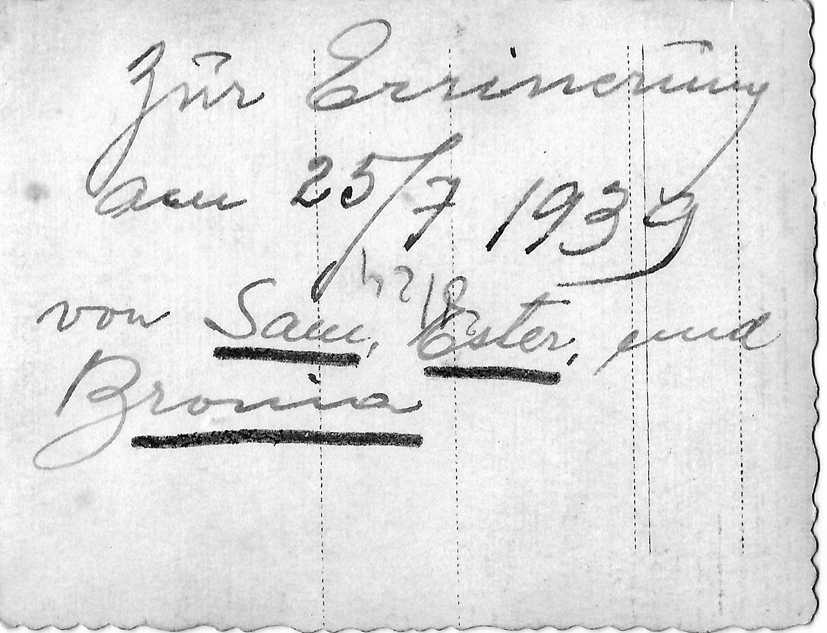
Questa fu la seconda Operazione alla quale Bob e Jack Greene scamparono riuscendo a nascondersi, diversamente da Shmiel, la moglie e la figlioletta. Provarono anche loro a trovare un rifugio? Impossibile accertarlo, come concludemmo con gli amici australiani. Come mai i Grünschlag riuscirono a nascondersi in un angusto budello dietro a una doppia parete in un fienile, e altri no? Bob ci raccontò un episodio: di tutte le storie che ascoltammo durante il viaggio, fu quella che colpí in modo particolare il mio fratellino dal cuore tenero – forse perché, a differenza degli altri orrori, che sfuggono a ogni tentativo di immedesimazione, era una storia quasi ordinaria, nella quale potevano compenetrarsi anche persone ingenue della generazione di Matt e mia.
«Durante la seconda Operazione» raccontò Bob «fui costretto a sopprimere il mio cane. Credetemi, fu il compito piú difficile da affrontare. Non potete capire. Lo avevo allevato sin da cucciolo, lo portavo a letto con me; ovviamente la mattina le lenzuola erano bagnate, ei miei non sapevano se fossi stato io o lui!».
Fu costretto a sbarazzarsene, proseguí, perché, una volta nascosti dietro la doppia parete, se abbaiava li avrebbero scoperti. Matt, che adora i cani, rimase molto turbato; e da quel momento è questa la storia che racconta, quando parla del nostro viaggio in Australia di quella primavera, per far capire l'orrore che quelle persone dovettero provare: un ragazzo costretto a uccidere il suo cagnolino.
Credo che lo abbia commosso cosí a fondo proprio perché era un dettaglio marginale. Per qualche ragione,l’orrore di un ragazzo costretto ad ammazzare l’amato cagnolino è piú facile da comprendere, ci si immedesima di piú rispetto agli eventi ben piú raccapriccianti di cui gli ebrei furono vittime. Per esempio, l’orrore di dover sopprimere un figlio in fasce, i cui vagiti avrebbero potuto tradire il genitore e gli altri nascosti insieme a lui. Ma naturalmente, quando Bob Grünschlag ci narrò questa vicenda, non avevamo ancora letto la testimonianza della signora Gelernter.
L’imbarcazione con cui si salvarono Noè, la sua famiglia egli esemplari di specie viventi incontaminate ha sempre attratto la fantasia degli uomini. L’aspetto piú interessante di questo celebre strumento di salvezza risiede nella singolarità del termine ebraico impiegato per indicare quella che comunemente designamo con il vocabolo «arca». A ragione Friedman lamenta l’inadeguatezza di questa ormai inevitabile traduzione,perché quel che in effetti il sostantivo femminile tabah connota è una «scatola». Certamente questa è l’immagine suggerita dalla descrizione dell’arca: di forma rettangolare, non ha chiglia, timone né vele, ed è completamente chiusa sui lati. Trovo toccanti gli appassionati commenti di Friedman su quest’oggetto stranamente cavo, in cui la mancanza di ogni caratteristica propria di un naviglio dà luogo a una scena di grande suggestione: «In una tale imbarcazione» egli scrive «gli esseri umani e gli animali sono del tutto inermi, in balia delle acquee senza alcuna possibilità di determinare il proprio destino. Per apprezzare appieno l’immagine evocata dal racconto, dobbiamo figurarci questa sorta di scialuppa di salvataggio come una scatola abbandonata alla mercé di un universo violento in disfacimento». L’idea di fragilità infantile suggerita da tale rappresentazione è, a suo modo, appropriata, poiché nella Torahl’altro oggetto indicato con la parola tebah è il cesto di vimini in cui viene nascosto il neonato Mosè, per salvarlo da un altro dei tentativi di sterminio presenti nella Torah: il decreto del faraone egiziano con cui si ordina la morte dei neonati maschi di Israele. Come l’arca di Noè, la cesta di Mosè è un manufatto umile, completamente chiuso, sigillato con la pece, senza dubbio spaventosamente buio – una scatola che rappresenta l’unica possibilità di salvezza per l’indifeso occupante.
L’immagine di una scatola come rifugio in un mondo in dissoluzione viene subito in mente quando si analizzano storie come quelle che ebbi occasione di ascoltare in Australia da Jack Greene e suo fratello Bob – racconti in cui, in un’epoca di terrore, era possibile trovare scampo solo nascondendosi in un luogo buio, simile appunto a una scatola: per esempio,l’angusto spazio celato da una doppia parete che Moses Grünschlag aveva fatto costruire in un fienile per sé e i due figli scampati alla furia nazista, o il rifugio sotterraneo scavato nella foresta dove in seguito quei tre e pochi altri si nascosero rimanendovi per un anno, fin quando il faraone dei nostri tempi non venne sconfitto. Anche in queste moderne arche gli esseri umani attendevano inermi, senza alcun controllo del proprio destino, passivi abitatori di luoghi oscuri dai quali, infine, sarebbero riemersi, novelli Noè, moderni Mosè, strizzando gli occhi accecati dalla luce.
Eppure, forse per la sottile insistenza con cui la parashat Noach collega concetti opposti, la creazione alla distruzione,la distruzione alla rinascita, idoli di terracotta a masse informi di argilla, acque sulfuree al legno altrettanto sulfureo con cui fu costruita l’arca, i nascondigli grazie ai quali i quarantotto ebrei di Bolechow si salvarono (per non parlare degli altri rifugi dove occupanti meno fortunati cercarono scampo,numericamente indeterminati poiché non è rimasto nessuno a testimoniarlo) inevitabilmente richiamano alla mente altre costruzioni a forma di scatola, rese tristemente famose dalla storia dei nostri giorni con il decreto di morte emanato contro il popolo di Israele, strumenti non di salvezza ma di sterminio .Sí, c’erano luoghi per nascondersi, compartimenti bui i cui occupanti potevano solo udire quanto stava accadendo e sperare; ma c’erano anche i carri bestiame, con il loro carico di esseri umani in balia della tempesta; e c’erano le camere a gas.
Anche quelle erano scatole. Anche quelle un’arca.
Quella, quindi, fu la seconda Operazione, che ebbe luogo nei primi giorni di settembre del 1942, durante la quale persero la vita Shmiel, Ester e Bronia, per lo meno secondo le testimonianze di tutti quelli seduti quel giorno intorno al tavolo a casa di Jack e Sarah. Rimane solo una fotografia che ritrae insieme i sei componenti della famiglia, risalente all’agosto del 1934; sorprendentemente, Shmiel ha un aspetto trasandato, il viso non sbarbato, circostanza giustificata dal fatto che, come si legge sul retro, è in lutto per la perdita della madre, la mia bisnonna Taube, morta un mese prima: sette volti seri, che finalmente sono in grado di identificare come quelli di Shmiel, Ester, suo fratello Bruno, Bronia, Ruchele, Lorka e Frydka dagli occhi scuri, con il viso in parte tagliato dal margine della foto – dei sei membri di questa famiglia, per i quali non è stato osservato un normale periodo di lutto, come quello che loro stessi stavano osservando quando fu scattata la fotografia, nell’ottobre del 1942 ne erano rimasti in vita soltanto due.
Come ci disse Jack, Lorka e Frydka erano state reclutate per lavorare nella Fassfabrik, la fabbrica di barili, insieme agli Adler. «Anche noi lavoravamo lí» aggiunse, intendendo i componenti sopravvissuti della sua famiglia: lui, il padre e Bob.
«Dopo la seconda Operazione» spiegò Jack «i superstiti vennero assegnati ai campi di lavoro. C’erano alcune concerie, una segheria, una fabbrica di barili. Alcune abitazioni furono trasformate in campi, in lager,bisognava vivere lí, andavamo al lavoro, per poi farvi ritorno la sera. Anche la nostra casa fu trasformata in un lager. Eravamo piú di venti».
«Lavoravano tutti nei campi di lavoro?» domandai.
«Chi non fu reclutato venne deportato nel ghetto di Stryj» rispose.
«Bisognava evitarlo a tutti i costi» dissero all’unisono i due fratelli. «Ma nel corso del 1943 era chiaro a tutti che anche i “lavoratori utili” sarebbero stati uccisi. Fu in quell’anno che i piú avveduti cominciarono a elaborare piani di fuga».
«E quand’è che Frydka e Lorka si unirono ai partigiani?» volli sapere.
«Nel ’43» rispose Jack.
«’43?» interloquí con aria assorta la signora Grossbard. «Non nel ’42?».
«’43» ripeté enfaticamente Jack.
Rivolto a me proseguí: «Frydka veniva nel nostro lager, nel nostro campo, quasi ogni sera. Lavorava come ragioniera nella Fassfabrik. Il ragioniere capo era malato, aveva problemi ai reni. Cosí quando quel ragioniere, si chiamava Samuels, Shymek Samuels, si ammalò,venne a stare nel nostro lager, migliore rispetto agli altri. Lei veniva a trovarlo quasi ogni giorno.
«Lei e Lorka vivevano nel lager vicino alla Fassfabrik, dove stavano anche gli Adler» aggiunse.
Quelle informazioni mi stimolarono alcune considerazioni. Innanzitutto, nel 1943 Frydka e Lorka vivevano insieme, circostanza che, immaginavo, costituiva per loro un certo conforto. Inoltre Frydka, nel 1943 ventunenne, doveva essere una ragazza molto affettuosa se andava a trovare quel ragioniere ammalato, Samuels,malgrado il fatto che in quel periodo girare per le strade di Bolechow significasse rischiare la vita, come aveva dichiarato la signora Grossbard («Non esisteva piú legge» disse per chiarire come stavano le cose. «Chiunque poteva ucciderci»). La terza riflessione riguardava gli studi commerciali compiuti a Stryj da questa ragazza slanciata dal passo deciso (che da adolescente, si era lasciata sfuggire Meg, andava in treno in una località termale non distante da Bolechow, Morszyn, con le sue amiche Meg e Pepci Diamant, intrufolandosi nelle sale da ballo, malgrado fosse troppo giovane per accedervi),questa fanciulla vivace i cui occhi scuri avevano fatto innamorare un giovanotto polacco biondo, di fede cattolica, circostanza che aveva determinato la condanna di entrambi, anche se i dettagli della vicenda li avrei scoperti solo molti mesi dopo. Ecco cosa le aveva concesso la costosa istruzione ricevuta in un istituto commerciale: qualche mese di vita in piú lavorando come ragioniera in un campo di lavoro.
A quel punto, dopo ore passate a conversare a casa di Jack e Sarah Greene, aver sorseggiato il caffè fumante tra il tintinnare di piattini, rimaneva da parlare solo di Frydka e di Lorka. L’ultima volta che le videro fu prima che si rifugiassero nella fitta foresta che sorgeva nei dintorni di Bolechow.
«Che cosa spinse la gente a scappare nella foresta?»domandai.
«Dopo il novembre del 1942 ci misero nel lager» ripeté Jack. «Ognuno aveva una lettera, una R, che stava per Rüstung, munizioni, o una W, che stava per Wirtschaft, economia».
Bob e Meg presero a discutere sul significato della
W: lei era convinta che fosse l’iniziale di Wehrmacht, mentre lui insisteva che aveva ragione Jack, perché, asserí, Rüstung e Wehrmacht erano praticamente sinonimi.
Per quanto mi riguardava, la questione era ininfluente. A me importava il fatto che nel marzo 1943 tutti i lavoratori che portavano la lettera W, all’incirca trecento persone, furono condotti nel cimitero ebraico,trucidati e gettati in una fossa comune. Questa fu l’Operazione «minore» cui aveva accennato prima Jack;e quella che Olga, la donna conosciuta in Ucraina, ricordava di aver visto dalla finestra del suo soggiorno.«A quel punto» continuò Jack «fu chiaro che anche i lavoratori “utili” non erano indispensabili».
«Sí» assentí lentamente Meg. «Esattamente sessanta anni fa. Tutte le mie amiche furono uccise».
«Tutte le W furono sterminate» precisò Bob.
Ovviamente, considerai tra me, ai tedeschi non importava nulla del significato della W.
«E le R furono risparmiate fino all’agosto del 1943»aggiunse Bob.
D’un tratto Jack disse: «Mi ricordo che ci fu un’altra Operazione. Presero gli ebrei tornati dai campi di Stryj.Nel marzo del 1943, per qualche strana ragione, riportarono a Bolechow una novantina o forse cento persone dal ghetto di Stryj. Tra questi c’era nostro zio, Dovcie Ehrmann. Entro ventiquattro, o quarantotto ore, li portarono al cimitero e li uccisero».
«Mi dispiace Jack, non lo ricordo proprio» si scusò Bob.
«Be’, non cambia niente» replicò Jack, «andò cosí».
«Lo so, lo so. Ricordo che le W che erano nel campo degli Adler furono presi nel marzo del ’43...».
«Forse era aprile» lo corresse Jack «ma furono prese novanta o cento persone».
Marzo, aprile: comunque fosse, allora Frydka e Lorka non erano piú a Bolechow, almeno secondo i ricordi di quelle persone. Insieme o separate, probabilmente con l’aiuto di quel ragazzo polacco, le due sorelle erano riuscite a lasciare la città. Scomparvero, e nessuno le vide piú.
O almeno cosí pensavamo allora.
Questa fu l’ultima informazione che i sopravvissuti dí Sidney furono in grado di fornirmi sugli Jäger. E fu anche l’ultimo argomento di cui parlammo. D’improvviso, la conversazione languì. Eravamo tutti, non solo gli anziani, esausti, sfiniti.
Ma a pensarci bene non fu cosí. L’ultima persona a parlare quel pomeriggio fu Boris Goldsmith, rimasto per quasi tutto il tempo in silenzio, poiché durante la guerra non si trovava a Bolechow, non aveva visto sentito cosa era capitato agli altri. Fu per questo che d’un tratto sentì il bisogno di intervenire, mentre la conversazione si stava esaurendo.
«Io non posso raccontarle niente» si scusò, guardandomi negli occhi e allargando le grosse mani, in un gesto mortificato, «perché non ero lí, ero con l’esercito russo».
«Lo so» risposi, comprensivo. Ma poi, volendo renderlo partecipe, aggiunsi: «Cosa accadde quando finí la guerra? Tornò a casa?».
Boris rise, scuotendo il capo. «No» rispose «non tornai a casa. Mentre ero ricoverato in un ospedale nel Caucaso mi imbattei in un tale che mi pareva di conoscere. Portava l’uniforme francese, sembrava ebreo, cosí mi avvicinai».
L’idea dell’incontro di un ebreo di una piccola cittadina polacca con un tale dall’aspetto familiare e rassicurante a migliaia di chilometri da casa, in qualche località sperduta del Caucaso, mi colpì, incredibile edesilarante com’era. Mi venne da sorridere. C’era un che di vagamente ironico nel modo in cui Boris raccontava quella storia, come fosse l’inizio di una barzelletta. Era cosí che mio nonno cominciava i suoi racconti. Pensa un po’: mi trovavo nel Caucaso, nel mezzo del nulla, e chi ti vedo, un ebreo con l’uniforme francese...
«Sembrava proprio ebreo» continuò Boris, «cosí mi avvicinai e gli chiesi: «Come posso fare per tornare a Bolechow?».
«E lui che rispose?» domandai al momento giusto,esattamente come avrei fatto con mio nonno.
Cosí Boris mi rivelò cosa gli rispose l’ebreo in uniforme francese, in occasione di quell’inverosimile incontro.
«Mi disse: “Scordatelo. Non è rimasto nessuno”».
8 Piccolo astuccio metallico contenente una pergamena con passi biblici che, secondo l’applicazione letterale di Deuteronomio 6,9, è fissata allo stipite destro della porta di casa, come per consacrarla e indicare che è sotto la protezione di Dio (N.d.T.).
9 La hora è un ballo tradizionale ebreo, spesso danzato ai matrimoni e alle cerimonie del bar mitzvah (N.d.T.).