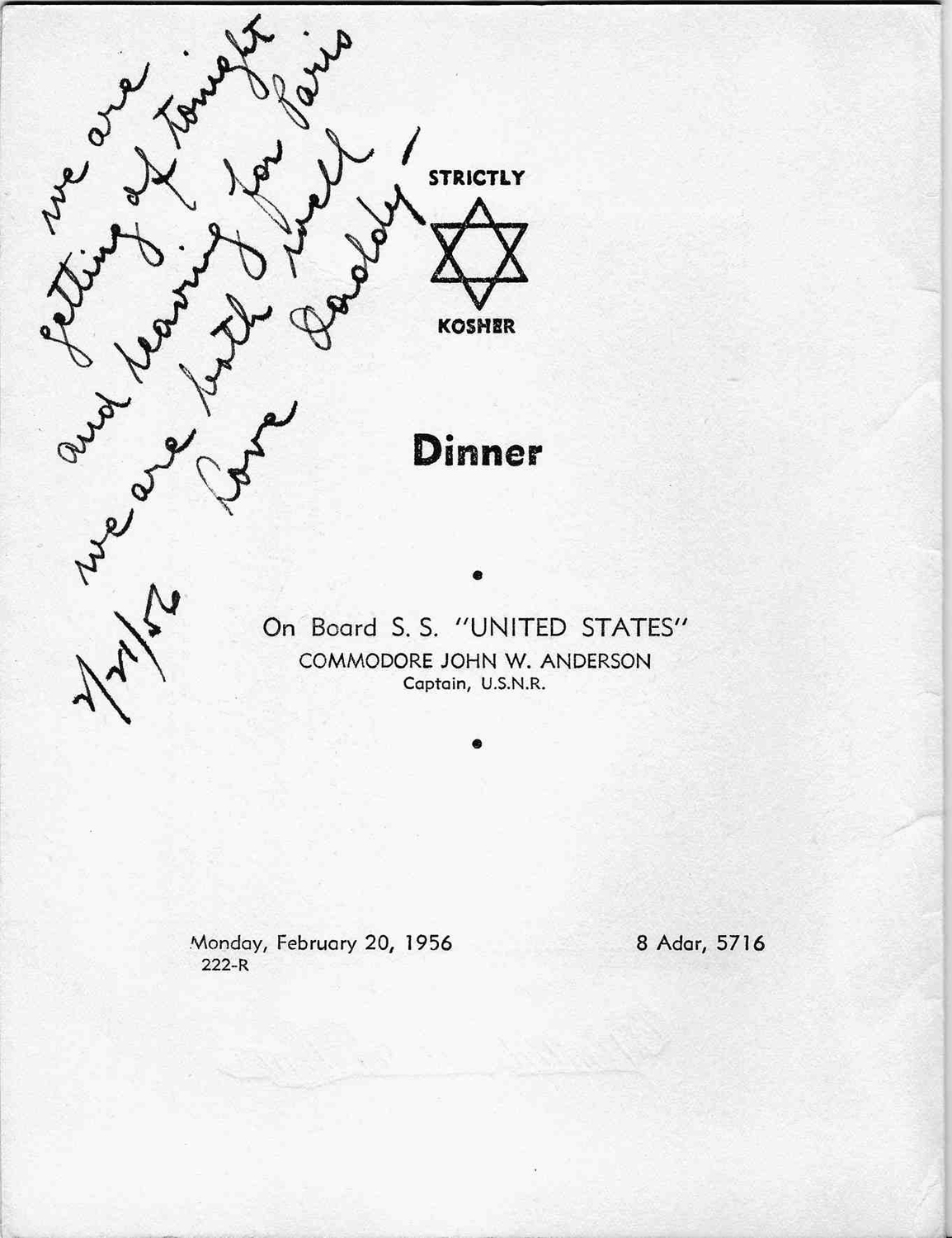
(Estate)
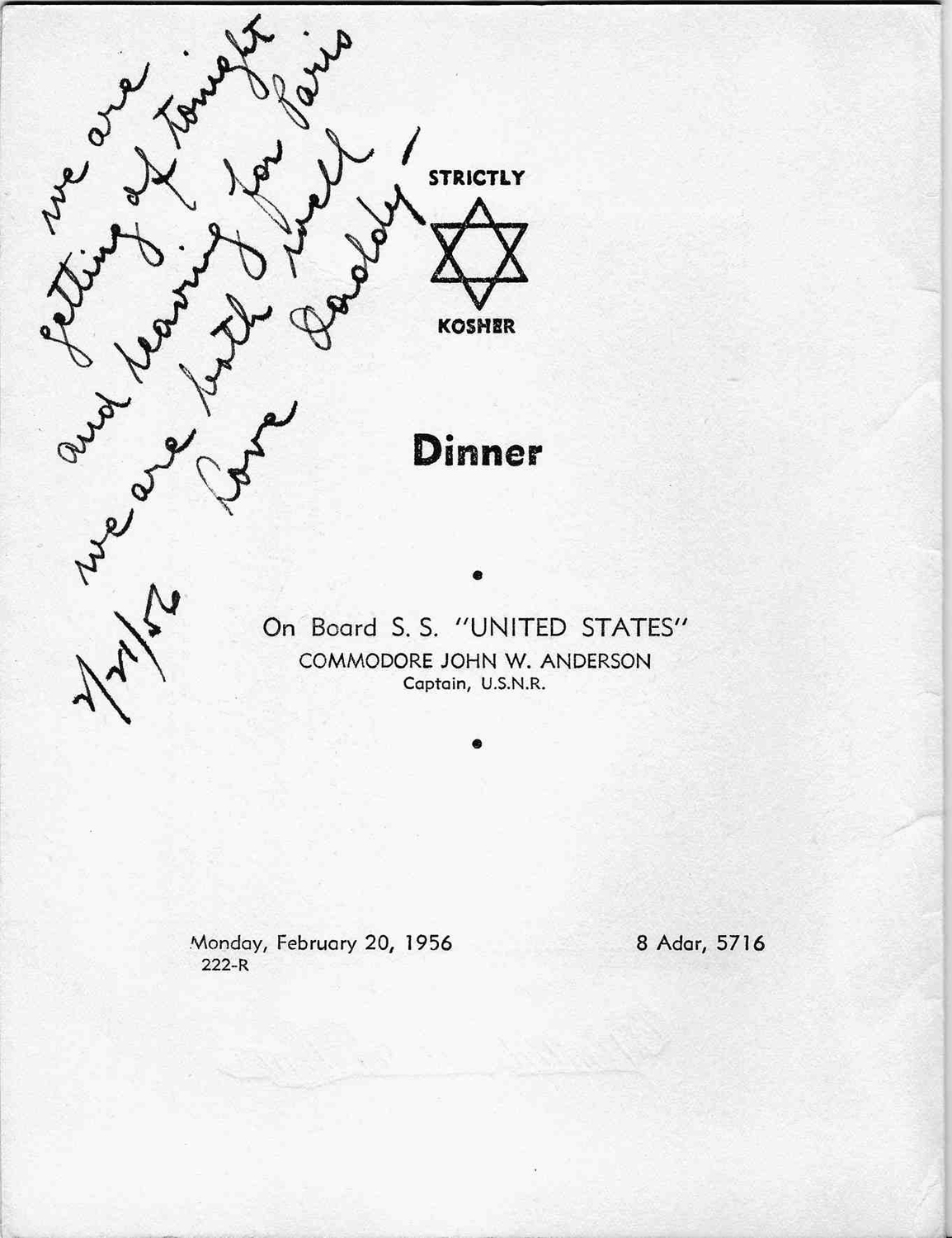
Era colpa di mio nonno se non ero mai andato in Israele.
Non che non amasse quella terra. Tutt’altro, mi aveva narrato un sacco di storie su quel paese. Tanto per cominciare, quella ormai leggendaria del viaggio in Palestina di suo fratello, negli anni Trenta. «Appena in tempo!» esclamavamo all’unisono, ogni qualvolta mio nonno mi raccontava della favolosa e profetica decisione del fratello maggiore (il cui nome ebraico, Yitzhak, oItzhak, in yiddish pronunciavamo ITZ-ik) di emigrare, appena cinque anni prima che il mondo precipitasse nel baratro, inconsapevoli che in questo modo alludevamo tacitamente al destino dell’altro suo fratello, del quale non parlava mai. Mio nonno mi spiegava come, sollecitato da zia Miriam, fervente sionista, anche Itzhak si era sottratto al campo gravitazionale di Bolechow, al richiamo del passato, all’attrazione esercitata da secoli di legami e vicende familiari, costruendo una nuova esistenza per sé e i suoi bambini, cugini di mia madre, che assunsero nomi israeliani. Fu così che l’unico Jäger della generazione di mio nonno che ebbe figli maschi dismise questo nome, e non solo: quando infine mi recai in Israele scoprii che parecchi dei numerosi discendenti di zio Itzhak ignoravano che in origine il loro cognome fosse Jäger.
Così zio Iztahk e zia Miriam si erano stabiliti in Israele, giusto in tempo per sfuggire all’abisso che inghiottì tutti gli altri. Lì ebbero figli e innumerevoli nipoti dai nomi strani, che a noi cugini americani suonavano gutturali, smozzicati e stranamente suadenti, un po’ come i personaggi dei film di fantascienza: Rami, Nomi, Gil, Gal, Tzakhi, Re’ut. In Israele si dedicarono ad attività che a quel tempo consideravo esotiche e ben poco attraenti, vivendo io in un mondo completamente diverso: abitavano in comuni, in dimore modeste, lavoravano i campi, raccoglievano arance, combattevano guerre interminabili, si sposavano molto giovani, mettevano al mondo numerosi figli e si moltiplicavano. Quand’ero bambino, un paio di volte l’anno ricevevamo da zia Miriam un aerogramma di carta velina, praticamente trasparente, con accluse (contravvenendo alle regole postali, ma all’epoca era una fervente socialista) patinate fotografie a colori del matrimonio di qualche parente; rimanevo immancabilmente colpito dal fatto che gli israeliani non indossavano mai cravatte, nemmeno le giacche, in occasione di quegli importanti eventi familiari. Un’inezia, direte, eppure ciò rafforzava in me l’idea che costoro in fondo non fossero autentici Jäger, convinto com’ero che far parte di quella famiglia, così come essere ebreo, significasse possedere necessariamente le stesse caratteristiche che associavo a mio nonno: eleganza, attenzione all’etichetta (che in termini religiosi si traduceva in una stretta ortodossia, e in senso laico poteva tradursi nel fatto che in viaggio ci si vestiva esclusivamente in giacca e cravatta), sobrietà, tutte peculiarità chiaramente riconducibili all’Europa, non certo a un posto sperduto nel deserto.
Comunque sia, mio nonno aveva sempre nutrito un amore profondo per Israele. Amava raccontare la storia – e, dopo la sua morte, fu mia madre a tramandarla – di come, durante la votazione dell’ONU sulla fondazione dello Stato d’Israele, nel 1947, seduto sul davanzale del suo appartamento nel Bronx ascoltava ansiosamente la radio che trasmetteva le operazioni di scrutinio, annotando meticolosamente su un foglio i voti di ogni membro, tenendo scrupolosamente il conto, e di come accolse la nascita dello Stato con grida di giubilo.
Dopo neanche dieci anni dalla fondazione di quella giovane nazione, ebbe luogo il leggendario viaggio sullo sfarzoso transatlantico con cui lui e mia nonna attraversarono l’oceano, per giungere stavolta in un paese nuovo eppure ancor più antico dell’Europa, ben diverso dall’ardua, perturbante e spaventosa traversata oceanica per arrivare in America. Nel febbraio del 1956 mio nonno, ritiratosi dal lavoro piuttosto presto dopo aver venduto l’azienda rilevata dai Mittelmark, che portava il suo nome, JAEGER, si imbarcò con mia nonna sulla nave Stati Uniti, rinomata per la velocità, che li condusse da Itzhak e Miriam: del resto, non vedendo il fratello da più di trentacinque anni, mio nonno poteva aspettare anche solo un minuto di più prima di poterlo riabbracciare?
Si raccontavano numerose storie sulla piacevole traversata, i menù e la lista dei passeggeri che mio nonno,e poi mia madre, conservarono scrupolosamente in buste di plastica (quando, venti anni dopo la crociera, li vidi, sembravano nuovi di zecca), l’eleganza e la raffinatezza di quel modernissimo transatlantico, l’abbondanza e la varietà del cibo strettamente kasher, gli interminabili intrattenimenti a bordo. E la riunione di famiglia tanto attesa, il celebre episodio dell’approdo quando, avendo intravisto il fratello nella folla all’estremità della dogana e spazientito dalle operazioni di sbarco che andavano per le lunghe, mio nonno afferrò la mano della moglie e si precipitò urlando verso gli agenti e gli ufficiali israeliani dell’immigrazione: «Non vedo mio fratello da trent’anni e non sarete certo voi a fermarmi! Arrestatemi pure!».
Fu così che mio nonno giunse in Israele. In quella nazione appena fondata, una terra antichissima, lui e mia nonna trascorsero un anno intero. Mia madre racconta ancora che in quel periodo, quando ben difficilmente si facevano telefonate intercontinentali, suo padre la chiamò due volte: appena arrivati, e il giorno del compleanno di mia madre. Comunque, nonostante si trovasse in un paese straniero, mio nonno, istrione di natura, continuò a essere uno Jäger. Si adeguava istintivamente alle varie circostanze, drammatiche o comiche che fossero («Adesso, Marlene, per prima cosa smetti di piangere. Lo sai che diventi brutta quando piangi...»), tendeva a instillare nelle persone che apprezzavano questa sua qualità il desiderio di compiacerlo. Un esempio non guasta: mio nonno amava gli uccelli. Quando ero bambino, d’estate trascorreva un periodo da noi, lo andavamo a prendere all’aeroporto Kennedy; di tutti i bagagli, le numerose valigie e la borsa con le pillole, l’unica che insisteva a portare da sé, dopo che mio padre, probabilmente esasperato ma senza darlo a vedere aveva caricato tutto in macchina, era la grossa gabbia tonda di Shloimeleh, il canarino. Salomone. Una mattina di luglio, avevo quindici anni, gli chiesi: «Perché l’uccello si chiama Shloimeleh?». Mi stava dettando le sue ultime volontà, per dattiloscriverle, non solo perché ero così interessato alla storia di famiglia, ma anche per non turbare mia madre. Ero comunque felice di passare del tempo da solo con lui. Pensava di frequente alla morte, ma in modo del tutto naturale, un po’ come si pensa a una visita, ancora lontana ma certa, a un amico d’infanzia con cui, si sa, non si avrà molto da dire.
Se dovessi morire di sabato o di venerdì notte
(mi dettò)
Desidero che il corpo non sia mosso fino a sabato sera dopo il tramonto. Il rito funebre dovrà essere officiato dal Chewra Kadishu, non dall’impresa di pompe funebri. Date loro cento dollari a questo fine. Assicuratevi che la notte il mio corpo sia vegliato da un ebreo, e che venga recitato il Thilim. E ora spedite immediatamente centocinquanta dollari al Centro Joseph Zvi, a Gerusalemme, all’attenzione del signor Davidowitz, affinché reciti per me il Kaddish per un anno. Il mio nome è Abraham ben Elkana. Avvolgete il corpo con il mio tallis.
«Perché l’uccello si chiama Shloimeleh?» ripeté, dopo aver apposto la firma al documento con la sua amata penna stilografica blu. «Come altro dovrebbe chiamarsi? È l’uccello più intelligente con cui abbia mai parlato».
Poiché mio nonno amava tanto gli uccelli, Itzhak, l’adorato fratello che ricambiava il suo amore, quell’anno che trascorse in Israele gli costruì una stia per piccioni sul tetto di casa, in modo che mio nonno potesse osservare i pennuti al tramonto.
Circolavano altre storie su quel viaggio in Israele, dove mio nonno appariva sempre come un grande eroe di notevole ingegnosità. Tanto per citarne una, quando mia nonna finì l’insulina lui non si rivolse banalmente a farmacie o ospedali, ma chiamò il consolato americano e fece in modo che lo accompagnassero con una motolancia su una nave da guerra statunitense ancorata al largo, dove avevano una scorta di quel medicinale («Sai com’era fatto» ha chiosato di recente mia madre, rispolverando l’episodio. «Non aveva paura di nessuno»). O quella di quando portò dei piccoli ospiti di un orfanotrofio – solo adesso, troppo tardi, mi chiedo, di chi erano quei bambini – a fare una passeggiata nel parco, offrendo loro delle caramelle. «Questo dell’orfanotrofio era l’episodio preferito di tuo nonno» ha ricordato mia madre l’altro giorno, quando le ho chiesto, tra le altre cose, del viaggio di suo padre in Israele. «Per questo ancora oggi mando dei soldi al Centro David Zvi». E dopo aver ridacchiato tra sé, ha proseguito: «Rammento che mi disse: “Quando tiro le cuoia, ogni anno, ogni vacanza, ogni yontiv, dovrete inviargli dei soldi. Ma sai, sono ebrei, ti succhierebbero i tuoi averi, quindi manda solo piccole somme!”». È rimasta un attimo in silenzio, poi ha aggiunto superfluamente: «E così ho fatto».
Quindi mio nonno non si smentiva, neanche durante quell’anno trascorso in Israele. È strano, visto che rievocava spesso quel viaggio e il lungo soggiorno, che da piccolo sapessi così poco di Itzhak. Molto tempo dopo che mio nonno annegò nelle fredde acque della piscina al 1100 di West Avenue di Miami Beach, mi resi conto che non conoscevo quasi per niente Itzhak, i drammi che avevano costellato la sua esistenza, eccetto la circostanza che avesse avvedutamente lasciato Bolechow, spinto a questa scelta dalla fervente ideologia della consorte. Era come se mio nonno reputasse superflua qualsiasi altra informazione, tranne che il fratello fosse stato così intelligente da partire giusto in tempo. Di Itzhak sapevo solo due cose. Una l’appresi da Elkana, quando infine mi recai in Israele: quando i figli piccoli (e poi i nipoti) gli chiedevano dei soldi per comprare un gelato o le caramelle suo padre, proprio come mio nonno, usava una spassosa e strampalata espressione, accompagnata da un sorriso: «Chi credi che sia, grafpototski?». Io stesso non avevo idea di cosa potesse significare quella parola, sciocca quanto buffa, che udivo da mio nonno in risposta alle mie suppliche per avere un nichelino o un quarto di dollaro. Del resto, quando anni dopo cominciai a studiare il tedesco e appresi che Graf significa «conte», avevo ormai dimenticato quell’assurda espressione.
Questa era dunque una delle due cose che sapevo di zio Itzhak. Fu mia madre a fornirmi un altro dettaglio che tratteggiava vividamente la sua personalità. Mi ripeteva sempre che, al pari di mio nonno, zio Itzhak possedeva uno spiccato senso dell’umorismo. L’unica fotografia che conservo di lui (a parte la foto tessera risalente al 1920, con su impressi due timbri, probabilmente scattata per un passaporto, dove appare snello, lo sguardo trasognato, un sorriso appena accennato e l’espressione lievemente preoccupata) mostra un uomo di mezza età dall’aspetto rubicondo, robusto, con un sorriso caldo che dà l’idea di una persona sempre di buon umore (be’, ne aveva ben donde). Mia madre ricorda che da ragazza scriveva educate lettere allo zio mai conosciuto, copiando l’indirizzo datole dal padre: ITZHAK YAGER, via tal dei tali, Kiryiat Hayim, Israele.

Di recente, rievocando questi particolari, mi ha detto tutta ilare: «E zio Itzhak mi rispondeva: “È questo il rispetto che mi porti? Hai scritto ITZHAK YAGER sulla busta. Hai dimenticato di scrivere SIGNOR ITZHAK YAGER!!”».
Abbiamo riso, ma in realtà pensavo che quel senso dell’umorismo probabilmente avesse origine da un’indole altezzosa e piena di sé.
Caratteristica, ormai dovrebbe essere chiaro, dei miei congiunti del ramo materno.
E così quello fu il primo viaggio in Israele intrapreso da un componente della mia famiglia. Abbiamo un mucchio di fotografie: non solo quelle scattate da mio nonno durante le operazioni di imbarco al molo di New York, che ritraggono mia madre, mia nonna, zie e zii nella lussuosa cabina prima di salpare, ma anche altre. Per esempio quella sul ponte, che raffigura i miei nonni abbracciati, in un giorno di sole in piena navigazione, foto scattata da chissà chi, mia nonna con un prendisole bianco, l’aria florida e beata, a dispetto della sua reale condizione; e un’altra dove lei, con la stessa mise, è seduta su una sdraio di legno sul ponte, con espressione assorta; e poi in Israele, in posa davanti a rovine greco-romane insieme a un giovanissimo Elkana, o su una carrozzella in una strada fiancheggiata da palme, probabilmente a Tel Aviv. Una delle mie preferite mostra la mia amata Nana a passeggio su una strada polverosa accanto a un beduino che cavalca un somaro e un cammello al guinzaglio. Sul retro di questa foto mio nonno scrisse: Israele, 1957, nonna col cammello e un ARABO. Amo questa fotografia; rifletto spesso su quanto sia stata difficile l’esistenza di mia nonna, vuoi per il diabete che la perseguitava («Ogni giorno doveva bollire quei terribili aghi in uno shissl» mi ha ricordato mia madre di recente, indicando la pentola con una parola yiddish, cosa che trovai alquanto strana, avendo sempre associato quel vocabolo a pietanze come kasha e gołąki), vuoi per aver vissuto accanto a mio nonno; e quando guardo questa istantanea che la ritrae su un cammello, mi piace pensare che anche lei, che aveva ricevuto una scarsa istruzione e aveva alle spalle un’infanzia di povertà, avesse finalmente vissuto una piccola avventura. Come ho già detto, per un periodo della mia vita fu la persona a me più cara, forse perché non raccontava storie; l’amavo per la sua personalità calda, gioiosa, perché era una persona silenziosa, per niente esigente, che mi lasciava giocare con i suoi orecchini mentre le sedevo in grembo; e il fatto che sia morta da quarant’anni non ha attenuato l’affetto che provo nei suoi confronti.
Conservo anche un’altra fotografia, che ritrae un gruppetto di persone piuttosto lontane dall’obiettivo, forse in strada, un’immagine che ho impiegato anni a decifrare, un po’ perché è alquanto sfocata e i volti non si distinguono, ma anche per via della curiosa angolazione da cui venne scattata: si vede una strana linea in diagonale sull’angolo in basso a sinistra. Solo di recente ho scoperto che la scattò mio nonno il giorno della partenza da Israele, dalla passerella della nave che li avrebbe riportati a casa, dopo un anno trascorso laggiù: quella linea immortalata è il parapetto. Così sono riuscito a individuare il crocchio di persone che si intravedono sullo sfondo: zio Itzhak e la sua famiglia sulla banchina, in attesa della partenza.

Sarebbero trascorsi quasi venti anni prima che un altro membro della nostra famiglia si recasse a trovare i cugini israeliani, ed esattamente altri trenta prima che vi andassi io, anche se, come ormai dovrebbe essere chiaro, non ero interessato a Israele ma a Bolechow. Ma nei venti anni successivi a quel primo viaggio, Israele era sempre nei nostri pensieri. Occasionalmente venivano a trovarci degli israeliani, persone che trovavo pittoresche e quindi interessanti. C’era, per esempio, una donna un po’ più giovane dei miei genitori, Yona – un altro di quei nomi israeliani misteriosamente tronchi, composti da sillabe brevi e smozzicate che sembravano incarnare l’essenza dello stesso Stato d’Israele: una lingua di terra, dal territorio poco esteso, dallo spirito necessariamente pragmatico, senza alcuna concessione a inutili fronzoli romanticheggianti. Questa Yona compariva di tanto in tanto a casa nostra, sola, o più spesso, per un breve periodo a metà degli anni Sessanta, in compagnia di mio nonno, «tra una moglie e l’altra» come una volta mi capitò di sentir dire da qualcuno, prima di scoprire il significato di quest’espressione – la mente dei bambini prende tutto alla lettera: mi figuravo mio nonno schiacciato tra la mia Nana ormai morta e qualche altra donna – e cogliere il tono di biasimo che la accompagnava. Forse fu per via di questa osservazione ascoltata per caso che una volta trovai il coraggio di chiedere a mia madre, mentre cucinava dei pisellini, gli unici graditi da mio nonno, se Yona era la sua fidanzata.
«Yona!» ripeté con una risata mia madre, scuotendo il capo. «No, stupidino, Yona è nostra cugina!».
Poiché mia madre è figlia unica, sapevo che quando parlava di «cugini» – così come per le «zie» e gli «zii» – si riferiva a parenti piuttosto alla lontana – se pur tali erano. Così mi convinsi che quella donna ancora giovane, per certi versi affascinante, con i capelli neri cotonati sul viso languido, era in qualche modo imparentata con la famiglia Jaeger, e che dovevamo essere gentili con lei. Lo sarei stato comunque, perché avvertivo che per me nutriva una certa predilezione. «Che begli occhi azzurri che ha!» diceva a mia madre, in tono affettuoso. Ed era una donna molto seria. Solo mio nonno, a quanto ne sapevamo, riusciva a farla ridere, lui che la canzonava chiamandola «Yona geblonah!» e raccontandole storielle piccanti in una lingua all’epoca per me incomprensibile. Poi mio nonno si sposò altre tre volte, e invece di Yona a casa cominciarono a venire prima Rosa, poi Alice e in ultimo Ray, Raya, con il braccio tatuato, che la sera a cena prendeva sempre il posto di mio nonno a capotavola, fingendosi sorpresa appena si avvedeva che lui era lì in piedi in attesa che gli cedesse la sedia, e quando infine cominciava a mangiare si avventava sul piatto come se temesse che qualcuno glielo portasse via; forse fu per via di queste mogli che perdemmo i contatti con Yona. Sul finire degli anni Sessanta smise di venirci a trovare a Long Island e non la vedemmo più.
Sempre negli anni Sessanta Elkana venne a farci visita per la prima volta. All’epoca era giovane, scuro di capelli, con un carattere particolarmente vivace. Il fatto che venisse a casa nostra scortato dalla polizia, in elicottero, era ai miei occhi motivo di fascino e un indice della sua importanza. Non era molto alto – come tutti gli Jäger, pensavo, finché non seppi di Shmiel – ma aveva un portamento autoritario e modi espansivi, proprio come mio nonno. Per me era a un tempo sconcertante e piacevole vedere rispecchiate in qualcun altro quelle caratteristiche a me familiari, trasfuse su quel giovane volto perspicace, scaltro, dagli occhi ridenti e i baffi vistosi, con in più un’aria vagamente esotica. Ogni volta che veniva a trovarci, a volte solo, altre con la bellissima moglie Ruthie (che, apprendemmo con somma sorpresa, non si era mai tagliata i capelli. Quando la mattina, nel nostro bagno con le mattonelle azzurre, si avvolgeva le trecce biondissime attorno al capo, alle volte mi permetteva di guardarla), e ci prometteva che se fossimo andati in Israele avremmo trascorso una vacanza indimenticabile.
«Non dofete far altro che prendere l’aereo – non passerete la dogana, il controllo del passaporto e roba del senere!» prometteva con quel suo strano accento. «Ci pesserò io!» aggiungeva con voce piana, divertita, autoritaria, con la pronuncia aspra e sibilante di vocali e consonanti tipica degli israeliani. «Dehniel» mi chiamava. «Tanti aucuri!» mi salutava quando si accomiatava prima di partire o al telefono.
Nel 1973, poco dopo la celebrazione del mio barmitzvah, i miei genitori finalmente accettarono il suo invito. Ero contento che partissero: mio nonno e Ray avrebbero badato a noi cinque durante la loro assenza. Che andassero pure in Israele: avevo il mio nonnino.
I miei genitori avevano in programma questo viaggio da lungo tempo, mio nonno aveva sempre desiderato che la figlia conoscesse il suo adorato fratello. Nell’autunno del 1972, mentre si organizzava il mio barmitzvah che avrebbe avuto luogo l’aprile seguente, i miei cominciarono anche i preparativi di quel loro primo viaggio all’estero, sempre rimandato. Ma a dicembre zio Itzhak venne a mancare. Era venuto al mondo con il nuovo secolo, aveva settantadue anni. Fu un duro colpo per mia madre, che già assaporava l’incontro con il leggendario zio, quando mancavano appena quattro mesi. Un paio di mesi dopo la sua morte, alcuni amici di famiglia si recarono in Israele e si fermarono per un po’ da Elkana. Tornarono da quel viaggio con un carico prezioso: tra le tante diapositive scattate, v’era quella della tomba di Itzhak. Una sera, non molto prima della partenza dei miei genitori, le visionammo: sull’immacolata parete del soggiorno si materializzò per la prima volta davanti ai miei occhi il nome Jäger in caratteri ebraici, su una tomba. Sarebbero passati trent’anni prima di rivederlo, nel cimitero di Bolechow quando ci imbattemmo nella lapide di una lontana cugina di mio nonno e di Itzhak, Chaya Sima Jäger, nata Kasczka.
Sulla parete del soggiorno, vidi questi caratteri enormemente ingranditi:

Fu poco dopo il bar mitzvah, quando con mia grande umiliazione la voce s’incrinò proprio sulle ultime parole della haftarah, che i miei genitori partirono per Tel Aviv. Ovviamente su quel viaggio circolano parecchie storie. Per esempio, mia madre adora raccontare come lei e mio padre non passarono la famigerata dogana, proprio come aveva promesso Elkana anni prima, e furono subito accompagnati all’automobile messa loro a disposizione; e la subitanea simpatia creatasi tra il mio cerebrale genitore e l’anziana zia Miriam, l’intellettuale poliglotta il cui fervente sionismo aveva salvato la sua famiglia; i viaggi segreti la sera nelle limitrofe zone arabe dove sorgevano ristoranti unici al mondo, le nottate nella cosmopolita Tel Aviv in compagnia di amici (cosa quest’ultima che mi sorprese non poco, convinto com’ero che quel paese non fosse altro che una distesa di edifici di cemento di recente costruzione). E l’escursione a Haifa, dove vivevano zia Miriam e la figlia, Bruria, sorella di Elkana (Miriam al piano superiore, Bruria e la sua famiglia al piano sottostante) le continue visite di amici e parenti che desideravano conoscere i cugini americani, mentre mia madre, simile al personaggio di una farsa, tutto il giorno non faceva altro che salire e scendere scale per passare più tempo possibile con i vari parenti. Un particolare suscitò il mio interesse. «Oh, Daniel» mi disse mia madre, quando mi chiamarono da Israele appena arrivati, per accertarsi che andasse tutto bene, «dovresti vedere l’album di fotografie di zia Miriam! C’è una foto del matrimonio di Jeanette, quella che non trovo più, dove lei indossa l’abito di pizzo che le comprarono i Mittelmark. È bellissima!». Per quanto emozionante, trovai strano che quei lontani parenti conservassero delle fotografie della mia famiglia.
E poi c’era la storia più famosa: mia madre che cercava di spiegare cosa fosse il colesterolo a un gruppo di lontani cugini, nell’unica lingua che (più o meno) avevano in comune, l’yiddish. Mia madre ama raccontare questo aneddoto, e ogni volta che lo riascolto non riesco a trattenere un sorriso, come è capitato qualche giorno fa:
E così ho detto: «Es iss azoy, di cholesterol iss di schmutz, und dass cholesterol luz di blit nisht arayngeyhen!».
«E i cugini all’improvviso mi guardarono e dissero:«Ahhhh, DUSS iss di cholesterol!».
Al di là del piacere che sempre provo nell’ascoltare questa storia, ciò che mi ha colpito ultimamente è un dettaglio mai menzionato in precedenza, o che forse non aveva mai attirato la mia attenzione: i cugini ai quali tentò di descrivere l’ultima ossessione americana in fatto di salute appartenevano al «ramo tedesco degli Jäger». «Chi erano esattamente?» le ho chiesto l’altro giorno, quando stava rievocando quel viaggio in Israele. Mio nonno mi aveva detto che uno zio paterno si era stabilito in Germania, e un altro in Inghilterra, ma a parte questo non sapeva nulla.
«Chi erano?» ripetei. Ma erano trascorsi trent’anni, e mia madre non seppe rispondermi.
L’aver nominato quei cugini Jäger di cui si erano perse le tracce, pensiero stuzzicante e frustrante al tempo stesso, mi fece ricordare il motivo per cui avevo sempre posticipato il viaggio in Israele. Sin da bambino, quando ascoltavo i racconti di mio nonno accucciato ai suoi piedi, e poi da adulto, quando cominciai a trascriverli e ad accumulare informazioni in uno schedario e (più di recente) al computer, ho sempre pensato che il significato della nostra famiglia, la sua peculiarità, fossero inscindibili dalle sue profonde radici europee, concetto che, mi rendo conto adesso, mio nonno cercò con tutte le sue forze di trasmettermi attraverso le sue storie. Naturalmente sapevo, in maniera teorica e concettuale, cosa rappresentasse Israele da un punto di vista storico, religioso e politico, per gli ebrei in generale e, certo, per la mia famiglia («Partí appena in tempo!»). Inoltre sapevo – già da bambino ero appassionato alle antiche civiltà greca e romana, passavo il tempo libero a costruire modellini di antichi templi – che Israele vantava una storia millenaria quanto le civiltà classiche, vi sorgevano resti archeologici di molti popoli. Eppure non sentivo il bisogno di andarci, probabilmente perché i miei parenti vi si erano trasferiti solo di recente, e quindi non avevano avuto parte nei secoli di storia di quella terra se non da soli trent’anni; al contrario, il coinvolgimento della mia famiglia nella storia europea, l’impero austro-ungarico, la Polonia, risaliva al periodo in cui gli Jäger e le prime comunità ebraiche si stabilirono a Bolechow, centinaia di anni fa. L’interesse che avevo di andare a trovare i miei parenti israeliani era simile a quello che uno studioso della guerra civile americana potesse avere di far visita alla mia famiglia nella villetta a due piani di Long Island.
Insomma, era proprio per le storie affascinanti e avvincenti narrate da mio nonno, immancabilmente ambientate in un lontano passato, quando ero abbastanza giovane da credere a tutto quel che diceva, che non nutrivo alcun interesse per Israele, uno Stato appena fondato. In realtà, adesso capisco che è stato per mio nonno se ho trascorso tanta parte della mia vita a ricostruire eventi remoti, non solo l’antica storia della sua famiglia, vissuta quattrocento anni nella stessa casa, una famiglia di prosperi commercianti e abili uomini di affari, dalle tradizioni consolidate per aver abitato così a lungo nello stesso posto, ma anche altre storie, persino più remote, risalenti ai greci e ai romani. Per quanto a prima vista diverse da quelle degli ebrei austro-ungarici, anch’esse narravano eventi comici, più spesso tragici, storie di guerre e di distruzioni, di giovani fanciulle sacrificate per il bene del casato, di fratelli avvinti in lotte mortali, di intere generazioni di una dinastia destinate a ripetere gli stessi fatali errori.
Da mio nonno sviluppai il gusto dell’antico, ed è per questo che non sentivo il bisogno di andare in Israele, fin quando, nel 2003, non scoprii che lì viveva un gruppo di sopravvissuti di Bolechow.
Giunsi in Israele il 26 giugno, un martedì.
O meglio, giungemmo. Matt non aveva potuto accompagnarmi, a maggio gli era nato il primogenito; avevamo già in programma un viaggio successivo, avrebbe immortalato con la sua Hasselblad i cinque sopravvissuti di Bolechow viventi in Israele, che Shlomo Adler mi avrebbe presentato. A parte lo stesso Shlomo, si trattava di Anna Heller Stern, un’amica di Lorka; viveva a Kfar Saba, un sobborgo di Tel Aviv dove abitava anche Elkana, il cugino di mia madre («Dovresti venire subito in Israele» mi raccomandò questi una volta, con la sua voce rauca, di chi la sa lunga ed è abituato a dare ordini e a essere obbedito, la voce di uno Jäger. «Dovresti venire a conoscere la famiglia» mi aveva suggerito anni prima, quando ancora non pensavo minimamente che un giorno sarei andato a Bolechow per scrivere un libro. Poi, lanciando sapientemente l’esca, aveva aggiunto: «C’è anche una donna che fu amica di Lorka, potrai parlarle». Accadde un anno prima che mi decidessi a recarmi in Israele, dopo avergli mandato lo sterminato albero genealogico degli Jäger disegnato con un nuovo software per le genealogie appena acquistato, punto d’inizio il 1746, anno di nascita della mia remota antenata Scheindl Jäger, un documento così voluminoso che srotolato copriva quasi interamente il mio soggiorno, da costringermi a spedirlo in un contenitore cilindrico. Quando lo chiamai per sapere se aveva visionato il documento che gli avevo mandato, con lo stesso tono perentorio mi disse: «Sì, è davvero imponente, hai fatto un ottimo lavoro. Ma ci sono degli errori – te li dirò quando verrai in Israele»).
Insomma c’era Anna Heller Stern.
Oltre a Shlomo e suo cugino Josef Adler, unici superstiti della loro famiglia, all’epoca solo dei ragazzi, salvatisi grazie a dei contadini ucraini che avevano procurato loro un rifugio, c’erano i coniugi Reinharz, Solomon e Malcia, che vivevano a Beer Sheva, a sud di Tel Aviv, unitisi in matrimonio nel lontano 1941, come mi informò Shlomo in una delle numerose email scambiate prima della partenza. Loro invece, durante i terribili rastrellamenti delle seconda Operazione, erano riusciti a fuggire e a nascondersi nel sottotetto di un edificio adibito a circolo ricreativo degli occupanti tedeschi – un casino, l’aveva definito Shlomo.
Mi aveva assicurato che avrei parlato anche con loro. Aveva organizzato ogni cosa nei minimi particolari, mi avrebbe accompagnato lui stesso. Lo ringraziai, riconoscente. Non fu la prima né l’ultima volta nel corso di una lunga e complicata amicizia con quell’omone grande e grosso come un orso, la cui pronunciata gestualità e la voce toccante avevo immortalato nelle videocassette che conservo del viaggio in Israele, gesti e intonazioni che mi sembra di vedere e sentire persino nel leggere le sue email. Adesso capisco che dietro le offerte di aiuto, l’entusiasmo, la smisurata energia che trasfondeva, si celava qualcos’altro di più personale: il bisogno di rimanere legato a Bolechow, alla sua infanzia, alla vita perduta.
Quindi ero d’accordo con Matt, saremmo tornati per rivedere quelle persone non appena lui avesse potuto lasciare il figlio appena nato, l’ultimo rampollo di una famiglia che, almeno per quanto ho potuto ricostruire,vide la luce nel 1746 con la nascita di Scheindl Jäger.
Comunque non partii da solo; mi accompagnò un’amica. La definisco tale malgrado sia più anziana di me: appartiene alla generazione di mia madre. È una collega, docente di lettere antiche specializzata nella tragedia greca, genere (sono convinto che persino Rashi sarebbe d’accordo) insuperato quanto a concisione ed eleganza, autentica riflessione poetica e rappresentazione drammatica dei disastrosi effetti derivanti dallo scontro tra il fato e il caso, la volontà non libera dell’individuo e l’assoluta arbitrarietà della Storia: quei momenti cruciali e folgoranti in cui gli uomini devono affrontare l’imperscrutabile volere divino, costretti a interrogarsi sulla causa delle proprie sventure. Quando decisi di intraprendere il dottorato in lettere classiche, scelsi l’università dove insegnava Froma, la mia compagna di viaggio, entusiasmato da alcuni suoi saggi pubblicati su riviste accademiche, il cui raffinato ordito stilistico, sinuoso, allusivo, complesso, brillantemente stratificato, rifletteva alla perfezione le peculiarità dei testi che si proponeva di interpretare, con sottili e sublimi significati che emergevano da complessi intrecci, continue, eleganti allusioni, culminanti in commenti profondi e stimolanti sulla vita. Avevo ventidue, ventitré anni quando m’imbattei in quegli studi, e decisi di conoscerla di persona; così mi iscrissi al suo corso. Ricordo ancora l’impressione che ebbi quando entrai nel suo ufficio, traboccante delle famose, metastatizzanti cataste di libri e pile di fogli; numerose sottili sigarette marroni bruciavano, dimenticate, in pesanti posacenere di vetro. Mi aspettavo di trovarmi di fronte una donna imponente, dal piglio severo – ero ancora così giovane da confondere la genialità con la severità – e invece si rivelò una persona dalla disponibilità disarmante, con il viso ovale e l’espressione attenta, i soffici capelli castano chiaro, molto corti, e i famosi abiti di velluto e pelle, dalle tonalità particolari, le borse in stile cubista con le lampo cucite nei punti più impensati. Quel giorno parlammo solo qualche minuto; alla fine mi rivolse uno dei suoi improvvisi, intensi sguardi ed esclamò,con la sua tipica voce bassa, quasi roca: «Ma certo che deve iscriversi qui, sarebbe un embarras de richesses!».
Dirò subito che Froma è dotata di un intelletto ben più capace del mio, in grado di elaborare sintesi più creative e audaci, di intuire opportunità dove io (cresciuto dopo tutto in una famiglia dove imperava «la mania per l’ordine tipicamente tedesca dei Mittelmark», per dirla con mia madre) vedo solo disordine e problemi. Quando a metà della mia tesi di dottorato sulla tragedia greca ritenevo di essermi infilato in un vicolo cieco, lei mi dimostrò di essere in errore. Guardandomi negli occhi, il capo lievemente inclinato, come le capita quando è molto concentrata, una sigaretta marrone fra le dita, incurante della cenere che stava per caderle in grembo, l’altra mano inanellata che giocherellava con uno dei suoi pezzi di bigiotteria smaltati che le piacciono tanto, Froma sottolineò: «Lei sbaglia a considerare la complessità un problema e non la soluzione».
Quando cominciai a seguire i suoi corsi scoprii che condividevamo un profondo interesse per la storia degli ebrei nella seconda guerra mondiale. Naturalmente i suoi interessi erano più vasti, di più ampio respiro, a un tempo più teorici e più specifici dei miei. Nipote di due rabbini, essi stessi prodotto della più alta cultura di Vilnius («la Gerusalemme del nord», com’era definita; purtroppo, essendoci stato, posso affermare che ben poco rimane di quella straordinaria stagione culturale), e figlia di ebrei Ricostruzionisti, Froma al contrario di me ha ricevuto una rigorosa educazione ebraica: legge e parla fluentemente l’ebraico, conosce approfonditamente la religione, la legge e la letteratura giudaica ed ebraica come io non mi sono mai peritato di fare. Ebrea fino al midollo, con una vita professionale dedicata allo studio della tragedia, poteva mai non essere ossessionata dall’Olocausto?
Per me invece era solo una questione di famiglia, un interesse privato. In fondo volevo scoprire quale fosse stato il destino di zio Shmiel e degli altri, mentre lei quello di tutte le vittime. E non solo. Persino oggi, anni dopo le prime segnalazioni delle decine di libri sugli esperimenti medici dei nazisti e i documentari sui partigiani di Vilnius, le dozzine, centinaia di film, documentari e volumi, una montagna di informazioni che non avrei il tempo di recepire, ancora adesso stupefatto dall’enorme energia mentale che le permette di leggere, vedere e assimilare tutto questo, dopo tanti anni è sempre alla spasmodica ricerca di informazioni che possano in qualche modo rispondere a domande profonde: come accadde e, interrogativo destinato a rimanere insoluto, perché.
In ogni modo, è questa la ragione per la quale, anni dopo aver terminato gli studi con lei ed essermi avvalso del suo aiuto per completare la tesi sulla tragedia greca, continuavo a imparare da quella donna, che mi spingeva a vedere il problema stesso come la sua soluzione.

E così anche Froma si unì alla ricerca degli scomparsi, e nell’estate del 2003 facemmo il viaggio insieme. Ci eravamo incontrati a Praga, dove si era recata per visitare i luoghi dell’Olocausto. Cosa vedemmo in quella città? Josefov, l’antico quartiere ebraico, con le sue sinagoghe minuscole, quasi sotterranee, dalle pareti fresche che difendono dal caldo estivo, le strade sinuose brulicanti di biondi turisti diligentemente armati di guide, che acquistano in tutta fretta cartoline della sinagoga Pinkas nella Praga ebraica; le sfarzose decorazioni in stile moresco degli interni dipinti di bianco e giallo della sinagoga spagnola, edificata nel 1868 dove un tempo sorgeva la più antica shul di Praga, ora restaurata in tutto il suo chiassoso policromo splendore per la gioia dei turisti; nel vecchio cimitero ebraico visitammo la tomba sontuosamente ornata da bassorilievi del rabbino Judah ben Loew Bezalel, morto a ottantaquattro anni nel 1609, colui che, secondo la tradizione, con il fango del fiume Vltava creò il golem per difendere gli ebrei dagli attacchi antisemiti di Rodolfo II d’Asburgo. Per una curiosa coincidenza, il golem venne chiamato Yossel – «Joey» inyiddish – lo stesso nomignolo che, tre secoli dopo, i riconoscenti ebrei di Bolechow diedero al discendente di Rodolfo, Francesco Giuseppe, in segno di affettuosa gratitudine per la sua benevolenza verso i giudei. All’uscita dal cimitero si possono acquistare statuine del golem, una delle prime ancorché primitive forme di difesa contro le persecuzioni degli ebrei di Praga.
Cos’altro vedemmo? Oggetti ben più pregevoli delle statuette di Yossel: le migliaia di tazze e vasi straordinariamente intagliati, scolpiti, a rilievi decorati e oggetti rituali di ogni tipo, esposti nella mostra permanente di arte giudaica europea allestita al piano superiore della sinagoga spagnola, un tempo galleria riservata alle donne, quando a Praga c’erano ancora ebrei che si recavano a pregare in quegli edifici di culto. In quella splendida giornata estiva, la visitai con grande reverenza, insieme a centinaia di turisti. Per una curiosa coincidenza, questa collezione di torah, candelabri da cerimonia, calici e medaglioni deve la sua ricchezza al fatto che Hitler avesse designato Praga come il luogo dove erigere il museo del popolo estinto, per gli ariani a venire (in verità tale informazione passa alquanto inosservata). E in effetti le ingenti proprietà di almeno centocinquantatré comunità provenienti dalle regioni limitrofe furono debitamente trasportate in città nel 1942 per essere esaminate e classificate, anche se il museo nazista del popolo ebreo non vide mai la luce; oggigiorno questi pezzi di raro pregio possono essere ammirati dai turisti che si recano nel quartiere ebraico di Praga, prima di ritornare agli alberghi e fare programmi per la cena.
Vedemmo tutto questo, prima di tornare a nostra volta in albergo e decidere dove cenare. Perché, dopotutto, per quanto interessati – oserei dire ossessionati – dal passato, vivevamo nel presente, e la vita continuava. Ma il passato ha modi inaspettati di manifestarsi. Fu a Praga che si verificò la prima di quella che allora ritenevo una bizzarra serie di coincidenze. La sera prima di recarci a Terezin – il campo di concentramento «modello» situato non lontano dalla città, che venne anche mostrato a ufficiali della Croce Rossa per dimostrare il trattamento umano riservato dai tedeschi a internati, ebrei, sovversivi e prigionieri politici – io e Froma avevamo preso l’ascensore per salire al bar dell’ultimo piano dell’albergo, da dove, recitava la nostra guida, si poteva godere una straordinaria veduta della città. A una fermata intermedia un signore distinto fece il suo ingresso nell’ascensore. Sfoggiava anelli d’oro e un orologio molto costoso. Come accade spesso in situazioni del genere, seguì un silenzio colmato da sorrisetti imbarazzati. All’improvviso il signore dalla bianca chioma e dall’aspetto vigoroso si voltò verso di noi con gesto casuale e, annuendo come a confermare una nostra supposizione, quasi fossimo nel bel mezzo di una conversazione, disse: «Sì, ero a Babi Yar».
La mattina seguente prendemmo posto su un gigantesco pullman dotato di aria condizionata per la prevista escursione di un’ora del gruppo di Froma all’ultimo campo di concentramento di quel mesto viaggio. I cechi lo chiamano Terezín, ma fino all’occupazione nazista il suo nome era Theresienstadt, «Città di Teresa»: la città di Maria Teresa, la grande imperatrice asburgica del diciottesimo secolo, la regina Vittoria della Mitteleuropa. Venne così chiamata perché Theresienstadt, completata nel 1780, l’anno della morte dell’imperatrice, era una delle città-fortezza dotate di mura di cinta edificate durante il regno di questa grassottella e dispotica sovrana, a protezione dei vasti domini asburgici. Questo crogiolo multiculturale di nazioni, regioni e principati si disintegrò quando un giorno di giugno del 1914 il nazionalista serbo Gavrilo Princip (evidentemente non soddisfatto di questa mescolanza) assassinò l’arciduca Francesco Ferdinando, discendente di Maria Teresa ed erede al trono del già anziano Francesco Giuseppe, Yossele. L’evento innescò una reazione a catena di dichiarazioni e ultimatum che, com’era prevedibile, portarono inevitabilmente di lì a breve allo scoppio della prima guerra mondiale e al conseguente collasso dell’impero. Visitammo il campo con i vari musei in quel piovigginoso giorno di giugno 2003, girovagando tra le baracche ricostruite e il museo del ghetto, indugiando davanti alla toccante esposizione dei manufatti creati dai bambini internati durante gli anni dell’occupazione nazista; quello che più mi colpì fu scoprire che in una delle vecchie celle, un tempo prigione della fortezza – un minuscolo stanzino dalle spesse pareti dove venni sopraffatto da un attacco di claustrofobia, come non di rado mi accade (per esempio negli ascensori o in luoghi angusti e sotterranei) – era stato incarcerato lo stesso Gavrilo Princip dopo l’assassinio dell’arciduca; fu lì che morì, non molto tempo dopo. Rimasi stranamente commosso da quell’inaspettata e concreta testimonianza del crimine che scatenò la prima terrificante carneficina del secolo, e ciò non senza imbarazzo, poiché solo questo fatto mi aveva toccato così nel profondo. Solo dopo averci riflettuto compresi la ragione della mia commozione: queste vestigia di Princip e del suo gesto, estranee agli interessi miei e di altri visitatori, tutti avidi di informazioni inerenti l’Olocausto, mi avevano riportato indietro nel tempo all’infanzia e adolescenza di mio nonno nel periodo austro-ungarico, al momento del più grave disastro politico mai occorso agli ebrei di Bolechow, come si rivelò, di fatto, l’assassinio dell’erede del loro amato imperatore, che innescò la guerra più terribile mai vista.
Cosí visitammo anche Theresienstadt. Dal suo sito web è possibile inviare agli amici delle cartoline elettroniche con il saluto ARBEIT MACHT FREI; la cartolina che mandai alla signora Begley da Praga raffigurava semplicemente Josefov, il pittoresco, antico quartiere divenuto meta turistica. «Praga è bellissima» le scrissi «oggi siamo andati al quartiere ebraico. Ma di ebrei nemmeno l’ombra». Considerato il suo senso dell’umorismo, immaginai che avrebbe apprezzato la dolente battuta, e non sbagliavo. «Molto divertente» commentò simulando disappunto quando andai a trovarla appena tornato dal viaggio durato un mese, durante il quale visitai Praga, Vienna, Tel Aviv, Vilnius e Riga. Eravamo a casa sua e la stavo ragguagliando sulle mie avventure. Brandí le cartoline esclamando: «Vede? Le ho tenute tutte». Fece cenno a Ella di versarmi dell’altro tè freddo; nel soggiorno faceva caldo, aveva spento il condizionatore, malgrado fosse fine luglio. «Non ci sento con quell’arnese acceso» si era giustificata, lanciando un’occhiata di fuoco all’apparecchio, dalla sua poltrona preferita, una riproduzione bergère, con lo schienale alto, situata nell’angolo della sala. La associavo a un trono, forse per la postura della mia amica, sempre così eretta, almeno fino a qualche tempo prima: stava appollaiata sul bordo, a volte poggiandosi a un bastone, mi osservava con sguardo fermo e indagatore, un occhio socchiuso, ascoltava le mie storie, di tanto in tanto scuoteva impercettibilmente il capo e mormorava che ero troppo sentimentale, o gesticolava irritata per il mazzo di fiori con cui la omaggiavo, che Ella subito sistemava sul tavolinetto, mentre lei lo respingeva con un gesto della mano grinzosa, come a dire che il denaro speso lo avrei potuto impiegare per i miei figli. «Come stanno i bambini?» era immancabilmente la prima domanda che mi rivolgeva, una volta assisa sulla poltrona a forma di trono accanto all’album di fotografie del figlio e dei nipoti. «Il bambino, il bambino, tutti mi dicevano di salvare il bambino» mi aveva confidato in lacrime un giorno, in una delle prime visite, nella stessa occasione in cui mi aveva confessato di soffrire di sensi di colpa per non essere riuscita a salvare gli altri parenti. Tre anni dopo, quello stesso giorno, mi recai da lei per narrarle la mia odissea europea; sorseggiavo il tè, lei sorrideva mestamente e commentò: «Non ci sono più ebrei laggiù. Certo, siamo tutti qui o nella tomba».
Dalla sudicia e deprimente stazione ferroviaria di Praga risalente all’epoca sovietica, dove un vecchio decrepito, rivelatosi un fattorino che ci offriva i suoi servigi, ci importunava con fare aggressivo, prendemmo il treno e in quattro ore giungemmo a Vienna. Amo questa città, non da ultimo perché compare in certe storie di famiglia («Mio padre» era solito ripetermi mio nonno «una volta all’anno andava a Vienna per affari; oh, i regali che ci portava, i giocattoli, i dolci!»). Froma non c’era mai stata, ed ero impaziente di mostrarle le sue imponenti bellezze, i celeberrimi palazzi in stile barocco e Beaux-Arts dall’intonaco scrostato e dai particolari sempre un po’ eccessivi, i cornicioni enfatici, le modanature elaboratissime, un tempo simboli di un impero fin troppo fiducioso nella propria grandezza, oggi alquanto imbarazzanti considerata la sua dissoluzione – un po’ come un’anziana parente eccentricamente agghindata in un’occasione informale. Malgrado ciò adoro Vienna, forse perché la tenacia con cui si tiene avvinta al desueto formalismo di un’epoca scomparsa mi ricorda alcuni austriaci conosciuti tempo addietro.
Cosa vedemmo a Vienna? Parecchi luoghi a me cari, non da ultimo, vista la mia passione per le tombe, non solo ebraiche, il Kaisergruft, la cripta imperiale degli Asburgo, un fresco ambiente sotterraneo che, entrandovi per la prima volta, mi fece pensare a una cantina, solo che al posto delle botti e delle bottiglie sotto il basso soffitto a vòlta sono allineati i sarcofagi in pietra e bronzo, decorati da statue e teschi coronati che sembrano sussurrare le epigrafi latine a coloro che abbiano l’ardire di guardare. Naturalmente il monumento più imponente è quello di Maria Teresa, una statua in bronzo a grandezza naturale, con un braccio sollevato dal coperchio della bara gigantesca, il viso immortalato in un sorriso estatico, espressione forse dovuta all’attesa della vita eterna, o magari al fatto che il suo adorato marito, Stefano di Lorena, si leva di fronte a lei. Visitammo il Kaisergruft, dove riposa lo stesso Francesco Giuseppe, in un lucente sarcofago di marmo posto al centro di un sobrio ambiente circondato da sottili candelabri, tra la bellissima moglie Elisabetta, anche lei vittima di un assassinio, e il romantico figlio Rodolfo, il principe ereditario che si tolse la vita insieme all’amante adolescente a Mayerling, una dimora di caccia reale, nel gennaio 1889, circostanza che, tra le altre cose, mi induce a riflettere su certe storie di famiglia, per esempio su quella che mi raccontava sempre l’infelice sorella di mio nonno, Sylvia: da bambina avrebbe visto quel principe ereditario in uniforme blu salire la scalinata di un palazzo a Lemberg (come si chiamava ai suoi tempi quella città) su un cavallo bianco. Peccato che sia nata nel 1898, cioè nove anni dopo l’atto che avrebbe reso il romantico Rodolfo così famoso.
Insomma, vedemmo tutto questo. Ma, come ho detto, la curiosità di Froma è insaziabile. Quando le chiesi la ragione della frase immancabilmente ripetuta al termine di ogni visita, «Torniamo a dare un’ultima occhiata», il motivo di quella smania di vedere quanto più possibile, di quelle incessanti domande, mi rispose: «Perché penso che probabilmente non torneremo più qui, quindi bisogna ricavare più informazioni possibili». Comunque non rimase particolarmente impressionata dalla cappella funeraria degli Asburgo, a lei interessavano soprattutto i siti giudaici. Tanto per cambiare, le esperienze di vita, l’influenza familiare e le storie a essa legate, mi fecero provare una particolare emozione in un luogo per altri non particolarmente interessante. Dopo aver visitato il museo ebraico in Dorotheergasse (dove scoprii che già sul finire del dodicesimo secolo, poco dopo lo stanziamento delle prime comunità ebraiche in città, si verificarono i pogrom, e sedici ebrei vennero uccisi con il beneplacito del papa); dopo aver visitato il nuovo museo nella vecchia Judenplatz, Piazza dei giudei (sotto la quale,ci fu detto, gli archeologi hanno rinvenuto i resti della prima sinagoga della città, distrutta il 23 maggio del 1420, giorno in cui il duca ordinò l’incarcerazione o l’espulsione degli ebrei di Vienna e la confisca dei loro beni; oggi rimane ben poco delle rovine, perché le pietre del tempio furono impiegate per costruire l’università); dopo aver preso visione del Memoriale delle vittime austriache dell’Olocausto, opera dell’artista inglese Rachel Whiteread, un cubo di cemento simboleggiante una biblioteca inaccessibile, contenente settemila volumi, che reca incisi alla base i nomi dei luoghi dove furono sterminati quasi settantamila ebrei viennesi; dopo aver visto tutto questo, l’ultimo giorno della nostra permanenza a Vienna ci recammo allo Zentralfriedhof, il grande cimitero della città. Froma desiderava rendere omaggio alla tomba originaria del pioniere sionista del diciannovesimo secolo, Theodor Herzl, «il padre del moderno Israele», morto a Vienna nel 1904 all’età di quarantaquattro anni (le spoglie vennero traslate nel 1949 nel neonato stato di Israele: gesto di grande pregnanza simbolica, se si considera che tombe, cimiteri, memoriali e monumenti, inutili per i morti, sono estremamente significativi per i vivi). Consultammo una delle innumerevoli cartine e guide che Froma ama acquistare in viaggio – io, meno curioso, più passivo, preferisco passeggiare e imbattermi nelle cose – e organizzammo la nostra visita.

Dal centro di Vienna allo Zentralfriedhof il tram impiegò venti minuti buoni, ma il cimitero, molto esteso, è servito all’interno da un’altra linea, con le fermate ai vari ingressi, sbarrati da grossi cancelli; la distanza tra un’entrata e l’altra, in termini di spazio e di tempo, è considerevole. Cominciammo dall’ingresso 1, quello del «vecchio» settore ebraico, e attraversammo a piedi un boschetto pieno di sterpaglie, per quanto, di recente, in seguito alle proteste per l’infelice stato della grande necropoli, siano stati compiuti degli sforzi per la sistemazione del sito. Ma dopo aver vagato per quasi un’ora tra sfarzose tombe, monumenti e memoriali trascurati di defunti che nessuno ricorda più, in quanto i discendenti di questi notabili del diciannovesimo secolo sono a loro volta scomparsi dalla faccia della terra, ci accorgemmo di essere nel posto sbagliato. Impiegammo venti minuti per raggiungere la parte centrale, e altri venti per arrivare all’ingresso 4, dove sorge il nuovo settore ebraico. Da parte mia non nutrivo particolare interesse per Herzl e la sua tomba, poiché, come ho già avuto modo di sottolineare, all’epoca Israele non suscitava il mio interesse. Ma fui sopraffatto da quel che trovammo.
O, dovrei dire, da quel che non trovammo. A occhi ben aperti, varcammo l’ingresso estremamente ricercato, Art Deco, di questa nuova parte dello Zentralfriedhof. Il cancello presentava motivi di archi stilizzati, di foggia vagamente moresca, ripresi, su scala gigantesca, nella cupola della Zeremonienhalle di questo nuovo settore ebraico, l’edificio appartenuto alla società che si occupa dell’inumazione, conosciuta in ebraico come Chevra Kadisha (per tradizione sono i suoi membri che lavano e preparano i cadaveri per la sepoltura: il rito che mio nonno mi dettò la mattina di una lontana estate). In seguito appresi che il complesso della Zeremonienhalle del cimitero di Vienna venne progettato e costruito tra il 1926 e il 1928 da un prolifico architetto ebreo viennese, originario dell’Ungheria, Ignaz Reiser; tutte le sue opere pubbliche, dalla sinagoga costruita negli anni 1912 1914 nella Enzersdorferstrasse alla stessa Zeremonienhalle, sono indicate come zerstört nel testo tedesco di architettura che consultai dopo aver visitato quel notevole complesso cimiteriale: «distrutti». Lasciammo la Zeremonienhalle, il rifacimento di un edificio distrutto la notte dell’8 novembre 1938, e ci dirigemmo verso la distesa di lapidi. Davanti ai nostri occhi sbalorditi si apriva un gran vuoto. Dell’esteso appezzamento di terreno acquistato dagli ebrei di Vienna nel 1920 per adibirlo a luogo di sepoltura, perché ormai il vecchio settore era sovraffollato, solo una parte relativamente poco estesa era occupata da tombe. Accanto ai loculi (notammo che quasi nessuno reca date più recenti dei primi anni Trenta) si stende una vasta distesa di terra. Rimanemmo a fissare lo scenario; infine ci rendemmo conto che il nuovo settore ebraico del cimitero di Vienna era quasi del tutto vuoto perché gli ebrei che dovevano riposare lì andarono incontro a una morte neanche lontanamente immaginabile, e vennero sepolti, se mai lo furono, in luoghi molto meno decorosi. Se ci si sofferma a riflettere sui danni incalcolabili prodotti dalle guerre, si pensa di solito a luoghi desolati un tempo brulicanti di vita: case, negozi, bar, parchi, musei, e così via. Io ho trascorso parecchio tempo nei cimiteri, eppure, fino a quel pomeriggio allo Zentralfriedhof, non mi era mai capitato di pensare che anche i cimiteri possano svuotarsi.
Fu questa l’inaspettata scoperta, mentre cercavamo il luogo di sepoltura del celebre sionista Theodor Herzl. La tomba non la trovammo; probabilmente Froma ci rimase male, ma per me era sufficiente quanto visto, o meglio, non visto, nel nuovo settore ebraico del cimitero di Vienna.
Dalla capitale austriaca mandai alla signora Begleyuna una cartolina raffigurante gli opulenti palazzi degli Asburgo. «Vienna è sempre bellissima» le scrissi «ma non ci sono ebrei – nemmeno i morti». Avrebbe apprezzato anche quella.
Il giorno seguente alla visita allo Zentralfriedhof partimmo per la terra concepita da Herzl.

La casa di Anna Heller Stern, l’amica di Lorka, era fresca e in penombra. Le persiane erano abbassate per ripararla dal sole estivo, addirittura fluorescente. L’arredamento era ridotto all’essenziale: un divano basso, un paio di sedie moderne attorno a un tavolinetto. Forse per lo scarso mobilio, per la frescura emanata dal pavimento senza tappeti, per l’ombra quasi sottomarina, entrando in quell’appartamento avvertii un piacevole sollievo, sensazione che a volte provo quando, per sfuggire al caldo estivo di un pomeriggio passato a ricopiare epitaffi rinvenuti in cimiteri dimenticati, trovo rifugio nel mausoleo di famiglia, un tempo grande ma ormai trascurato.
Come la sua dimora, Anna sembrava a un tempo socievole e riservata. Sfoderava un sorriso caldo, e quando Shlomo ci presentò mi strinse con vigore la mano; percepii però anche un’ombra di circospezione, come se quel posto, o forse lei stessa, nascondessero qualcosa. Quando aprì la porta, mi trovai di fronte una donna dalla corporatura vagamente a pera, con un viso dalla carnagione delicata di chi evita di esporsi al sole, l’espressione esitante, e i capelli tendenti al fulvo. Indossava una camicetta bianca senza maniche e un’attillata gonna grigia che le arrivava alle ginocchia. Come le mie nonne, aveva le braccia sode e pienotte dalla pelle liscia,come una pasta a lungo lavorata. Anna ci invitò a entrare e ci accomodammo. Lei sedette di fronte a Shlomo, io presi posto sul divano, dove poggiai il registratore, le cassette, la videocamera, le cartelline e l’unica fotografia di Lorka in nostro possesso, quella che ritrae la famiglia il giorno del funerale della madre di Shmiel, nel 1934.
Shlomo stava parlando in yiddish, e d’un tratto percepii le parole Di ferlorene, Gli scomparsi.
«Sta scrivendo un libro sulla sua famiglia» le spiegò. Sul tavolinetto c’erano piattini, tazze, tovaglioli, un vassoio con delle fette di torta accuratamente tagliate, pasticcini, una quantità di cibo sufficiente per quindici persone. Sorridendo, Anna mi avvicinò il vassoio, invitandomi a servirmi. Shlomo continuò: «Si chiamerà Gli scomparsi. Di ferlorene».
«Di ferlorene» ripeté Anna, annuendo, come se il titolo non richiedesse alcuna spiegazione.
Di ferlorene. Con mia sorpresa, la conversazione si svolse in yiddish; mi aspettavo il ricorso al polacco, con i suoi suoni dolci e sussurrati, lingua madre di entrambi, parlata nella loro infanzia a Bolechow negli anni precedenti la guerra, idioma cui spesso si era abbandonata Meg Grossbard nella riunione di gruppo a Sidney, simulando un lapsus, anche se, sospettavo, e a maggior ragione lo sospetto oggi dopo averla conosciuta, che fosse un modo astuto per sottolineare che si stava parlando di argomenti riguardanti la sua vita, era la sua storia da cui io, «americano di seconda generazione» come le piaceva definirmi, ero inevitabilmente escluso, considerato al più un mero osservatore, giunto ormai troppo tardi. Avevo anche pensato che parlassero in ebraico, la lingua del paese in cui ora vivevano, ma in seguito Shlomo mi spiegò che Anna si era stabilita in Israele solo di recente, avendo vissuto in Sud America con il marito dalla fine della guerra.
«Lasciò la Polonia nel 1947» mi riferì Shlomo in inglese. «Aveva ventisei anni. Ne ha vissuti quarantadue in Argentina. Si è trasferita qui solo da qualche anno».
Quando pronunciò la parola Argentina Anna sorrise, prese un giornale in spagnolo poggiato su un tavolino e lo indicò con un cenno del capo. «Ikh red keyn Ebreyish» mi disse in yiddish. «Non parlo ebraico».
Be’, nemmeno io. In quella lingua avevo imparato a pappagallo la haftarah che dovevo recitare, non sapendo neanche che stavo intonando un brano sulla purificazione della comunità ebraica. E per lungo tempo non mi passò nemmeno per la mente di decifrare testi in ebraico che invece, mi avvidi troppo tardi, avrebbero potuto gettare una luce sui segreti di famiglia e su storie non vere. Così fui ben felice di ascoltare da un nativo di Bolechow la lingua yiddish, circostanza che non avrei più creduto possibile dopo la morte di mio nonno. L’yiddish era la lingua d’Europa, della terra dei padri; quei suoni pastosi e pieni serpeggiano nei miei ricordi, familiari eppure misteriosi, come le lettere ebraiche con le loro forme curvilinee segnate su un foglio di carta o incise sulla pietra. Mia madre lo parlava in famiglia, così come i suoi zii, e la sua cugina più grande, Marilyn, la figlia di Jeanette, lo parlava da bambina con la nonna paterna, la temuta Tante, come mi ha rivelato l’altro giorno. Lei è rimasta ormai l’unica della famiglia a conoscere quell’idioma, visto che gli altri sono quasi tutti morti. Si rivolgeva in yiddish al padre quando voleva mantenere un segreto, celare un litigio o un pettegolezzo («Ober mayn frayndine hut gezugt azoy» diceva aggrottando la fronte, smorfia che lui non poteva vedere, mentre conversava al telefono, gesticolando all’indirizzo di un vicino con cui aveva discusso e a cui avrebbe presto tolto il saluto: «ma la mia fidanzata ha detto che...»). Soprattutto, l’yiddish era la lingua delle battute finali delle barzellette di mio nonno.
Per questo, quando Shlomo mi chiese se non avessi niente in contrario che si parlasse in yiddish, ne fui ben lieto. Desideravo ardentemente riascoltare quell’idioma.
«Yaw» dissi rivolto ad Anna, che sorrise. Posò il giornale, si voltò verso Shlomo e prese a parlare, troppo velocemente per me. Lui aspettò che terminasse, annuì e tradusse: «In Argentina ricominciò una nuova vita. Lì capì che era di nuovo un essere umano».
Annuii, quindi dissi: «Cominciamo».
Le spiegai che per completezza dei dati dovevo chiederle il nome da nubile, della sua famiglia a Bolechow. Era più semplice iniziare così.
«Ikh?» ripeté. «Io?». «Ikh hiess Chaya, jetz hayss ich Anna». «Mi chiamavo Chaya, poi ho preso il nome Anna».«E la “Klara Heller” di cui mi ha parlato Meg Grossbard, che avrei incontrato in Israele?» domandai stupito. Senza chiederlo ad Anna, Shlomo mi spiegò che da ragazza ai tempi di Bolechow si chiamava Klara, ma in memoria del prete ucraino che le salvò la vita procurandole un certificato di battesimo falso aveva mantenuto anche dopo la guerra il nome che questi le aveva attribuito: Anna.
«E la sua famiglia?» chiesi, come a imbeccarla per facilitarle le cose.
Mi guardò e con la mano fece il segno del quattro. «Vir zaynen geveyn fier kinder» rispose. «Eravamo quattro figli». Batté sull’indice: la prima. «A shvester, Ester Heller...».
Sulla seconda sillaba di Ester di colpo la voce si ruppe in pianto e lei si portò le mani al volto. Rivolta a Shlomo disse in yiddish, e stavolta compresi:
«Vedi? Già non riesco ad andare avanti».
In seguito, in quell’appartamento fresco e in penombra, avrei appreso che Ester venne catturata nella seconda Operazione – Anna, nascosta in un fienile, ne fu testimone, vide i duemila ebrei di Bolechow condotti alla stazione ferroviaria, costretti a intonare «Mayn Shtetele Belz», un ricordo troppo doloroso da rievocare, più di una volta si coprì il volto con le mani – e uccisa, come i due fratelli e i genitori: un’altra famiglia di sei persone distrutta; ma tutto ciò me lo raccontò più tardi. All’inizio di quella conversazione, quando ancora non avevamo nemmeno assaggiato i dolci, Anna cercava educatamente di collegare ogni informazione alla mia famiglia.
«Ikh verd den Detzember dray und achzig yuhr» mi disse. A dicembre compirò ottantatré anni. E poi aggiunse:«Lorka aveva qualche mese più di me».
«Ah» feci, pur sapendolo già, dato che il certificato di nascita di Lorka reca la data 21 maggio 1920. Le chiesi come faceva a ricordarlo così bene.
Anna sorrise. «Vayss farvuss ikh vayss?». «Lo sa perché lo ricordo? Perché al primo anno di scuola ero la più piccola e la più minuta. Con Lorka abbiamo frequentato la stessa classe fino in terza media. Dai sei ai tredici anni. Capisce?». Fershteyss?
Annuii. «Ihk fershteyeh» risposi.
A quel punto cominciò a parlare della famiglia Jäger. Le reminiscenze si succedevano caoticamente. Non la interruppi. Quel susseguirsi di pensieri mi interessava quanto i ricordi stessi.
«Shmiel Jäger aveva un autocarro, portava la merce a Lemberg» rievocò Anna, usando il vecchio nome della città di Lwów. «E lì caricava anche della merce... Erano proprio una bella famiglia, la moglie era una persona simpatica...».
Non mi sembrava vero poter scoprire qualcosa di più su Ester. «Ha qualche ricordo preciso di Ester, la moglie di Shmiel?» domandai.
Anna sorrise. «Sie veyhn a feine froh, a gitte mamma, agitte balabustah. Vusse noche ken ikh vissen?». «Era una persona distinta, una buona mamma, una buona donna di casa. Cos’altro potevo sapere?».
Aggiunse qualcosa rivolta a Shlomo, che tradusse: «Era una bambina, non conosceva la loro vita privata. La madre era un’ottima moglie, la casa era sempre in ordine e le bambine erano pulite e ben vestite».
Anna si rivolse a me: «Di zeyst?» dichiarò. «Lorkas familyeh kenn ikh besser als Malka Grossbard!».
«Vede? Conosco la famiglia di Lorka meglio di Meg Grossbard!».
Aggiunse qualcos’altro, e Shlomo mi spiegò che il fratello della madre, un certo signor Zwiebel, era vicino di Shmiel Jäger. Viveva proprio accanto a lui. Anna andava a trovare lo zio, e per questo vedeva spesso Lorka, non solo a scuola.
Forse per provare la veridicità di quell’affermazione, Anna ci rese partecipi di una vecchia reminiscenza. «Ricordo che le prime fragole raccolte si vendevano a Lemberg, e suo zio Schmiel Jäger le portava a Bolechow, dove ancora non si trovavano. E Lorka mi invitava a casa sua e mi diceva: “Vieni a mangiare le fragole fresche!”».
All’improvviso, distintamente, mi parve di afferrare un segno, una traccia, inequivocabile per quanto elusiva, un certo stile di vita, ormai scomparso.
Shmiel e i suoi autocarri: era un particolare che ricordavano tutti. Le chiesi di descrivermi il mio prozio.
Ad Anna sfuggì un risolino e tamburellò con le dita sulle orecchie. «Er var a bissl toip!». «Era un po’ sordo!».
«Sordo?» ripetei, al che lei confermò:
«Sí! Toip! Toip!».
Mi arresi. Poi le domandai: «Ricorda le altre figlie?».
«Di Kleynste» cominciò a dire, «la più piccola...».
«Bronia» suggerii. Ero eccitato al pensiero di aver finalmente conosciuto qualcuno in grado di dirmi qualcosa di Bronia, la bambina scomparsa sessant’anni prima nei cosiddetti bagni e stanze delle inalazioni in un campo di concentramento; Bronia, disgraziatamente troppo piccola quando venne catturata, quindi non abile al lavoro; quasi nessuno tanto giovane – le amiche, le compagne di scuola – era sopravvissuto, per questo è rimasto così poco di lei.
«Bronia?» ripetei. Ma Anna scosse il capo e disse: «Ruchele war di kleynste».
«Ruchele?» dissi, stupito. Anna annuì con convinzione, e ritenni opportuno non approfondire.
Così, mentre mi spiegava che di kleynste, la più piccola, era una ragazza molto seria, sensibile e delicata, il genere di bambina educata e tranquilla – descrizione che combaciava con quella di Jack su Ruchele – dubitavo di poter mai scoprire qualcosa di Bronia.

«Le voglio mostrare alcune fotografie» dissi ad Anna.
Per sollecitare la sua memoria avevo con me la cartellina con le vecchie istantanee di famiglia, la stessa portata in Australia. Ma dopo l’esperienza di Sidney, quando Boris Goldsmith, sbirciando la piccola foto del 1939 con Shmiel, Ester e Bronia, aveva dichiarato con un sospiro «Non riesco a distinguerli», avevo imparato la lezione: avevo provveduto a far ingrandire tutte le foto in mio possesso. Adesso anche la più piccola istantanea della mia collezione aveva un formato standard: il viso stanco e preoccupato di Shmiel, nell’ultima fotografia del dicembre 1939, era quasi a grandezza naturale. Mentre le passavo la cartellina uno degli ingrandimenti scivolò sul tavolino: era la foto del 1936 di Frydka, Meg Grossbard e Pepci Diamant che si recavano a scuola, con cappotti e i cappelli di pelliccia.
«Duss iss Frydka mit Malka Grossbard und Pepci Diamant» dissi. «Questa è Frydka con Malka Grossbard e Pepci Diamant». Anna indicò subito Meg e, come scegliendo la carta vincente dal mazzo, afferrò la foto ed esclamò: «Malka! Frydka var zeyer sheyn – zeyer shein!».
«Frydka era molto carina – molto carina!».
Accompagnò le parole con un gesto ammirato, un’espressione universale di meraviglia: si portò le mani al volto e alzò gli occhi al cielo. Dovevamo parlare di Lorka, lei era l’unica in grado di rivelarmi qualcosa, eppure non ero sorpreso che si parlasse di Frydka, una ragazza bellissima, a cui un giovane aveva immolato la sua vita, il tipo di ragazza cui si attagliano naturalmente storie e leggende.
«Voglio dirle una cosa» riprese Anna, contemplando la foto della quattordicenne Frydka. Shlomo ascoltò e poi tradusse: «Ha detto che Frydka avrebbe dovuto vivere al giorno d’oggi. Era una ragazza moderna, ma è vissuta nell’epoca sbagliata!».
«Cosa intende?» domandai.
«Viveva in un piccolo borgo, in quell’epoca, ed era criticata! Sai, era una ragazza libera!».
«Criticata?» ripetei, pensando: «Persino allora se ne parlava. Circolavano già storie su di lei».
Annuì. «Sarebbe dovuta vivere cinquant’anni dopo» ribadì. «Lorka era tranquilla, seria, aveva una sola sympatia...» (In seguito cercai la parola «sympatia» nel vocabolario polacco: significa «fiamma», e il sapore antico di quella parola mi commosse, ripensando ad Anna che parlava di Lorka e della sua sympatia).
«... una sola sympatia per volta. Le piaceva un ragazzo, il fratello della signora Halpern. Usciva con lui...Bumo Halpern».
«Davvero?» mi stupii. Ero sorpreso. Spiegai loro che a Sidney Meg Grossbard aveva insistito che il fidanzato di Lorka era un lontano cugino, Yulek Zimmerman. Anna scosse il capo decisa, e ripeté: «Bumo Halpern».
«Va bene» dissi. Per quel che contava, ormai.
Shlomo proseguì: «Secondo Anna, Lorka aveva un comportamento irreprensibile, non... tradiva la sua simpatia».
Tradiva.
«E Frydka?» domandai a quel punto, già intuendo la risposta.
Anna mi scoccò un sorriso e scosse il capo, divertita a quel ricordo, e agitando le mani rispose: «Frydka var geveyn a...»
(Si fermò, e non trovando la parola adatta in yiddishri corse allo spagnolo).
«... sie’s geveyn a picaflor!».
«Frydka era un colibrì!».
Mentre traduceva, Shlomo sorrise divertito al paragone. La ricordava anche lui, e commentò quasi gridando: «Sì! Era una farfalla! Andava di fiore in fiore!».
A quel punto, Anna e Shlomo presero a bisbigliare fitto in yiddish. Shlomo si batté la mano sulla coscia e scoppiò a ridere.
«Mi ha raccontato due cose» spiegò. «La prima riguarda Frydka. Anna e alcune amiche andarono a trovare un tale che aveva affittato una stanza nel quartiere russo di Bolechow, erano curiose di conoscerlo. Bussarono, e chi venne ad aprire? Frydka».
Sorrisi. Una farfalla! Be’, pensai, come biasimarla? Avevo visto le foto dell’album di Pepci Diamant. Frydka l’adolescente malinconica, con la testa fra le nuvole; Frydka, in una luminosa giornata con un vestitino bianco e scarpe aperte, che guarda di sbieco l’obiettivo, una ragazza alta e con le gambe lunghe; Frydka che gioca tra i cespugli nei pressi del fiume Sukiel; Frydkain posa, l’espressione accigliata, le dita sulle labbra finemente disegnate, sorpresa mentre fa uno spuntino con qualche prelibatezza preparata dalla madre. Era facile prendere una cotta per una ragazza così.
Anna si scusò e si alzò per rispondere al telefono,che aveva cominciato a squillare proprio mentre finiva di raccontare questa storia; mentre era via parlai di Frydka con Shlomo, che aveva lavorato nella Fassfabrik con lei.
«Sai» gli feci, «a guardare le foto sembra una star del cinema...».
Shlomo annuì, puntandomi contro un ditone, com’è solito fare, quasi per suggerire «Eh, te l’avevo detto!». «Come ti dicevo, mi sembra di ricordare di averla vista nella Fassfabrik. C’erano due bellissime ragazze che noi, pur essendo ancora piccoli, avevamo notato – avevo dodici anni e mezzo, e ho passato un anno in quel posto – me lo ricordo, probabilmente una era Frydka, l’altra una certa Rita, una profuga proveniente da Bolechow. Una Flüchtling, una ragazza bellissima. Sì, l’altra era Frydka.
Rappresentavano le donne nella Fassfabrik. Ricordo che commentavamo: “Frydka e Rita sono le più belle di tutte”».
Anna tornò a sedersi. Mi offrì da bere, accettai una Coca Cola. Tornò in cucina, e Shlomo mi riferì il secondo aneddoto rivelato da Anna su Frydka la farfalla, un racconto di tempi ben più cupi.
«Non è facile da tradurre» si scusò, ridendo forte. «Anna ricorda che durante la guerra, in fabbrica, la maggior parte delle ragazze lavorava all’aperto. Ma Frydka, essendo, come dire, sai, così libera... trovò il modo di lavorare dentro! Nel campo, nel lager, nella fabbrica di botti...».
«Be’» osservai, piuttosto divertito ma anche spinto dall’impulso di difendere la reputazione di quella cugina da lungo tempo scomparsa, «da quello che ci ha detto Jack Greene e dalle lettere di Shmiel sappiamo che Frydka aveva frequentato l’istituto commerciale per diventare ragioniera» («La cara Frydka ha finito le superiori» aveva scritto Shmiel «mi costa una fortuna e non sarà facile trovarle un lavoro». E in un’altra lettera: «Frydka ha terminato la scuola commerciale a Stryj, ma deve continuare gli studi; vorrei che imparasse un mestiere adatto a lei, oggi se non conosci un mestiere non sei nessuno...»). «Quindi» continuai, «forse era per questo che lavorava nel campo?». Dopo tutto, considerai tra me, Jack mi aveva detto che lei lavorava come ragioniera nella Fassfabrik.
Anna tornò con una grossa bottiglia di Coca Cola e la poggiò sul tavolo. Shlomo le riportò la mia osservazione, al che lei scosse la testa con un largo sorriso e replicò.
«Sostiene di no» mi spiegò Shlomo, «Frydka non lavorava in un ufficio, non faceva la ragioniera, era addetta a una macchina». Si rivolse di nuovo ad Anna, quindi continuò: «Le ho detto che anch’io lavoravo in quell’edificio, era tutt’altro che piacevole, anzi era molto dura, ma Anna mi ha appena fatto notare: “Sì, ma era sempre meglio che lavorare all’aperto, nel gelo dell’inverno”».
«Ess var shreklikh kalt!» esclamò Anna, consapevole che non c’era bisogno di traduzione. «Faceva un freddo tremendo!».
Mi ricordai di un’interminabile conversazione avuta con Andrew, anni prima, quando ipotizzammo come se la sarebbe cavata nostro nonno se fosse rimasto intrappolato a Bolechow durante la guerra; se la sua notevole abilità di ottenere sempre quel che si prefiggeva,di sapersela cavare, fosse una sua peculiarità o se non si trattasse di un tratto distintivo della nostra famiglia, ormai scomparso (che poi era la nostra sensazione). La frase di Shlomo che mi aveva ridestato quel ricordo, pronunciata con una certa ammirazione, era stata: «Trovò il modo di lavorare dentro!».
«Avrebbe dovuto vivere al giorno d’oggi» ripeté Anna.
Sorrisi. Sì, pensai, effettivamente era una ragazza per la quale si poteva prendere una cotta.
Volevo mostrarle altre fotografie, tra cui l’unica immagine che ci rimaneva della sua amica Lorka. Ma mentre rovistavo nella cartella per recuperare l’ingrandimento della foto di gruppo, risalente ormai a settant’anni prima, Anna disse qualcosa a Shlomo. Percepii i nomi Shmiel e Frydka. Finiremo per parlare solo di Frydka, temetti.
Il mio amico tradusse: «Ricorda di aver sentito dire che Frydka e Shmiel si erano nascosti da qualche parte, ma qualcuno li tradì e vennero uccisi».
«Frydka e Shmiel?» ripetei, sbalordito. Anna mi guardò, annuendo; aveva colto la mia incredulità. Quindi proseguì:
«Zey zent behalten bay a lererin...».
Shlomo stette ad ascoltare, poi tradusse, anche se a grandi linee avevo capito. «Vennero catturati a casa di un’insegnante. Era una professoressa di disegno».
«Insegnava educazione artistica» lo corressi.
«Sí» confermò. «Un’insegnante di educazione artistica. Una polacca».
«Ne ricorda il nome?» domandai. Volevo qualcosa di concreto, di specifico, che avvalorasse quella diceria.
Anna parlò ancora con Shlomo. «No» disse questi, scuotendo il capo. Ripresero a parlottare, e sentii un nome che conoscevo bene: Ciszko Szymanski. Alzai la testa, gli occhi sgranati. Per chi trascorre un mucchio di tempo negli archivi, a fare ricerche su eventi oscuri da lungo tempo dimenticati, a eccezione forse di qualche persona anziana, è gratificante trovare dei riscontri. E così anche lei aveva sentito la storia di Ciszko Szymanski. Anna sorrise, annuendo, e aggiunse qualcos’altro.
«Ha detto che Ciszko Szymanski era il fidanzato di Frydka» tradusse Shlomo.
Lo pregai di riferire ad Anna che Meg Grossbard a Sidney si era rifiutata di raccontarci quel che sapeva, perché Ciszko non era ebreo. Quindi mi voltai verso di lei ed esclamai: «Gurnisht!». «Niente!» facendola sorridere. Dopo aver ascoltato la traduzione, Anna mi fissò con espressione incredula, inarcando le sopracciglia e allargando le braccia, come a dire: «Perché mai, dopo tutto questo tempo?».
Le spiegai che avevamo saputo da Jack Greene che Ciszko Szymanski venne ucciso per aver aiutato Frydka. Dovette capire quel che stavo dicendo in inglese, perché ancor prima che terminassi mi guardò ed esclamò in yiddish: «Sì, l’ho sentito dire anch’io».
A quel punto si protese sul tavolino verso di me, come per confidare un segreto a un’amica, e pronunciò delle frasi concitate. Mi colpì la stranezza della situazione: l’intimità e l’immediatezza di quel gesto e il fatto che dovessi aspettare la traduzione di Shlomo. Quella sensazione era sintomatica dei sentimenti che stavo provando quel giorno – la perturbante sensazione di dover ripercorrere all’improvviso impossibili distanze di tempo, di lingua e di memoria, per cogliere piccoli ma commoventi e vividi dettagli sui miei parenti da lungo tempo defunti. Vieni a mangiare le fragole! Era sordo! Una farfalla!
Shlomo ascoltò, quindi, chinandosi confidenzialmente verso di me, tradusse:
«Ha detto che quando furono presi, Ciszko esclamò: “Se uccidete lei, dovete uccidere anche me!”».
Seguì qualche attimo di silenzio. Naturalmente immaginavo che Frydka avesse suscitato ben più di una cotta: «Quel ragazzo pagò con la vita quel che aveva fatto» mi aveva detto Jack Greene a Sidney. Ma era ben più emozionante ascoltare le ultime parole pronunciate da quel giovane, che comunicavano tutto il fervore e la giovanile spavalderia da cui era certo animato. Se uccidete lei, dovete uccidere anche me! E così fecero; su questo concordavano tutti, anche se dovetti aspettare altri due anni prima di scoprire i particolari.
«Come fa a saperlo?» domandai.
Shlomo e Anna parlottarono per un po’, quindi lui tradusse: «Gliel’ha raccontato suo cugino, che un tempo viveva a Kfar Saba, adesso sta ad Haifa. Era scappato in Russia, tornò a Bolechow dopo la guerra. È stato tra i promotori della costruzione del monumento a Taniawa. Era a conoscenza di un sacco di particolari – cosa accadde, come e dove. Si informarono, sai, quelli che tornarono dopo la guerra, appena finita la guerra parlarono con gli ucraini».
Shlomo fece una pausa, poi aggiunse: «Ci sono tante cose che non ho mai chiesto... che io non ho mai chiesto. Sai, mi pongo tante domande. Oggi voglio sapere molto più di un tempo».
Trasse un sospiro e tornò a parlare del cugino di Anna, che aveva udito le ultime parole pronunciate da Ciszko Szymanski. «Così sapeva molto, sapeva un mucchio di cose, e questo è quel che sentì».
«Cosa è accaduto al cugino?» domandai. Provai un’improvvisa eccitazione: se viveva ancora ad Haifa avrei preso il treno e sarei andato a parlargli direttamente, magari avrebbe ricordato altri dettagli.
Parlarono a lungo. Shlomo si volse verso di me e spiegò: «Non è più molto lucido. Lo ha chiamato di recente al telefono, e lui ha esordito: “Ho sentito mia cugina”, al che lei gli ha chiesto: “Quale cugina?” “Anna” ha risposto lui, e lei di rimando: “Ma sono io Anna!”».
E così avrei fatto a meno di quel cugino.
Probabilmente in quei momenti lasciavo trasparire le emozioni suscitatemi dal commovente particolare relativo al destino di Ciszko e Frydka (seppur autentico) e, ancor più, dalla nuova versione della morte di Shmiel, diversa da quella raccontatami a Sidney dai quattro superstiti di Bolechow, assolutamente convinti che Shmiel fosse stato catturato insieme alla moglie e alla figlia minore durante la seconda Operazione, e fosse morto a Belzec. Mi ci volle qualche attimo per analizzare le sensazioni prodotte in me da questo improvviso colpo di scena. Per un verso ero sconcertato; cominciavo a rendermi conto dell’inconsistenza delle storie che ascoltavo («Senti» mi fece notare qualcuno molto tempo dopo, «come fanno i sopravvissuti ad affermare con certezza come andarono le cose? Riferiscono solo particolari di seconda mano. Loro non c’erano. Se si sono salvati, è perché erano nascosti da qualche parte...»).
D’altronde, avvertivo la strana eccitazione che si prova quando si è alle prese con un giallo particolarmente avvincente, o con un cruciverba. Insomma, cosa era davvero accaduto a zio Shmiel?
Il volto doveva lasciar trasparire le mie emozioni, perché Anna disse, guardandomi teneramente con un dolce sorriso sulle labbra: «Du sehst? Ich veyss alles».
«Vede? So tutto».
Alla fine le mostrai la fotografia della sua amica.
«Ho una foto di Lorka» annunciai. In fin dei conti era per scoprire qualcosa di lei che ero lì, anche se gran parte della conversazione, i suoi ricordi più vivi, si riferivano a Frydka. Mi chiesi, fugacemente, se fosse esistita una qualche rivalità tra Lorka, la sorella maggiore con la testa sulle spalle, ragazza fedele e leale, e la più ribelle (o così credevo) sorella minore, la cui personalità mi appariva più reale, nitida e concreta, considerate tutte le storie che avevo sentito su di lei.
«Pictures fun Lorka?» reagì lei entusiasta. Andò in camera da letto a prendere gli occhiali. Quando tornò, le mostrai trionfante la vecchia foto risalente a sessantanove anni prima. Eccoli lì, schierati al funerale della mia bisnonna, mezzi assiderati: Shmiel, Ester e suo fratello, Bruno Schneelicht, e le quattro figlie, che finalmente ero in grado di identificare: Ruchele, di nove anni, Bronia, di cinque, la quattordicenne Lorka – quella alta in fondo, leggermente china per entrare nella foto,con il viso affilato, l’espressione timida e seria, non del tutto priva di attrattive, ma di certo non così carina come la dodicenne Frydka.
Anna tenne la foto tra le mani e la osservò per qualche istante. Con gesto fiducioso, indicò Ester e disse: «Duss ist di mitter fun Lorka» e io confermai: «Sì, è la madre di Lorka». Anna sollevò lo sguardo, e con un cenno negativo della mano spiegò: «Ester non era di Bolechow, era originaria di Stryj». Ciò corrispondeva a quanto avevo appreso nel corso delle mie ricerche, ma ero curioso di scoprire cos’altro sapeva, magari il ricordo di qualche conversazione avvenuta settant’anni prima, misteriosamente riaffiorata alla memoria. Annuii e ripetei: «Stryj»al che lei sorrise e dedusse: «Allora lo sa già!».
Tornò a osservare la fotografia, e mentre la esaminava, accigliata, commentò: «Di kinder, zi kenn ikh nokh nikht».
«I bambini, non li riconosco più».
Le indicai Lorka. Avvicinò la foto, e osservandola attentamente chiese in quale anno era stata scattata. «Nel 1934» risposi. Di questo ero più che certo. «Zur erinnerung an den ersten Monat wo ich nach unser gottseligen Mutter trauerte. Bolechów in August 1934. Sam». «In ricordo del trigesimo dalla morte della nostra adorata madre, Bolechow, agosto 1934». La mia bisnonna, Taube Mittelmark Jager, morì il 27 luglio 1934. Taube. Quand’ero bambino arrivarono dei nuovi vicini, e quando mia madre conobbe la signora, che si chiamava Toby, sorrise e le disse: «Mia nonna si chiamava Taube». Significa «colomba».
Anna posò la fotografia, scattata per commemorare la morte di quella donna esile, che in effetti aveva qualcosa della colomba e in tutte le foto che conserviamo di lei ha sempre un’espressione triste, e prese a parlare concitatamente con Shlomo.
«Che ha detto?» gli chiesi, sulle spine.
«Non crede che quella sia Lorka. Ha detto che la ricorda bene, e non era così».
Le chiese conferma: «Nayn?». Anna ripeté con suono chiocciante: «No no no». Quindi si voltò verso di me e chiese in yiddish: «Chi le ha detto che questa è Lorka?».
«Mayn zeyde» risposi, appena esitante. «Mio nonno». Era stato lui a trasmettermi la passione per quelle foto, trent’anni prima; mi aveva raccontato tutto quel che sapevo sulla storia familiare, la sua famiglia: aneddoti, storielle e drammi, a chi appartenevano i volti tristi in quelle vecchie fotografie. Ero certo che fosse Lorka; c’erano quattro ragazze, e le avevo indicato la più grande.
«Mayn zeyde» ripetei più convinto.
Anna mi rivolse quel suo sorriso malinconico ma deciso. «Dayn zeyde hut zi gekeynt?» mi domandò.
«Tuo nonno la conosceva?».
Che potevo rispondere?
«No».
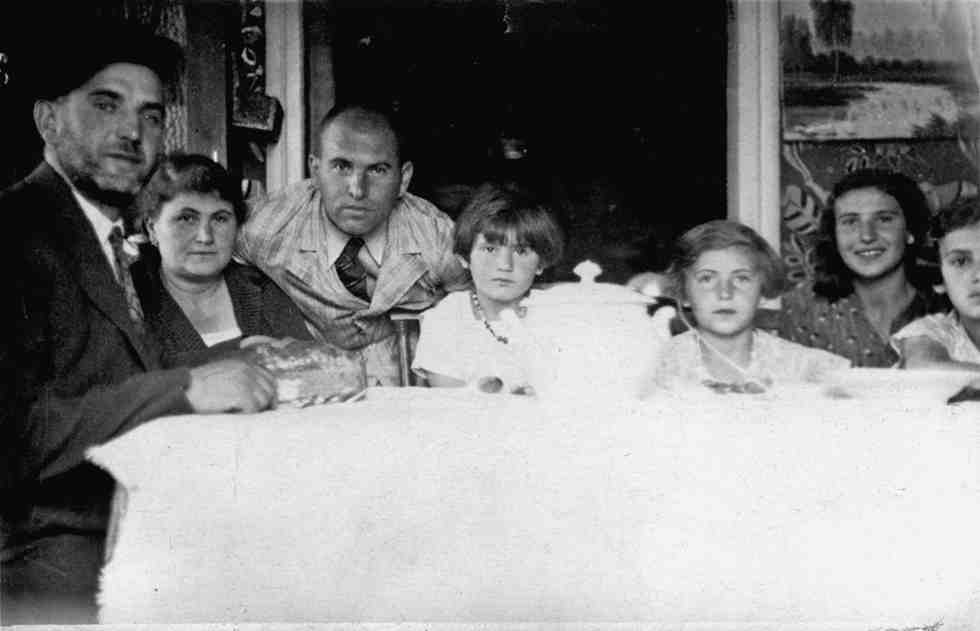
La discussione sull’aspetto di Lorka sembrò stimolarle la memoria. All’improvviso Anna parve emozionarsi. Lo sguardo che vagava da me a Shlomo, la voce più roca, cominciò a parlare animatamente, gesticolando con le mani, alzandole al cielo come a chiamare Dio a testimone, poi cingendosi i fianchi, come in un abbraccio. Infine tacque, guardandomi speranzosa, in attesa che Shlomo traducesse.
«Ah» esclamò il mio amico, «vedi? Ti ricordi quel che ti ho detto, che ognuno pensava a sé, che erano tutti egoisti?».
In effetti il giorno precedente, rivangando il passato, mi aveva raccontato di come lui e il cugino Josef si erano nascosti, dopo l’uccisione degli altri membri della sua famiglia, e così si erano salvati; mi aveva detto che la madre, essendo molto frum, devota, aveva abbandonato il nascondiglio per celebrare Pesach, la Pasqua ebraica, ed era stata catturata e portata via; lui aveva cercato di seguirla, ma per salvarlo lei gli aveva ordinato di tornare a casa per prenderle un paio di calzettoni di lana, e quando era tornato nel punto in cui l’aveva lasciata lei non c’era più. Nel raccontarmi tutto questo aveva sottolineato che, tra le tante conseguenze, l’occupazione tedesca aveva reso tutti più riservati, anche con gli amici e i propri cari. Chi progettava di nascondersi, aveva aggiunto con un’espressione a un tempo convinta e addolorata, sapeva che minore era il numero di persone a conoscenza dei propri piani, maggiori erano le possibilità di sopravvivenza. Non riesco a immaginare cosa significhi essere costretti a nascondere la verità ai propri cari, consapevole che non coinvolgerli in quei piani di salvezza significhi mandarli a morte sicura.
«Vedi?» ripeté Shlomo, quel giorno a casa di Anna Heller Stern. «Chi aveva deciso di nascondersi non lo rivelava a nessuno! E lei era amica intima di Lorka, lavoravano insieme nella Fassfabrik. Anna ricorda che il giorno della fuga si recarono insieme a piedi alla fabbrica. E all’improvviso disse a Lorka: “Lorka, abbracciamoci e diamoci un bacio, perché Dio solo sa quando ci rivedremo”».
E quella fu l’ultima volta che la vide.
Rimanemmo in silenzio per un po’. Poi domandai:«Quando accadde?». Shlomo e Anna parlarono per qualche minuto, quindi lui tradusse: «Nel novembre del ’42».
Subito dopo aggiunse: «Nel ’42 lei lasciò Bolechow e si nascose. Dice di sapere quel che accadde a Lorka: scappò e si rifugiò presso i Babij, poi probabilmente fu uccisa. Rammenta di aver sentito dire che Frydka si era nascosta insieme a Shmiel. Ma ignora come furono uccise, sia lei che Lorka.
«Non sa nemmeno che ne fu della sua famiglia» concluse.
Quest’ultima osservazione mi indusse ad astenermi dal porre altre domande. Ma avevo scoperto che nel novembre del 1942 qualcuno vivo ancora oggi vide Lorka per l’ultima volta; vide il volto di cui non conoscerò mai le fattezze.
A quel punto il vassoio era pieno di briciole e i bicchieri di Coca Cola vuoti. Stavamo parlando da circa un’ora e mezza, ed ero convinto che Anna ci avesse detto tutto quel che sapeva sulla nostra famiglia. Riflettei tra me: Se tra quarant’anni qualcuno venisse a casa mia a chiedermi se ricordo un ragazzo cresciuto nel mio quartiere, compagno di scuola alle elementari? Per esempio Danny Wasserman, il biondino che abitava di fronte, poco più grande di me, di cui rammento solo i capelli biondi, il fatto che era alto e simpatico e appassionato di sport; cosa potrei aggiungere? Per questo motivo quella mattina fui grato a Anna Heller Stern. Le fui riconoscente per la storia delle fragole, e devo confessare che avvertivo una strana, lieve eccitazione all’idea di non aver ancora scoperto con esattezza cosa fosse accaduto a Shmiel, e un forte disappunto di fronte alla rivelazione che la ragazza della fotografia non era Lorka – chi poteva saperlo meglio di quella donna,sua amica intima? – perché ciò significava che non esistevano più immagini di lei.
Ma quella non fu l’ultima sorpresa, l’estrema disillusione, la definitiva, necessaria modifica da apportare alla storia di famiglia. Cominciai a pensare di porre fine alla conversazione. Eravamo esausti, credevo di aver appreso tutto ciò che era ragionevole auspicare di scoprire da quell’incontro,e mi rendevo conto di cosa comportasse per Anna da un punto di vista emotivo rivangare un passato così traumatico; inoltre dovevo prepararmi per la gigantesca riunione di famiglia che Elkana aveva organizzato per quel pomeriggio, dove avrebbero presenziato tutti i cugini curiosi di fare la conoscenza con quel parente americano, che sapevano stava scrivendo un libro sul mishpuchah. Così posi la domanda che credevo avrebbe riassunto e posto fine a quella lunga conversazione.
«Ricorda qualcun altro degli Jäger a Bolechow?».Dal gruppo di Sydney, tre mesi prima, avevo appreso dell’esistenza di alcuni lontani cugini, proprietari della cukierna, i fratelli Jäger, uno dei quali si chiamava Wiktor, figlio (lo sapevo con certezza) di quella Chaya Sima Jäger la cui tomba Matt aveva così imprevedibilmente scorto quel giorno dalla macchina di Alex, quel Wiktorla cui sorella era la madre di Yulek Zimmerman, il ragazzo che fino ad allora ero convinto fosse il fidanzato di Lorka. Speravo che Anna potesse aggiungere qualche altro particolare.
Invece, mentre parlava con Shlomo, sentii pronunciare il nome Itzhak Jäger. Zio Itzhak! Era strano pensare che ci fossero persone lì in Israele che lo ricordavano ai tempi di Bolechow, prima che avesse – o meglio, che zia Miriam avesse – la premonizione di lasciare la Polonia.
Dopo un po’ Shlomo si volse verso di me e tradusse: «Itzhak Jäger aveva una macelleria, ma non nella Rynek...»
(Nella Rynek ai tempi di mio nonno sorgeva il negozio di famiglia, Shlomo sapeva che ne ero al corrente:avevo una fotografia pubblicata sul libro Yizkor, raffigurante un lato della Rynek con il municipio, e proprio di fronte un edificio basso sotto il quale mio nonno aveva tracciato una freccia per indicare dove si trovava la macelleria).
«... non nella Rynek» stava spiegando Shlomo, «madi fronte al mulino. Era lì. E per quel negozio dovette scappare da Bolechow».
Ben conoscendo le difficoltà che sorgono quando si parla contemporaneamente in diverse lingue, chiesi:«Vuoi dire che lasciò il negozio quando andò via da Bolechow?».
Shlomo scosse la testa.
Riprovai: «Vuoi dire che non voleva rimanere lì?».Ero confuso.
Shlomo mi guardava.
«Dovette scappare» specificò.
«E perché... che significa?».
Anna, che assisteva a questo scambio di battute,chiese a Shlomo: «Er vill vissn?»
«Vuole saperlo?».
Shlomo si voltò verso di me e ripeté la domanda di Anna, anche se avevo già capito: «Vuoi davvero saperlo?».
«Sì».
A quel punto Anna si lanciò nel racconto di una lunga storia. Intuii che non sarebbe stata breve dal modo in cui faceva le pause per respirare, dal ritmo delle frasi in yiddish, quelle vocali piene e le consonanti squillanti che si dipanavano nella stanza come un grosso filo di lana che si scioglie da una matassa. Andò avanti per qualche minuto, seduta sul bordo della poltrona,guardando ora me ora Shlomo. Quando finì, si appoggiò allo schienale con un sospiro, come se avesse portato a termine un lavoro gravoso.
Shlomo cominciò: «Dunque. Erano clienti della macelleria di Itzhak Jäger» (intendeva la famiglia di Anna). «A un certo punto Itzhak si costruì una bella casa,non lontano da dove abitava Shmiel, con un grande cantino».
«Cantina» lo corressi.
«Sì, una grande cantina. Anna ricorda che per un periodo, un anno, non si trovava la carne di vitello. No, no, no... non si trovava il vitello».
Facevo fatica a seguire. C’era penuria di vitelli. Per quale ragione? Chiesi se per caso qualche piaga avesse colpito il bestiame, lievemente imbarazzato, chissà perché, al pensiero di aver fatto ricorso a quella parola antiquata, di origine biblica, «piaga», forse perché mi trovavo in Israele. Probabilmente era per quello, ipotizzò il mio amico, forse quell’anno le mucche non avevano figliato.
Shlomo proseguì: «Un giorno, una donna capitò nella cucina di un’amica, e vide della carne di vitello. Così le chiese: “Dove hai preso quella carne?” e l’altra rispose: “Da Itzhak Jäger”».
Essendo cresciuto tra persone che parlavano yiddish, sapevo che la preposizione «da» corrispondeva all’yiddish «bay», derivante dal tedesco «bei», «a casa di», come il francese «chez». Zey zent behalten bay a lererin. «Furono catturati a casa di un’insegnante». Bay Itzhak Jäger. «A casa di Itzhak Jäger».
«Bay Itzhak Jäger» ripeté.
«Bay Itzhak Jäger» feci eco a mia volta.
Shlomo continuò: «E così la notizia si sparse in giro
– era poco più di un villaggio. E andavano tutti a comprare la carne da Itzhak Jäger. Finché non scoprirono da dove veniva la carne. Lui si recava nell’interno della regione e comprava un vitello, lo metteva in cantina,lo uccideva lui stesso e ne vendeva la carne».
Pur non discendendo da una lunga schiatta di macellai kasher, com’è invece il mio caso, si sa bene cosa questo significhi. Se il vitello non viene ucciso da uno shochet, un macellaio esperto nel rito della macellazione, la carne non è kasher.
Shlomo mi osservava annuendo. Commentò ad alta voce: «Quindi non era carne kasher!». Sorrideva tutto eccitato dall’aver appreso quella storia che non conosceva;forse all’epoca era troppo piccolo, magari non era nemmeno nato. Proseguì: «Perché sia kasher la macellazione deve essere eseguita da un macellaio rituale. E così i rabbini di Bolechow additarono quel negozio, dicendo che non vendeva carne kasher! E le donne devote dovettero rompere tutti i piatti. Fu un grande scandalo!».
Aggiunse di suo: «Sai, la carne kasher costava il doppio dell’altra. Fu così che Itzhak poté costruirsi la sua grande casa!».
Rimasi in silenzio per un po’, prima di chiedere:«Che anno era?». Shlomo riportò la domanda ad Anna,quindi disse: «Lei aveva una decina d’anni».
Il 1930, dedussi. Poco prima che Itzhak si trasferisse in Palestina. «Appena in tempo! Era un sionista!».
Credevo non ci fosse altro da aggiungere, invece all’improvviso Shlomo saltò in piedi e si mise a gridare: «Capisci? Hai capito? Devo rivelarti una cosa molto importante».
Non avevo idea di cosa avesse in mente.
Shlomo mi fissava. Controllando a stento la commozione, cominciò: «Voglio farti partecipe di una cosa molto importante. Mia madre era una frum, una donna religiosa. Si nascose per non essere presa dai tedeschi, ma lasciò il nascondiglio per celebrare Pesach, lo fece per il Signore!».
Tirò un profondo respiro. Come molti uomini robusti che non si danno tema di palesare le emozioni, sembrò gonfiarsi, farsi più grande, mentre parlava con voce tremante.
«uscì e venne uccisa».
Mi lanciò uno sguardo significativo, e a quel punto intuii dove volesse andare a parare. «Shlomo, so cosa stai per dirmi».
Fu come se non mi avesse udito. Mi guardò, puntandomi contro il grosso indice, e continuò: «Mia madre era frum, e questo le costò la vita! Invece Itzhak Jäger fece una cosa contraria alla religione! E Dio lo salvò, lo mandò in Palestina. Capisci?».
Sí, capivo. Pensai a mio nonno, che anni prima mi aveva raccontato di un altro pasto a base di carne non kasher, «Ma se c’è in ballo la vita, Dio perdona!». Però lui aveva mangiato quella carne per non morire, il caso era diverso. Non sapevo cosa replicare. Ascoltai Shlomo che traduceva ad Anna quanto mi aveva appena detto. Era ancora molto agitato.
«Itzhak hut gemakht a zakh duss iss kegn Gott» gridò di nuovo.
«Itzhak fece una cosa contro Dio».
«Unt Gott hut ihm gerattet!».
«E Dio lo salvò!».
A quel punto Anna, che immagino avesse avuto parecchi anni per riflettere sull’ironia della storia, sull’intervento di Dio, se davvero c’è, nelle vicende umane, interruppe Shlomo, scuotendo il capo con quel suo sorriso mesto unito a una sorta di ironica rassegnazione, e alzò le mani al cielo.
«Vuss, kegn Gott?» lo ammonì. «Kegn di rabbunim!».
Non avevo bisogno della traduzione. Aveva detto:«Non contro Dio. Contro i rabbini».
Se c’è in ballo la vita, Dio perdona!
Di lì a poco ci congedammo. Shlomo mi accompagnò da Elkana, dove mi aspettava la rimpatriata di famiglia. La cugina di mia madre offrì una cena pantagruelica, servita nella sala riservata ai ricevimenti dell’elegante complesso dove abitava. Nell’atmosfera festosa, tra timidi sorrisi e muti cenni del capo, mi vennero presentati all’incirca venticinque cugini di primo,secondo e terzo grado, dai nomi strambi, Rami, Nomi,Pnina, Re’ut, Gal, Tzakhi (di nuovo quei nomi israeliani monchi! Mi ricordai dell’ilarità suscitataci dal nome YONA, che ripetevamo in continuazione, da bambini,quando mio nonno veniva a trovarci accompagnato da quella donna israeliana dai capelli scuri). Quando prendemmo posto a tavola, Elkana si alzò in piedi per un brindisi di benvenuto. Imbarazzato perché non potevo replicare in ebraico, sorrisi con aria imbambolata e salutai tutti con un cenno del capo. In inglese comunicai loro la mia felicità di trovarmi in Israele e di aver finalmente incontrato tutto il mishpuchah. Elkana mi aveva opportunamente collocato accanto alle nipoti di sua sorella, ragazze tra i venticinque e i trent’anni che parlavano bene l’inglese. Cominciammo a conversare e a scambiarci pettegolezzi sui segreti familiari. «In questa famiglia?» chiese stupita Gal, replicando a una mia domanda. «Stai scherzando?». Guardò Ravit e scoppiò a ridere. Sorrisi e confermai: «Sì, parecchi di noi». All’altro capo del tavolo Elkana sedeva accanto al nipote Tzakhi,figlio di suo figlio Rami, un giovane bruno e affascinante sulla trentina. Rami è il diminutivo di Abraham, il nome di mio nonno. Tzakhi è il diminutivo di Itzhak. Rami era in viaggio da qualche parte in Estremo Oriente; era un pezzo grosso, come il padre. Elkana pontificava con il nipote. I giornali annunciavano che erano in atto le ricerche per scovare il deposto dittatore dell’Iraq; Elkana, per quanto da lungo tempo in pensione,dava ancora l’impressione di poter accedere a informazioni riservate, per cui accennò col capo verso di me e affermò con una certa smargiasseria: «Lo troveranno a Tikrit, credetemi. Quella è la sua casa, lì c’è la sua gente». Alla mia destra sedeva Ruthie, le trecce biondo paglia screziate di bianco; faceva da interprete nei miei tentativi di comunicazione, traducendo, più veloce che poteva, ogni frase che riteneva valesse la pena di ripetere. Appresi così che la maggior parte dei giovani presenti a quella riunione non sapeva che quella grande e allegra famiglia proveniva da una cittadina chiamata Bolechow, e che un tempo il loro nome era

.
Il primo incontro di Abramo con una cultura straniera non si rivela, a prima vista, un gran successo. In uno dei primi passi della parashat Lech Lecha leggiamo che poco dopo l’arrivo di Abramo, guidato da Dio, nella terra di Canaan, la terra promessa, ci fu una carestia che costrinse lui e la sua famiglia a fuggire in Egitto, terra dell’abbondanza. Prima di giungere lì, Abramo escogita un piano. Poiché Sarai è una donna bellissima, teme che gli egiziani la rapiscano e uccidano lui; per evitare ciò la istruisce: non dovrà dire che lui è suo marito, bensì il fratello. Così le dice: «Di’, te ne prego, che tu sei mia sorella, affinché io riceva del bene in grazia tua, e mi sia salva la vita per tuo riguardo». La prima parte della profezia di Abramo si rivela esatta: una volta in Egitto, i funzionari del faraone tessono le lodi della bellezza di Sarai al sovrano, e di conseguenza «la donna fu presa e condotta nel suo palazzo». E in effetti Abramo ne ricavò un vantaggio, poiché fu ricompensato, malgrado la sua bugia, con «pecore e buoi e asini e serve e asine e cammelli». Una cospicua fortuna, non c’è che dire.
Riguardo alla seconda parte della profezia, caratterizzata da una certa apprensione – il timore di essere ucciso se gli egiziani avessero scoperto che Sarai era sua moglie – non ci sono prove a suo sostegno; casomai il testo suggerisce il contrario. Sarai viene condotta nella reggia del faraone (e non ci viene detto cosa vi accade), e in seguito Dio funesta l’Egitto con «grandi piaghe» per punire il supposto insulto che il faraone reca (inconsapevolmente) a una coppia sposata. In un passo significativo per quello che lascia sottintendere, lo stesso faraone deduce, presumibilmente dalla natura delle piaghe, anch’essa non specificata, di essere stato punito per aver preso Sarai in moglie malgrado la donna, in realtà, sia già sposata, e irato manda a chiamare Abramo. «Che cosa mi hai fatto?» tuona. «Perché non mi hai detto che era tua moglie?Come mai mi hai detto: “È mia sorella”, per cui l’ho presa in moglie? Ecco dunque tua moglie: prendila e vattene!» E come apprendiamo in Genesi 13,1, Abramo «lascia l’Egitto»con il suo carico di bestiame, oro e argento.
Numerosi esegeti biblici si sono soffermati su questa particolare deviazione compiuta da Abramo nel corso dei lunghi viaggi da lui intrapresi, e in particolare sul risalto dato al conflitto con il faraone, sulle piaghe con le quali Dio punisce l’Egitto, sull’ira del sovrano verso l’uomo di Dio e sul suo ordine perentorio di «lasciare» l’Egitto con la sua famiglia «e tutti i suoi averi»; l’episodio prefigura sapientemente la vicenda principale dell’Esodo. Si è molto discusso sullo strano espediente di Abramo, basato su presunti comportamenti degli egiziani che in realtà, da quanto si deduce, non trovano conferma alcuna; in particolare, quella che a molti commentatori appare come una tacita accettazione della prostituzione di sua moglie, abbinata all’ordine di mentire, ha creato un certo disagio a molti studiosi, che si sono dati un gran da fare per discolpare Abramo. «Non si può biasimarlo per aver posto sua moglie in una situazione compromettente» scrive Friedman, «perché, a suo giudizio, Sarai sarebbe stata comunque oggetto della lussuria degli egiziani». Eppure il comportamento del patriarca reca in sé una nota sgradevole. Friedman, uomo dalle vedute più moderne, propende per l’idea che dopo tutto Abramo «non è perfetto»; diversamente da lui, Rashi suggerisce che Abramo non è interessato ai doni in quanto tali, ma – consapevole che l’episodio di cui è protagonista è solo l’antefatto di un dramma biblico di più ampia portata – si preoccupa che la futura progenie di cui si parla nell’Esodo possa lasciare l’Egitto ugualmente carica di doni.
Questi e altri tentativi di giustificare il padre di tutti gli ebrei mi sembrano poco convincenti. Rifletto spesso su questa storia: un uomo con moglie e famiglia costretto ad abbandonare la terra d’origine in un momento difficile. La menzogna come mezzo per arricchirsi (non c’è altra spiegazione), la strumentalizzazione della moglie in modo da creare un pretesto per la fuga, che si rivela un improbabile stratagemma per aumentare i propri averi, e per la proliferazione della propria discendenza in una nuova terra. E sono convinto che l’autore della parashat Lech Lecha, chiunque egli fosse,avesse ben chiaro il comportamento degli uomini in epoche travagliate.
Domenica 29 giugno Shlomo mi venne a prendere all’Hilton di Tel Aviv, semideserto per la guerra che ormai si protraeva da sei mesi e per la minaccia sempre incombente di attentati terroristici, uno degli inevitabili effetti collaterali. Quella mattina c’erano sei o sette persone nella sala ristorante, dove era allestita la famosa colazione a buffet celebrata da Froma, con grande varietà di salmoni e pesci affumicati, il gigantesco frullatore elettrico zeppo di coloratissime arance israeliane, formaggi, aringhe, ciambelle e diverse specie di pane. Diedi una scorsa ai giornali. Un terrorista di quindici anni aveva ucciso un israeliano, dipendente della società telefonica. Gli israeliani erano scettici riguardo al cessate il fuoco annunciato da Hamas e dalla Jihad islamica. Un marine era rimasto ucciso durante un’azione contro Hamas. Leon Uris, l’autore di Exodus, era morto. Deposi il giornale e bevvi un succo d’arancia.
Alle dieci in punto Shlomo attraversò il controllo posto all’entrata dell’albergo e si fermò al centro del vasto atrio deserto. Si era prodigalmente offerto di accompagnarmi da Solomon e Malcia Reinharz, che abitavano a un paio di ore da lì, a sud, nella zona desertica. Ci aspettavano per l’ora di pranzo, mi aveva avvertito Shlomo.
«Il marito non vuole stare via troppo a lungo dal lavoro» mi aveva spiegato.
«Lavoro?» ripetei, stupito. A quanto mi aveva detto,il signor Reinharz doveva avere quasi novant’anni.
«Certo» rispose ridendo. «Hanno un negozio di scarpe da quasi mezzo secolo».
«Almeno avranno una buona memoria» mi consolai.
Lasciammo Tel Aviv, passando per Jaffa – dove Elkana mi aveva portato a cena la sera del mio arrivo, in un ristorante arabo dall’aspetto per nulla attraente ma dove si servivano pietanze gustosissime, e avevamo conversato in arabo col proprietario, un suo vecchio amico – e poi imboccammo l’autostrada, che presto divenne una sottile linea che affondava nel deserto. Parlammo per tutto il tragitto. Era dalla morte di mio nonno che non mi sentivo così libero di soddisfare il desiderio di fare domande su Bolechow. Discutemmo animatamente sulle rivelazioni del giorno precedente: in particolare, l’insistenza di Anna sulla circostanza che Frydka si nascondesse con Shmiel – una versione che doveva non poco del suo fascino al fatto che coincideva con quella trasmessami dazia Miriam, così tanti anni prima. Ancora una volta avvertii l’entusiasmo di Shlomo, lo slancio che traeva da ogni rivelazione su Bolechow, pur riguardante persone estranee. Non a caso si considerava un po’ come il leader della comunità dei sopravvissuti di quella città; quell’autunno, come di consueto, avrebbe organizzato l’incontro annuale. E amava parlarmi degli originari di Bolechow o delle zone circostanti assurti a una certa fama.
«Conosci Krauthammer, il giornalista americano?»mi domandò.
Sì, lo conoscevo.
«Viene da una famiglia di Bolechow!» gridò entusiasta.
«Davvero?».
Volle sapere se quel tal Krauthammer mi avesse contattato quando era apparso l’articolo sul nostro viaggio a Bolechow nel 2001.
«No» risposi con un sorriso. Comunque, lo informai, un altro noto personaggio dell’editoria americana,il cui padre era nato a Stryj, mi aveva chiamato dopo aver saputo del mio viaggio in Ucraina, due anni prima. «Wieseltier» risposi quando mi chiese il nome.
«Ah!» esclamò. «Sì, certo, anche a Bolechow c’erano i Wieseltier».
Annuii e gli spiegai che questo famoso direttore di giornale, che viveva a Washington, mi aveva riferito che la famiglia di sua madre, i Backenroth, aveva dei legami con Bolechow, ed era convinto che alcuni parenti del ramo paterno fossero vissuti in quella cittadina prima della guerra, anche se non ne conosceva i nomi. Forse avevano un panificio, come il padre a Stryj. Shlomo annuì di nuovo; convenimmo che Wieseltier era un nome raro, che non si dimentica o si confonde con altri. «Naturalmente conoscevo Wieseltier» mi aveva detto la signora Begley, quando tornai dall’Ucraina. «Aveva un panificio. Conoscevo il padre» aggiunse, immaginando che conoscessi il figlio per tutt’altre ragioni. Quindi aveva avvicinato il vassoio di fine porcellana bianca,dicendo: «Prenda un altro biscotto, crede forse che li mangi tutti io?».
«Guarda!» esclamò all’improvviso Shlomo, indicando dal finestrino una figura che camminava tenendo un cammello per le redini. «Beduini!»
«Be’, non siamo certo a Bolechow» scherzai. Mi ricordai della fotografia di mia nonna nel 1956, con un cammello e un arabo.
Mi pregò di raccontargli con maggiori dettagli quanto appreso in Australia. Mentre rievocavo, come meglio potevo, quelle lunghe conversazioni, lui annuiva lentamente, assaporando ogni particolare, pur essendo ovviamente fatti a lui ben noti. A un certo puntogli chiesi se avesse mai sentito la storia rivelatami da mia madre molti anni prima: che le sue cugine erano state violentate prima di essere ammazzate. «Avevano quattro ragazze bellissime, le hanno violentate e poi uccise» mi aveva raccontato. Mi ero sempre chiesto dove avesse attinto quell’informazione; e quando infine glielo domandai, mi rispose: «L’ho dimenticato. Si narravano storie terribili, la notte avevo gli incubi». E così, durante quel viaggio a Beer Sheva, con il deserto scoppiettante intorno, chiesi a Shlomo cosa ne sapesse, spiegandogli che in Australia nessuno aveva menzionato particolari specifici. Fece una smorfia e scrollò le spalle con un gesto sconsolato. «Durante quelle Operazioni accaddero cose terribili, certo, è possibile. Potrebbe essere. Ma nessuno può dirlo con certezza».
Annuii, senza fare commenti. Forse certe cose è meglio non saperle.
Dopo qualche attimo riprese: «Lo sai che anche Regnier viveva in Australia?». Anatol Regnier è l’autore di Damals in Bolechow, il libro che narra la storia di come Shlomo e suo cugino Josef, Jack Bob e tutti gli altri erano sopravvissuti. Pensai a Meg Grossbard, quando mi raccontò lo strano episodio di un tedesco che un giorno l’aveva chiamata, chiedendole di parlargli di Bolechow, e del suo rifiuto, perché non voleva che qualcun altro scrivesse la sua storia.
«Sì» risposi, «lo sapevo». E poi, dando seguito a un pensiero inespresso, aggiunsi con un vago sorriso:«Scrivere la storia di chi è sopravvissuto è diverso, almeno hai qualcuno a cui fare domande, ti può raccontare storie incredibili». Stavo pensando alla signora Begley, che una volta mi aveva detto guardandomi freddamente: «Chi è sopravvissuto ha certamente una storia incredibile da raccontare».
«Il mio problema» spiegai a Shlomo «è che voglio scrivere la storia di chi non è sopravvissuto. Persone che non hanno più una storia».
Shlomo assentì, gli occhi fissi sulla strada: «Ah, capisco». Dopo qualche attimo aggiunse: «Sai, questo Regnier è tedesco, ma ha sposato una famosa cantante israeliana, Nehama Hendel. Qui è famosissima».
Spiacente, non la conoscevo.
«È molto famosa in Israele» ripeté. «È morta qualche anno fa».
D’un tranno mi venne in mente di fargli una domanda che da un po’ mi ronzava per la testa. «Sai, quand’ero ragazzo mio nonno mi cantava sempre due canzoni; mi chiedo se le avesse apprese durante l’infanzia,magari gliele cantava la madre. Canzoni di Bolechow».
«Come facevano?» mi chiese.
«Be’» risposi piuttosto imbarazzato, «la prima ce la cantava la sera prima di andare a dormire». Infatti,quando eravamo piccoli e mio nonno si fermava da noi,mentre ci preparavamo per andare a letto a volte entrava nelle nostre stanze e ci intonava quella canzone, i cui versi appaiono non poco strani ma sembrano insignificanti se trascritti, ben più, per dire, di quelli di «Mayn Shtetele Belz», «La mia piccola città di Belz», che dopotutto è un brano sentimentale. Se volessi spiegare cosa aveva di così speciale quella canzoncina, non dovrei limitarmi a trascriverne le parole:
Oh, perché hai picchiato il mio Daniel,
Il mio Daniel non ti ha fatto niente.
La prossima volta che picchierai il mio Daniel,
chiamerò la polizia!
Hoo hoo!
Per esempio potrei cercare di riportarle in modo leggermente diverso, per comunicarne il ritmo, che trovavo così tranquillizzante (poiché conteneva una promessa di protezione e la minaccia di una punizione) e al tempo stesso spaventoso (visto che esprimeva l’incomprensibile idea che qualcuno volesse picchiare me, un bambino). Ecco una possibile trascrizione:
Oh, perche hai picc-hiato il mio dan-iel,
Il mio dan-iel, non ti ha fatto niente.
La prossima volta che picch-ierai il mio dan-iel
chiamerò la poli-zia!
Hoo-hoo!
Ma naturalmente, anche così è impossibile trasmettere le particolari inflessioni della voce ormai non più percepibile di mio nonno (uso questa espressione perché mio nonno si tolse la vita prima dell’avvento dei videoregistratori, e quindi l’unica registrazione che ci rimane della sua voce è un nastro audio inciso nel 1974, quando ci narrò la storia di come aveva abbandonato casa in fretta e furia, a piedi nudi, durante un bombardamento dei russi. Le voci sono le prime a scomparire,nel caso di gente vissuta prima dell’evoluzione delle tecnologie: nessuno conoscerà mai le voci di Shmiel e dei suoi congiunti). Per comunicare qualcosa di più delle mere parole di questa canzone, che a mia volta ho cantato, non senza impaccio, ai miei bambini, anche se dubito che loro faranno lo stesso a tempo debito con i propri figli, dovrei cercare di rendere la particolare pronuncia di una persona originaria di Bolechow:
Oh, pe-cche hai picc-hiato il mio dehn-iel,
Il mio dehn-iel non ti ha fatto niette.
La prossima volta che picch-ierai il mio dehn-iel
chiammerò la polizia!
Hoo-hoo!
E comunque non è possibile ricostruire la melodia, la malinconica tonalità minore adatta a evocare un mondo scomparso; pensavo potesse trattarsi di una vecchia canzoncina della sua infanzia. Non molto tempo fa ho domandato a mio fratello Andrew, ottimo pianista, se ricordava la nenia che ci cantava il nonno,e quando rispose: «Certo che me la ricordo» gli ho chiesto di trascrivermela. Dopo nemmeno una settimana mi ha mandato per posta elettronica il file con lo spartito, intitolato «Oh, perché hai picchiato il mio piccolo Andrew?». Tra l’altro mi ha confessato candidamente: «Non ho mai pensato che la cantasse anche a qualcun altro».
E così l’intonai per Shlomo, mentre ci dirigevamo a sud attraverso il deserto, diretti a casa dei Reinhartz. Al termine della mia performance scosse il capo: «No, non credo di averla mai sentita».
Ero deluso. Comunque mi interessava anche un altro motivetto, un canto piuttosto malinconico, e forse proprio per la tristezza che evocava ipotizzai, poco versato nella musica popolare come sono, che si trattasse di una canzone risalente all’infanzia di mio nonno, il pargolo, un secolo fa, di una famiglia di macellai in una cittadina distante 6.500 chilometri. Cantai anche quella,a Shlomo, in quel viaggio.
Vorrei vorrei, oh, se vorrei
Avere ancora sedici anni.
Sedici anni non avrò piú
Fin quando le mele su un ciliegio spunteranno!
Stavolta non mi preoccuperò di segnalare gli accenti; forrei, diceva mio nonno. Forrei o se forrei. Fin quanto le melle spunteranno. Shlomo ascoltò, l’espressione amareggiata. «Nemmeno questa l’ho mai sentita» fu il suo responso.
«Non importa. È solo una canzone».
Guardai fuori dal finestrino; il deserto aveva lasciato spazio alle case.
«Ahh!» esclamò Shlomo indicando il panorama.«Siamo arrivati a Beer Sheva».
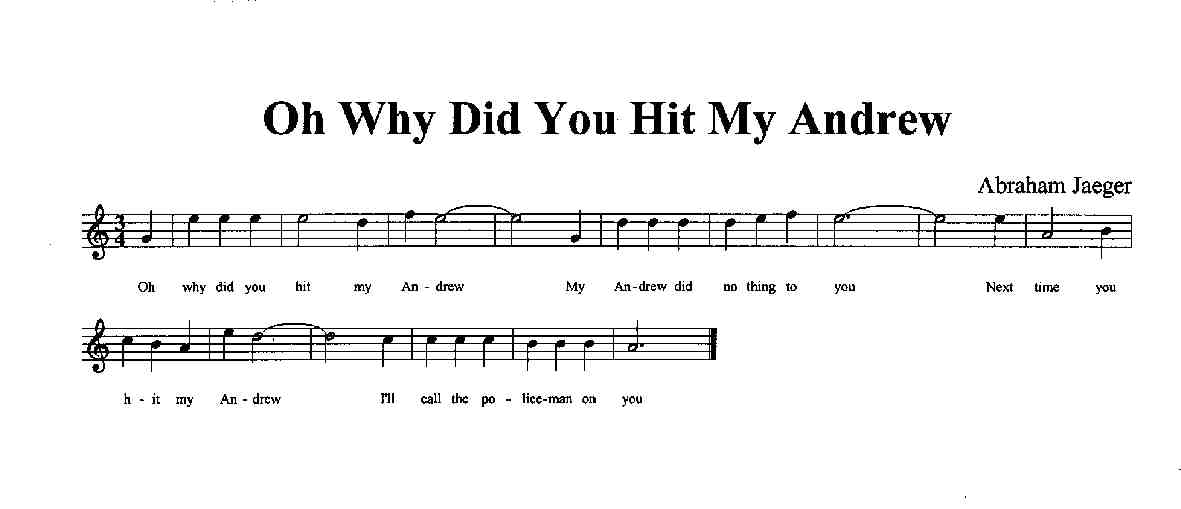
Malcia Reinharz ci stava aspettando sul pianerottolo del suo appartamento. Indossava una vestaglia senza maniche con allegri motivi floreali in varie tonalità di azzurro. Superata la scalinata di cemento, la trovammo davanti alla porta; ci accolse con un largo sorriso che metteva in mostra una dentatura regolare. «Salve!» ci salutò in inglese. La sua voce era profonda e gradevole,simile al suono limpido di un clarinetto. Aveva i capelli di un castano chiaro con riflessi ramati, il viso affilato, le guance piene e l’espressione allegra, quasi fanciullesca.
«Salve, Malcia!» la salutò Shlomo. Mi aveva detto che parlava un buon inglese, al contrario del marito,quindi all’uopo avrebbe tradotto lui. Entrammo in casa. L’appartamento era piuttosto in penombra, con le imposte chiuse per ripararsi dal sole pomeridiano. Infondo, di fronte alle finestre, c’erano delle poltrone accoglienti; all’entrata, subito dopo la porta, c’era un piccolo tavolo da pranzo. Vi era seduto, spalle alla parete della cucina, il signor Reinharz. Mi piacque subito il suo viso: ancora giovanile, l’espressione seria ma cordiale. Dava l’idea di un vecchio agricoltore benestante. Indossava una camicia marrone chiaro perfettamente stirata, pantaloni scuri con le bretelle, e un cappellino marrone da giocatore di golf. Si alzò e ci strinse la mano. Quindi Malcia ci invitò a sederci.
«Prego, accomodatevi. Prima parliamo un po’, poi mangiamo qualcosa, va bene?» propose.
«D’accordo» approvai. «Perfetto».
Per qualche minuto conversarono in yiddish, mentre io preparavo il registratore e la telecamera. Shlomo stava illustrando l’oggetto della mia ricerca; la coppia annuiva. Infine fui pronto. Cercavo di rivolgermi a entrambi, ma sapendo che Malcia conosceva l’inglese – e anche perché avvertivo in lei un certo fascino, per i modi dolci e disponibili, qualità che mi ricordava la mia nonna materna – finii per parlare soprattutto con lei. Durante la lunga conversazione di quel giorno notai che lei e il marito si scambiavano frequenti sguardi, come a chiedere silenziosa conferma alle mie domande o alle sue risposte.
«Bene» esordii, «cominciamo».
Lei annuì.
«Nessuno di noi sapeva niente di Shmiel, della moglie e delle figlie. Per questo mi sono messo a viaggiare per il mondo, per parlare con chi lo ha conosciuto, e da queste conversazioni sto cercando di ricostruire qualcosa su di lui e sulla sua famiglia. Sapevamo solo che vennero uccisi».
Malcia chiuse gli occhi e disse: «Lo so».
«Ma non ci bastava, volevamo scoprire dell’altro»proseguii.
Malcia annuì di nuovo, ed esclamò: «Oh, io li conosco, li conosco molto bene».
Mi colpì l’uso del presente riferito a persone scomparse: li conosco, li conosco molto bene.
«Mi chieda quello che vuole» acconsentì. «Quello che le serve sapere».
«D’accordo».
Cominciammo a parlare. Mi rivelò che la sua famiglia era originaria di Bolechow. «Le dispiacerebbe dirmi in che anno è nata?» domandai. S’illuminò d’un sorriso e rispose: «Sono nata in Ungheria! Nel 1919!». Sembrava divertita dal mio imbarazzo nel chiederle l’età. Poi spiegò che era nata in Ungheria perché i genitori si trovavano lì per un breve soggiorno, ed erano tornati a Bolechow quando lei aveva tre mesi. La famiglia comprendeva la sorella Gina e due fratelli, David e Herman. «Sono tutti morti. Conservo solo una fotografia di mio fratello più piccolo».
Si era sposata nel 1940. «Al giorno d’oggi chi può vantare un matrimonio così lungo, sessantatré anni?». E scoppiò a ridere, gesticolando con le mani come a respingere immaginarie proteste di chi era sposato da meno tempo.
«Quindi da ragazza ha conosciuto gli Jäger?» domandai.
«Li conoscevo molto bene» rispose, stavolta usando il passato. «Shmiel Jäger e la moglie, era una bella donna. Aveva belle gambe!».
Afefa pelle campe.
Malcia portò la mano sinistra al cuore e fece un gesto da intenditrice, come un maître che decanti la specialità della casa.
«Oh, aveva un paio di gambe... non ho mai visto gambe come quelle!».
Io e Shlomo sorridemmo.
«E due figlie carine» continuò. «Anche Lorka aveva belle gambe!».
«Anche lei?» chiese Shlomo, divertito.
«Sí» confermò Malcia, annuendo.
Ma a me interessava di più un altro dettaglio. Due figlie carine. A quanto pareva ognuno ricordava un numero diverso delle figlie di Shmiel e di Ester.
«Conosceva solo due figlie?» domandai
«Solo due?». Mentre parlavamo Malcia ascoltava pazientemente in silenzio, come una studentessa attenta, il viso lungo serio e concentrato; ma spesso, non appena finivo di porre la domanda, il volto manifestava qualche intensa reazione. Come in quel caso, di palese incredulità.
«Erano quattro» specificai.
Malcia mi fissò. «Quattro? Aveva quattro figli?».
Le elencai i nomi: «Lorka, Frydka, Ruchele, Bronia».
«Quattro femmine?» ripeté. A quel punto le mostrai la fotografia raffigurante Shmiel, Ester e Bronia, ma si limitò a commentare: «Ja, Shmiel Jäger».
Posò la foto sul tavolo ed esclamò: «Ai, Gott».
«Sapevo solo che la più grande era Lorka» continuò subito dopo «e la minore era Frydka. Ci vedevamo spesso. Con Lorka... naturalmente. Era una ragazza carina. E Frydka era un po’ più grande di Lorka». Fece un gesto con la mano, e compresi che intendeva dire piú alta. Non la interruppi. Ogni parola era di vitale interesse: qualsiasi dettaglio, per quanto secondario, era prezioso. Ester aveva delle belle gambe. Frydka era più alta di Lorka. Erano particolari che non conoscevamo, e adesso facevano parte della loro storia. «Frydka era molto alta, più alta della sorella maggiore» avrei detto ai miei familiari quando sarei tornato a casa...
Poi disse: «Era un tipo forte, Frydka. Una lottatrice,sì, una lottatrice».
Rieccoci, pensai. Si finisce sempre per parlare di Frydka. «Una lottatrice?» ripetei. «Cosa intende?».
Malcia bevve un sorso di vino. «Ja. Era così forte!».
E piegò i bicipiti per mimare la forza, a mo’ di pugile.
«Forte» ripetei. Be’, pensai, era una lottatrice.
«Ma Lorka» proseguì Malcia, ignara dei miei dubbi,«era carina. E aveva due gambe...!».
La voce le morì in gola; alzò lo sguardo al cielo, come se chiamasse Dio a testimone.
Le mostrai la fotografia dove compariva la famiglia al completo, il giorno del funerale della mia bisnonna Taube. Il nome significa colomba. D’un tratto Malcia alzò lo sguardo su di me, con un sorriso radioso, per un improvviso ricordo.
«Shmiel Jäger era hiresh!». Poiché mi aspettavo che ricorresse all’yiddish o al tedesco se non le sovveniva una parola inglese, rimasi disorientato; poi mi resi conto che stava parlando in ebraico. Nel pronunciare quella parola, hiresh, portò le mani alle orecchie, proprio come faceva mia madre quando parlava al telefono con mio nonno in yiddish; è ascoltando lei che ho appreso qualche rudimento di quella lingua.
«Toip» spiegò Shlomo. «Sordo!».
«Lo so» dissi.
«Bisogna parlare a voce molto alta con lui» proseguí Malcia. Forse fu per l’intensità del ricordo che Malcia impiegò di nuovo il presente.
«Era alto?» la sollecitai.
«Sì, era alto... era proprio un bell’uomo. E... adorava la moglie!» esclamò, mimando nuovamente l’espressione di chi chiami Dio a testimone. «L’amava davvero tanto!».
Non dissi niente. Dopo tutto è possibile riferirsi alla propria moglie come die liebe Ester, «la cara Ester», per abitudine o per formalità; ma adesso sapevamo. Adorava la moglie! Se persino gli amici dei loro figli ne erano a conoscenza, considerai tra me, probabilmente lo dava a vedere. Shmiel ed Ester, una coppia tenera.
Le mostrai un’altra fotografia.
«Ya, duss ist Shmiel Jäger» sospirò. «Shmiel Jäger, era proprio un bell’uomo. Un bell’uomo, un uomo pieno di fascino!».
Poi, facendo segno con la mano, aggiunse: «Alto!».
Malcia versò il vino e riprese a parlare dei suoi ricordi. Osservai la bottiglia. L’etichetta recitava MURFATLER PINOT NOIR.
«Mia madre mi portava con sé quando andava acomprare la carne nella sua macelleria» spiegò. «E lui le dava la migliore qualità! Insieme dicevano Du, perché avevano frequentato insieme la scuola».
Dopo un attimo capii cosa intendesse: sua madre e il mio prozio si davano del tu. Erano stati compagni di scuola.
«Quindi con Lorka avevate più o meno la stessa età»dedussi. Forse Lorka era un anno più piccola.
«Sì, Sì. Non stavamo nella stessa classe, ma nella stessa scuola... non c’erano altre scuole a Bolechow!».
«Giocavate insieme?».
«Sì, sì» ripeté. Quindi, dopo un attimo di esitazione,aggiunse: «Ma lei era... ogni volta era...».
Non trovando la parola giusta si rivolse a Shlomo. «Es tat ihr immer leid» disse con un riso sbarazzino. In tedesco significava «La offendevano sempre, era sempre di
spiaciuta».
«La insultavano?» chiese Shlomo.
Sempre ridacchiando, Malcia specifico in yiddish: «Zi is immer geveyn mit a hoch Nase».
Un naso alto? Quell’espressione mi era nuova.
«Ah! Ah!» esclamò Shlomo. Si voltò a guardarmi e spiegò: «Ha detto che era una ragazza, come dire, piena di sé». Portò l’indice al naso e lo tirò su, nell’universale gesto che denota l’altezzosità.
«Come mai?» chiesi a Malcia.
Sul volto le apparve un’espressione seccata. «Be’, sapeva di essere carina e di avere una bella casa, una bella famiglia...».
«E come era considerata la famiglia?» domandai. Mi raccontò un’altra storia. Suo padre aveva fondato un ente di beneficenza, il cui nome era Yad Charuzim, «La mano del diligente». Rise. «Quando mio padre ne era presidente, mi vantavo: “Mio padre è il presidente!”». Sorrisi; poi aggiunse che anche Shmiel per un certo periodo aveva rivestito quella carica. Questo finalmente spiegava la fotografia che anni prima avevo trovato nel libro Yizkor di Bolechow. In calce alle due immagini che appaiono a pagina 282, mio nonno aveva scritto i nomi dei due fratelli, Shmiel e Itzhak. Shmiel appare al centro di un numeroso gruppo di persone vestite elegantemente,indossa una giacca da sera e una camicia con un colletto a farfalla e un papillon nero; Itzhak è seduto a terra,regge l’estremità di un cartello, che probabilmente indica il nome del circolo di cui facevano parte, ma nella riproduzione sono visibili solo le lettere CH A. Intanto Malcia stava parlottando concitatamente con Shlomo,che si alzò e si avvicinò a un mucchio di carte. Di lì a poco tornò e mi diede un foglio formato A1, l’originale della fotocopia così mal riprodotta nel Sefer HaZikaron LeKedoshei Bolechow, che, come scoprii, apparteneva a Malcia.Il cartello retto da Itzhak era perfettamente leggibile:
ZAŁOZYCIELE
19 JAD 28
CHARUZIM
BOLECHOW
Fondatori dello Yad Charuzim, 1928, Bolechow
Malcia indicò un viso che conoscevo bene: avvenente, riservato, con un paio di baffetti perfettamente curati che (immagino) a suo giudizio lo facevano apparire piú maturo, conferendogli maggiore dignità. Aveva appena trentatré anni. Al contrario, Itzhak sfoggia un’espressione lievemente divertita.
«Qui» stava dicendo Malcia «Shmiel Jäger è presidente. E questo è mio padre».
Indicò un uomo dall’aspetto distinto, con occhi sbiaditi e pizzetto, seduto nella stessa fila di Shmiel. «E questo è Kessler il falegname» continuò.
Ancora una volta, provai un’emozione dolorosa al pensiero che ognuna di quelle persone aveva una famiglia, una storia; e che, da qualche parte, poteva esserci qualcuno, per esempio un parente dei Kessler, che avrebbe detto: «Quello al centro non è Shmiel Jäger, lo spedizioniere, quello che aveva gli autocarri? E quello non è il fratello, il macellaio, ricordi la storia...?».
«Sì, Lorka aveva una bella casa, una bella famiglia»rievocò Malcia, scrollando lievemente le spalle, la voce che le moriva in gola. Pensai di nuovo a Shmiel e alle lettere inviate a mio nonno.
È inutile che vi dica, miei amati, che persino i forestieri dicono che i miei figli sono i migliori, i più distinti di Bolechów...
Oppure,
La gente a Bolechów crede che sia ricco (visto che pago un sacco di tasse), e chiunque abbia bisogno di qualcosa si rivolge a Shmiel Jäger. Ho una discreta influenza qui, beneficio di un trattamento di favore un po’ ovunque, quindi devo presentarmi bene. A dire il vero frequento le persone più in vista, sono ben accolto da tutti, e viaggio in continuazione.
«Hoch Nase» ripetei. Malcia annuì e sorrise; non avevo alcun motivo per non crederle. Tutto combacia alla perfezione, considerai.
A quel punto, Malcia servì il pranzo, e per un po’ ci intrattenemmo in argomenti più ameni.

Più tardi, al termine del pantagruelico pasto preparato in nostro onore, Malcia ricominciò: «E lo sa qualche accadde dopo, durante l’Occupazione?». Notai che Shumek – spesso Shlomo si rivolgeva a Solomon Reinharz con quel nomignolo polacco – non sembrava intenzionato a tornare al lavoro.
All’epoca ero convinto di saperlo ma, come già avevo fatto con i sopravvissuti a Sydney, le chiesi di raccontarmi tutto quello che ricordava, gli avvenimenti e le date. Però questa volta tenni a mente la lezione insegnatami da Matt: non mi limitai a chiederle solo cosa era accaduto, ma la reazione della gente, quel che pensava e diceva.
«Quando avete saputo dell’arrivo dei tedeschi, nell’estate del ’41, cosa si diceva in giro? Cosa si temeva sarebbe successo?».
Shumek e Malcia si scambiarono un’occhiata. Lei rispose: «Sapevamo, sapevamo, sapevamo. La sera che i russi lasciarono Bolechow, gli ucraini, i nostri goyim, uccisero centoventi ebrei, li gettarono nel fiume».
Annuii. Ricordavo quel che mi avevano detto Jack e Bob a Sydney: «La prima cosa che accadde fu che gli ucraini presero a uccidere gli ebrei. Sai, se avevi dei conti in sospeso con gli ebrei, li uccidevi».
«Ma la gente che si aspettava dai tedeschi?» insistei.«Cosa si sapeva a quel punto?». Malcia guardò di nuovo il marito, quindi rispose con un riso amaro: «Alle gloybten duss di doytscher wirdn uns tzvingen in a fabrik». «Pensavamo tutti che i tedeschi ci avrebbero costretti a lavorare nelle fabbriche».
A quel punto chiesi in quanti erano a conoscenza, almeno in linea generale, dei piani tedeschi sugli ebrei d’Europa quando scoppiò la guerra.
Malcia ripeté: «Sapevamo, sapevamo, sapevamo. Nel ’39 la gente, tutti gli ebrei, scapparono dalla Polonia – si era ancora sotto il governo polacco – fuggirono».
All’improvviso si portò le mani al volto, come sovvenendosi di qualcosa. «Oh!» esclamò. «Doveva vedere tutta quella gente, che si portava dietro i suoi miseri averi, tutte quelle famiglie...».
Anche Meg Grossbard ricordava le orde di profughi ebrei, insieme ad alcuni polacchi, che fuggivano a est e a sud, nella zona sovietica della Polonia, verso l’Ungheria, con carri, biciclette, a piedi, più rapidamente possibile dopo che i tedeschi avevano cominciato a bombardare Varsavia quel giorno di settembre del 1939. Meg mi aveva spiegato che Bolechow era l’ultima città prima della frontiera ungherese e migliaia di profughi avevano attraversato la città nella loro fuga. Molti, in realtà, si fermarono lì. Erano chiamati Flüchtling; i profughi. Preferivano il dominio sovietico a quello nazista.
Come se mi avesse letto nel pensiero, Malcia precisò: «Scappavano verso di noi. Non solo dalla Polonia, ma dalla Cecoslovacchia, dall’Austria. Sapevano che eravamo sotto i sovietici». Scosse il capo ancora una volta, in preda alle reminiscenze, e aggiunse: «Non dimenticherò mai».
A quel punto Shlomo interloquì: «Malcia, tu hai qualche anno più di me. Hai visto quei profughi...».
«Oh, i profughi!» esclamò lei, coprendosi di nuovo il viso con le mani.
«Ricordi che furono due anni tranquilli, dal 1939 al1941» proseguì Shlomo, «e la gente sapeva che stavano arrivando i tedeschi».
Malcia annuì, e Shlomo le pose una domanda, con la caratteristica enfasi che lo contraddistingue: «Allora perché non siamo scappati come gli altri profughi?».
Malcia fece un mesto sorriso. «Perché, perché?...
Ahhhh... Perché non si può lasciare la propria casa! Come si può abbandonare la propria casa?».
Come si può lasciare la propria casa? A quelle parole mi rammentai di un altro particolare delle lettere di Shmiel: il suo continuo tentennamento tra disperate fantasie di fuga e un orgoglioso rifiuto di abbandonare tutto. Scrisse che aveva intenzione di inviare una lettera al presidente Roosevelt; avrebbe venduto tutto, pur di poter scappare, mettere in salvo le figlie, almeno una, «La cara Lorka». Eppure, spesso nella stessa missiva cambiava idea. «Ma voglio sottolineare a voi tutti che non intendo partire senza mezzi di sussistenza – al contrario, grazie a Dio qui ho tutto quello di cui ho bisogno... So bene che in America non potrei raggiungere in breve tempo il tenore di vita che conduco qui». Fino a quando non ho avuto un lavoro, una casa e una famiglia, mi sono spesso chiesto la ragione di quei repentini sbalzi di umore. Parlando dell’Olocausto, delle lettere del mio prozio, la sua tardiva presa di coscienza che il mondo si stava serrando in una morsa attorno a lui, i vani sforzi per fuggire, mi capita non di rado di sentire coloro che conoscono gli avvenimenti della storia, che giudicano col senno di poi, porre lo stesso interrogativo di Shlomo – anche se la sua domanda impulsiva era motivata dal dolore, non dalla compiaciuta benevolenza di fronte agli eventi storici di chi conduce un’esistenza tranquilla. «C’è da chiedersi come abbiano fatto a non leggere la scritta sul muro» alcuni si compiacciono di affermare. Mauna volta adulto ho smesso di stupirmi. Né, come mi avvidi, si stupiva Malcia.
Come si può abbandonare la propria casa?!
A quel punto Malcia esclamò: «Non abbiamo ancora preso il dolce!». Si alzò e andò in cucina. Shumek e Shlomo si misero a parlare fitto in yiddish, rievocando episodi dei tempi della guerra. Cercai di seguirli, ma parlavano troppo velocemente. Sentii Shlomo chiedere a Shumek qualcosa riguardo alla Yiddishpolizianten, la milizia ebrea reclutata in ogni città, spesso costretta dagli invasori a fare il lavoro sporco: per esempio rastrellare un certo numero di ebrei, individuarli e condurli in luoghi da cui non avrebbero fatto ritorno. Avevo letto, circostanza confermata dalla viva voce dei sopravvissuti, che la milizia ebraica era temuta e odiata; vi facevano parte persone che fino a quel momento erano stati amici e vicini di casa. Due giorni prima,quando l’argomento era venuto fuori, Anna Heller Stern aveva reagito con veemenza. «Avevo più paura di loro che degli altri» aveva confessato. Eppure non potevo fare a meno di riflettere: se fossi convinto di salvare la mia famiglia entrando a far parte della milizia ebraica, lo farei? Pensai ai miei figli e mi astenni dal dare giudizi.
Comunque, come Shumek stava dicendo a Shlomo,la milizia ebraica non era certo indispensabile. «Und vuss hut zey getin? Zey hutten zi alle geloysht».
«E cosa fecero? Li liquidarono tutti».
Poi Shlomo chiese cosa ne era stato di due miliziani di loro conoscenza. Parlavano troppo rapidamente, e non riuscii ad afferrarne i nomi.
«Er is oykh geloysht geveyn?» domandò Shlomo. «Fu liquidato anche lui?».
«Yaw, er oykh» rispose Shumek, con un’espressione mite, in qualche modo rassegnata.
A quel punto Malcia portò un grosso dolce e, avendo colto la conversazione tra il marito e Shlomo, ci apostrofò: «Basta così. Non voglio parlare di mishugenah tzayten e mishugenah menshen».
«Tempi pazzi e gente pazza».
Quindi chiese: «Chi gradisce una bella tazza di tè?».
«Dunque sapete già quel che accadde durante l’Occupazione» disse Malcia. Avevamo finito di gustare il dolce ed eravamo tornati a sederci, satolli. Come mi era capitato a Sidney, ospite di Meg, durante il déjeuner à la Bolewchow, mi venne da pensare: «Tra non molto non ci sarà più nessuno a cucinare questi piatti».
«Be’» replicai «in realtà no. Cioè, sappiamo a grandi linee quel che accadde, ma non conosciamo in modo preciso il loro destino». Non volevo fornirle alcun dettaglio; volevo sentire cosa sapeva.
«Gli Jäger. Fecero la fine di tutti gli altri» affermò con un sospiro.
Ma subito dopo aggiunse: «E Frydka, aveva una relazione con il figlio di un polacco, un vicino».
Di nuovo Frydka, pensai. Dissi solo: «Ciszko Szymanski».
Fece un cenno affermativo con il capo. «E ci fu qualcuno che...».
Si rivolse a Shlomo per chiedere la parola esatta.
«Qualcuno che li denunciette» precisò il mio amico.
«Denunziò» lo corressi.
«Sì» confermò Malcia, annuendo di nuovo.
Frydka. Dopo la conversazione con Anna Heller Stern dubitavo di poter scoprire qualcos’altro; certamente niente di così drammatico e commovente come quell’episodio: «Se uccidete lei, dovete uccidere anche me!».
«Va bene» dissi, desideroso di soffermarmi su quel punto.
Ma a Malcia sovvenivano sempre nuovi ricordi, e andò avanti.
«Li denunciarono, li trovarono, e lei era incinta».
«Incinta?» ripetei stupito. Mi raddrizzai sulla sedia,fissandola.
«Si dice così?» chiese a Shlomo, per sincerarsi di aver usato la parola corretta.
Lui annuì. Sì, la parola era quella. Incinta.
«Un momento, torniamo un attimo indietro. Frydkastava con quel ragazzo polacco, Ciszko Szymanski. Si frequentavano, lei gli piaceva?» domandai.
Malcia disse qualcosa a Shlomo, e lui tradusse: «Lui l’aveva salvata, aveva cercato di nasconderla».
Malcia annuì e riprese a parlare in inglese. «L’aveva nascosta. E vivevano insieme».
Non ero certo di aver capito bene; volevo dettagli piú specifici. «E dove vivevano insieme?».
«A casa sua, di lui».
«La nascondeva a casa sua?» ripetei, sbalordito. Nessuno mi aveva riferito quel particolare.
Malcia annuì, più rivolta a se stessa che a me. «Sì. Efurono scoperti, li presero e lei era incinta. Così ho sentito dire».
Shlomo mi lesse nel pensiero, e chiese: «E dimmi,suo padre, Shmiel, era lì?».
«No» rispose Malcia, scuotendo adagio ma risolutamente il capo.
«Lui l’amava molto» proseguì, «e le propose di nasconderla. Gli piaceva molto, e lui piaceva a lei. Per lei era un, come si dice, un mazel. E la nascose, ma qualcuno lo sapeva e...».
Le mancò la voce. Aveva un’espressione assorta. Shlomo commentò: «Quindi parte della storia è vera. Qualcuno ha tradito Frydka».
Parte della storia, pensai. Ma come potevamo essere certi che fosse vera? Perché qualcun altro, riuscito a salvarsi nascondendosi chissà dove, quindi non testimone di quegli eventi, conosceva solo per sentito dire la sorte di Frydka, avendola appresa dopo la fine della guerra da qualcun altro, che a sua volta l’aveva sentita da chissà chi? E un certo dettaglio di quella storia di terza mano ora coincideva con un particolare che Malcia aveva udito da qualcuno, che a sua volta l’aveva sentito da un altro ancora. Avevano aiutato Frydka a nascondersi e poi qualcuno l’aveva tradita. Ma Shmiel dov’era? Avevo la sensazione di camminare sulle sabbie mobili.
«Tradita» ripeté Malcia. «Sì».
«E non si sa chi è stato?» provai a chiedere.
Da donna concreta qual era, Malcia si limitò ad allargare le braccia e a rispondere: «I vicini. Gli ucraini».
Stavo cercando di assimilare quella nuova versione,in cui non comparivano né Shmiel, né un’insegnante polacca di cui nessuno ricordava il nome, ma solo Frydka e Ciszko. Shlomo mi lanciò un’occhiata, e come leggendomi nel pensiero spiegò a Malcia: «Perché, sai, ci avevano detto che Frydka e Lorka si unirono ai Babij».
Il volto di Malcia assunse un’espressione decisa di diniego, quasi di sdegno. «No, no!».
«Va bene. Quindi l’ultima cosa che sappiamo di Frydka è che si nascondeva con Ciszko, e che qualcuno li denunciò...» ricapitolai.
Malcia annuì. «Li uccisero tutti e due. Incontrai la madre di lui, dopo la guerra».
«Sua madre?». Ecco un particolare interessante. «E cosa disse?» domandai.
Malcia sembrava divertita. «Cosa disse? “Era un ragazzo stupido!”».
Mi lanciò uno sguardo penetrante, indefinibile. «Ha pagato con la vita il suo gesto».
Continuai a interrogarla sull’argomento, volevo scoprire quanti più dettagli possibile. «E così ha incontrato la signora Szymanski dopo la guerra...».
«Non la cercammo, venne lei da noi. Avevamo un negozio a Breslau dopo la guerra...».
«Wrocław?» domandai. Sapevo che «Breslau» era l’antico nome tedesco dell’odierna Wrocław, così come «Lemberg» era l’antico nome di L’viv. Un giorno a Praga, esausti dopo aver girovagato per la città, io e Froma scoppiammo a ridere per come articolavamo quella parola rispetto alla pronuncia corretta: Vrotzwohf. Solo in seguito scoprii come si pronunciano alcune lettere in polacco.
Malcia annuì e sorrise. «Sì, Wrocław». Ricordava ancora l’indirizzo della sua abitazione. Rynek sześć. Ringplatz sechs. «Piazza del mercato numero 6». Ritornando alla madre di Ciszko Szymanski, spiegò: «Venne da noi,sapeva che avevamo un negozio. Tutti cercano qualche faccia conosciuta. Voleva incontrarci. Pianse, e parlammo a lungo».
Malcia mi guardò, e come per spiegare l’emozione di quel ricordo, aggiunse: «Gente di Bolechow».
Poi ripeté: «Mi parlò del figlio. Disse: “Quanto era stupido!”».
Malcia gridò la parola «stupido», come in quell’occasione doveva aver fatto la signora Szymanski. Quindi proseguì: «Diede la vita per quella ragazza. Mal’amava davvero tanto».
Tale madre, tale figlia, pensai.
Mi rivolse uno sguardo fermo e proseguì: «E per lei era una mitziyeh, sa cosa significa mitziyeh?».
Scossi la testa; lei gesticolò, come amava fare, il pollice, l’indice e il medio uniti, come quando si indica di aggiungere un po’ di sale a una pietanza.
Shlomo spiegò: «Un mitziyeh è qualcosa... qualcosa,sai, di speciale».
(In seguito verificai il significato della parola nel mio vecchio dizionario ebraico-inglese, edizione 1938,ereditato da mio nonno, e trovai: «ritrovamento, scoperta; una scoperta; una cosa preziosa»; fu interessante apprendere il vocabolo connesso al verbo mâtzâh, che significa scoprire, ipotizzare; imbattersi, incontrare, venire a conoscenza; accadere, succedere. Che cultura era quella ebraica, mi chiesi consultando il dizionario, mesi dopo l’incontro con i Reinharz, dove le nozioni di imbattersi, incontrare e scoprire erano indissolubilmente legate all’idea di preziosità?).
Malcia annuì con vigore e gridò: «Rimanere vivo!Rimanere vivo! Chi ha un tale mazel? Chi ha una tale fortuna?».
In quel momento mi tornarono in mente le parole di mia madre, quando ero a Sidney, dopo aver parlato con Jack Greene. «Perché la mia famiglia non è sopravvissuta?» si era chiesta in lacrime in quella telefonata. «Nemmeno uno?». Avevo posto la stessa domanda a Jack; la sua risposta fu: «Vedi, è solo questione di fortuna, tutto qui». Adesso, mentre ascoltavo Shlomo e Malcia, mi venne da pensare che in fondo, sebbene fosse morta, Frydka era stata fortunata. Era vissuta più degli altri, qualcuno aveva cercato disperatamente di salvarla, persino a costo della propria vita. Un mitziyeh, un mazel: che strano guardare le cose in retrospettiva; un lusso che Frydka e Ciszko non si erano mai potuti permettere.
Shlomo commentò: «Chi poteva immaginare che qualcuno li avrebbe traditi?».
«Vorrei appurare l’esatta cronologia degli eventi» ripetei, riferendomi a Frydka. «Viveva in uno dei lager, giusto? E poi...».
«Vede» mi interruppe Malcia, «ci fecero lavorare fino a Juni del ’43».
«Luglio!» la corresse Shlomo. «Non giugno, luglio!».
«E poi i tedeschi annunciarono che stavano costruendo un nuovo lager e tutti sarebbero stati salvati. Ma volevano solo mettere tutti in lager. E quella fu la fine».
Annuii. Jack mi aveva detto che quelli caduti nel tranello ordito dai tedeschi erano stati rinchiusi in un nuovo campo e uccisi. Con armi da fuoco, aveva specificato.
«E a quel punto» continuai «invece di andare in quel nuovo lager, Szymanski nascose Frydka a casa sua?».
«Sì» confermò Malcia.
«Quindi Szymanski la nascose a casa sua dopo il giugno ’43».
Malcia annuì.
«Luglio» ripeté Shlomo.
«Luglio del ’43» mi corressi. «E così nel mese di luglio del ’43 lei si nascose a casa di lui» ricapitolai, sperando che aggiungesse qualche altro particolare concreto. «E qualcuno sa dove questa casa si trovava?».
Non era la prima volta che mi capitava di mutare lievemente la sintassi parlando con i sopravvissuti di Bolechow.
«Io lo so» rivelò Malcia. «Non era lontano da quella di Frydka. Stava all’inizio della strada...».
Tirai fuori la mappa di Bolechow procuratami da Shlomo. Malcia la osservò e mi chiese dov’era via Dlugosa. Poi con un gridolino trionfante indicò un punto.
«Sì. Qui stava la casa degli Jäger e qui...» aggiunse indicando un altro punto sulla stessa strada, ma dalla parte opposta, «stava quella della famiglia Szymanski,all’inizio della via».
Quindi Ciszko abitava proprio all’angolo, dedussi. Ecco dove si era nascosta. Adesso che avevo scoperto com’era andata, volevo conoscere il posto, vederlo con i miei occhi se mai fossi tornato a Bolechow.
Shlomo, Solomon e Malcia stavano parlando in yiddish e in tedesco dello sterminio degli ebrei detenuti nel lager nella tarda estate del 1943 – il che equivale adire della liquidazione degli ultimi sopravvissuti, salvo chi era riuscito a nascondersi. In quel periodo i Reinharz si nascondevano, vigili e attenti a non tradirsi, nel circolo ricreativo dell’edificio dove si erano insediati gli ufficiali tedeschi, il Kasino, proprio al centro della città.
«Am vier und zwanzigsten August» stava dicendo Malcia in tedesco. «Dann is meine schwester gegangen:und jeden Schuss haben wir gehört».
«Il 24 agosto. Quel giorno mia sorella andò. E abbiamo sentito ogni sparo».
«Erano nascosti» precisò superfluamente Shlomo.
Malcia annuì e aggiunse in inglese: «E ogni, ogni...».
Si rivolse a Shlomo «Unt yayden shuss hub’ikh getzuhlt».
Era ricorsa di nuovo all’yiddish. Questa frase la compresi. «Ho contato ogni sparo».
Si volse di nuovo verso di me, ma proseguì in yiddish. «Noyn hindert shiess hub’ ikh getzuhlt».
«Ho contato novecento colpi».
Tacque un attimo, poi riprese in inglese: «E poi tornarono al Kasino, si lavarono le mani e si misero a bere! Ero proprio lì, li vidi! Si lavarono le mani e andarono a bere!».
Shlomo, emozionato quanto me davanti a quell’immagine dei due ebrei nascosti, stretti in quel minuscolo nascondiglio, che non videro il massacro ma continuarono a contare, uno dopo l’altro, i colpi che tolsero la vita ai loro amici e vicini, si volse verso Malcia e domandò: «E sapevate cosa stava succedendo?».
Malcia portò l’indice alla tempia, e rispose: «Lo immaginavamo».
Anche io in quel momento mi stavo figurando la scena. Eravamo arrivati verso mezzogiorno, ed erano quasi le tre; avevo appreso molto su cui riflettere. Non si trattava solo delle nuove e sorprendenti novità riguardanti Frydka – era incinta, e lui l’aveva nascosta a casa sua – anche se, come l’immagine di Malcia e Shumekche contano i colpi delle armi da fuoco, non erano certo trascurabili; richiedevano uno sforzo di immaginazione, inevitabile se volevo raccontare tutta la storia.
Erano amanti, si amavano profondamente, erano tempi disperati, dormivano insieme, lei era incinta. Lui l’amava a tal punto da mettere a repentaglio non solo la propria vita, ma quella di tutta la sua famiglia. Be’, pensai, buon per lei. Buon per loro. Sono contento che abbia vissuto un amore profondo prima di morire. Al diavolo quel che pensa Meg Grossbard. Al diavolo quell’esclamazione, «Non so niette, non ho visto niette!».
Eppure, malgrado l’importanza di quei particolari,non riuscivo a togliermi dalla testa le parole di Malcia, «Lo immaginavamo». C’era di che riflettere. L’amava così tanto! Aveva delle gambe davvero belle. Anche questi erano fatti, raccontavano una piccola storia. Forse quel giorno del 1918, quando si erano conosciuti, inizialmente Shmiel era stato attratto proprio da quelle gambe; lei una ragazza carina di ventitré anni con i tratti somatici regolari e l’espressione seria propria della sua famiglia, lui un giovane volitivo, una specie di eroe di guerra, determinato a riportare in auge l’attività commerciale paterna. Forse l’aveva vista giocare con delle amiche, in una placida estate del 1919, sulle rive del Sukiel, proprio dove la loro figlia un giorno avrebbe sgambettato con le sue amiche, pochi anni prima di essere quasi tutte stuprate e ammazzate a colpi di pistola, di mitra o con il gas. Forse fu quel piccolo particolare a far sbocciare la loro storia d’amore, che per quanto ne sappiamo non ebbe mai fine. L’amava davvero tanto – au au au!
Mentre riflettevo sull’importanza dell’immaginazione, la possibilità di ricostruire una storia a partire da pochi dettagli concreti, mi avvidi che Malcia e Shlomo stavano ricordando, dopo il pasto luculliano, certe pietanze dell’epoca, in pochi ormai in grado di cucinare. «Ahhh, bulbowenik!» esclamò Shlomo. Shumek roteò gli occhi tutto in sollucchero, quindi mi spiegarono di cosa si trattava: «Un piatto di patate grattugiate e uova, mantecato e...».
«Aspettate!» esclamò Malcia. Era sollevata di non dover parlare più del passato. «Adesso ve lo preparo!».
Lanciai un’occhiata a Shlomo. Gli ricordai che dovevamo tornare a Tel Aviv per le sette, perché ero stato invitato a cena da un collega conosciuto negli Stati Uniti,un professore di filosofia dell’università di Tel Aviv.
Shlomo sorrise e disse qualcosa a Malcia, che scosse la testa impaziente. «Non ci vuole niente, lo preparerà in un attimo» tradusse Shlomo.
Perché no?, pensai. Anche quello faceva parte della storia; dopo tutto, non avveniva spesso che qualche aspetto della vita scomparsa di Bolechow si potesse facilmente materializzare. Sorrisi a mia volta e annuii. «D’accordo. Cuciniamolo».
Malcia mi fece accomodare in cucina, per assistere alla preparazione. Grattugiammo le patate, sbattemmo le uova e mettemmo tutto a cuocere nel forno per quarantacinque minuti. Quindi tirammo fuori la pentola per farla raffreddare. E pensare che avevamo consumato un pranzo sontuoso, innaffiato da un bel po’ di vino!Per non parlare della cena altrettanto abbondante che di certo mi aspettava.
Ma educato com’ero, sapevo come dovevo comportarmi: sedetti e feci onore alla tavola. Era squisito. Malcia era raggiante. «È un autentico piatto di Bolechow!» ci assicurò.
Solo dopo il bis ci fu concesso di andar via.
Io e Shlomo scendemmo la scalinata di cemento del palazzo dove abitavano i Reinharz e ci incamminammo verso il parcheggio. Vuoi per la lezione di cucina, vuoi per l’assaggio del bulbowenik, ci eravamo attardati. Il sole, basso all’orizzonte, brillava intensamente, e in macchina aprimmo i finestrini. Shlomo era intento a trovare il modo di arrivare all’imbocco dell’autostrada. Eravamo in Rambam Street – strada, fui felice di notare, che portava il nome del grande studioso e filosofo ebreo del dodicesimo secolo, Maimonide (il cui acronimo del nome ebraico, Rabbi Moses ben Maimon, è RMBM). Rambam era un ebreo di origine spagnola, la cui famiglia fu costretta a fuggire per le persecuzioni anti-semitiche del califfo, e si stabilì in Egitto; Maimonide divenne servitore stimato dell’illuminato sultano del Cairo. Insieme a Rashi è lo studioso più largamente apprezzato e letto tra tutti gli intellettuali ebrei. Le idee razionalistiche espresse nel suo capolavoro, La guida dei perplessi – e, verosimilmente, l’enorme notorietà da lui goduta – fecero infuriare alcuni rabbini suoi rivali in Francia, che lo denunciarono all’Inquisizione francese;al contrario, alla sua morte al Cairo i musulmani proclamarono tre giorni di lutto. Chi ti è fedele? recita la parashat Lech Lecha; c’è poco da stupirsi.
Mentre ci lasciavamo alle spalle la strada intitolata alla memoria di quell’uomo straordinario, commentammo entusiasti l’incontro con i Reinharz.
«E così era incinta» ripetei a Shlomo, intento a controllare i cartelli stradali.
«Be’, almeno così sostiene» replicò. «Comunque è interessante, no?».
Annuii. Certo che lo era. Ero andato fino in Australia senza sapere nulla, e adesso mi ritrovavo un’autentica storia drammatica per le mani. Mi chiesi cosa avrebbe detto Meg, se le avessi rivelato quanto avevo appreso.
Non ci volle molto a uscire dalla città, e filammo verso Tel Aviv. Eravamo entrambi esausti dopo quella giornata; dopo alcuni minuti di amichevole silenzio il mio accompagnatore accese la radio, e la cosa non mi dispiacque. Nell’abitacolo si diffuse il canto di una voce femminile, e mi ci volle un po’ per rendermi conto che cantava in inglese e non in ebraico. La melodia mi era familiare, ma all’inizio non riconobbi la canzone, non conoscendone i versi, bensì solo il ritornello, come presto scoprii. La voce della donna mimava quella di una fanciulla che intonava un canto elegiaco. Era morta, diceva, per amore di un giovane che non l’amava. E poi la voce intonò il ritornello:
I wish I wish
I wish in vain
I wish I was
a maid again
but a maid again
I never can be
till apples grow
on an ivy tree 11
Mi raddrizzai sul sedile, farfugliando, e infine urlai:«È questa la canzone! È questa la canzone! Quella di cui ti parlavo stamattina. La canzone che mi cantava mio nonno!».
La voce stava intonando l’ultimo verso, che attirò la mia attenzione, forse perché le parole morta per amore mi risuonavano in mente in quell’afoso tardo pomeriggio:
Oh, make my grave
large, wide and deep
put a marble stone
at my head and feet
and in the middle
a turtle dove
so the world may know
I died for love 12
«Come diavolo aveva fatto mio nonno a conoscere quella canzone? Perché l’aveva imparata?» mi chiedevo mentre appuntavo questa strofa; l’immagine della tomba, della lapide, della colomba mi aveva commosso, e volevo impararne i versi a memoria.
Al termine della canzone l’annunciatore barbugliò qualcosa in ebraico. Shlomo tradusse: «È una canzone irlandese».
«Come faceva nonno a conoscerla?» mi chiesi nuovamente. «E come mai l’aveva imparata?».
Shlomo accentuò il sorriso.
«E non è tutto» soggiunse. «La sai l’altra coincidenza?».
Scossi il capo. Che altro poteva succedere di ancor piú perturbante?
Guardandomi, mi rivelò: «Lo sai chi la cantava? Nehama Hendel, la moglie di Regnier, l’autore del libro su Bolechow».
Il mio volto dovette tradire un’espressione inequivocabile. Shlomo espirò a fondo, e con un gesto della mano a indicare la radio e il deserto circostante, disse: «Vedi? Lo vedi? Israele è il paese dei miracoli».
Non credendo nei miracoli, mi limitai a sorridere e ad annuire. Poi, una volta tornato all’Hilton, feci una ricerca su internet digitando la sequenza «I WISH I WISH I WISH IN VAIN». Sullo schermo comparvero all’istante decine di citazioni, e impiegai un paio di minuti per scoprire il titolo della canzone che mio nonno mi cantava da bambino; da sempre convinto che l’avesse imparata da piccolo, era invece chiaro che lo fece dopo aver lasciato Bolechow. Per ragioni che posso solo ipotizzare,era rimasto profondamente colpito forse già solo dal titolo, che mai avrei scoperto se non fossi andato in Israele: The Butcher Boy. Il garzone del macellaio.
Era domenica. Il martedì incontrai il cugino di Shlomo, Josef. Venne lui da me, in albergo. Era un uomo sulla settantina, di bell’aspetto e piglio militaresco, poco propenso al sorriso, con un fisico asciutto e in perfetta forma. Con voce ferma e distaccata parlò per un’ora e mezzo, praticamente senza interruzioni, rievocando il destino degli ebrei di Bolechow. Lo ascoltai con attenzione, pur conoscendo bene quella storia, non solo grazie a quanto appreso dai sopravvissuti, ma anche per aver letto i succinti capitoli informativi del libro Yizkordi Bolechow sugli anni della guerra, il cui autore era proprio lui, Josef Adler. Qualcosa nel suo contegno mi spingeva a chiedere la sua approvazione: forse per quella gravità militaresca, accentuata dai pantaloni perfettamente stirati e l’immacolata camicia a maniche corte color cachi. Ci accomodammo nelle anguste poltrone dell’albergo che avevo disposto attorno allo scrittoio; Josef Adler chiarì subito di non conoscere bene i miei parenti scomparsi; ma ci teneva che sapessi cosa era accaduto. Annuii e lo lasciai parlare. L’arrivo dei tedeschi. La prima e la seconda Operazione. Il lager. La Fassfabrik. Lo sterminio finale nel ‘43. Gli straordinari particolari del modo in cui lui e Shlomo, appena due ragazzi, erano riusciti a sopravvivere. Il fortunoso approdo in Israele, l’importanza di quel paese per gli ebrei. Mentre discorreva di quest’ultimo argomento,con voce carezzevole ma ferma e con dovizia di particolari, provai vergogna per la mia atavica mancanza di interesse nei confronti del moderno Israele; mi chiesi se tutti gli ebrei americani che visitano quel paese finiscano prima o poi per sentirsi come dei renitenti alla leva. Al termine del nostro incontro lo ringraziai di cuore per essere venuto in macchina da Haifa fino a Tel Aviv, cosa che, mi aveva assicurato qualche giorno prima quando avevamo organizzato l’appuntamento, non costituiva un problema. «Quello che sta facendo è molto importante» mi confidò prima di congedarsi, quando ci stringemmo la mano. «È fondamentale che la gente sappia cosa è accaduto».
Ma questo avvenne il martedì, come ho già detto. Il lunedì lo passammo a Tel Aviv. Froma, che sin dal giorno dell’arrivo in Israele era stata impegnata con le visite ai parenti, voleva recarsi al Beth Hatefutsoth, il museo della Diaspora ebraica, situato vicino al modernissimo campus dell’università di Tel Aviv. «C’è parecchio da vedere» mi aveva avvertito. Dovevamo andarci presto. Arrivammo nella tarda mattinata di una giornata luminosa; il museo aveva appena aperto. Le palme disseminate davanti all’edificio non riuscivano ad attenuare la sua monumentalità quasi aggressiva.
All’interno dell’atrio cavernoso la temperatura era gradevolmente fresca. Facemmo il biglietto e iniziammo a visitare la mostra permanente, che si apre con la riproduzione di un bassorilievo dell’Arco di Tito che si trova a Roma, sul quale è raffigurato il trionfante ritorno delle legioni romane che nel 70 d.C. conquistarono la Giudea e distrussero il secondo Tempio. È ben visibile una menorah, il candelabro usato nel Tempio, portato via a spalla da robusti soldati romani. Il monumento è una sorta di austera introduzione a ciò che sugli opuscoli del museo viene descritto come il desiderio del fondatore di «mettere in risalto gli aspetti positivi dell’esperienza della Diaspora». Proseguendo nella mostra vera e propria, si rinvengono reperti più degni di nota. Come nello Zentralfreidhof di Vienna, il percorso del Beth Hatefutsoth è costituito da una serie di «ingressi», per quanto si tratti di varchi metaforici: la Porta della Famiglia, la Porta della Comunità, la Porta della Fede, la Porta della Cultura, e così via. Visitammo tutto, notando ogni particolare. Mi colpirono molto i modelli in scala e i diorami, piuttosto grandi e minuziosamente dettagliati, tramite i quali i curatori del Beth Hatefutsoth hanno cercato di evocare i molteplici aspetti culturali delle comunità ebraiche nei secoli della diaspora. Ci sono, per esempio, ammirevoli riproduzioni di sinagoghe di tutto il mondo, da quella di Kaifeng, in Cina, dell’ottavo secolo, che al mio occhio poco istruito non sembra dissimile da un qualsiasi edificio cinese, con le gronde incurvate verso l’alto e le esili colonne decorate, al tempio israelitico di Firenze, una grandiosa costruzione moresca a cupola, che mi riportò alla mente un’altra riproduzione in miniatura di un imponente luogo di culto ebraico, la sinagoga spagnola di Praga.
C’era anche un bellissimo modellino della grande sinagoga di Vilna, l’odierna Vilnius, in Lituania, edificata nel 1573, lo stesso periodo in cui i primi ebrei si stabilirono a Bolechow, consistente in un vasto complesso di scuole, yeshiva e luoghi di preghiera – circostanza ben naturale, a pensarci, visto che la città, definita la Gerusalemme del Nord, era rinomata per ospitare trecentotrentatré studiosi che affermavano di poter recitare il Talmud a memoria – distrutto nel 1942, lo stesso anno in cui scomparve la maggior parte degli ebrei di Bolechow.
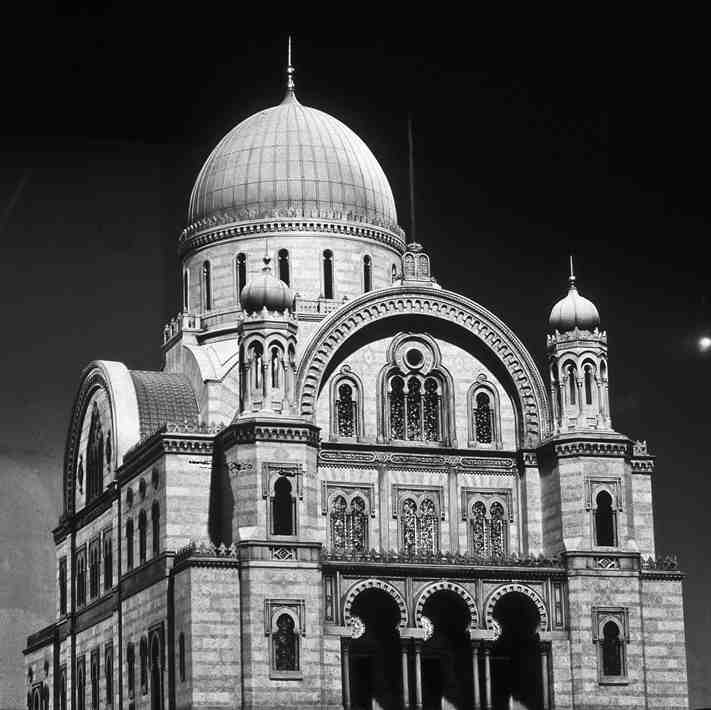
(Quando lasciammo Israele, con Froma mi recai a Vilnius; trascorremmo il fine settimana alla ricerca delle sparute tracce di quella che un tempo fu la culla della cultura ebraica. Visitammo la tomba del celebre Gaon di Vilna, uno studioso vissuto nel diciottesimo secolo, talmente famoso per la sua erudizione che remote congreghe come quella portoghese aspettavano pazientemente anni per ricevere i suoi responsi su interrogativi inerenti le scritture e la legge. La guida ci informò che in quella tomba erano sepolte anche le ossa di un cattolico polacco, rampollo di una ricchissima famiglia aristocratica, un conte, un Graf, che dietro l’insegnamento del Gaon si convertì al giudaismo e per questo venne bruciato vivo dall’inquisizione cattolica. Esaminammo compitamente l’iscrizione in polacco incisa sulla tomba e lessi ad alta voce, esitante, il nome di questo Graf: «Potocki?» pronunciai incerto, suscitando un sorriso nella guida, che mi corresse: «No, no, la «ck» si pronuncia «ts», la pronuncia corretta è Pototski»).
Ancora più meravigliosi dei modelli trovai i magnifici diorami altrettanto particolareggiati, come quello collocato nella sezione della mostra permanente intitolata «Tra le nazioni», raffigurante il grande saggio babilonese del decimo secolo Saadia Gaon, nel pieno di una dissertazione all’interno del palazzo del califfo di Baghdad. La minuscola figura del Gaon è raffigurata sotto lesplendide volte ornate della reggia, avvolto in una veste bianca, con il braccio sinistro proteso, come nell’atto di un’importante disquisizione retorica. Non c’è da stupirsi: la carriera di quest’uomo di straordinaria erudizione, egiziano di nascita – il vero nome, Said al-Fayyumi, allude alle sue origini nel Fayum, regione dell’alto Egitto – che divenne l’elemento di spicco del gaonato babilonese, fu costellata di importanti dispute dottrinarie, culturali e intellettuali. Non ancora quarantenne, Saadia aveva brillantemente arginato il tentativo del suo astuto rivale Aaron ben Meir, Gaon della comunità ebraica nel territorio palestinese, di mettere in discussione l’autorità del gaonato babilonese; gli sforzi degli ebrei palestinesi di introdurre un nuovo calendario svanirono presto. Saadia indirizzò i suoi strali anche contro gli ebrei babilonesi di lingua araba, una colta élite affascinata dal razionalismo illuminato dei filosofi greci, reintrodotto tramite le traduzioni in arabo. Con la sua opera innovativa Kitab al-amanat wall’ i‘tiqkadat, «Il libro degli articoli della Fede e delle dottrine del Dogma» (oggigiorno conosciuto, per ovvie ragioni, con il titolo ebraico, Emunoth ve-Deoth, «Il libro dei Dogmi»),scritto in un arabo elegante indirizzato a un pubblico cosmopolita, Saadia – particolarmente influenzato dai Mutaziliti, i dogmatisti razionalisti dell’Islam – elabora il primo studio sistematico e l’origine filosofica dei principi del giudaismo. In esso espone la razionalità della fede ebraica, sottolineando il fascino intellettuale che la Torah condivide con gli scritti dei filosofi greci,che in quel periodo andavano riscuotendo una crescente fortuna. Anche la traduzione in arabo della Bibbia, opera altrettanto seminale, corredata da un lucido quanto gradevole commentario, è parte del suo progetto esegetico di spiegazione delle fonti principali del giudaismo.
Nell’apprendere tutto ciò mi resi conto che il fascino esercitato su di me da ebrei come Maimonide e Saadia Gaon era dovuto al loro illuminato cosmopolitismo, a sua volta riflesso delle società imperiali multietniche in cui vissero, nelle quali, tanto per fare un esempio, ebrei di lingua araba scrivevano trattati per contrastare il crescente fascino intellettuale riscosso dagli antichi filosofi greci; culture non così dissimili, per certi versi, da quella altrettanto multietnica in cui crebbe mio nonno,nella quale per un periodo l’ebraismo fu uno dei molteplici, vividi elementi, parte di un complicato e mirabile puzzle, da tempo andato in frantumi. Parrà strano,ma mi parve di trovare un legame tra Saadia e mio nonno; questi, naturalmente, non era uomo di sconfinata erudizione o di finezza intellettuale, ciò nondimeno era un ebreo ortodosso europeo che parlava sette lingue e,ancora dopo la seconda guerra mondiale, continuava a recarsi a Bad Gastein, località termale nel cuore dell’Austria, perché era di moda in un certo ambiente europeo: un tipico soggetto appartenente a un impero scomparso. Due anni dopo la visita al Beth Hatefutsoth, durante la quale contemplammo ammirati il diorama di Saadia Gaon, Froma e io sedevamo in un caffè di L’viv a conversare appassionatamente della straordinaria ricchezza culturale esistente prima della guerra in quella città, dove avevano convissuto ebrei, polacchi,austriaci e ucraini, ed esponenti del clero ucraino mangiavano regolarmente in certi ristoranti dove si serviva gefilte fish fianco a fianco con burocrati polacchi e mercanti ebrei. «Oggi è tutto così omogeneo» commentò Froma, alquanto sconsolata, forse anche con una nota di biasimo, mentre osservava le bionde fanciulle ucraine, slanciate e oltremodo attraenti, passeggiare per il viale,davanti ai palazzi delle Belle arti e della Secessione,edificati dagli austriaci un secolo fa. Fissandola, replicai maliziosamente: «Proprio così. È quello che avviene in un paese dove vivono solo ebrei». Mi lanciò un’occhiata perplessa, mentre mandavo giù un sorso di birra ucraina, la L’VIVSKAYA.
Tornando al decimo secolo: la disputa più cruciale che vide protagonista Saadia fu quella condotta nei confronti della setta nota con il nome di Caraiti. A cominciare dal nono secolo, questo «Popolo delle scritture» si distingueva dal giudaismo rabbinico tradizionale per alcuni elementi fondamentali: a differenza degli ebrei ortodossi, i Caraiti non consideravano parola di Dio l’immenso corpus legislativo orale, ritenendolo semplicemente l’opera di saggi e maestri, e come tale soggetto a errori. Il risultato di questo rifiuto dell’interpretazione rabbinica, base di tutta la pratica giudaica contemporanea, si concretizzava in una profonda divergenza di certi riti dei Caraiti rispetto a quelli del giudaismo ortodosso. Per esempio, i Caraiti non accendevano le candele il sabato, pratica universalmente seguita da tutti gli altri giudei (inoltre, il sabato si astenevano dai rapporti sessuali, sebbene altri ebrei considerino il sabato particolarmente propizio per quest'attività). Per queste e molte altre eresie, nei tre trattati che dedicò alla confutazione del credo dei Caraiti, Saadia concluse che essi non erano ebrei. Tale aspetto è interessante per diverse ragioni, non da ultimo il fatto che dodici secoli dopo le affermazioni di Saadia, nel 1934 i capi delle comunità caraiti che sostennero le medesime argomentazioni davanti alle autorità naziste – gesticolando, forse, nel modo infervorato in cui sono rappresentate le figurine del Beth Hatefutsoth – e persuasero gli esponenti del Reich di non essere affatto ebrei, e quindi non soggetti alle leggi razziali naziste; ragion per cui l’esigua popolazione di Caraiti dell’Europa orientale (tanto per citarne una, la comunità della città di Halych, che dista un’ora di macchina da Bolechow),ne uscì incolume mentre gli ebrei delle zone circostanti scomparvero dalla faccia della terra.

Quella mattina a Tel Aviv impiegammo parecchio tempo ad assimilare queste e altre nozioni; avevamo visitato appena i due terzi del museo quando mi avvidi che erano già le due e mezza, e non avevamo ancora pranzato. Così uscimmo dal museo; emergendo nell’accecante bagliore solare trovammo un ristorantino sui prati del campus universitario. Seduti all’ombra di un tendone divorammo un piatto di pappardelle e un’insalata; presto fu chiaro che Froma, come di consueto,era intenzionata a mettere a frutto la rimanente parte della giornata.
Appena terminato il pranzo mi spronò: «Vieni, torniamo dentro. Non possiamo mica andarcene senza aver terminato la visita, no?».
Scossi il capo, sorridendo. Dopo tutti quegli anni conoscevo bene la sua insaziabile curiosità intellettuale, e non di rado mi divertivo a stuzzicarla – proprio come lei fa con me, punzecchiandomi per la mia pigrizia e lo scarso interesse.
«Froma» replicai, «ne ho abbastanza». Sorridevo, ma ero ben determinato a uscire vincitore da quella piccola schermaglia. Ero ancora stanco per il lungo viaggio a Beer Sheva del giorno precedente; per di più faceva un caldo infernale, e l’indomani, martedì, era l’ultimo giorno che avremmo trascorso in Israele. Dovevo ancora incontrare delle persone. Desideravo riposare, magari fare un bagno nel Mediterraneo, che si stendeva proprio dietro l’albergo, incantevolmente verde e cristallino. E,non da ultimo, ho sempre opposto una certa resistenza a donne più anziane e autoritarie, dell’età di mia madre, verso le quali sono portato a essere condiscendente e ubbidiente quando ordinano: «Torniamo dentro».
Comunque mi giustificai dicendo che volevo restare un po’ solo per assemblare tutte quelle informazioni,buttare giù qualche pagina del libro, e scuse simili.
«Ma Daniel» insisté Froma, puntandomi contro una piccola oliva nera, «non hai ancora visto la sezione genealogica!». Era inorridita dalla mia mancanza di entusiasmo. All’ingresso del museo ci era stato detto che al piano superiore c’era un archivio dedicato alla genealogia – una stanza con computer tramite i quali si poteva,per esempio, fare ricerche sul proprio cognome. Cercando di sedurmi per accompagnarla sulla collina dove sorgeva il gigantesco museo, Froma mi fece balenare la possibilità di chissà quali straordinari risultati se solo avessi interrogato quelle macchine inserendo il nome degli scomparsi Jäger di Bolechow. Al che replicai seccamente che le informazioni ricavabili da quell’archivio potevano solo essere quelle immesse dai miei parenti, anni addietro; e comunque ero convinto di saperne più di loro.
Ma naturalmente alla fine la vinse lei. Mi spingeva sempre ad andare avanti, a riflettere più a fondo; pur consapevole che stavolta non ci sarebbe stata contropartita, mi sembrava indelicato non accompagnarla se lo desiderava così tanto. D’altra parte, considerai tra me,ormai erano quasi le tre e un quarto e il museo chiudeva alle quattro, quindi non ci saremmo fermati molto.
Tornammo indietro e ci dirigemmo al piano superiore del museo. C’era già aria di smobilitazione; passando davanti alle porte degli uffici sentivamo l’inconfondibile chiacchiericcio di chi è sul punto di andare via. Nella stanza dedicata alle genealogie trovammo solo un paio di donne sulla sessantina, chiaramente due impiegate:se ne stavano in piedi accanto alla porta a conversare confidenzialmente in ebraico. Froma mi incitò: «Dai, di’ loro cosa cerchi, magari scoprirai qualcosa».
Prima ancora di aprire bocca, quella che sembrava la responsabile, una donna dall’espressione seria, i lineamenti dolci e l’aspetto riservato, mi avvertì in inglese:«Spiacente, stiamo chiudendo».
«Oh» feci. Naturalmente mi sentii sollevato.
«Non le conviene» mi spiegò «pagare un’ora per il computer; chiudiamo alle quattro e mancano pochi minuti».
Per affetto nei confronti di Froma simulai una certa delusione. Annuii con espressione triste.
La donna abbozzò un sorriso, mi lanciò uno sguardo vagamente materno e mi chiese: «Viene da TelAviv?».
«New York» risposi.
«Da New York? Be’, non è proprio dietro l’angolo!».Mi squadrò, parve intenerirsi e capitolò: «Va bene, senta, mi dica il cognome, farò io la ricerca e vediamo subito cosa viene fuori».
«Fantastico!» esclamò Froma. Era rimasta all’ingresso della sala, poggiata a una piccola cancellata, e fece per avvicinarsi.
Credo che la ragione per cui dissi Mendelsohn invece di Jäger fosse dovuta in parte a una forma di resistenza all’entusiasmo palesato da Froma, alla sua insistenza di voler «tornare a dare un’altra occhiata», alla sua fiducia che la mia ricerca sarebbe stata agevolata dalla visita in quel luogo, malgrado fossi convinto del contrario. Ero andato in Israele per fare ricerche sulla storia del ramo materno della mia famiglia, non quello paterno; ma per un’irrazionale ripicca, quando quella donna mi chiese il nome per interrogare l’archivio risposi Mendelsohn. Quando si viene educati in una famiglia dove vige un ordine rigoroso, persino maniacale, si trova una profonda soddisfazione nella ribellione.
«Mendelsohn!» ripeté la donna, accennando un sorriso. Si voltò verso la collega e le mormorò qualcosa in ebraico, quindi scoppiarono a ridere. Poi, per non apparire scortese, si volse di nuovo verso di me e mi spiegò il motivo di quella ilarità: l’archivio era zeppo di Mendelsohn.
«È un nome ebreo molto diffuso» aggiunse.
«Lo so» replicai.
Mentre smanettava sul computer, si voltò verso di me che ero rimasto sulla soglia e disse: «Sa, conoscevo dei Mendelsohn, ma non a New York. Vivevano a Long Island».
Io e Froma ci scambiammo uno sguardo divertito,quindi precisai: «Davvero? Io sono nato a Long Island».
«Oh? E dove?».
«La vecchia Bethpage» risposi con un sorrisetto disfida. Nessuno conosce quella località, è troppo piccola. Le cinque città, vi rispondono immancabilmente, con l’aria di chi la sa lunga, quando spiegate che siete di Long Island. Gli Hamptons. Ma la vecchia Bethpage è un nonnulla, un minuscolo ago in un immenso pagliaio.
A quel punto sorrise e mi chiese: «Come si chiama suo padre?».
«Jay» risposi.
Mi fissò per qualche secondo.
Poi aggiunse: «E tua madre si chiama Marlene, vero? E ci sono altri tre ragazzi, no? Andrew, Daniel e Matthew».
Io e Froma avevamo smesso di sorridere. La mia amica aveva la bocca letteralmente aperta.
Sbattei le palpebre e le domandai: «Chi sei?». Chiunque fosse, non frequentava i miei da lungo tempo, perché non sapeva che mia madre aveva avuto altri due figli dopo Matt.
La donna sorrise di nuovo, non nel modo formale e impersonale con cui mi aveva accolto, né in quello appena più cordiale di quando avevamo cominciato a conversare. Adesso esibiva un sorriso a un tempo dolce, lievemente malinconico e rassegnato, proprio di chi è avvezzo ai casi della vita. Per un attimo ebbi la chiara impressione, per quanto irrazionale, che se lo aspettasse.
«Sono Yona».
Il pomeriggio seguente, una giornata radiosa e piuttosto ventilata, Yona e io passeggiavamo lungo la spiaggia limitrofa al mio albergo. Ancora non mi capacitavo della casualità dell’incontro, dopo tutti quegli anni. E pensavo anche alle coincidenze che avevano sempre legato le nostre famiglie, come avevamo ricordato il giorno prima all'entrata della sezione genealogica.
Dopo un primo momento di forte emozione, le esclamazioni, gli abbracci, mi aveva chiesto: «Lo sai perché mi chiamo Yona?».
«No».
Sorrise timidamente. «Be’, sai, ha a che fare con tuo nonno e i miei genitori. A Bolechow, l’amicizia che legava tuo nonno Avrumche – per tutta la conversazione si riferí a mio nonno con il nome yiddish – ai miei genitori risale a prima della guerra del ’14-18. Avrumche era il loro amico più caro. Si conoscevano sin da bambini».
Non l’avevo mai saputo. Questo spiegava perché lui le fosse così affezionato.
Yona annuì. «Sì, vedi, abitavano vicino. E mia madre conosceva la tua bisnonna Taube, erano amiche intime. Tanto che quando era incinta di me (si toccò il petto con gesto repentino) sognò la sua amica, la tua bisnonna,per questo porto il suo nome».
D’improvviso il viso di Froma si illuminò. Fino a quel momento aveva seguito la scena impalata, immobile. E mi disse: «Yona in ebraico significa “colomba”».Yona mi guardò e mi chiese: «Che ci fai in Israele?».
Le sorrisi e risposi: «È una lunga storia».
Quella sera chiamai mia madre dall’albergo per raccontarle quell’incredibile incontro. Reagí come me, rimase basita, e poco ci mancò che non scoppiasse a piangere. «Mio padre la chiamava Yona geblonah!» mi rivelò, in preda all’emozione, come sempre le capita quando si parla di mio nonno. Yona sembrava stranamente fatalista, mentre io ritenevo il nostro incontro un’incredibile coincidenza; tornando sull’argomento il giorno seguente, mi fece capire che in fondo si aspettava che accadesse una cosa del genere.
«Be’» mormorò a bassa voce, «Israele è...». Una folata di vento troncò la sua frase.
«Il paese dei miracoli?» buttai lì tra il serio e il faceto, rammentando l’orgogliosa esclamazione di Shlomo mentre tornavamo da Beer Sheva.
Yona mi fissò con quel suo sorriso dolce e malinconico, lievemente asimmetrico. «No, è solo che il paese è piccolo, ecco tutto. Non c’è da sorprendersi. Qui eventi come questo possono accadere».
Passeggiammo per un po’, finché non scovammo un ristorantino senza pretese e ci sedemmo, con l’immensa distesa baluginante del mare che si apriva davanti a noi. Lei ordinò un pasto frugale, io un’insalata e una Diet Coke.
«Mangi solo questo?» si stupì, lanciandomi uno sguardo tra l’incuriosito e il divertito. «Prendi qualcos’altro! Che ci fai con un’insalata?».
Sorrisi e scossi il capo. Cominciammo a parlare della storia della mia famiglia. Mi aveva preannunciato parecchie rivelazioni sugli Jäger di Bolechow.
Dopo avermi rivelato il motivo per cui le avevano dato quel nome, le avevo chiesto di parlarmi della mia bisnonna Taube, di raccontarmi «qualcosa di specifico».
«Oh, era una personlikhkayt, un personaggio, una donna tanto buona» cominciò, sforzandosi di richiamare alla mente i commenti dei suoi genitori, risalenti a decenni prima. «Era molto onesta e... buona».
Be’, pensai, cosa ti aspettavi? Era morta anni prima della nascita di Yona; e comunque, cosa si può dire delle persone? «Era tanto buona, aveva gambe molto belle. Morì per lei».
«Per i miei genitori tuo nonno era una persona speciale» proseguì. Dicevamo sempre: «Avrumche non è un amico, è come un fratello».
Ero così aduso a pensare a mio nonno soprattutto come a uno Jäger, come membro e poi capo di quella famiglia scontrosa, inquieta, dagli atteggiamenti istrionici, segnata da un destino tragico, che fu sorprendente apprendere che avesse avuto amici intimi, relazioni con persone al di fuori della cerchia familiare, nelle quali aveva suscitato tanto affetto e dedizione.
Yona annuì. «Ai tempi d’oggi non si può comprendere un’amicizia come quella» affermò, guardandomi fisso.
Annuii a mia volta. Anche se non capivo esattamente cosa intendesse, non mi sorprendeva che le amicizie tra abitanti di Bolechow, legami forgiati in una civiltà e in un impero scomparso con il primo conflitto mondiale fossero, come tutto ciò che riguardava Bolechow, irrecuperabili.
All’improvviso sorrise. «Tuo nonno era un vitzer, sai cosa significa?».
Annuii di nuovo. Sì, lo sapevo. Un provetto narratore di barzellette, abile tessitore di storielle divertenti. Pensai a mia zia Ida che se l’era fatta addosso per le risate, il giorno della festa del Ringraziamento di mezzo secolo fa; e a come mia nonna esclamava: «Oh, Abie!».
«La tua famiglia viveva nella Schustergasse» continuò. Via dei calzolai. Quel piccolo dettaglio era interessante; ero stato in quella casa, ma non conoscevo il nome della strada. SCHUSTERGASSE, scrissi sul retro del foglio di carta che faceva da sottopiatto.
Mi lanciò un’occhiata. «Prendi appunti?».
Annuii. «È per la storia di famiglia!». Avvertivo una certa diffidenza in quel suo modo di parlare a voce bassa; era gelosa della sua vita privata. Fece una smorfia, ma continuò a farmi partecipe dei suoi ricordi. Parlò del padre, il cui nome era Sholem, emigrato a Vienna nel 1916 in cerca di lavoro, per mantenere la famiglia. Vi si trovò bene; era appassionato di musica. La sua famiglia aveva un negozio di generi alimentari. «Erano tempi duri» commentò.
Sorrisi. «Ricordi qualche altro particolare riferito dai tuoi genitori sulla famiglia di mio nonno?» domandai. Speravo potesse riferirmi qualcosa sul padre di mio nonno, il gentiluomo facoltoso, con il pizzetto e il cappello di feltro, morto in una località termale, il disastroso evento che aveva determinato il trasferimento a New York di mio nonno e anche di Shmiel, che però preferì tornare a Bolechow, e in ultimo persino il mio viaggio in Israele.
Yona scosse il capo. Di Elkune Jäger non sapeva niente.
«Ma mi risulta che la famiglia di tuo nonno fu sempre molto povera» se ne uscì.
«Povera?» La guardai. «Molto povera? Sempre?».
annuì. «Sì. Mio padre raccontava che da bambino andavano a villeggiare a Zakopane, in Polonia, e lui era triste perché Avrumche era troppo povero per andarci».
Riflettei per un momento, quindi spiegai: «Sapevo che se la passavano male dopo la morte del mio bisnonno, e poi venne la guerra...».
Scosse la testa, e con una scrollata di spalle ribadì:«Anche quando erano piccoli».
Ripensai alle storie raccontate da mio nonno. Le descrizioni del padre, un prospero uomo d’affari, un uomo influente in città; le bottiglie di Tokaj che portava da Vienna; la domestica ucraina quand’era bambino, la cuoca che cucinava a ognuno di loro la sua piccola challah, il venerdì sera. Non misi in dubbio la veridicità di quei racconti, ma ascoltando le rivelazioni di Yona su quanto fosse stata disperatamente povera l'infanzia di mio nonno, non potei fare a meno di chiedermi, ancora una volta, quanto fossero basate sui fatti le storie di mio nonno e quanto invece fossero il frutto della sua fervida fantasia. Non è una novità che un bambino, rimasto orfano di padre ad appena dieci anni, con il tempo ne ingigantisca il ricordo, ne ammanti la figura di un fascino,di una statura, di una ricchezza che forse non aveva, perché nel difficile momento della crescita questa distorsione della memoria – che negli anni si cristallizza infatti e in storie da raccontare ad altri, come me – permette al ragazzo di avere una migliore opinione di sé. «Un tempo eravamo qualcuno» si ripete, «eravamo una famiglia speciale». In questo modo le difficoltà della vita paiono al ragazzo come un banco di prova di quella tempra, di quell’innata superiorità che caratterizzava il defunto padre, sempre più relegato nel passato. La ricchezza, la posizione sociale, la considerazione con le quali il giovane, divenuto adulto e uomo d’affari di successo, arricchisce il ricordo del genitore scomparso, nei racconti di cui è protagonista, dopo tutto sono solo l’espressione esteriore di quella superiorità. Non sempre le storie che narriamo sono resoconti di quel che accadde, non di rado sono la proiezione dei nostri desideri, la giustificazione inconscia di un’esistenza ormai perduta. Eravamo ricchi, avevamo la domestica. Lei era una sionista, lui era il mio preferito. In fondo è solo nei racconti che i contorni delle vicende appaiono ben definiti, e solo in essi anche il più piccolo dettaglio si incastra al posto giusto. E in fin dei conti, se collimano troppo perfettamente, probabilmente mettiamo in dubbio la loro veridicità.
Riflettevo su tutto questo, cominciavo a interrogarmi sull’identità della mia famiglia, quando arrivò il conto. Yona insistette per pagare; dopo qualche doverosa protesta, acconsentii. Erano circa le due e il sole era infuocato. Mi costringeva a tenere gli occhi socchiusi.
«Hai sempre avuto occhi così azzurri» notò, contemplandomi il viso, mentre aspettavamo il resto. Sorrisi. Prima di lasciarci ci scambiammo indirizzi di casa, email e numeri di telefono.
«Yona» dissi tutto impacciato, mentre appuntavo i suoi dati su un tovagliolo di carta, «è così imbarazzante».
Mi lanciò uno sguardo interrogativo.
Avevo scritto solo il suo nome. La guardai e spiegai:«Mi accorgo solo adesso, dopo tutti questi anni, di non conoscere il tuo cognome».
Sfoderò il suo caratteristico sorriso, e con un’impercettibile scrollata di spalle disse: «Wieseltier».
Questo accadde in estate. Sul finire dell’autunno tornai a Tel Aviv con Matt, e lui poté scattare le sue foto a Yona e a tutti gli altri. Ma Israele fu la seconda tappa del viaggio. Prima eravamo andati a Stoccolma.

Il racconto delle peregrinazioni di Abramo per giungere nella Terra Promessa è una storia di accrescimento: del territorio, della discendenza, della ricchezza (e, presumibilmente,anche della conoscenza). La ricchezza accumulata da Abramo, derivante dalla lucrosa permanenza in Egitto, in ultimo causa uno screzio tra i suoi pastori e quelli di suo nipote, Lot;per evitare il conflitto Abramo e Lot concordano di separarsi e stabilirsi in territori diversi, il nipote rivendicando le pianure a est del Giordano (territorio ove sorgono le famigerate città di Sodoma e Gomorra), e lo zio il territorio a ovest del fiume. Ma Abramo è interessato a un altro tipo di crescita,anche dopo essersi stabilito nella terra a lui assegnata. Dopotutto, Dio gli promette di continuo che sarà fecondo e la sua prole numerosa come la polvere e le stelle. Eppure Sarai, la bellissima moglie, non gli ha ancora concepito un figlio. Così all’abbondanza si accompagna la penuria. Abramo, consapevole del paradosso, a un certo punto si lamenta aspramente, chiedendosi a che pro possedere tutte quelle ricchezze quando saranno degli estranei a ereditarle. Il problema sembra risolto quando Sarai gli offre la sua schiava egiziana,Agar, dicendo: «Forse potrò avere prole da lei». Abramo acconsente – per quanto si creeranno delle tensioni tra i coniugi – e dall’unione nasce Ismaele. Tredici anni dopo, quando Abramo ha novantanove anni e Sarai ottantanove, Dio annuncia che l’anno seguente la moglie gli darà un figlio. Naturalmente il patriarca apprende la notizia con una certa incredulità, si prostra, letteralmente, fino in terra e ride. A tempo debito il figlio nasce, e il nome che gli viene dato ricorda la reazione del padre alla notizia di quel concepimento: in ebraico infatti Yitzhak significa «colui che ride».
La dinamica della Lech Lecha è, in definitiva, una dialettica tra opposti: accrescimento e penuria, attività e stasi, sterilità e fertilità, e – come sempre nei racconti di viaggi avventurosi – solitudine e moltitudine, da un lato il romitaggio del viaggiatore, dall’altra l’enorme confusione dei luoghi in cui transita che egli sente estranei. A mio avviso, questa continua tensione tra forze contrarie, questa tormentata dinamica significativa (metafora del nostro desiderio di possesso, di accumulare sempre di più man mano che la nostra esistenza si snoda, ma col timore che l’arricchimento ci faccia smarrire la nostra identità e dimenticare il nostro passato) è espressa in maniera ancor più concisa ed elegante verso la fine della Lech Lecha, quando Dio promette al quasi centenario Abramo un figlio e una progenie. Simbolo di questa nuova condizione di padre di grandi nazioni, Abramo beneficerà di un altro accrescimento: il suo nome acquisterà una sillaba e diverrà «Abrahamo». Anche il nome della moglie muterà, da Sarai a «Sara». Riguardo al cambiamento dei nomi sono state fornite diverse spiegazioni. Rashi si crea non pochi problemi per argomentare come l’ebraico Avraham può, infatti, essere interpretato secondo l’intenzione di Dio, cioè una contrazione di Av-hamon, «padre di moltitudini». La «r» di Avraham, che non compare in Av-hamon, pone una difficoltà che Rashi come al solito risolve con sorprendente ingegnosità. Similmente, Rashi si sofferma a lungo sull’elisione della «i» finale del nome Sarai, una volta che questa è divenuta Sara, perché l’eliminazione di una lettera nel nome di una persona giusta è considerata un insulto (ma per Rashi ciò non costituisce un problema: l’ultima lettera del nome ebraico Sarai fu, come ci viene detto, in seguito aggiunta al nome dell’eroe Hoshea, che quindi rinasce come Joshua).
Per quanto trovi ingegnosa e appagante questa spiegazione, ritengo più convincente l’interpretazione di un altro commentatore (non Friedman, che non si sofferma su queste modifiche dei nomi), il quale argomenta che il significato del processo di accrescimento del nome è da ricercarsi non tanto nel suo significato quanto, in senso più ampio, nel fatto che,accettando il patto con Dio, Abramo deve assumere un nome nuovo, proprio come i sovrani quando salgono al trono. Si tratta di una spiegazione più psicologica che filologica. Avendo una notevole familiarità con le varie vicissitudini cui vanno incontro i nomi, trovo calzante questa interpretazione: so bene come si possa desiderare di cambiare il proprio nome,per operare in tal modo una necessaria cesura con il passato,ma anche come sia importante che il nome sia identificativo,poiché non sempre appare chiaro cosa valga la pena conservare del passato.
11 «Vorrei vorrei/ o come vorrei/ vorrei ancora essere/ una fanciulla/ ma una fanciulla/ mai più sarò/ fin quando mele/ spunteranno dall’edera» (N.d.T.).
12 «Oh, fate grande la mia tomba/ larga e profonda/ mettete una lapide di marmo/ alla testa e ai piedi/ e nel mezzo/ una colomba/così che il mondo sappia/ che sono morta per amore» (N.d.T.).