3. Ireneo e Tertulliano

Mosaico, II sec., Loupian (Francia),
Villa gallo-romana
3.1 Ireneo di Lione e la critica allo gnosticismo
Attivo nella seconda metà del II secolo, il vescovo Ireneo di Lione sviluppa il suo pensiero teologico attorno a due nuclei concettuali fondamentali: la verità della fede cristiana e la comprensione del mistero di Dio. Secondo Ireneo l’uomo è per natura chiamato alla comprensione della verità rivelata, condizione imprescindibile per acquisire la conoscenza di Dio. In una delle sue opere più importanti, l’Adversus hae-reses (Contro le eresie), Ireneo afferma che il compito di manifestare la verità su Dio si può realizzare soltanto se ci si impegna parallelamente nella confutazione delle dottrine che non sono conformi a ciò che è rivelato dalle Sacre Scritture.
La conoscenza di Dio
Pur senza sminuire l’alterità e trascendenza di Dio e affermando la radicale differenza che separa Dio, increato e creatore, dall’uomo, creatura fallibile, che tutto riceve da colui che l’ha creata, Ireneo polemizza con le posizioni degli gnostici e afferma che l’uomo è in grado di conoscere Dio e che questa possibilità è una diretta conseguenza del suo amore per l’uomo.
Nella storia umana si compie inoltre una progressiva rivelazione di Dio che ne procura una conoscenza reale e sostanziale. Nella teologia di Ireneo è infatti centrale la riflessione sul cosiddetto “ritmo trinitario della verità”. Questa espressione viene utilizzata da Ireneo per sostenere che la rivelazione di Dio e la storia dell’uomo sono segnate dal dinamismo del rapporto tra le persone della Trinità. La rivelazione è concepita da Ireneo come un percorso formativo all’interno del quale l’amore di Dio si pone come condizione e principio propulsore per la conoscenza di Dio stesso e per la comprensione dei misteri rivelati.
TESTO
T5 : Ireneo di Lione, L’uomo e la gloria di Dio
TESTO
T6: Ireneo di Lione, La crescita dell’uomo
Il creato
Secondo Ireneo il creato è l’esito della libera iniziativa di Dio, principio assoluto di tutto ciò che esiste, volontà e materia da cui tutto trae origine. Nel processo della creazione, come nella storia, si manifesta il dinamismo trinitario: Dio crea da se stesso, assistito dal Figlio e dallo Spirito Santo (che sono le “mani” di Dio).
Reagendo contro l’idea che la perfetta gnosi (penetrazione intellettuale della fede in tutta la sua ampiezza) consista nell’apprendere che il Padre è inafferrabile e incomprensibile, Ireneo afferma che fare theología significa penetrare nel mistero di Dio, che ci dà vita e conoscenza. La storia rappresenta lo scenario ideale in cui Dio si fa conoscere instaurando con l’uomo un legame sempre più intenso. La verità cui attingere attraverso il confronto con i misteri divini si identifica ovviamente con la fede cristiana e viene diffusa dalla Chiesa, che l’ha ricevuta direttamente da Dio. Luogo della verità, la Chiesa è frutto dell’azione rivelativa di Dio e rende possibile all’uomo percepire Dio in modo adeguato. La comunione con Cristo e la presenza dello Spirito Santo fanno della Chiesa il luogo in cui si attualizza nella storia il rapporto con Dio.
3.2 Tertulliano e il rapporto tra religione e filosofia
Tertulliano nasce a Cartagine attorno al 165-170, e si nutre della cultura classica dell’epoca. Tertulliano conosce il greco e può leggere gli apologisti cristiani del II secolo, impegnati nella difesa dell’ortodossia cristiana contro opposizioni esterne, e Ireneo di Lione. Ha inoltre una solida cultura filosofico-giuridica.
Tertulliano si prefigge quale obiettivo prioritario quello di difendere la verità della fede dagli attacchi degli eretici. Tale difesa viene sostenuta in uno dei suoi scritti più celebri, l’Apologetico. In esso Tertulliano assume un atteggiamento di sostanziale rifiuto della cultura pagana. Nei primi secoli dell’età cristiana, infatti, la storia dei contatti tra filosofia e cristianesimo è inizialmente soprattutto la storia di una reciproca incomprensione. Il caso di Tertulliano è particolarmente significativo per approfondire le motivazioni di questa marcata presa di distanza dalla filosofia.

Scena sacrificale dal Santuario di Saturno di Jebel Boukornine, presso Cartagine, 195 ca., Tunisi, Museo Archeologico di Cartagine
I Padri cappadoci
Basilio
Nasce a Cesarea di Cappadocia, regione storica dell’Anatolia (oggi in Turchia) in una ricca e influente famiglia cristiana, attorno al 330. Ritiratosi nella comunità monastica di Annisi, Basilio compone insieme all’amico Gregorio di Nazianzo la Philokalía, un’antologia tratta dalle opere di Origene. Pochi anni dopo scrive la sua opera teologica fondamentale, Contro Eunomio, in risposta al vescovo di Cizico che sosteneva una concezione trinitaria secondo cui il Padre aveva creato il Figlio senza trasmettergli la propria stessa sostanza. Il Figlio risultava quindi “diverso” dal Padre. La risposta di Basilio è chiara: Padre e Figlio hanno una sostanza comune, mentre la diversità dei loro nomi riflette semplicemente proprietà particolari che non influiscono sulla loro consustanzialità. Qualche tempo dopo Basilio si trasferisce a Cesarea, di cui diventerà vescovo attorno al 370. In questo periodo compone L’orazione ai giovani. Qui descrive la maniera corretta di avvicinarsi alla cultura profana, da utilizzarsi (mantenendo comunque un occhio critico) come esercizio propedeutico alla lettura dei testi sacri, cardine della paidéia cristiana.
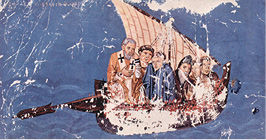
La fede ortodossa contro l’arianesimo, miniatura su pergamena, 880 ca.,
Parigi, Bibliothèque Nationale
Una delle grandi eredità lasciate da Basilio al millennio bizantino è rappresentata dalle “regole” pensate per i monasteri di tipo cenobitico. In esse si distingue una parte centrale, costituita dai precetti etici ripartiti in 80 regole, alla quale si aggiungono il Piccolo ascetikón, dove si trova una serie di “domande e risposte” sulla dottrina cristiana, e il Grande ascetikón, con istruzioni per la vita monastica.
Gregorio di Nissa
Nasce tra il 332 e il 340 circa a Cesarea. Al contrario di Basilio, Gregorio rifugge in un primo tempo la vita ascetica: sceglie il matrimonio e la carriera retorica che era stata del padre. Ma nel 372 Basilio decide di nominarlo vescovo di Nissa. Dopo la metà degli anni Ottanta del IV secolo, Gregorio sceglie la vita monastica e si ritira in un monastero basiliano, dedicando il resto della vita, fino al 394, data presunta della morte, all’attività letteraria.
In Gregorio di Nissa si realizza più che mai quella fusione tra “paidéia esterna” (cioè profana) e “filosofia interna” (cioè cristiana), tipica della produzione dei Padri cappadoci. Questa compenetrazione è visibile già dai generi praticati da Gregorio: esemplari a questo proposito la Vita di Macrina e il dialogo Sull’anima e la resurrezione. Nella prima opera, Gregorio crea una sorta di nuovo “romanzo” cristiano, capace di sfruttare e adattare al nuovo pubblico moduli narrativi tipici della letteratura di intrattenimento pagana. Nel secondo, riprendendo lo schema del Fedone platonico ed elementi neoplatonici, cerca di dare un’esposizione organica della psicologia cristiana e del rapporto tra anima e corpo: entrambi concorrono a definire l’identità individuale, tanto che anche dopo la morte e prima della resurrezione il corpo rimane parte integrante dei processi conoscitivi dell’anima e della sua esistenza.
Nel De opificio hominis, invece, Gregorio si confronta anche con lo spinoso tema della creazione del genere umano nella sua totalità, immagine diretta di Dio nel suo aspetto intellettuale, atto destinato poi a perfezionarsi e completarsi nella contingenza delle singole esistenze.
Quanto alla mistica gregoriana, uno dei punti centrali rimane la nozione di epéktasis: si tratta del continuo processo di ascesa dell’anima verso Dio, un processo destinato a non compiersi mai data l’infinità e la non circoscrivibilità di Dio. Va ricordato infine l’imponente sforzo dogmatico dei libri Contro Eunomio, volti a chiarire in senso niceno i rapporti tra il Padre e il Figlio nella Trinità, e composti tra il 380 e il 384.
Gregorio di Nazianzo
Nato a Karbala, in Cappadocia, tra il 326 e il 330, Gregorio di Nazianzo viene cresciuto nella fede cristiana. Nella sua opera principale, i cinque Discorsi teologici, Gregorio rafforza il tema dell’unità e consustanzialità delle persone della Trinità, oggetto del Concilio di Nicea del 325. Il suo discorso teologico, essenzialmente apofatico, è fondato sulla convinzione che l’essenza della divinità sia inconoscibile dalla ragione discorsiva o con i mezzi dialettici. Un’altra parte consistente dei Discorsi è consacrata all’esposizione della dottrina della consustanzialità nicena, e riprende la distinzione basiliana tra sostanza e ipostasi. Gregorio, inoltre, introduce il termine di “processione” per indicare il modo in cui lo Spirito Santo proviene dal Padre, pur senza esserne generato come accade per il Figlio: una terminologia che avrà grande fortuna nella teologia bizantina dei secoli successivi.
Atene e Gerusalemme
ESERCIZIO
E13: Tertulliano e Ireneo
Egli per primo ha utilizzato il tema della contrapposizione tra Atene e Gerusalemme come punto di partenza del confronto tra la filosofia pagana (simbolicamente rappresentata da Atene, ovvero il mondo greco) e la fede cristiana (il cui simbolo è Gerusalemme, ovvero il mondo giudaico-cristiano, fondato sulla tradizione e sulla Sacra Scrittura). Reagendo contro il paganesimo antico, Tertulliano mette in ridicolo le dottrine dei filosofi che, a suo avviso, spesso giungono a conclusioni in odore di eresia. Nell’opera Contro Marcione, il suo scritto teologico più voluminoso, Tertulliano tenta una confutazione di tutte le eresie, mentre nel trattato Prescrizione degli eretici sviluppa una riflessione molto puntuale circa la trasmissione viva della fede apostolica in seno alla tradizione ecclesiale.
Critico della sapientia saecularis (“sapere mondano”) e della vanitas (“vanità”) della filosofia, Tertulliano non risparmia ai filosofi antichi definizioni infamanti. A Platone, fiero della sua scienza, Tertulliano oppone un qualunque umile “operaio” cristiano, che, una volta trovato Dio, è in grado di farlo conoscere al suo simile testimoniando la propria fede attraverso la sua stessa vita. Sia nell’Apologetico sia ne La prescrizione degli ereticiTertulliano si impegna nella difesa del cristianesimo evidenziando che i cristiani dimostrano con i fatti la loro fede, mentre i filosofi, gonfi di vanagloria, cercano di persuadere più con la parola che con l’insegnamento. Atene è simbolo della sapienza profana, è la linguata civitas (città dell’eloquenza) che ospita l’Accademia e i filosofi, ridicoli osti di sapienza, simili agli eretici e ai ciarlatani perché, spinti da una curiosità malsana, si interessano più delle creature che del Creatore. L’attività del filosofare è viziata dalla pretesa di giungere alla verità prescindendo dalla rivelazione, impresa che, secondo Tertulliano, costituisce una minaccia per la fede.
Tertulliano non va presentato come un cieco irrazionalista: egli non intende ripudiare in assoluto la ragione in quanto inconciliabile con la fede, quanto piuttosto condannare quei filosofi che non sono riusciti a superare il politeismo idolatrico.
L’antropologia di Tertulliano
Tertulliano colloca l’uomo al centro del progetto creativo di Dio. Egli dimostra che le argomentazioni platoniche sull’incorporeità dell’anima sono vane e spiega che l’uomo è un composto di anima e corpo. Anima e corpo non sono due sostanze autonome e separate e il termine homo si può correttamente utilizzare solo per indicare la compresenza di queste due sostanze. Non a caso, nella vita ultraterrena, l’anima potrà essere premiata o castigata soltanto quando, dopo la resurrezione, si sarà riunita con il proprio corpo.
Circa la sorte che attende le anime nel periodo che intercorre tra la loro morte individuale e la retribuzione finale, Tertulliano afferma che alla fine dei tempi Cristo stabilirà sulla terra una Gerusalemme discesa dal Cielo, un regno terreno della durata di mille anni; i giusti risorgeranno per regnare con Cristo, ma la resurrezione sarà scaglionata nel corso del millennio, poiché alcuni dovranno scontare le loro colpe residue in un luogo sotterraneo (carcer, deversorium, inferi). Alla fine del millennio ci sarà la resurrezione di tutti i morti: i reprobi saranno giudicati e condannati, mentre i giusti saranno trasferiti dal regno terrestre a quello celeste.
TESTO
T7: Tertulliano, Apologia della fede cristiana
La nascita della Trinità: Ario e il concilio di Nicea
Uno dei fondamentali problemi che si presentano ai cristiani dei primi secoli è quello di definire in maniera rigorosa il rapporto fra Dio e suo Figlio. Inizialmente, all’interno della Chiesa cattolica, la questione è affrontata elaborando una dottrina che struttura tale relazione su un asse verticale avente ai due vertici Dio e il mondo, e, in posizione intermedia, Cristo, che è inteso come la Sapienza e Parola di Dio, immanente in lui dall’eterno. Secondo tale visione, elaborata nel corso del II secolo, Cristo sarebbe stato generato da Dio prima del tempo, in funzione di reggente della creazione e di mediatore con il mondo e con l’uomo. Questa formula non è però universalmente accettata, perché ad alcuni sembra che essa metta in discussione il concetto dell’unicità di Dio, mentre per altri l’enfasi sulla natura divina di Cristo finisce per lederne la sua umanità.
Sono queste le basi su cui si innesta la riflessione di Teofilo, patriarca di Antiochia, morto intorno al 183. Per Teofilo all’opera creatrice di Dio collaborano sia il lógos sia la sapienza. Ne deriva uno “schema triangolare”, dove al Dio creatore si affiancano appunto le sue “mani”, lógos e sapienza. Uno schema ternario quindi: non a caso il patriarca di Antiochia è il primo autore cattolico a utilizzare il termine “trinità”. Poco tempo dopo, un vescovo di nome Ippolito utilizza per la prima volta il termine tecnico di “persona” per designare il Padre e il Figlio, vocabolo destinato a uno straordinario successo nel lessico teologico. Tra i principali risultati di questo fervore interpretativo può annoverarsi la determinazione della formula di fede della Chiesa romana, il Credo più antico a noi noto.

Sarcofago degli Apostoli del dolore. Particolare, IV sec., Arles,
Musée Départemental Arles Antique
Una tappa fondamentale nel processo di formazione della dottrina trinitaria è costituita dalla cosiddetta “questione dei due Dionigi” – il patriarca di Alessandria e il vescovo di Roma – che ha luogo intorno alla metà del III secolo. In effetti Dionigi di Alessandria si spinge a sostenere che il Figlio sia “creatura” del Padre. A questa formulazione risponde duramente il Dionigi romano, accusando il collega di predicare tre ipostasi separate della divinità, e, di conseguenza, tre divinità. Di fronte a una tale imputazione, l’alessandrino ritratta ciò che ha affermato a proposito del Figlio e dichiara che il Figlio è “consustanziale” al Padre, cioè dello stesso suo genere e della stessa sua natura: si tratta della prima sicura attestazione di questo termine fondamentale nell’ambito della teologia trinitaria.
Ario, prete sovversivo
Intorno al 320 la pace della Chiesa stabilita da Costantino con il suo editto di tolleranza del 313 viene turbata da una controversia destinata a sconvolgere in breve tempo l’intera oikouméne cristiana. Tutto comincia quando un presbitero (membro anziano con incarichi di responsabilità all’interno della comunità locale) di Alessandria, di nome Ario, giunge ad affermare pubblicamente che il Figlio/lógos divino è estraneo alla sostanza (in greco ousía) del Padre e non coeterno a lui. Il Figlio/lógos, che secondo Ario si è incarnato ma non fatto uomo, è dunque Dio in quanto creatore, ma di una divinità diversa e inferiore, subordinata a quella del Padre. In un dibattito tenutosi in presenza del patriarca Alessandro e del clero cittadino, la dottrina ariana è sconfessata.
Ario però resta fermo sulle sue posizioni: di conseguenza viene scomunicato e la sua dottrina condannata. In poco tempo, tutto l’Oriente cristiano è coinvolto nella polemica fra i due partiti, quello favorevole ad Ario e quello a lui contrario.
Il concilio di Nicea e il Simbolo niceno
Il concilio di Nicea (maggio-giugno 325), primo concilio ecumenico della storia della Chiesa, è convocato e presieduto dall’imperatore Costantino in qualità di “vescovo dei laici”. Costantino invita a Nicea tutti i 1800 vescovi della Chiesa cristiana. Tuttavia, solo da 250 a 320 vescovi sono in grado di prendere effettivamente parte ai lavori.
Il punto cruciale è ancora una volta legato al problema cristologico: com’è possibile, da un punto di vista razionale, che il Cristo/lógos patisca la Passione e “senta” la Resurrezione? E, d’altra parte, quali sono i rapporti fra Cristo/lógos e l’unico Dio?
A Nicea, il concilio ecumenico condanna definitivamente Ario e stabilisce il cosiddetto Simbolo niceno, una formula di fede che, integrata con quella di Calcedonia del 451, è ancora oggi il principale punto di riferimento dottrinale della Chiesa cattolica. Nelle deliberazioni conciliari, al concetto ariano del lógos “incarnato ma non fatto uomo” si oppone il concetto del lógos “incarnato e fatto uomo”, e quindi all’idea di Cristo come “fattura e fondazione” di Dio si sostituisce quella di Cristo unigenito “generato, non fatto”, coeterno al Padre e consustanziale a Lui. Si aggiunge poi il “credo” nello Spirito Santo: in questo modo, il dogma trinitario è chiaramente e stabilmente formulato.