EPISTULA AD ANDREAM ZANZOTTO POETAM
Non numquam miratus eris quod verba sepulta
nunc etiam valeant vivaces condere versus
quae in longa videas aevi siluisse ruina.
Quamquam lingua natali saepius usus,
ut nostros versus facerem, tamen ipse aliquando
alterius veteris capior sermonis amore
et nobis chartis stupeo haec florescere verba
longum post aevum verno quasi tacta tepore
ceu genus exstinctum florum mirabiliter quos
rursum prodiderit tellus, ut lilia rubra
quae tacitis olim ridebant vallibus, usque
dum nimias hominum perierunt passa rapinas.
Et cum mirificos videor tibi carpere flores,
tum quasi praeteritum dicas me quaerere tempus;
quin laetus densas aevorum mersor in umbras
haec ubi verba velut tremulae lampyrides ardent
huc illuc nantes tenui per inane volatu:
illis, ut caelum stellis, scatet alta vorago
annorum. Placuit faculas includere pugnis
aligeras et item verborum praedam agere auream.
Me puerum memini (iam me de more vocabat
vespere mater, erat dormitum tempus eundi
ac vellem nollem linquendi prata iocosque)
bestiolas raptim capere atque includere deinceps
ampullam in vitream quam rebar lampadis instar
ut iuxta tacitum lucerent nocte grabatum.
His cum perparvis percurrimus avia lychnis
antiquos his cum verbis exquirimus annos
cum caela humanis rebus propiora nitebant
maioresque hominis subsultim parvulus anthus
aequabat passus nil territus illius umbra.
Tum deinde, ut nosti, nobis gens ferrea venit
et silvae ac montes stupuere fragore viarum.
Nunc ubi terrarum voces, si audivimus unquam?
Forsan quae matris tener infans mussat in ulna
vel puer, ut dormit, nigris balbutit in umbris
(in somnis sibi visus adhuc librare per auras
e chartis pictis milvum), purissima credas
cuiusdam saecli longinqui verba perempta
quo raucum ex illis aliquando murmur aquarum
percipias volucrisque palustris mane querelam.
Aures dede, sonos terrarum adnosce vetustos
cum fuit horrendus mundus sed vivere dulce.
Vocibus infractis puerorum et versibus aurea
aetas te affatur: recolit qui carmina scribit
aetates priscas cum verba virentibus unus
iunxit rebus amor ac floribus astra iugavit.
At nunc innocuas si vis cognoscere terras
occulto tetraone sonans subeundus erit mons
sanguineis rubi laete spineta rubebunt
et nemus aureolis spargit myosotis ocellis.
Ut quaeram intactum regnum quandoque in opacis
saltibus ingredior quos vesperis alluit aura
miror et afflatas occasus lumine quercus:
aethera proceris ramis temptare videntur.
Adnosco veteres sub venti murmure terras
brachia tendentes caelo ex quo ducimus ortum.
Atqui animo nostro cum quercubus es amor unus:
tamquam divinus quidem sub pectore nobis
dormierit genius subitoque expergitus ultro
incipiat fari post longa oblivia rerum,
ecce revirescunt verborum saecla sepulta.
Nescio quo rapido momento verba renata
florum ut fasciculos in amata poemata cogo.
Quid nostra refert linguam periisse latinam?
Ut nitet in silvis antiqua pueritia mundi,
antiquae sic linguae hominum tibi nonne videntur
murmur inextinctum tacito sub corde manere?
Nos contra mortem contendimus atque silenter
illi intercipimus dominatus particulam atri,
reddimus in lucem praesens miretur ut aetas.
Condidit Arthurus Rimbaldus et ipse latina
carmina, quinque decem minor annis cum puer esset.
Tum nondum laceris sulcaverat Ebria Navis
Oceanum velis, nondum iactata per undas,
amisso clavo et nautis nulloque regente,
visa erat in nimbo se ornare volucribus alis.
Hoc quotiens memini mirum legisse poema!
atque, ut qui vigilans sibi somniet, ultima rerum
litora sub lucem vidisse et polline fetas
orchitas avibusque novis aurescere caelum!
Attamen egregie iam tum puer ille latine
cantabat: Longis fessus erroribus artus
deponens, iacui viridanti in fluminis ora
Ecce per aetheriam vallem incessere columbae,
alba manus, rostro florentia serta gerentes…
Nonne eadem in somnis aspexit Horatius olim
dum puer umbroso tranquille in Vulture dormit?
Unam igitur videas, Andreas, esse poetis
omni aevo matrem. Quin te, quamquam uteris usque
aetatis nostrae lingua cum carmina pangis,
suaviter hic illic verba inseruisse latina
deprendo veterisque adnosco messis odorem.
Sed vis hanc linguam pro mortis imagine habere
ut quae nusquam alibi, pictis nisi sub Linnaei
floribus exstiterit cum facta est muta vel atrum
significet nomen transfixi papilionis;
hanc veterum censes hominum quasi perpetuare
aetheris horrorem, physici quod caeca elementa
tractarint mundi tali sermone priusquam
algentem tetigit caelestis naucula lunam;
hac doctos portenta ais usurpare ferarum
obruta diluvio siccatas atque lacunas
Phoebes et Martis stellae rutilantia tesqua.
Attamen unde novam tua ducere carmina lucem
dicas, intersint si quando verba latina?
Unde hanc mollitiam? Num morti talia debes?
Antiquae enodant tibi musae nomina rerum
dum vim verborum radice exhauris ab alta;
sic agit infernos fontes qui rure requirit:
si intremuere manus sinuantes rite bacillum
scit quibus ex imis possit scaturire aqua venis.
Nec dubitare aliquid tibi, dulcis amice, negabo
omnia cum videam trepido in maerore iacere,
at latiam linguam pacatus temperet ordo.
Nonne hanc contemnant homines habeantque alienam
quae adversas rerum semper neglexerit undas?
Non suevit variare diu neque lege deerrat
a prisca hic sermo multo iam tempore mutus,
non ullis vicibus neque sorte inflectitur ulla.
Aequum animum praebet veteris non immemor aevi
si, ut nos affetur, risu petiit secretum:
ut Sphynx quae steriles Aegypti servat harenas.
Sed nos non famae contiget grata corona.
Quaeremus laurum nec non fragilem tamericen
et nos aspiciet nemo: ceu vespere tegmen
alarum reserans lucanus deserit ulmum,
caelo diffusum procul inde abscedit in aurum.
Non nostros nomen vulgabunt acta diurna,
nostra notis frontem signata poemata rubris
in nulla aspicies docta prostare taberna.
En noster Lebedus, tibi mitto hinc pauca serenus,
non avidus laudis, vanorum oblitus honorum
ut si me accipiat sub odoratis favus umbris:
has malo latebras ubi mel mirabile lucet.
Sed miseris aliquid potuit contingere vicis
(grande novumque aliquid quamvis pro nilo habeas tu)
alque aliquid laetum minimus promittere casus.
De quodam referam tibi vico ignobile cuius
nomen deest tabulis… Fuerat felicior olim,
sed veterem pauci servabant pascua sedem
in celebres urbes cum iam plerique migrassent.
Falx ubi fenisecae nuper bis fulserat anno
tum vento caput herba dabat non tonsa sereno.
Et iam desertam tacitamque sciurus habebat
versutus silvam: non, laeto dente sub umbra
dum rodit nuculam nudatam cortice duro,
pavit in aridulo crepitantem sarmine passum.
Tum domulam obtinuit sibi phoenicurus inanem
ponere et assuevit vetere in sartagine nidum.
Paucis iam pueris, ludorum voce sonabant
areolae raro; vetulorum maior erat grex
frontem sulcatam rugis et cana moventum
tempora: sed cuinam tremulum caput annueret?… Cum
a tergo montis clivoso limite quidam
venerunt homines robusto corpore adusti
(nescio si fabri reparatoresque viarum)
armaque parietinis florentibus admoverunt.
Ibant a pedibus tenuatae longius umbrae
declinante die. Quinam quaesivi ego et unde
essent, cur misera haec venissent bucita visum.
Unus ad haec: «Sursum deorsumque opus ire ut ad istos
vicanos venias!». Risere. Acalanthis ab horto
ut quaedam si quassaret crepitacula risit.
Et dum mecum animo iocularia dicta voluto
hinc inde egreditur passim vicinia tectis.
Se hospitibus timida circumfudere corona
cumque illis tempus vario sermone terebant
et vicis nostri reliquis tandem exhalabat ab ore
nescio qua causa persuave et amabile lumen.
In clivo mulier dabat auris lintea lota
exsiccanda procul ventoque inflanda quieto;
et silva in tacita dulcis quam deinde puella
conveni ex solito mihi nux est lactea visa,
praecoquis, intacta… Noctescere coeperat. At quis
ad nos hunc solem tulerat feriasque inopinas?
Quam pridem croceum suspensa crepuscula lumen
spirabant?
Iuga perlustro clivosque supinos
si assint illi iterum. Video sub fine diei
effugere ut quadam rerum novitate paventes
nigros per resonas valles et pascua corvos.
Ast ignoti homines, iucundo vespere visi,
hunc in secessum numquam rediere silentem.
EPISTOLA AL POETA ANDREA ZANZOTTO Ti sarai certo stupito che parole sepolte / sotto mute rovine di secoli / possano rivivere e farsi poesia: / dormono un duro sonno letargico esse, lo so, / e a me più agevole è far versi nella mia lingua madre; / ma ecco che mi prende questo amore per l’altra, il sermone antico; / e allora accade come se da un’humus profonda, / sbocciata nelle mie carte al tepore d’una primavera, a tratti / di nuovo rinverdisca la lingua del Lazio, / e una stirpe di fiori già estinta prodigiosa esprima la terra / (penso ai gigli che rossi ridevano nelle nostre convalli, / estinti ormai dalla rapacità degli umani). / E come mi vedi perdermi dietro fiori perduti / così un istinto di morte ti parrà il mio latino. / Ma io, in queste ombre fitte di secoli, con che voluttà mi ci immergo, / in traccia di parole, come baluginio di lucciole erranti nel buio: / o stelle, sperse nel tempo, per gli abissi del cielo. / E proprio come trepidando tenevo nel cavo del pugno l’esserino volante, / con la stessa gioia m’approprio l’aureo splendore di quelle remote parole. / Bambino, mia madre a sera soleva richiamarmi a casa / e riluttante lasciavo i miei bei prati e i giochi giocondi; / allora. catturata qualcuna di quelle bestiole, di nascosto, ricordo, / le custodivo in una bottiglia, fantasticando che a guisa di lampada, / mi potessero far lume presso il lettino. / Come si andava per sentieri in compagnia di queste vive fiammelle, / così con quelle parole abbiamo risalito le distese degli anni, / nell’età favolosa, allorché i Cieli splendevano prossimi alla terra, / e per nulla impressionata dall’ombra dell’uomo, / seguiva a saltelli la cutrettola imperterrita i suoi passi giganti. / Poi è sopraggiunta, lo sai, della gente dal cuore di ferro, / capannoni hanno invaso le attonite campagne, / e monti e selve stupirono al fragore inaudito delle strade. / Ed ora, dove trovare più le voci terrestri, che pure tu hai ascoltato? / Eppure, chi ciangotta ancora in braccio alla madre / e la parola detta in sogno dal bimbo (egli che vede il nibbio uscire dal foglio e spiccare il volo…) / sia il favellare indistinto dell’acqua, e i lai dell’uccello palustre sul fare dell’alba, / non ti sembrano messaggi d’un’altra vita? / Ascolta: ancora puoi afferrare le terrestri voci, quando / terribile era il mondo, ma dolce la vita. / Nel balbettio dell’infante, come nei versi, si schiude / all’oggi un’età senza tempo. Attinge chi fa poesia / l’Origine, allorché Amore accoppiò i nomi / alle cose, quando tutto era pieno di senso. / Ma, purché tu voglia, puoi fare ancora esperienza di terre illese: / basta salire sui monti dove cova non visto il gallo cedrone, / e di more sanguigne rosseggiano ispidi i rovi, / e nelle radure occhieggiano teneri i miosotidi: / in cerca d’un mio intatto regno in pendii già in ombra, / che il fiume della brezza trascorre, attonito / vedo talora querce ancora accese di luce divincolarsi nell’aria. / E nel fremito del vento mi par sia la terra stessa / ad anelare così al cielo da cui tutto proviene. / Ebbene nell’animo nostro non diverso dalle querce sta quest’amore: / è come se un qualche spirito divinatore ci dorma in petto, e destatosi inaspettato / dopo lungo silenzio prenda a dar nome alle cose: / ed ecco rivivere in me parole da secoli estinte, / e come in trance mi trovo a stringerle in versi, appena fiorite. / Che importa a noi se sia morta la lingua latina? / Guarda il bosco: non vedi vivere in esso adolescente ancora la terra? / E non senti che ti sale al cuore, se tace, un murmure senza fine, / ed è la lingua antica degli uomini? / Noi poeti lottiamo in silenzio contro la morte, / portiamo via qualche particella al suo atro regno, / su, verso la luce, perché l’età presente ne goda. / Anche Arthur Rimbaud, non ancor quindicenne, compose versi latini: / non solcava ancora l’oceano con lacere vele il suo Bateau ivre, / battuto dalle onde, perduto il timone, e vuoto ormai di equipaggio, / impavesato nella tempesta d’uccelli marini. / Oh quanto volte ricordo d’aver letto il suo meraviglioso poema! / Ma pure, ogni volta, come in un vigile sogno, / ho visto profilarsi nel mattino un’incognita terra, / e d’orchidee gravi di polline, e d’uccelli mai visti farsi aureo il cielo! / Pur fanciullo, come splendidamente sapeva Rimbaud il suo latino! / … Longis fessos erroribus artus / deponens, iacui viridanti in fluminis ora … / Ecce per aetheriam viam incessere columbae, / Alba manus rostro florentia serta gerentes. / Non son le stesse colombe che sognò Orazio fanciullo, dormiente / sulle pendici del Vulture ombroso? / Una, lo vedi, Andrea, è, in ogni tempo, la madre dei poeti. / Forse che, pur componendo tu nella lingua più moderna, / non vi trovo inserite qua e là voci latine? / Vuoi che del vecchio miele non sappia riconoscere il profumo? / Ma tu pretendi che questa lingua sia morta, come / non ne fosse mai esistita una diversa / da quella che fa da didascalia ai fiori di Linneo / – ora anch’essa muta –/ o che solo serva ai naturalisti / per designare il triste nome delle farfalle trafitte. / Forse pensi che, perché i filosofi d’un tempo che fu / in lingua latina vaneggiarono sui quattro elementi / si perpetui, usandola oggi, quasi il terrore superstizioso del cielo, / prima che una navicella spaziale approdasse sulla gelida luna: / portento ben maggiore, tu dici, della scoperta dei mostri estinti in antiche catastrofi, / o delle essicate lagune lunari e dei deserti della rosseggiante stella chiamata Marte. / Eppure, donde dirai che nuova luce sprigionino i tuoi carmi, / se vi si mescono tante voci latine? E a che altro si deve la loro morbida dolcezza? / saresti dunque debitore di tali prove ad una lingua morta? / Ma sono le antiche Muse a svelarti la proprietà di quei nomi, / quando attingi da radici profonde la forza d’una parola. / Non altrimenti il rabdomante vagando per i campi, / se le sue mani protese avvertano il sobbalzo della sensitiva forcella, / sa che lì sotto corrono vene d’acqua pronte a scaturire. / E questo almeno, dolce amico, non lo saprai negare, / che mentre si fa così ansiosa e confusa la nostra vita, / nella lingua latina trovi intatte riserve d’ordine e di calma lucidità. / E non sarà che gli uomini l’hanno messa da parte come un’estranea, / proprio perchè se ne sta essa in alto, sicura sull’incalzare dei marosi? / Da tempo muta, fatta sicura da perturbazioni, immune da umane sorti, / né facile mutevolezza, ormai, né ansia d’attualità / sono più affare suo. / Pure, non immemore di ciò che fu, si conserva discreta, / se, per parlarci, come la Sfinge insonne, guardiana dei suoi deserti, / ci richiede sorridendo la solitudine. / A noi, che così spesso in latino verseggiamo, / non tocca corona di durevole alloro né di tamerice effimera: / al tramonto sfrecciano sull’olmo ombre d’ali, / poi dileguano all’alba, nell’oro effuso del cielo: / così di noi non s’accorge nessuno; / i giornali ci ignorano, nelle librerie i nostri nomi vengono relegati in un angolo. / Ma qui è il mio Lebedo, di qui ti mando queste poche cose, sereno, / non avido di elogi, dimentico di beni vani, / purché un favo mi attiri sotto ombre odorate, / mi piacciono di più questi verdi eremi, dove traluce mirabile il miele. / Eppure, seppur tu lo spregi, sappi che qualcosa di nuovo e di alto / può accadere anche in questi paeselli sperduti, / e qualche pur minimo caso può portare un evento lieto. / Ti narrerò d’un oscuro villaggio, il cui nome non entra nelle cronache, / un tempo più fortunato, ma ormai pochi abitanti si prendono cura dei campi, / la gran parte è migrata nelle città. / E dove la falce fienaia soleva brillare due volte all’anno, / ora il vento spettina l’erba intatta, / e nella selva, deserta e ormai silenziosa, regna lo scoiattolo saputo: / ora, mentre, spaccata la dura cortice, / si rosicchia al sicuro la sua nocciola, / più non teme improvviso il passo risonante di rami spezzati e foglie calpeste. / E il codirosso lasciò vuoto il suo antico industre rifugio / e imparò a farsene uno in una pentola sfondata: / pochi i bambini rimasti, a far chiasso nelle aie; / ma i più sono vecchi, fronti rugose, oscillanti teste canute: / ma assentono col capo a nessuno. / Ebbene, ecco che un giorno, dall’altro scosceso versante del monte, / giungono uomini prestanti, abbronzati: / non so se fossero costruttori e riparatori di strade; / appoggiarono i loro attrezzi alle macerie fiorite: / pedisseque le loro ombre si allungavano al tramonto. / Chiesi chi erano e donde venivano, e perché, a visitare quelle ca’ perse. / Uno di loro mi fa: «Per venire a trovare costoro bisogna proprio scavalcare i monti»: / risero. Un cardellino dall’orto come uno scosso campanellino / anch’egli rise. / E mentre mi accingo a dire anch’io qualcosa di scherzoso, / ecco che cominciano a farsi vedere gli abitanti: / dapprima esitanti, presero a far corona intorno agli ospiti. / E come quelli indugiavano in vari discorsi, / anch’essi presero a dire la loro, con non so che arguzia soave. / Sul pendio un po’ discosto una donna stendeva il bucato, / che mollemente si gonfiava al vento; fanciulla ancora – intatta precoce mandorla nuda, / più tardi al convegno nel bosco … Faceva ormai sera. Ma chi / ci aveva portato in dono quel giorno e la festa inaspettata? da quanto ormai / continuava a inviarci il suo lume di croco un crepuscolo immoto? \ Percorro i gioghi e i pendii erbosi / se mai quegli uomini si facessero ancor vivi. Sul finire del giorno, / soli, alti sopra i pascoli, lamentosi, neri corvi in fuga passano a volo. / Ma gli ignoti, incontrati in una sera gioconda, / in questo montano deserto mai hanno fatto ritorno. [trad. di Giovanni Pellizzari]
NOTA
La lettera, ovviamente, richiama, nel titolo e nel metro, il suo celebre modello, l’oraziana Ars poetica, esemplare dichiarazione di poetica, appunto affidata alla forma epistolare (la terza del secondo Libro delle Epistolae, ossia il trattato Ad Pisones). Qui il destinatario, a differenza dei patrizi romani, padre e figli, cui s’indirizza Orazio, ricettori inerti agli effetti testuali, è un temibile Andrea Zanzotto, poeta anch’egli, col quale il dialogo a distanza si fa serrato e l’argomentare ad hominem. E, almeno in apparenza, mentre Orazio dà un manuale in versi di poetica normativa, le ambizioni di Bandini sono molto più ristrette: limitandosi a difendere, contro le obiezioni dell’amico, il suo diritto di poetare in latino: o al massimo quello dei pochi e negletti, come lui inclini a far uso poetico d’una lingua inattuale; e tuttavia, per poterlo fare, deve inevitabilmente prender posizione sulla poesia in generale, e sul suo rapporto genetico non tanto col latino, ma con la lingua in generale. Il tema, insomma, è questo: ad onta di ciò che l’amico Zanzotto può pensare, il poetare in latino non è esercizio frigido, ma nasce da un sentimento profondo, una sorta di necessità, e non è diverso da ogni altro poetare.
Qualche osservazione di commento al testo latino e ad alcune scelte di traduzione.
Il riferimento di «Et rus attonitum perubique est aedificatum» (v. 34) è al ‘miracolo economico’ degli anni Sessanta, con un consumo del territorio già devastante.
Ai vv. 36-37 è un’allusione al ‘petèl’ dell’Elegia in petèl del dedicatario (in A. Zanzotto, La Beltà, Mondadori, Milano 1968).
Il gallo cedrone o urogallo (v. 50), oltre che nell’acrocoro sommitale dell’Altopiano dei sette Comuni, nidifica anche nell’alta Lessinia, sul cui confine vicentino Bandini insegnò o soggiornò alcuni anni, nel paesino di Crespadoro.
Per i v. 74 sgg. Va ricordato che in un compito in classe sul tema Sviluppare il soggetto indicato da Orazio nel l’Ode IV del III libro, Rimbaud, collegiale non ancora quindicenne, compose nelle tre ore e mezzo assegnate il poemetto latino dal titolo Ver, qui citato: cfr. Arthur Rimbaud, Œuvres complètes, Gallimard, Paris 2009, pp. 5-7 e 810-812; in B1 (vd. le Note del curatore), ad uso dei giudici del Certamen, Bandini appone la seguente «Adn[otatio] ad vv. 33 et 35: Arthurus Rimbaldus: Arthur Rimbaud, gallicus poeta symbolista; Ebria navis: insigne eius poema c[ui] t[itulus] gallice Bateau ivre». La traduzione dei vv. 83-86 è «stanco per il lungo vagabondare / mi abbandonai al sonno nella riva verdeggiante del fiume… / Quand’ecco giù per la valle, in volo giunse uno stuolo bianco di colombe, / con in becco serti fioriti…»: parole che Rimbaud mette in bocca ad Orazio, dilatando lo spunto dell’ode oraziana.
Per il v. 94 va tenuto presente che Zanzotto adotta, specie in IX Egloghe (Mondadori, Milano 1962) una lingua mescidata col latino: si ricordi la celebre 13 settembre 1968 (Variante), sorta di litania lunare, affollata di latino o di latinismi fidenziani. In merito alla lingua latina come “lingua della morte” per Zanzotto, si veda la puntualizzazione di nel suo Bandini, Zanzotto tra norma e disordine, «Comunità», XXIII, 158, maggio giugno 1969, pp. 78-83, a p. 82.
La traduzione dei vv. 98-100 si è dovuta misurare con un passo non perspicuo.
Lo sbarco della navicella americana Apollo 12 sulla superficie lunare, ricordato al v. 103, avvenne il 20 luglio 1969.
Sulla traduzione del v. 104: sappiamo bene che Marte non è una stella. La scelta di «pianeta» si deve a ragioni metriche.
Il «sed» del v. 124 non è agevole da giustificare.
Su «En noster Lebedus» (v. 136): il giovane Bandini aveva insegnato per anni alle elementari di Chiampo, e ad ogni fine d’anno scolastico anno era inviato nei paesini dell’alta Valle, a presiedere gli esami delle ‘pluriclassi’, talvolta pernottandovi: credo che nell’epistola si alluda a Crespadoro. Lebedus (Λέβεδος era un’antica città della Jonia, ridotta all’età di Orazio a poche case superstiti fra rovine sparse. Nella XI del libro I delle Epistole (è l’epistola famosa della strenua inertia), Orazio chiede a un amico lontano, in viaggio di piacere fra le metropoli della Grecia e dell’Asia Minore: «che effetto ti fanno quelle città famose che vai visitando, Smirne, Colofone, Bisanzio, Pergamo? Ti pare che reggano il confronto con Roma? Tu sai com’è oggi Lebedo: più squallida d’una Gabi e di Fidene: bene, io oggi vorrei vivere là, dimentico di tutti e da tutti dimenticato». Il tertium comparationis consiste nel fatto che, oltre ad essere un paesetto remoto dalle città, Crespadoro, quando Bandini vi faceva scuola, era quasi spopolato dall’emigrazione: dunque in gran parte fatto di case abbandonate e di campi ed orti incolti. La differenza è che Lébedo aveva avuto un passato illustre.
«Nux» (v. 174) sarebbe «noce» o «nocciola». [Giovanni Pellizzari]
NIMBUS
Quid patet in nimbo, quae nostrae sortis imago?
Ingens magnoliae qui frondibus ingruit imber
et longi tonitrus veris lapidosaque grando.
Te capit in laribus strepitus crystallinus altae
grandinis. En auri – quo armaria cara nitebant
et vestitorum corio caesura librorum –
tantillum superest quoddam tibi lumen et ardet
sub clausis tacite ceu granum sacchari ocellis.
Et quod candefacit muros arbustaque fulgur
umbras tam vehemens momento temporis afflans
ut videatur eas aeterna incendere luce;
quod tempus simul exiguum simul immortale –
omnia dum fiunt marmor manna atque ruina –
ut poenam tacito condis sub pectore nec non
te mihi, cara soror, magis ipso adstringit amore.
Dein durus sonitus, dein sistra ac tympana quassa
ad rapidum barathrum, subeuntis somnia belli
quae nimbo in tremulo sum visus nocte videre,
in numerumque pedes moti, saltatus hiberus,
iactataeque manus confuse ac molliter.
Ut cum
ad me respiciens cirrosque a fronte repellens
gestu iussisti tenebras initura valere.
Eugenio Montale, LA BUFERA […] La bufera che sgronda sulle foglie / dure della magnolia i lunghi tuoni / marzolini e la grandine, // (i suoni di cristallo nel tuo nido / notturno ti sorprendono, dell’oro / che s’è spento sui mogani, sul taglio / dei libri rilegati, brucia ancora / una grana di zucchero nel guscio / delle tue palpebre) // il lampo che candisce / alberi e muri e li sorprende in quella / eternità d’istante – marmo manna / e distruzione – ch’entro te scolpita / porti per tua condanna e che ti lega / più che l’amore a me, strana sorella, – // e poi lo schianto rude, i sistri, il fremere / dei tamburelli sulla fossa fuia, / lo scalpicciare del fandango, e sopra / qualche gesto che annaspa… \ Come quando ti rivolgesti e con la mano, sgombra / la fronte dalla nube dei capelli, // mi salutasti – per entrar nel buio.
NIVEUS NIMBUS
Ecce divini pueri redit nox.
Rus sub informi nive delitescit
atque labenti scatet usquequaque
vellere caelum
perque desertos tacitosque calles
flamina impellunt fragiles pruinas
ac viatoris feriunt acuto
verbere vultum.
Luce quam fundunt vitreae fenestrae
fulget interdum glaciatus imber:
nonne demitti vacuo videntur
aethere stellae
dum domos libat sagulo viator
et leves intus resonare voces
audit? Extemplo meminit remota
tecta laresque
quo redit serus. Per aperta canus
avolat pulvis nivibusque mire
arbores florent: tumido gravantur
pondere rami.
Quam notam pressus facit in nivali
calceus campo sepelit subinde
densa tempestas. Tenet unus arva
candidus horror.
Tu, puer, qui poneris hac in arto
nocte praesepi manibusque gestis
parvulis, duras fovet atque cunas
bos et asellus,
ecquid hos regnas deus inserenos
per polos? Utrum sonat insolenter
eurus an vagis metuendus olim
nunc tener infans?
Iamque longinquis venient ab oris
(et nive ignota dromades stupebunt)
tres Magi vasta rutilum sequentes
nocte cometam.
Mira per campos tenebrasque pompa
prorsus arctoum borean subibunt
aureae spargunt leve dum coronae
lumen in umbris.
Dona sed nondum sua porrigentes
te genu nixi coluere regem:
dormis in feno trepidantis altus
ubere matris
et foris late sine fine ningit
inter albentem volitantque nimbum
angeli, terris tacitis et auris
concolor agmen,
nix quibus praebet borealis alas
plumulis factas rapidoque vento:
dulcis illorum resonat per intervalla
susurrus.
Nos viatores patria carentes
ac domo porro niveam procellam
findimus. Nusquam datur invenire
hospita tecta
deque subgrundis domulae silentis
stiriae pendent prope quam moramur
usque pultantes aperitque nobis
ostia nemo.
Nos, puer, bruma prohibe maligna
atque iucundum recipe in teporem.
Fac foci ad flammas bona persequamur
somnia pacis.
BUFERA DI NEVE
Ecco torna la notte del divino fanciullo.
Sotto la neve che cancella le forme si nascondono i campi
e di fiocchi che d’ogni intorno cadono
brulica il cielo
e per i sentieri silenziosi e deserti
il vento spinge avanti le fragili brine
e ferisce con la sua acuta sferza
il viso del viandante.
Della luce ch’emana dai vetri delle finestre
splende a tratti il turbine gelato:
non sembra quasi che discendano stelle
dagli spazi celesti
mentre il viandante sfiora col mantello le case
e sente dentro risuonarvi fioche
voci? D’un tratto pensa alla sua remota
casa e ai suoi lari
dove (è tardi) ritorna. Via per l’immensità
svola la bianca polvere, gli alberi fioriscono
meravigliosamente di nevi: sono carichi
del gonfio peso i rami.
L’orma che la scarpa stampa sul suolo
nevicato presto viene sepolta
dalla fitta tempesta. Domina i campi un unico
candido orrore.
Tu, fanciullo, deposto questa notte
in una stretta mangiatoia, che agiti
le piccole mani, la cui dura culla riscaldano
un bue e un asinello,
sei davvero il dio che regna su questi cieli
senza pace? Questo è il rombo insolente dell’euro
o è il tuo vagito, tu una volta terribile,
ora tenero infante?
Ed ecco arriveranno da lontane contrade
(sbalorditi i cammelli dalla neve mai vista)
i tre Magi seguendo nella vasta notte
la fiammante cometa.
Prodigioso corteo per la pianura e le tenebre
affronteranno il vento del nord
mentre le corone d’oro spargono nell’ombra
un leggero barlume.
Ma ancora non t’hanno offerto i loro doni
adorandoti in ginocchio come un re:
dormi nella paglia, nutrito dal seno
dell’inquieta tua madre
e fuori fittamente continua a nevicare
e angeli volano in mezzo alla bianca tempesta,
schiera che ha lo stesso colore che c’è in terra
e nel tacito cielo,
cui fornisce le ali la neve boreale
fatta di piccole piume e di rapido vento:
ad intervalli s’ode risuonare
il loro dolce canto.
Noi viandanti senza patria e senza casa
avanziamo fendendo la burrasca
di neve. In nessun luogo riusciamo a trovare
un tetto che ci ospiti
e pendono ghiaccioli dalle gronde
della povera casa alla quale sostiamo.
Continuiamo a bussare ma nessuno
ci apre la porta.
Difendici, bambino, dall’inverno inclemente,
accoglici nella gioia del calore.
Fa che presso la fiamma del focolare inseguiamo
miti sogni di pace.
DE MELI FRAGMENTUM
Quo iamnunc fugiat repente quis scit
meles gutture luteo notata.
Inter fulgura forsan ille scandit
in pinum, speculatur unde deorsum
os a frondibus exserens acutum
dum longe arma iterum tonant Dianae.
Giorgio Orelli, FRAMMENTO DELLA MARTORA … / A quest’ora la martora chi sa / dove fugge con la sua gola d’arancia. / Tra i lampi forse s’arrampica, sta / col muso aguzzo in giù sul pino e spia, / mentre riscoppia la fucileria.
PAPILIONES
Qui mores variis sint papilionibus, a quo
occulto nitidae nascantur semine pennae
admiranda canam levium spectacula rerum
ac ter dissimiles mutato corpore formas.
Namque fuere humiles tondentes germina campae
dein ceu Nilicolum medicata cadavera regum
picto in sarcophago longo stupuere veterno.
Sed verno pellit dum mane favonius umbras
et coniventes aperit myosotis ocellos
chrysalida excudit nova papilionis imago.
Tum propria gaudent specie meditantur et alas,
tum temere venti vestigia vana sequuntur
et nostrae simulant fugientia somnia Musae.
Principio campas aversa in fronde videbis
sub tentoriolis tenui quae vellere mire
texerunt ipsae. Fervent, exilis acervus
frigore deprensus vitae, primique diei
cum timeant lucem sese per mutua nectunt.
Sed grege fraterno mox una atque altera cedunt,
roscida dein omnes linquunt cunabula: pro se
campe quaeque petit longinqui pabula rami.
En avide gratas incumbit frondis in escas
inque dies sensim crescit bene pasta nitetque
dum teneri caules illius pondere nutant.
A fronte in caudam bis septem glauca quibusdam
scribitur anellis qui corpus pingue resolvunt,
strenua sexdenis pedibus per corticis aspros
arrepit calles foliis aut levibus haeret.
Ut videat centum minimis ornatur ocellis
et caput interdum vacuum super aera profert
ignotum speculans sublimi ex arbore mundum.
Arcanis armis est illi praedita bucca:
nam binae malae quasi acuta cisoria lembum
escarum fragilem resecant binaeque minores
deinceps deinde terunt, gula frustula trita ligurrit.
Fila etiam quondam tenuissima fundit ab ore
aureolusque tremit frondes nitor inter opacas.
Daedalus haec eadem deducit vellera bombyx,
haec legere arboribus prisci cecinere poetae
Seras in Eois, haec crescere sponte sub umbra
artificem vermem non noti operisque laborem.
Non omnes vero foliis epulantur iisdem.
Pieridis campae mollis dat brassica cibum,
Argynnis violas, urticas Aglais optat,
vescitur halanti marathro daucove Machaon
luteaque Antocharis aurorae lumine tincta
herbae silvestris quae alli mentitur odorem
erosit siliquas dum pictas somniat alas.
Et miranda alias delectant fercula campas.
Papilio est quidam tenebrosis noctibus errans
tempore qui certo furtim sua collocat ova
populei trunci in rimis et cortice laeso.
Non pridem natae tacito sub cortice campae
en librum terebrant. Tum mordicus arboris imis
vescuntur venis et per penetralia multus
obscura serpens ambage cuniculus errat.
Populus ad fluvium corrosis aegra medullis
pallescit neque causa patet languentis honoris.
At duras latebras acida mollire saliva
cum soleant ipsae, gravis aura ex arbore manat
portitor et callens dum mergit in aequore remum
exesos truncos insigni agnoscit odore.
Sed cum pinguescat facilis per ganea cibi
et nimis angusto rigidoque prematur amictu
non semel est avidae mutanda cuticula campae.
Iamque diu dulcis fastidit pabula frondis,
aegrotare putes, buccam stupor urget inertem
et capite erecto vacuum stat in aethera versa
tanquam si olfaceret palans per nubila numen,
nescio quid sacrum opperiens. Tum denique parvus
terga tremor rursum prorsum torpentia currit,
anelli turgent summi, cutis arcta fatiscit,
ecce novum maius caput apparere cadentem
post larvam veteris; dein toto corpore tractim
finditur et lacerum nitens in tegmen inanes
reicit exuvias eademque atque altera serpit.
Sed mollis lorica recens expersque coloris;
quae pluma horridulae, lentos torquentur in orbes
intenduntque cutem vario luctamine donec
deriguere pili viscoso rore madentes.
Nunc iterum ieiuna fames impellit ad escas
et parvi ventris nunquam satiata vorago.
Quin solidas etiam silvas quandoque peremit
praedonum populus: fetus populantur acutos
pini vel laricis, folio maiore virentes
sanguineas cornos vastant canasque betulas
et resinosas cerasus spoliata catervis
dat lacrimas nudos tendens ad sidera ramos.
Illas non audent picus nec erithacus esse,
fugerunt volucres. Campae de fronde triumphant,
excrementorum tenuis cadit altius imber.
Iam se in chrysalides mutant atque undique pendent
arborea et resonat per dormitoria ventus;
alarum decies centum cras millia cernes
in faciem nubis squalentem linquere silvam.
Extremum sibi se eripiunt et tegmine fisso
chrysalis egreditur quam pallida bractea tingit,
lucis inops, conchae similis. Non viva videtur,
illam si attrectas paulum micat alvus acuta
et caecos horret digitos. Quin ambigis utrum
pro feretro cunisne habeas hoc pensile monstrum;
nam somno visa est repens eruca supremo
sopiri nec adhuc eadem quodammodo nata;
arridet nigrae sub cortice vita sorori.
Quantum chrysalidum tacita ad mysteria spectat,
nymphosis spatium satis est memorare locosque.
Aversa de fronde aliae cum stamine pendent
(virgineo velut aure lapis) solitaeque soporem
undenos soles aut unum ducere mensem;
atque trilix alias adiungit zonula muro:
sub grunda a pluviis tectae gelidisque pruinis
cum zephyris somnum rumpent et hirundine prima;
sub terris aliae longe iacuere sepultae
dum quater autumnus frondes et poma colorat:
sericus has nidus thalamusque volubilis obdit.
Sed iam papilio (nostrae pars altera curae)
dicendus, iam tempus adest quo perforat urnam
et vix emergit late madefactus et alas
contractas avidus sub aperto extendere caelo.
Velorum pansos nunc contemplare colores.
Millia squamarum fingunt decus illud opusque
versicolor, natura ubi vult imitarier artem.
Squamas non cernes sed si comprenderis unum
indoctaque manu miseras male strinxeris alas
primores digitos quaedam tibi purpura tinget:
sunt squamae hic pulvis; quas si tu cernere posses
iunctis embricibus similes tectoque paterent.
Quin lucem frangunt ipsae scinduntque colores
in septemgeminos vitreum ceu prisma levisve
quam tenui quondam puer efflat arundine bulla:
cunctanti illa natat mollique per aera cursu
adverso varia collucens Iride sole.
Bis binis en laeta volant ad pabula pennis,
floribus insidunt altumque proboscide sucum
absorbent calathi. Sed serva: non color idem
aversis nitet in velis neque habebit eundem
alas pingentem sponsi femella colorem.
Saltibus in vacuis campisque vagantur apricis,
effugiunt nimios exustae Syrtidis aestus
et nubes vitant pluvias. Sed Aphantopus ater
cuius penna brevis viridi micat eminus auro
per densas nebulas volitat largosque per imbres,
et Cufrae fugitiva obiit Melitaea Saharam
unicus in tanta flos ariditate dehiscens.
Innumeras species et nomina dicere non est.
Sunt Maurum qui Atlanta colunt Alpesque nivales
Andesque, Oceanus vasto quas murmure lambit,
et iuga sola Imai terrarum templa superna.
Illic papilio discurrit pascua quidam
ver breve sortitus. Cum sese librat in alas
culmina perpetuum gelidis redimita pruinis
candore exsuperat puraque in luce renidet;
sanguineae velis in posterioribus umbrae
longinquis referunt rhododendra rubentia clivis.
Innatat immensum, spirantis filius aethrae,
induiturque volans nivium florumque colores.
Ast alii fervens Tropici quibus obtigit aestas
floribus aeternis gaudent ripasque Orinoci
aut rapidi Congi libant maioribus alis.
Quandocumque repens toto ruit aethere nimbus
illis suffugium praestat frons ampla mimosae,
dein laeti revolant per destillantia tesqua
et pluvios findunt alis radiantibus arcus.
Saepe altos nemorum cupidi visisse recessus
inter Amazoniae virides errant labyrinthos
aut calidam Bornei lustrant leni agmine iunglam.
Tum sparsas filices superant tortasque lianas
aufertque alarum silvae nox densa colorem.
Sed solis radius si per spiracula frondis
extemplo penetret violata aurescat et umbra,
magnis in pennis roseas mirabere guttas,
se nigram violam nitido miscere smaragdo
et mille incendi pictarum somnia rerum.
Infirmus sedenim segnisque volatus et ipsa
illos illaqueat pennarum lata venustas,
remigio oppressos tanti ac torpedine solis.
Edocuit contra nos experientia quantum
perparvis alis rapidus sit caerulus ille
papilio, nostri gratus saepe incola ruris,
nomine qui lacedaemonio Lysandra vocatur:
urgent reticulo pueri manibusve fugacem
sed caeli fluitans fragmen vinclisque solutus
ille alias aliter venanti irrisit inepto.
Non omnes vero lux haec iuvat aurea solis,
arcanas alii noctes et sidera malunt.
Insomnem hunc populum quidam notissimus anteit
magnus centurio cuius grave nomen Averni
commemorat tenebras ripasque Acherontis avari.
Thoraca insignit turpis metuendaque calva
incertumque ubinam lateat tuba flebilis illi est
(nam tactus gracilem ciet imo e pectore vocem).
His hastam adde brevem sed acuta cuspide fretam
qua flores penetrat vel laesos vulnere truncos
manantes potans lacrimas. Furtivus eadem
intrat apum sedes et cerea tecta terebrat
Hyblaeum ducens e cellis munus odorum.
Importunus adest fervensque opus impedit: illi
primo quoque tamen pendendae tempore poenae.
Nam flavis fur iste procax si forte sub umbris
carpserit ignavum satiatus melle soporem,
incautum aggrediuntur apes stipantque frementes:
leniter ac sensim tum fuco incommodus hospes
obtegitur ponitque tenaci in glutine vitam.
Dein lentus fucus cera fit durior ipsa
et cras mellifluos retegens apiarius alvos
manes sub propoli squalere videbit et alas
ut per translucentem onycem nigrare sepultas.
Nostris quin ausus laribus succedere quondam
suspenso allectus patulae splendore fenestrae.
Advenit et ravo penetralia murmure complet
parietibusque caput furiose impingit et alas.
Nescio quae formido animos tunc occupat omnes;
ipse domus custos catulus (temerarius olim)
repens it retro tremulasque oggannit ad umbras
haec Hecates proles quas in laquearia iactat
ardentem circumvolitans sine fine lucernam.
Papilio (nomen cui praestat Cecropis) alter
vespere comparet furtimque proboscida longam
colligit in spiram dum nigras pervolat umbras,
Bellae Nocturnae vagus aut concolvolus et phlox
sicubi se pandunt omnino evolvit et imos
ingerit in calyces: fruitur dulcedine suci
nec flori insidit pendetque coruscus in auris
tam crebro quatit ille leves tam concitus alas.
Sic tenebras servat tacitus florumque soporam
mellitamque animam spectantibus ebibit astris.
Visit et ille domos nostrisque interfuit olim
in cenis, clara anteferens triclinia nocti;
albis imminuit mensis interque culullos
explicuit spiram degustavitque lyaeum,
aerius conviva epulis qui accumbere spernit.
Quod superest seu nocte volant seu mane sereno
pars almum nunquam fruticem neque molle relinquunt
per quod pascuntur pratum: sic bella Lycaena
cui crocea est vestis nigro circumdata limbo,
Hermione nemorum cultrix, Melanargia ruris
levia distinguens maculis lugubria canis.
Non nemo interea natali a sede facessit:
ancipiti collem superat flumenve volatu
villula donec eum conclusis accipit hortis;
hic ferrugineo pervincae in flore quiescens
in numerum pandit committit leniter alas.
Nocte satae vero quas educat Africa terra
Sphynges, Internum nullo comitante sodali
transvolitant pelagus. Recto in borealia cursu
litora contendunt et quondam nescia navis
Hersen hospitio Macroglossumve recepit
(aerios lemures) in cornibus antennarum
delituitque cavis Acherontia furva carinis
angustam lateris furtim penetrata fenestram.
Virginiae Danaus silvas et rus Alabamae
nonnunquam linquit: confuse fervet in auris
alarum populus longumque intendit in Austrum.
Caeruleae Panamae cum fauces denique cernunt
quae bimarem fluctum proscisso miscuit isthmo
in geminas acies exsul se dividit agmen:
altera Atlantiacas iter obtinet inde per undas,
altera in Oceanum Pacis solemque cadentem.
Tunc infinite volitat tribus aequora iuxta
atque ubi tangit aquas finitor circulus, olim
nautae visa Thetys tremulum exhalare vaporem
dum caeli nullo transcendunt ordine fines.
Mors tamen Europae aut Asiae regionibus illos
lenta manet neque prole nova nova rura frequentant.
Nam grate ignotos ales bibit advena flores
sed posthinc eruca vagans sibi commoda frustra
pabula quaesivit, peregrinas respuit escas;
sese iniucunda seiungens fronde repente
praecipitat siccoque viarum pulvere squalet.
Interea Danaus nostris evanuit oris:
magna tribus fuerat, nunc unus vespere deerrat
qui legit extremae trepidus vestigia lucis.
Ipse libri noti de papilionibus auctor
hic mussat dubius quaenam sit causa migrandi.
Illorum citior quam campes labitur aetas
nec procul a laeto distat Libitina hymenaeo.
Prolis amore fremunt. Una quandoque fugacem
alatus thiasus sponsam vestigat odore;
albae Pierides pomoeria saepe relinquunt
urbesque albenti penetrant bene mane maniplo,
pompa novae nuptae. Sed cras iam nocte peracta
alarum strages ostendet trita crepido.
Pavonisque imitans oculos Saturnia maesto
nuptura est sponso cui mors servatur acerba
cum careat tenui qua flores combibat hasta
et rigidae Parcae ternorum fata dierum
illi dispensant, olim scidit Atropos aevum
dum thalamum tremebundus avet volitatque per umbras.
Papilio superest hieme impendente serenus
cui rutila obscuram pingunt incendia pennam:
Vulcanum Galli merito cognomine dicunt,
rus colit atque nemus sed saepe migravit inanes
in Boreae terras atque accipit ultima Thule.
Nunc is quem seras celebrare aspeximus uvas
a nivibus tutam nequiquam quaeritat umbram,
maceriam explorat, pontis circumvolat arcum;
sique domi trepidet detentus forte fenestra
atque exspes vitrum quatiat, pellucida claustra
captivo resera, sine per pomaria nuda
angusto reliquae potiatur tempore vitae.
ANNOTATIONES
v. 43: Pieris brassicae brassicae Linnaeus 1758, notissimus papilio est albo colore, anglice «Large White», gallice «Piéride du chou», germanice «Grosser Kohlweissling», hispanice «Blanca de la Col», italice «Cavolaia».
v. 44: Argynnis paphia paphia Linnaeus 1758, angl. «Silver-washed Fritillary», gall. «Tabac d’Espagne», germ. «Silbestrich, Kaisermantel», hisp. «Nacarada», it. «Pafia»; Aglais urticae urticae Linnaeus 1758, angl. «Small Tortoise-shell», gall. «Petite Tortue», germ. «Kleiner Fuchs», hisp. «Ortiguera», it. «Vanessa dell’ortica».
v. 45: Papilio machaon Linnaeus 1758, praeclarus inter papiliones qui nostras regiones incolunt, magnis alis praeditus quae in binos apices desinunt caudam hirundinis imitantes; angl. «Swallowtail», gall. «le Grand Porte-queue», germ. «Schwalbenschwanz», hisp. «Makaon», it. «Macaone».
v. 46: Anthocharis cardamines Linnaeus 1758, pulcher papilio qui Europam Occidentalem incolit et Asiam temperatam usque ad Iaponem; angl. «Orange», gall. «l’Aurore», germ. «Aurorafalter», it. «Aurora». Aprili mense volitat. Eius eruca cardaminen, sysimbrium et alias Craciferarum familiae herbas edit, sed super omnes herbam diligit cui nomen apud botanicos Alliaria pettiolata. Haec in margine silvarum crescens et secundum saepes putresque muros singularem odorem allii manat. Eruca Iunio mense longis viridibusque siliquis huius herbae vescitur et, cum et eruca viridis sit, difficillime ab istis distinguitur.
v. 50: De papilione nocturno agitur cui nomen apud entomologos Cossus cossus, Linnaeus 1758. Antiqui dicuntur huius papilionis erucas tanquam exquisita fercula mensis apposuisse; sic enim Plinius. Hieronymus in libro adversus Iovinianum scribit in Ponto et Phrygia cossos optatissimos esse: «… Quomodo apud nos attagen et ficedula, mullus et scarus in deliciis computantur, ita apud illos ξυλοφάγον comedisse luxuria est». Nomen graecum, quo Hyeronimus utitur, nominis italici «perdilegno» simile est, et gallici «le Cossus-gâte-bois», quo vulgo hunc papilionem et eius erucam vocant. Sed iam veteres scriptores hunc cossum in quercubus vivere tradiderunt et minime ideo de nostra eruca agitur, quippe quae populos, salices et cerasos tantum incolat. Adde quod eruca huius papilionis nauseantissimum odorem manat. Antiquorum cossus enim, ut patuit, vermiculus est futuri Cervi Lucani (it. «Cervo Volante»). Primus errore falsus est Linnaeus cuius opinionem Forcellini (ad vocem cossus) sequitur.
v. 140: Raro papiliones diurni sub pluvia volitant, ut solet Aphantopus hyperantus Linnaeus 1758, angl. «Ringlet», gall. «le Tristan», germ. «Brauner Waldvogel», hisp. «Sortijitas».
v. 143: Melitaea deserticola Oberthur 1876, ex numerosa Melitaearum familia, Marochii et Algeriae Tunisiaeque papilio, quandoque Saharam peragrat novam oasim petens.
v. 149: De papilione agitur cui nomen Parnassius apollo Linnaeus 1785, angl. «Apollo», gall. «l’Apollon», germ. «Apollo» et ita italice. Sed etiam ceteri memorantur huius familiae papiliones (ut P. phoebus et P. mnemosyne) qui altos orbis terrarum montes incolunt.
v. 180: Lysandra bellargus Rottemburg 1775 (primus Rottemburg enim, non Linnaeus, huic papiliunculo nomen dedit), angl. «Adonis blu», germ. «Himmelblauer Bläuling», hisp. «Niña Celeste Rastrillo». Multi sunt papiliones qui nomine Lysandra designantur et inter se simillimi, illisque similes innumeri alii papiliones quibus nomen Plebiculae et Agrodiaeti.
v. 186: Acherontia atropos Linnaeus 1758, mirus nocturnus papilio vulgo notus, angl. «Death’s-head moth», gall. «le Sphynx-tête-de-mort», it. «Testa di morto».
v. 217: Herse convolvoli Linnaeus 1758, gall. «le Sphynx-du-liseron», it. «Spiritromba». Cecropidem hunc papilionem poetice appellamus: nam Herse in antiquis fabulis una ex filiabus Cecropis vel Actaei fuit, Aglauri et Pandrosis soror, de qua in secundo Metamorphoseon libro Ovidius canit. Cum nomen Herse a rore nonnulli ducant (ros enim graece ἕρση), sic Linnaeo Hersen hunc papilionem, utpote qui per nocturnos rores volitet, cognomine forte dicere placuit.
v. 234: Lycaena (Heodes) virgaureae Linnaeus 1758, angl. «Scarce Copper», gall. «l’Argus satiné», germ. «Dukatenfalter», hisp. «Manto de Oro». Multi papiliones Heodes nominantur, sed Heodes virgaureae vestis singularitate ac pulchritudine excellit.
v. 236: Hermione hermione a Linnaeo vocatur papilio cui nomen communius in libris entomologiae Hipparchia fagi Scolopi 1763 (nomen Hermionen huic papilioni Linnaeus dedit anno 1764), angl. «Woodland Grayling», gall. «le Sylvandre», germ. «Grossier Waldportier», hisp. «Banda curva». Hic papilio in nemoribus vivens cum fessus volatu est corticibus arborum insidit. Multae sunt Hipparchiae (alcyone, siriaca, ellena, semele, etc.) et variarum Hipparchiarum recognitio difficillima.
ibid.: Melanargia galathea galathea Linnaeus 1758, angl. «Marbed White», gall. «le Demi-Deuil», germ. «Schachbrett», hisp. «Medioluto norteña». Et papiliones nomine Melanargia cogniti innumeri sunt (Russiae, occitanica, arge, etc.).
v. 247: Macroglossa stellatarum Linnaeus 1758, angl. «Humming-bird-moth, Hawk-moth», gall. «le Moro-sphynx», it. «Macroglossa», mirabilis papilio nocturnus qui, ut Herse, nunquam floribus sidit dum eos proboscide sugit sed suspensus rapidissimis alis in aere manet. In extremo abdomine nonnullos pilos, albos et nigros, habet qui dum volat panduntur aut committuntur tanquam flabelluli radii: hi pili cursum volatus dirigunt ut fit in avibus per plumas caudae. Vivis coloribus valde allicitur et saepe, deceptus, ad flores ex charta picta volat aut ad illos ex panno qui bellarum dominarum petasos exornant.
v. 251: Danaus plexippus Linnaeus 1758, angl. «Milkweed, Monarch», it. «Monarca»; Americam incolit a Peruvia usque ad Canadam. Hic pulcher papilio immania itinera migrans superiore saeculo perfecit: anno 1840 Novam Zelandiam assecutus est, anno 1870 Indonesiam Australiamque, anno 1880 Accipitrum insulas («Azzorre») unde postea in Europam diffusus est.
v. 283: Saturnia pyri Schiff. (Pavonia maior Linnaeus), papilio nocturnus, maximus inter Europae papiliones. Quattuor ocelli magnas alas ornant, similes illis qui pavonis plumas pingunt, unde illi nomen pavonia (gall. «le Grand-paon-de-nuit», angl. «Emperor-moth»). Fraterculum habet minoribus alis praeditum. Mares sine proboscide nascuntur et vitam brevissimam trium aut quattuor dierum degunt. Notissimum est J.H. Fabre illius experimentum, qui una femina captiva quinquaginta mares per noctes octo in domum suam attraxit. Nam femella odorem fundit quem mares olfactricibus quibusdam antemnulis, etsi longissime absunt, percipiunt et per multa miliaria taedas petentes ad ignotam sponsam volant.
v. 289: Vanessa Atalanta Linnaeus 1758, angl. «Red Admiral», gall. «le Vulcain», germ. «Admiral», hisp. «Numerada», incola numerosus et gratissimus nostri ruris. Autumno, ut persaepe vidimus, vindemiatores sequitur dum uvam colligunt et diu postea, dum iam paucissimi flores, neglectos racemos per inarescentes vites quaerit, usque ad primam nivem volitans.
LE FARFALLE Canterò che abitudini abbiano le screziate farfalle, da quale nascosto seme le splendide ali nascano, meraviglioso spettacolo di leggerezza, e le forme tre volte diverse per il mutamento del corpo. Furono infatti umili bruchi che si pascevano di germogli, quindi intorpidirono in un lungo letargo come i medicati cadaveri dei re egiziani entro un sarcofago dipinto. Ma un mattino di primavera, mentre il favonio scacciava le ombre e la miosotis apriva gli occhietti addormentati, una nuova immagine foggiò la crisalide della farfalla. Poi esse godono della propria specie e preparano le ali, e temerariamente seguono le vane tracce del vento e simulano i sogni fuggenti della nostra Musa. // All’inizio vedrai i bruchi sul rovescio della foglia sotto tendine che essi stessi hanno mirabilmente tessuto di un velo sottile. Si agitano, esile mucchio sorpreso dal freddo della vita, e poiché temono la luce del primo giorno si allacciano l’uno all’altro. Ma dal gregge fraterno si allontanano prima uno e poi l’altro, quindi tutti abbandonano le culle rugiadose: per sé ciascun bruco cerca la pastura di un ramo lontano. Ecco avidamente si getta sul cibo gradito della fronda e di giorno in giorno, nutrendosi bene, cresce sensibilmente e s’ingrassa finché i teneri steli vacillano sotto il suo peso. Glauco dalla fronte alla coda, è segnato da quattordici anelli, per così dire, che disgregano il corpo pingue; strenuamente striscia con sedici piedi per i sentieri aspri della corteccia, o si attacca alle foglie lisce. Per vedere è fornito di cento piccoli occhi e talora sporge il capo sopra l’aria vuota esplorando dall’alto dell’albero il mondo sconosciuto. // La sua bocca è fornita di armi segrete: due mascelle come una cesoia affilata tagliano un fragile membro di cibo, poi altre due, più piccole, di nuovo lo tritano; la gola trangugia i pezzetti tritati. Talora inoltre dalla bocca emette sottilissimi fili e un luccichio d’oro tremola tra le fronde scure. Questi stessi velli produce l’industrioso filugello; questi, i poeti antichi cantarono che i Seri raccoglievano dagli alberi d’Oriente, e che crescevano spontaneamente all’ombra, non conoscendo la maestria del baco e la fatica del suo lavoro. // Ma non tutti si nutrono delle stesse foglie. Il cavolo molle fornisce il cibo al bruco della Pieride, l’Arginnide sceglie le viole, l’Aglaide le ortiche, la Machaon si nutre di finocchio profumato o di carota, e la gialla Anthocharis tinta della luce dell’aurora ha rosicchiato le silique dell’erba silvestre che simula l’odore dell’aglio mentre sognava le ali dipinte. E meravigliose pietanze rallegrano altri bruchi. C’è una farfalla che se ne va in giro nelle notti tenebrose, che al tempo stabilito depone furtivamente le sue uova nelle fessure e nella corteccia lacerata del tronco di pioppo. I bruchi nati da poco sotto la corteccia silenziosa ecco forano il libro. Allora a morsi essi si nutrono delle vene più interne dell’albero e una lunga galleria ne percorre i penetrali serpeggiando nel cieco labirinto. Il pioppo malato, vicino al fiume, a causa del midollo corroso ingiallisce; la sua bellezza svanisce e non si vede il perché. Ma siccome sono soliti essi stessi ammorbidire con la saliva acida i duri nascondigli, dall’albero esce un’esalazione pesante e il barcaiolo esperto, mentre immerge il remo nell’acqua, riconosce dal forte odore i tronchi corrosi. // Ma poiché ingrassa per l’ingordigia del facile cibo ed è premuto dall’involucro troppo rigido e stretto, non una sola volta la pelle dell’avido bruco deve essere mutata. E già a lungo egli disdegna i cibi della dolce fronda (penseresti che fosse ammalato), un torpore invade la bocca inerte e con la testa eretta sta immobile, rivolto verso il cielo come se fiutasse un nume errante tra le nubi, attendendo non so cosa di sacro. Poi infine un piccolo tremito corre di nuovo per il dorso completamente intorpidito, gli anelli in alto si gonfiano, la pelle tesa si fende, ecco apparire il nuovo capo più grande dietro la larva cadente del vecchio; quindi si spacca un po’ alla volta in tutto il corpo e facendo forza sulla copertura lacera, rigetta le inutili spoglie e riprende a strisciare, identico e diverso. Ma è molle la nuova corazza, e priva di colore; e i bruchi un po’ irsuti si torcono in lenti cerchi e tendono la pelle con vario sforzo finché i peli bagnati dal liquido viscoso diventano rigidi. Ora di nuovo la digiuna fame e l’avidità mai saziata del piccolo ventre spinge verso il cibo. Anzi il popolo dei predoni talora è arrivato a devastare anche le selve intere: distruggono gli spinosi frutti del pino e del larice, devastano i cornioli sanguigni, e le bianche betulle verdeggianti di foglie più grandi; il ciliegio spogliato da quelle schiere emette lacrime resinose, tendendo i nudi rami alle stelle. Il picchio e il pettirosso non osano mangiarli, gli uccelli sono fuggiti. I bruchi trionfano dai rami, più fitta cade una pioggia di escrementi. Già si trasformano in crisalidi e penzolano da ogni dove; il vento risuona tra i dormitori arborei; domani vedrai un numero infinito di ali abbandonare in forma di nuvola la selva desolata. // Strappano infine se stessi da sé, e dall’involucro spaccato esce la crisalide: la colora una lamina opaca, priva di luce, simile ad una conchiglia. Non sembra viva, ma se la tocchi un poco, guizza il ventre acuto e rizza le dita cieche. Anzi, si resta in dubbio se ritenere questo mostro pensile una culla o una bara; poiché sembrava che il bruco improvvisamente si addormentasse nel sonno supremo ma anche che non fosse ancora nato; sotto la scorza la vita sorride alla nera sorella. // Per quanto riguarda i taciti misteri delle crisalidi, è sufficiente ricordare tempi e luoghi della ninfosi. Dal verso di una foglia alcune pendono con un filo (come la pietra dall’orecchio di una vergine) e sono solite trascorrere nel sonno undici giorni o un mese; altre, una cintura di tre fili le lega al muro: sotto la grondaia, riparate dalla pioggia e dalle gelide brine, interromperanno il sonno con gli zefiri e con la prima rondine; altre giacquero sepolte a lungo sotto terra, mentre quattro volte l’autunno colorava fronde e frutti: un nido di seta e un talamo volubile le rinchiude. // Ma ormai dobbiamo parlare della farfalla (l’altra parte della nostra cura). È ormai il tempo nel quale essa perfora l’urna e faticosamente emerge, tutta bagnata e avida di stendere sotto il cielo aperto le ali contratte. Osserva ora i colori spiegati dei veli. Migliaia di squame formano quell’ornamento e l’opera variopinta, con cui la natura vuole imitare l’arte. Non distinguerai le squame, ma se tu prenderai una farfalla e con una mano inesperta stringerai in malo modo le povere ali una specie di porpora ti tingerà l’estremità delle dita: le squame sono questa polvere; e se tu potessi distinguerle, si rivelerebbero simili a tegole unite, ad un tetto. Anzi esse frangono la luce e la scindono in sette colori come un prisma di vetro o come la bolla leggera che il fanciullo soffia da una canna sottile: essa nuota nell’aria con volo esitante e morbido, brillando dei colori dell’iride di contro al sole. // Ecco che volano ai floridi pascoli con quattro ali, si posano sui fiori e con la proboscide assorbono sino in fondo il succo del calice. Ma osserva: nel rovescio delle ali non risplende il medesimo colore né la femmina avrà lo stesso colore che dipinge le ali dello sposo. Vagano nelle balze deserte e nei campi aprichi, sfuggono l’eccessivo calore della Sirte riarsa ed evitano le nubi cariche di pioggia. Ma l’Afantopo nero le cui piccole ali palpitano da lontano di verde oro, se ne va volando attraverso dense nebbie e piogge abbondanti, e la Melitea, lasciando Cufra, visita il Sahara; unico fiore che si schiude in tanta aridità. Non è possibile citare le innumerevoli specie e dirne i nomi. Ci sono quelle che abitano l’Atlante in Mauritania e le Alpi innevate e le Ande, che Oceano lambisce con il suo cupo mormorio, e i gioghi solitari di Imaio, superni templi della terra. Lì una farfalla corre per i pascoli, avendo ottenuto in sorte una breve primavera. Quando si libra sulle ali supera in candore le cime ornate perennemente di gelide brine e risplende nella luce pura; ombre sanguigne sulle ali posteriori ripetono i rosseggianti rododendri sui lontani clivi. Nuota nell’immenso, figlia dell’etere spirante, e mentre vola si riveste dei colori della neve e dei fiori. Ma altre alle quali è toccata in sorte la rovente estate del Tropico, godono di fiori perenni e con ali più grandi sfiorano le rive dell’Orinoco o del Congo impetuoso. Quando la bufera improvvisa precipita da tutto il cielo, l’ampia fronda della mimosa fornisce loro rifugio, quindi ritornano a volare liete per le stillanti lande e attraversano l’arcobaleno con le ali scintillanti. Spesso, bramose di andare a visitare i profondi recessi dei boschi, vanno tra i verdi labirinti dell’Amazzonia o perlustrano in placida schiera la calda giungla del Borneo. Allora superano le felci sparse e le liane attorcigliate e il buio fitto della foresta spegne il colore delle ali. Ma se un raggio di sole improvvisamente penetra attraverso gli spiragli delle fronde e l’ombra violata si tinge di oro, ammirerai rosee gocce sulle grandi ali, la nera viola mescolarsi allo splendido smeraldo e accendersi mille parvenze di oggetti dipinti. Ma un volo debole e fiacco e la stessa vasta bellezza delle ali le impaccia, sfinite dal remeggio e dal torpore di tanto sole. Al contrario, l’esperienza ci ha insegnato quanto sia veloce quella farfalla azzurra fornita di ali piccolissime, frequente abitatrice della nostra campagna, nome spartano di Lisandra; i fanciulli la inseguono con una reticella o con le mani, ma quel frammento di cielo, fluttuante e sciolto da vincoli, ora in un modo ora in un altro si fa gioco del cacciatore inetto. // Ma non a tutte piace questa luce dorata del sole: altre preferiscono le notti arcane e le stelle. Una condottiera famosa è alla testa di questo popolo insonne, il cui grave nome ricorda le tenebre dell’Averno e le rive dell’avido Acheronte. Ne segna la corazza un orrendo e spaventoso teschio, e non si sa dove nasconda la sua flebile tromba (toccata, fa uscire una gracile voce dal fondo del petto). A ciò aggiungi un’asta corta, ma fornita di una punta acuminata, con cui penetra i fiori o i tronchi lesi da una ferita, bevendo le lacrime che ne sgorgano. Anche entra di nascosto negli alveari e fora i tetti di cera, traendo dalle celle il profumato dono Ibleo. È presenza molesta ed ostacolo al fervido lavoro: tuttavia tocca anche a lei pagare il fio alla prima occasione. Se infatti accade che questa ladra arrogante, satolla di miele, abbia pigramente preso sonno nell’ombra bionda, le api s’accostano all’incauta e la circondano fremendo: lentamente e gradatamente allora l’ospite scomoda è ricoperta di glutine e pone la vita in quella tenace colla. Poi il lento glutine diventa più duro della stessa cera e domani l’apicoltore, aprendo gli alveari pieni di miele, sotto la propoli vedrà un cadavere secco e le ali sepolte nereggiare come attraverso un’onice trasparente. Addirittura, una volta ha osato entrare in casa nostra, attirata dallo splendore sospeso della finestra aperta. Arriva, riempie la stanza del suo rauco ronzio e sbatte furiosamente il capo e le ali contro le parenti. Non so che paura tiene allora tutti gli animi; perfino il cagnolino, custode della dimora (una volta coraggioso), improvvisamente arretra e abbaia alle ombre che questa prole di Ecate getta sul soffitto, volando senza fine attorno alla lampada accesa. // Un’altra farfalla (a cui dà nome la Cecropide) appare di sera, e di nascosto raccoglie la lunga proboscide in una spirale mentre attraversa in volo le nere ombre; se da qualche parte si schiudono le Belle di Notte o l’erratico Convolvolo e la Viola selvatica, la svolge completamente e la introduce nei profondi calici: gode della dolcezza del succo, né si posa nel fiore, ma resta sospesa tremolante nell’aria, tanto fittamente e tanto rapida scuote le ali leggere. Così essa abita in silenzio le tenebre e sugge l’anima soporifera e dolce dei fiori, mentre le stelle stanno a guardare. Visita anch’essa le case e una volta partecipò alla nostra cena, preferendo la sala illuminata alla notte; stette sopra la bianca tovaglia, tra grandi bicchieri svolse la spirale e degustò il vino, aereo commensale che disdegna di mettersi a tavola. // Inoltre, volino di notte o nel mattino sereno, alcune non abbandonano mai il buon ramo o il morbido prato grazie al quale si nutrono: così la graziosa Lycena dal vestito giallo cinto di un orlo nero, Ermione abitatrice dei boschi, Melanargia che orna di bianche macchie la liscia veste scura della campagna. Intanto qualcuna si allontana con volo rischioso dalla sede natale: supera il colle o il fiume, finché una cascina l’accoglie con i suoi orti chiusi; qui riposando su un fiore turchino di pervinca ritmicamente apre e chiude con dolcezza le ali. Nate di notte, le Sfingi che la terra di Africa nutre trasvolano il mare Mediterraneo senza alcuna compagnia. Viaggiando in linea retta tendono ai lidi settentrionali; e una volta una ignara nave diede ospitalità ad Erse e Macroglossa (aerei spettri) sulle sommità delle antenne, la scura Acherontia si nascose nelle cavità della carena dopo essersi introdotta di nascosto per la stretta feritoia del fianco. // La Danaus talvolta lascia le selve della Virginia e la campagna dell’Alabama: confusamente ferve nell’aria un popolo di ali e si dirige verso il lontano Austro. Quando infine scorgono lo stretto dell’azzurra Panama che mescolò il flutto dei due mari dopo che l’istmo fu tagliato, la massa esule si divide in due schiere: una fa rotta da lì attraverso le onde atlantiche, una verso l’Oceano della Pace e il tramonto del sole. Allora il gruppo continua a volare senza fine a pelo del mare, e dove l’orizzonte tocca l’acqua una volta parve al marinaio che Teti esalasse un vapore tremulo, mentre esse senza alcun ordine valicavano i confini del cielo. Tuttavia la morte le attende lenta nelle regioni dell’Europa e dell’Asia né esse popolano le nuove campagne con nuova prole. Infatti l’alata forestiera ha succhiato con piacere i fiori sconosciuti, ma poi il bruco vagando ha inutilmente cercato un pascolo adatto a lui; rifiuta il cibo esotico; separandosi dalla fronda sgradita, subito cade giù e giace nell’arida polvere delle strade. Intanto la Danaus è sparita dalle nostre regioni: era stata una grande tribù, ora nella sera se ne aggira una sola, che raccoglie trepidante le tracce dell’ultima luce. L’autore stesso di un famoso libro sulle farfalle esita incerto sulla causa della migrazione. // La loro vita scorre più veloce rispetto ai bruchi, e Libitina non è molto lontana dal lieto imeneo. Fremono d’amore per la prole. Insieme, a un certo punto, il tiaso alato rintraccia dall’odore la fugace futura sposa; spesso le bianche Pieridi abbandonano il loro territorio e di buon mattino penetrano nella città in bianco manipolo, corteo della nuova sposa. Ma domani, trascorsa ormai la notte, il marciapiede mostrerà un massacro di ali. E imitando gli occhi del Pavone, Saturnia è in procinto di unirsi al mesto sposo al quale è riservata una morte prematura, poiché è privo dell’asta sottile per succhiare i fiori; e le rigide Parche gli assegnano un destino di tre giorni: Atropo gli troncò la vita mentre tremante bramava il talamo e svolazzava tra le ombre. // Una farfalla sopravvive serena mentre l’inverno incombe: fiamme rosse le dipingono le ali scure: i francesi la chiamano giustamente Vulcano, abita la campagna e il bosco ma spesso è migrata nelle deserte terre di Borea e l’accoglie l’estrema Tule. Ora quella che vedemmo frequentare le uve tardive cerca invano un riparo sicuro dalle nevi, esplora le mura, vola attorno all’arco del ponte; e se avviene che si agiti in casa, trattenuta da una finestra, e sbatta disperata contro il vetro, tu apri alla prigioniera la gabbia trasparente, lascia che per gli spogli frutteti sia padrona del poco tempo della vita che le resta. [trad. di Betty D’Agostini]
CAELUM SACELLI XYSTINI
Sacras historias, mira quas arte Sacelli
Xystini Michael Angelus in camera
pinxit, inassueto stupeo splendere nitore
tamquam sol infans irradiaret eas.
Iam non annosi vestigia turpia fumi
quem spiraverunt thura piaeque faces,
non pulvis, Christi proavorum stratus in ore
seque Sibyllarum vestibus insinuans,
pristina degenerant pigmenta: serenior aer
caerulea scaenas virgine luce replet.
Ut cum post pluviam coepit sol rumpere nubes
et campos radius luminis ecce ferit
expergefaciens herbae florumque colores
sublustri visos delituisse die,
sic in miranda camera, quocumque tueris,
omnia caelesti lumine tacta nitent.
Haec ars pictoris: non ille coloribus usus
est vespertinis, ut docuere libri,
sed situs annorum species velabat et eius
verum pingendi texerat usque genus.
Nunc opus exutum nebulis fallacibus aevi
ceu modo depictis ridet imaginibus
redditaque est illi nimbosae gratia musae
quae Genesin rutili turbinis instar habet.
En Deus abscindit solida caligine lucem
atque inter tenebras flutat et acre iubar;
humanam vestit speciem: manus altera nocte
mersa madet tenebris, altera luce micat,
quin Illum mundi prolixa annosaque barba,
cana ut flos mali, commonet esse Patrem.
Et postquam Tempus peperit iussitque dierum
ut sol dux esset lunaque noctis hera,
aurea per caelos stellarum semina spargit
perpetuis tenebras ignibus ut vigilent,
a terra disiungit aquas maris aequora pandens
dum fremit indocili murmure triste chaos.
Et quam perspicuum fuit immemorabile mane
quo lucem mundi primitus hausit homo!
Pictores Adam multi fecere iacentem
dum manus e terra sublevat ipsa Dei;
ille aliquid miri scaenae super addidit ut si
caelestis quidam spiritus afflet eum.
Adam nam viridi recubantem ponit in herba:
iam caput extollit tergaque lentus adhuc,
cumque Deum cernat prope adesse, en poplite fultam
invalidam laevam porrigit ille Deo,
Quem venti librant, caelestia pallia tamquam
carbasa conflantes, angelicusque chorus;
atque etiam Dominus digitum protendit in Adam
porrectamque manum tangere paene potest:
sed non omnino tetigit scintillaque vitae
Eius suspenso floruit e digito.
Quae tamen aspicimus nos nunc miracula, nostri
viderunt crepera luce repressa patres.
Per parvas lunas et curva triangula (muris
quae cameram picta concavitate iugant)
maiorum Christi tunicae laenaeque renident
sericaque oblito texta colore vibrant.
Induit hebraeis peregrinos pictor amictus
illisque eoos imposuit petasos,
sic priscum simulans habitum cultumque virorum
Messiam trepidi qui cupiere diu.
Ast ubi Matthaeus proavos ab origine censet
quorum divinum germen Iesus erat
et quadraginta memorat duo nomina patrum,
et matres pictor filiolosque videt.
Patres filiolis locat atque uxore remotos
aegro animo visos vivere tempus iners.
Restaurata aliquid series non ante notatum
artificisque palam condita sensa facit.
Nonne sui vultus manifeste in vultibus Azor
effinxit pictor tristitiamque suam?
Matrem perdiderat sex annos natus et usque
vivum sub tacito pectore vulnus erat,
nec nidum proprium, puerum neque noverat unquam
qui «pater!» exclamans obvius iret ei.
Pictor, non Azor, limis post terga tuetur
matrem quae nato leniter alloquitur.
Conivet cordisque cavam secedit in umbram,
transverso meditans indice labra tegit:
aeque est ille pater sub pectore, filius aeque,
duplex intravit lumina maesta dolor.
Ecce Prophetarum vetere emergente colore
atque Sibyllarum pristina verba sonant.
Limina Zacharĭas servat, Davīdis in urbem
qui Christi ingressum vaticinatus erat,
sacra voce canens: «Exsulta, filia Sion!
laetitia clama, filia Ierusalem!
Pauper, demissus, mansueto vectus asello,
en tuus intrabit rex Hierosolyma».
Frons praecalva Ioel insignit pariete dextro;
genua umerosque tegunt pallia tincta Tyro.
Evolvit longam tractim tenuemque papyrum
in qua clementem prodidit esse Deum
atque iras, quamvis iustas, persaepe morari,
semper Eum missi paenituisse mali.
A regione Ioel est Delphica picta Sibylla
caerula cui velat maesta lacerna caput,
funiculus prasinam tunicam sub pectore stringit
mordet et ad laevum fibula curva latus.
Ex eius spirat labris arcana iuventa,
ardores animi pupula nigra refert;
iamque librum sacro correpta affiamine liquit
et procul in vacuum lumina fixa tenet.
Surgit Erythrarum non orto sole Sibylla
(haud procul Ionii personat unda maris).
Iam puer accensam faculam lychno admovet inflans
in dubiam flammam, clarus ab igne, genas,
dum seorsum positus puer expergiscitur alter
lumina languidulus semisopora terens;
et lychno similis mens sublucana Sibyllae
post somni tenebras ardet et ante diem.
Vultus ad puerum convertit pone loquentem
Esāias (penetral cordis at usque tenet).
Nescio quid vati digito puer indicet, eius
sed turbat cirros aura coorta domi
et ventus limbum vult secum ducere veli
quod teneris alte fluctuat ex umeris.
Fors vati patulas communicat esse fenestras
et caelo nimbum se cumulasse gravem;
ast alius ventus spirat sub corde Prophetae,
auribus auscultat, mens procul exsul abit:
infantem longe videt ille a virgine natum
cuius vagitum sceptra superba tremunt.
Divina Ezechĭel vox appellasse videtur,
ora retro flectit, barba imitante nivem.
Eminet ingenti Cumaea Sibylla figura
aevi infiniti non memor illa sui,
et quamvis rugis facies sulcetur, in ulnis
ac nudis umeris cruda senecta patet.
Persica, et ipsa vetus, multis sub vestibus alget,
librum iuxta oculos luscitiosa tenet;
mentis at obtutus longum spatiatur in aevum
quin etiam finem Temporis illa videt.
Ingens in gremio Daniel mirare volumen
quod cervice regit parvulus impar Atlas!
Mente vigens alacri pleno sub sole iuventae
nonnihil in chartis adnotat ille suis,
sed nos quae scripsit iubet obsignare, statuto
utpote quae tantum sint retegenda die.
Qualis Hieremĭae pectus dolor occupat altus?
Quae nova cor vatis sollicitudo premit?
Vox eius suerat Domini portendere poenas,
sed populi lacrimas quam miseratus erat!
En caput inclinat curarum pondere lassum,
mentum canutum sustinet ille manu.
Ut demum exstingui caeli desiderat iram!
Ut prope iam regnum somniat esse Dei!
At Lybicae vatis spirans apparet imago,
nunc ipsum tacito visa furore capi;
et sicut Dominus qui proximus agmina lucis
extentis manibus separat a tenebris,
brachia pandit item librum clausura Sibylla
immensum, gestu paene imitata Deum:
et vacuum Deus omnipotens illuminat, illa
hoc hominum tempus carmine vaticino;
claudere nisa librum simul et consurgere, pallam
explicat ardentem versicolore croco.
Ingens hanc iuxta Ionas impendet in aram
et sacri spatium prospicit omne loci.
Qui gemuit nigra balaenae clausus in alvo
nunc ista attoniti luminis antra stupet.
Non volvit libros neque secum cogitat alte,
occupat illi oculos irrequietus amor.
Ionas, cui dederat Dominus novisse futura,
praeteritum mundi noscere tempus avet,
sed super astantes nequit aspectare figuras,
declivi camerae margine namque sedet.
Tum pectus nisu resupinat collaque torquet,
grande thronum cubito dexteriore premit;
e curvo dicas prorumpere pariete crura,
indicibus tensis fors vetus ira subest
cum nequam Ninivae Dominus peccata remisit
aut umbram vati vermis adempsit edax.
Sed lucem tenebris seiungi denique cernit
et vere iustum colligit esse Deum.
Nec mirum tanto sit Ionas factus honore,
alvum cum Michael Angelus ipse cavam,
inter captivus cameram tabulataque summa,
noverit angusti suppliciumque loci,
dum stans depingit, laquearia vertice lambens,
aut iacet et recidens stillat in ore color;
et quamvis tacita solus depingat in umbra
divinum generant carcer et umbra iubar.
Huius sed nobis obscuro tempore saecli
nunc egressuris spes quoque lucis abest.
En duo complentur millennia, caelitus ex quo
inter nos venit filius ipse Dei,
hactenus et fera bella manent ac funera fratrum
innocuo quorum sanguine terra madet,
dum res humanas facinus fraudesque gubernant
atque obscuratur religionis amor.
Tum corde ausculto nostrum si forte futurum
Ionas vel quaedam sacra Sibylla canat.
IL CIELO DELLA CAPPELLA SISTINA
Le sacre storie che con arte meravigliosa dipinse
Michelangelo nella volta della Cappella Sistina,
le vedo stupito splendere di un insolito nitore
come se le irradiasse un sole appena nato.
Non più ormai le turpi tracce di un fumo antico
esalato da incensi e da pie torce,
non la polvere che copriva il volto degli avi di Cristo
e s’insinuava nelle vesti delle Sibille,
guastano le originarie tinte: un’aria più limpida
riempie le scene di azzurra vergine luce.
Come quando dopo la pioggia il sole comincia a squarciare le nubi
ed ecco colpisce i campi un raggio di luce
richiamando in vita i colori dell’erba e dei fiori
che sembravano scomparsi durante il giorno in penombra,
così nella volta meravigliosa, dovunque tu guardi,
tutto splende toccato da un lume celeste.
È questa l’arte del pittore: non ha usato colori
vespertini, come i libri ci hanno insegnato,
ma il deposito degli anni velava le figure e aveva
nascosto il suo vero modo di dipingere.
Ora l’opera spogliata dagl’ingannevoli filtri del tempo
splende d’immagini che sembrano appena dipinte
e ha ritrovato la grazia di una musa tempestosa
che vede il Genesi come un’abbagliante burrasca.
Ecco Dio distacca la luce dalla compatta caligine
e galleggia a metà fra le tenebre e il vivo splendore;
veste sembianze umane: una sua mano, immersa
nella notte, è bagnata di tenebre, l’altra scintilla di luce,
anzi la barba dilagante ed antica, bianca come il fiore del melo,
ci ricorda che Lui è il padre dell’universo.
E dopo aver generato il Tempo e ordinato che il sole
fosse la guida dei giorni e la luna padrona della notte,
sparge per i cieli la semente d’oro delle stelle
perché sorveglino le tenebre coi loro eterni fuochi,
separa dalla terra le acque aprendo le distese del mare
mentre con un ribelle mormorio freme il caos tenebroso.
E come fu limpido quell’indicibile giorno
quando per la prima volta l’uomo bevve la luce del mondo!
Molti pittori hanno ritratto Adamo nell’istante
in cui lo solleva da terra la mano stessa di Dio;
ma alla scena egli ha aggiunto qualcosa, come se
uno spirito celeste lo investa del suo soffio.
Dipinge infatti Adamo sdraiato sul verde dell’erba:
già, non ancora in forze, solleva la testa e la schiena,
e vedendo che Dio gli è vicino, ecco a Dio porge
la mano fiacca che si appoggia sul gomito,
Dio che librano i venti gonfiando come una vela
il suo mantello celeste e che libra il coro degli angeli;
e anche il Signore protende verso Adamo il suo dito,
e sta quasi per toccare la mano che gli vien porta;
ma non l’ha nemmeno toccata che già la scintilla
della vita fiorisce dal suo dito sospeso.
Tuttavia le cose stupende che noi oggi scorgiamo, i nostri
padri le hanno viste velate da una luce crepuscolare.
Attraverso i lunotti e i curvi triangoli (che uniscono
la volta alle pareti con una concavità dipinta)
rilucono le tuniche e i mantelli degli antenati di Cristo
e i tessuti di seta vibrano di un colore dimenticato.
Il pittore fa indossare agli ebrei abiti esotici
e mette loro cappelli di foggia orientale:
così con immaginari vestiti egli rappresenta le antiche
generazioni che a lungo bramarono il Messia.
Ma là dove Matteo passa in rassegna fin dalle origini gli avi
dei quali Gesù era il divino germoglio,
e trascrive il nome di quarantadue padri,
il pittore scorge anche le madri e i bambini.
Colloca i padri in disparte dalle madri e dai piccoli: sembrano
vivere con l’anima in pena un tempo stagnante.
Il restauro della serie svela dell’artista qualcosa
che prima non si notava e i suoi pensieri segreti.
Non è evidente che nel volto di Azor il pittore
ha ritratto il proprio volto e la propria tristezza?
Aveva perso la madre a sei anni e quella ferita
continuava in silenzio a vivere dentro di lui,
non aveva mai avuto un suo nido né conosciuto un bambino
che gridasse «padre!» correndogli incontro.
È il pittore, non Azor, a guardare di sottecchi alle spalle
la madre che dolcemente conversa col suo figlioletto.
Abbassa le palpebre e si rifugia nella cava ombra del cuore,
con l’indice di traverso sigilla pensieroso le labbra.
È insieme un padre e insieme un figlio nel profondo dell’anima,
il dolore nei suoi occhi mesti è entrato due volte.
Ecco col riemergere del colore d’un tempo risuonano
le antiche parole dei Profeti e delle Sibille.
Zaccaria è il custode della porta, lui che aveva vaticinato
l’ingresso di Cristo nella città di Davide,
con sacra voce cantando: «Esulta, figlia di Sion!
Grida di gioia, figlia di Gerusalemme!
Povero, dimesso, in groppa a un mansueto asinello,
ecco entrerà il tuo re nella Città Santa».
L’ampia calvizie della fronte distingue Gioele sulla parete di destra;
un mantello di porpora di Tiro gli copre le ginocchia e le spalle.
Srotola a poco a poco un lungo e sottile papiro
nel quale ha reso noto che Dio è clemente
e spesso trattiene, per quanto giuste, le sue collere,
sempre si pente di averci inviato un castigo.
Dirimpetto a Gioele è dipinta la Sibilla di Delfi,
le vela il capo un’azzurra mesta lacerna,
una cordicella le stringe sotto il seno la tunica di tenero verde
che una fibbia ad uncino morde sul fianco sinistro.
Un’arcana giovinezza spira dalle sue labbra,
la nera pupilla trasmette gli ardori del cuore;
rapita da un sacro afflato abbandona il suo libro
e tiene fissi i suoi occhi lontano, nel vuoto.
Si alza la Sibilla di Eritre prima che sorga il sole
(non lontano risuona l’onda del mare Ionio).
Già un fanciullo accosta un’esca accesa alla lampada e gonfia
contro la fiamma incerta, riverberato dal fuoco, le gote,
mentre, in disparte, un altro fanciullo si sveglia
sfregandosi fiaccamente gli occhi ancora assonnati;
e la mente albale della Sibilla come la lampada
arde dopo le tenebre della notte e prima del giorno.
Gira la faccia verso il fanciullo che parla alle sue spalle
Isaia (ma non esce dal penetrale del cuore).
Non so cosa il fanciullo indichi al vate col dito, ma una corrente
levàtasi dentro la casa scompiglia i suoi riccioli
e il vento vuol portare con sé un lembo del velo
che fluttua a mezz’aria dalle sue tenere spalle.
Forse comunica al vate che le finestre sono aperte
e che in cielo si è accumulata una cupa tempesta;
ma un altro vento spira dentro il cuore del profeta,
ascolta con le orecchie e intanto la sua mente vaga esule altrove:
vede in lontananza un infante nato da una vergine
al cui vagito tremano gli scettri superbi.
Una voce divina sembra aver chiamato Ezechiele,
volge indietro la testa, la sua barba somiglia alla neve.
La Sibilla Cumana spicca per la sua vasta figura
(non ricorda il numero infinito dei suoi anni),
e sebbene abbia il viso solcato di rughe, nelle sue braccia
e nelle spalle nude si palesa una cruda vecchiaia.
La Sibilla Persica, anch’essa vecchia, ha freddo benché infagottata
di abiti e, miope, tiene il libro vicinissimo agli occhi;
ma lo sguardo della sua mente si estende lontano nei secoli,
che anzi lei vede anche la fine del Tempo.
Guarda che enorme volume ha in grembo Daniele!
Glielo sorregge sul capo un piccolo ìmpari Atlante.
Con la mente alacre e pronta, nel pieno sole della giovinezza,
Daniele sta annotando qualcosa nelle sue carte,
ma ci ordina di sigillare le cose che ha scritto, perché soltanto
nel giorno stabilito si dovrà sciogliere il loro segreto.
Quale alto dolore colma il petto di Geremia?
Che nuova angoscia opprime il cuore del vate?
La sua voce era solita predire i castighi del Signore,
ma quanta pietà provava per le lacrime del popolo!
Ecco piega la testa spossata dal peso di tanti pensieri,
con la mano sorregge il mento canuto.
Come brama che finalmente si estingua l’ira del cielo!
Come sogna che già sia vicino il regno di Dio!
Ma appare come fosse viva l’immagine della profetessa Libica,
sembra colta proprio in questo momento da un segreto furore;
e come il Signore che lì vicino separa la massa
della luce dalle tenebre allargando le mani,
allo stesso modo la Sibilla spalanca le braccia per chiudere un libro
immenso, quasi imitando Dio col suo gesto:
e Dio onnipotente illumina il vuoto, lei
questo tempo umano col suo carme profetico;
cercando di chiudere il libro e insieme di alzarsi, dispiega
il lungo abito ardente di croco dai riflessi cangianti.
Accanto ad essa un Giona enorme incombe sopra l’altare e dall’alto
abbraccia con lo sguardo tutto lo spazio del luogo sacro.
Lui che gemette, prigioniero nel ventre oscuro di una balena,
ora guarda stupito questi antri di attonita luce.
Non sfoglia libri, non è immerso in profondi pensieri,
un desiderio assillante è dentro i suoi occhi.
Giona, al quale il Signore aveva concesso di conoscere il futuro,
brama di conoscere il tempo passato del mondo,
ma non può contemplare le figure che stanno sopra di lui,
siede infatti ai margini della volta, là dov’essa declina.
Allora con sforzo piega il petto all’indietro, torce il collo,
col gomito della destra si puntella sul grande trono;
diresti che le sue gambe prorompano dalla curva parete,
negl’indici tesi c’è forse una traccia dell’ira di un tempo
quando alla malvagia Ninive il Signore rimise i peccati
o un verme ingordo lo privò delle foglie che gli facevano ombra.
Ma finalmente vede la luce staccarsi dalle tenebre
e ne deduce che Dio è veramente giusto.
E non è da stupirsi che Giona sia stato dipinto con tanto rilievo
perché anche Michelangelo conobbe la cavità
di un ventre, prigioniero tra l’alta impalcatura e la volta,
e il tormento di uno spazio tanto angusto,
mentre dipinge in piedi, sfiorando con la testa il soffitto,
o sdraiato, e il colore che ricade gli sgocciola in faccia;
e sebbene dipinga in compagnia soltanto del silenzio e del buio,
quel carcere e quel buio danno vita a un divino splendore.
Ma noi, che adesso stiamo per uscire dal tempo
oscuro del secolo, non abbiamo nemmeno una speranza di luce.
Ecco si compiono due millenni da quando tra noi
è giunto dal cielo il figlio stesso di Dio,
e ancora ci sono guerre feroci e stragi di fratelli
del cui sangue innocente è imbevuta la terra,
mentre delitto e frodi governano le cose umane
e l’amore per le cose celesti si oscura.
Allora col cuore ascolto se per caso Giona o una qualche
sacra Sibilla predica il nostro futuro.
NOTA
Il poemetto Caelum Sacelli Xystini è stato premiato nel Certamen Vaticanum del 1996. La retorica chiama questo genere di scrittura letteraria, che descrive un’opera d’arte, ecphrasis. Se ne trovano innumerevoli esempi, da Virgilio a Proust. Gli antichi mescolano liberamente la descriptio alla narratio, al racconto dei fatti dipinti o scolpiti nell’opera. Lo pseudo-Esiodo nello Scudo da lui descritto “vede” anche i rumori.
La quantità prosodica dei nomi ebraici dei personaggi delle Sacre Scritture segue quella codificata dai poeti latini cristiani (Prudenzio, Giovenco, Sedulio, Venanzio Fortunato, ecc.). Nella descrizione dei singoli profeti si fa riferimento a passi dei loro libri raccolti nella Bibbia.
ANGUILLA
Anguilla borealium
syrenen marium, quae mare Balticum
linquens nostra petit vada
ac nostros fluvios; hos penitus dehinc
adverso subit agmine
rivorum penetrans multifidas vias
se porro tenuantium,
usque ad saxa iugi, turbidulos luto
inter lapsa lacusculos
missum donec eam castaneis iubar
e spiramine frondium
incendit trepidam per resides aquas
Appennini ubi saltibus
in Romaniolam fossula decidit;
anguillam faculae parem
vel flagro, Paphii vel iaculo dei,
quam nostrae modo fossulae
Pyrenesve macer rivulus aridae
in pontum referunt maris
ad laetam venerem, caesius ut lemur
vitam strenua quaeritans
solum saevit ubi squalida siccitas;
quae, scintilla fugax, monet
res enasci iterum quas sub humo fere
carbonescere crederes;
cui splendore brevi gemmula pupulae
aeque quam tubi fulgurat
ex umbra cilii cum legis integra
humanum luteum genus –
quidni credideris paene sororculam?
Eugenio Montale, L’ANGUILLA L’anguilla, la sirena / dei mari freddi che lascia il Baltico / per giungere ai nostri mari, / ai nostri estuarî, ai fiumi / che risale in profondo, sotto la piena avversa, / di ramo in ramo e poi / di capello in capello, assottigliati, / sempre più addentro, sempre più nel cuore / del macigno, filtrando / tra gorielli di melma finché un giorno / una luce scoccata dai castagni / ne accende il guizzo in pozze d’acquamorta, / nei fossi che declinano / dai balzi d’Appennino alla Romagna; / l’anguilla, torcia, frusta, / freccia d’Amore in terra / che solo i nostri botri o i disseccati / ruscelli pirenaici riconducono / a paradisi di fecondazione; / l’anima verde che cerca / vita là dove solo / morde l’arsura e la desolazione, / la scintilla che dice / tutto comincia quando tutto pare / incarbonirsi, bronco seppellito; / l’iride breve, gemella / di quella che incastonano i tuoi cigli / e fai brillare intatta in mezzo ai figli / dell’uomo, immersi nel tuo fango, puoi tu / non crederla sorella?
MORS IN SPATIO
(commenticia rerum futurarum fabula)
Longinquas Cygni, spatium permensus et annos,
attigerat stellas irrequietus Homo
et simul anterior statio, simul ultima Thule
immensi nobis sideris umbra fuit.
Hac vasta septem caeli regione planetae
se volvunt, notus nomine quisque suo,
et circum Deneb magni vacuique feruntur,
praecipuum Cygni turbineumque iubar
in cosmi tabulis quod littera denotat ἄλφα;
attamen haud stellae calfacit ignis eos.
Nam nimis extentos orbes et aphelia longe
dissita percurrunt: inde perennis hiems
incertique dies quos sera crepuscula dicas
caerulea et glacies omnia paene tegens.
Unum de septem colimus cui nomen Adrastus;
est minus a Deneb longus at alget item:
imis thermometrum numeris atrociter haeret
et quam fundis humi dum cadit unda gelat.
Cum ningit frigus minuit, sed vellera densa
ecce novi torquet vis aliena Noti;
lunae nocte duae, si nimbus forte remisit,
candore inficiunt ulteriore nives.
Ut liceat nobis immiti evadere caelo
et meteorolithis qui sine fine cadunt,
urbs inferna iacet, tabulatim structa, planetae
sub rigida crusta perpetuoque gelu.
Pensilibus cellis in partes urbis inimus,
usque ad longinquas inferiusque sitas,
aut cochleis (sed tardus erit descensus ab illis)
quae tractim penetrant oppida mersa decem.
Tum stupet immissam lucem violatus Avernus
necnon per plateas per celebresque vias
insolitos rursum prorsum cursare animantes,
procero passu lenta robota gradi…
Advocat in coetum resonans nos nuntius olim
omnibus ingeminant quem megaphona viis.
In quinti propere tabulati pergimus urbem
nostra relinquentes summa vel ima loca:
illic imperii sita sunt praetoria nosque
sparse adventantes excipit aula capax.
Nauarchi taciti, distincti insignibus aureis,
notum qua causa coetus agatur habent;
pone ignara sedet numerosaque nautica pubes
risu decipiens rite iocisque moram.
Oh, iuvenes vultus memini sociosque, futura
quorum sarcophagus naufraga navis erat!
Sed quidam magna inox voce «attendite!» clamat.
Surgit et immotus quisque silensque manet.
Dux ingressus erat qui castra hypogaea planetae
et firmamentum sideris omne regit.
Lustrat nos oculis (omnes et nomine novit
tantos post annos!) atque sedere iubet,
et «spatii nautis loquimur callentibus» infit,
«quorum per stellas inclyta fama volat.
Iampridem generi patuit Via Lactea nostro;
sidera nacti, hominum saecula multa, sumus.
Stirps Adae vidit miracula Cassiopeae
astris implosis quae violenta rubet,
Andromedae vidit nebulosa enormia pasci
priscae caelestis pulvere materiae
et somnurna velut phantasmata nare cometas
per Cephei vacuas horriferasque plagas.
Nos in visceribus taetri gelidique planetae
ut talpae fossas incolimus latebras
iamque diu nostrae torpentes frigore naves
sub nivis aggeribus sub glacieque iacent!
A Terra venit speratus denique iussus
tendere in ignotam praecipimurque Lyram.
Sunt opus ante tamen quam devolet agmine classis
exploratores qui speculentur iter:
hoc navi Ionae munus committitur, illi
intentata erit haec antevolanda via;
et Deus incepto faveat!». Sic desinit ille,
attonitum vocum murmur ubique sonat.
Binos terrestres dein navis nostra per annos
continue caeli templa remota fidit.
Xı Cygni, paribus cessans iubar intervallis,
palpebrantem oculum clauserat in tenebris
dum sensim minuens Deneb fit gutta corusca
quam spatii longe caeca vorago bibat.
Saepe gubernandi, iussus, vice fungor et unus
adiutor mecum est, artis alumnus adhuc.
Amplam translucens tegit hemisphaerion aedem
in prora positam, mens ubi navis inest.
Praescriptum dum fida tenent moderamina cursum,
instrumentorum daedalus ordo vibrat:
a multiplicibus tabulis monitorius olim
index scintillat tinnula signa ciens,
calculus algebricus vitreo comparet in albo
de navis motu nos posituque docens.
Dispatet exterius nox desolata sed intus
in navi stabilis fulget ubique dies
perpetuusque chalybs cum totum vestiat alveum,
solum per tenebras enitet ille tholus;
aedem si obscures tremulas est cernere stellas
et spatii regnis invigilare cavis.
Uranii nucleus semoto exardet in antro;
nostrum vis eius vivida momen alit
iugi et curriculo per concava membra, per artus
navigii murmur ceu penetrale fluit.
Ionas nomen erat navi pristisque videmur
quae caeli pelagus praepete mole secet.
Et iam βῆτα Lyrae propius splendere videbam,
iam maior Vegae caesius ignis erat.
Olim dum nobis nigra quaedam stella minatur
flammas e rabido corde subinde vomens
(a longo contra interitum nam dimicat aevo
cum nuclei furiam stringat iners gasium),
quae mecum meditor dederam: «Regionibus istis
turbida mors tantum sacer adestque pavor.
O Terrae campos ubi vixi cum puer essem,
laetos aestiva luce nitente dies!
En mihi succurrit dulcissima matris imago
me implicitum ducit dum per aperta manu.
Luteolum viridi quacumque taraxacus herba
iam caput exseruit magnaque prata replet;
tum flore evellens achenia plumea mater
pappos cum risu flabat in ora mea…
Nusquam, tot mundos mensi tenebrasque, planetam
comperimus Terrae fertililate parem,
quem mites pingant variatae fructibus horae
caeruleusque color aeris ac marium.
Quidnam per caelos adipisci ardemus? Eritne
calx unquam nostrae torva sub astra viae?».
Vix ea fatus eram cum formidabilis index
instrumentorum fulgurat in tabulis
et necopinatum navi prope adesse periclum
fractis scintillis commonet atque sono.
Mi Deus! Id rutilans nostri bene noverat omen
causam naufragii! Nos tamen illa latet;
praemonitam nescimus utrum latura ruinam
sit cava nox mundi navis an ipsa paret.
Cor nobis citius saliebat pulsibus aequans
intervallatae tempora crebra facis,
cum mox exstingui coeperunt lampades omnes
navisque in tenebris mersa repente silet.
Non erat eventus nullius temporis ille!
Saepius exstingui lampadas acciderat,
abruptus sed forte fluor si electricus esset
se nova pandebant lumina sponte sua;
nunc umbra exterior penetrare haud cessat in aedem
astraque per cameram lucidiora nitent.
Lampadio tabulas manuali scrutor ubique
at nihil indicibus cogitur e tacitis;
caelestes numeros quod computat instrumentum
quantumvis pulsem plectra moratur iners:
non algorythmis quanto volet impete navis,
non notat ellypsi quo teneamus iter;
pergimus ire tamen neque prorae possumus altum
corrigere impulsum nec retinere fugam.
Ex imo interea surdum consurgere murmur:
tractim navigii vasta caverna tonat.
Me rauca socius compellat voce: «Quid hoc est?»,
atque ego pro certo nos periisse scio.
Mente quid eveniat video, quae turbinis instar
vis illic deorsum res hominesque petat:
captivi rabies atomi sua claustra revulsit,
attonitum temere per penetrale furit.
Omnia delet edax, nautarum corpore raptim
se circumvolvit, luminis acer halos.
Sunt aliqui vice quisque sua de more cubantes
in propriis cellis quos premit alta quies:
exitialis eos fulgor somno excutit et iam
clamandi cupidas mors replet igne gulas.
Sub prorae camera quam personat alta ruina
hactenus indemnes incolumesque sumus
et «servate animas nostras!» sine fine per undas
quaesumus aetherias, spes quia nulla manet.
Non omnis muta est antemna: electridis illi
voltametrum nobis dat superesse notas…
Nuntia fors aliquis quae mittimus audiet etsi
vis radians Vegae fortiter obstet eis…
O, utinam Cygni classis nos pone sequatur
proxima iam volitans a regione Lyrae,
aut stellis istis statio spatialis oberret
quae cosmi voces hauriat aure cava!
Sed fauces nostras subitaneus occupat angor
tussis et ambobus pectus anhela quatit.
Ad socium «caveas!» clamo, «iam deficit aer!
Oxygenî nobis est opus auxilio!».
Bracatam trepidi tunicam cum casside, duro
facta ex chrystallo, protinus induimur
et primos avide iam ducimus aeris haustus
cum mille in partes dissilit ecce tholus
nosque reluctantes vis arripit horrida mundi,
secum per tenebras imperiosa trahens.
Et nunc caerulea spatii fluitamus in umbra,
corpora quae nullum naufraga pondus habent,
fragmina dum camerae, displosae ut semina stellae,
circum nos ningunt candificata gelu.
Tercentum circa metris chalybeia distat
navis et interno turbine quassa tremit,
donec pars lateris veluti flos igneus hiscit,
sed sensim nullo rumpitur illa sono,
haec ut si miro fierent in horamate quod se
lentis ac tacitis volvat imaginibus.
Heu, comiti tunicam schidiae scissere metalli
perque foraverunt aeris excipulum,
utque manus agitat quasi prendere vellet inane!
Illi per rimas vita sed usque fugit.
En minus atque minus super atram pronus abyssum
se movet, en tunicae brachia pandit iners,
alba nigris visus nymphaea paludibus innans,
dum me nescio quae longius unda vehit.
Caelorum maneo deserto in gurgite solus
perque Infinitum perdita larva nato.
Stellarum vis et gravitas in devia mundi
me ducent, spatii praeda silentis ero.
Si nuper navem sociumque recedere vidi
meque levi sensi mobilitate rapi,
nunc res nulla meum mihi dat cognoscere motum
quam minui cernam dum procul usque feror,
obvia nec tacite venient mihi caelitus astra,
immemorabiliter namque remota nitent.
Ipsa nimis longe Vegae fax caerula splendet,
tres annos mensos luce Ophiucus abest.
Sic iam non videor conferta sub astra moveri
et me suspenso corpore stare puto.
Attamen aeterne per inanes deferar umbras
quo me sol aliquis quove planeta trahant,
dum mihi vita manet necnon cum lumina claudam,
autumni ut folium quod niger Auster agat.
Has olim veniens animans alienus in oras
aut homo, visuri tristia regna Lyrae,
hactenus indutos albenti veste stupebunt
in spatio Manes, oh! fluitare meos.
Et si quis parvo navem pontone relinquet
ut pius e tenebris corpus inane legat,
casside sub vitrea vultus agnoverit Adae
sidereus quamvis usserit algor eos…
Vix aegreque animam duco, iam copia prorsum
aeris exhausta est, iam mihi sanguis hebet.
Quid fit? Praecipites video descendere caelos!
An sunt quae video somnia vana modo?
Contrahitur mundus minuuntur et omnia, parvae
ceu morti vellent esse propinqua meae.
Exiguae factae veluti terrestribus agris
lampyridum tremulae noctivagae faculae,
undique me placida cingunt vertigine stellae
ac vestem libant, agmen inerme, meam.
Et vocem mox percipio dulcedine plenam
cassidis angusta sub cavitate loqui.
Quis me solatur? Per vasta silentia Quidam
quem scio, quem pariter nescio, forsan adest?
Isne est qui stellas, ut pappos matris amatae
emoriens memorem, sufflat in ora mihi?
NOTE
v. 24: Meteorolithus “meteorite”, cfr. Lexicon recentis latinitatis, Libraria Editoria Vaticana, in Urbe Vaticana, volumina II, a. MCMLXXXXII et MCMLXXXXVII; Lexicon dehinc litteris singularibus LRL indicabitur. Quod ad quantitatem pertinet, nomina Graeca sequimur μετέωρα, λίθος.
v. 25: Tabulatim structa, cfr. LRL ad vocem “stratificare”.
v. 27: Pensilis cella “ascensore” (LRL).
v. 34: Robotum “robot” (LRL).
v. 59: Nebulosum “nebulosa” (LRL).
v. 77: Xı Cygni, stella “variabilis” in limite sideris, ad Lyram vergens.
v. 89: Album “schermo” (LRL).
v. 115: Taraxacus “tarassaco”, flos luteus camporum, vulgari nomine “dente di leone” vel “soffione” appellatus.
v. 117: Achenium “achenio”, nomen botanicum (α privativo ac verbo χαίνω “hio, hisco” compositum), fructum simplicem et siccum designans aliquorum florum, ut eiusdem taraxaci; formam habet globuli lanei, quem cauliculus fulcit intus cavus.
v. 139: Abruptus sed forte fluor etc.: vide LRL ad vocem “Black-out”.
v. 143: Lampadium manuale “pila” (LRL).
v. 145: Caelestes numeros etc.: de instrumento computatorio “computer” (LRL) agitur.
v. 146: Plectra “tasti”.
v. 167: Servate animas nostras “Mayday! Mayday!”, cfr. LRL ad vocem “SOS”.
v. 172: Vis radians “radioattività” (Bacci).
v. 180: Oxygenium “ossigeno” (LRL).
v. 198: Excipulum “serbatoio” (LRL).
v. 227: Ponto “traghetto (modulo) spaziale”.
MORTE NELLO SPAZIO (narrazione fantastica ambientata nel futuro) Solcati spazio e anni, le lontane / stelle del Cigno aveva, irrequïeto, toccato l’Uomo / e insieme ultimo albergo e ultima Tule / fu per noi l’ombra di un’immensa stella. / In questa vasta regione del cielo / ruotano – ognuno noto col suo nome – sette pianeti / che vanno, grandi e vuoti, intorno a Deneb, / del Cigno eccelso e vorticoso lume / nelle celesti mappe detto alfa; / nessun fuoco di stella, tuttavia, gli dà calore. / Orbite troppo estese e lontanissimi / afeli essi percorrono: ne nasce perenne inverno, / giorni incerti, o – semmai – tardi crepuscoli, / e ghiaccio, che ceruleo ricopre quasi ogni cosa. / Quello dei sette che noi abitiamo / si chiama Adrasto; il più vicino a Deneb, ma gelido lo stesso: / atrocemente bassi sono i numeri / segnati dal termometro, e cadendo a terra l’acqua ghiaccia. / Meno freddo è se nevica, ma ecco / la forza aliena di un ignoto Noto contorce i densi fiocchi; / due lune, se passata è la tempesta, / nella notte colorano le nevi di ulteriore candore. / Per sopravvivere all’immite clima / e ai meteoriti che infiniti cadono, / sotterra giace la città, per strati, / sotto la dura crosta del pianeta e il gelo eterno. / Della città le zone raggiungiamo / – anche quelle lontane e più profonde – con ascensori / o scale a chiocciola (molto più lente), / che a poco a poco penetrano dieci sommerse cittadelle. / L’Averno, vïolato, della luce / stupisce, e piazze e strade frequentate / percorrono su e giù esseri insoliti, / lenti robot che a passi lunghi avanzano… / Allora ci richiama all’adunata / un messaggio sonoro, che i megafoni per le strade riecheggiano. / Andiamo alla città del quinto piano / lasciando i nostri luoghi, in alto o in basso. / Lì è situato il quartier generale: / ci accoglie, provenienti da ogni dove, una capiente aula. / Già nota è la ragione dell’incontro / ai taciti navarchi, distinguibili per le dorate insegne; / siedono dietro, ignari e numerosi, / gli astronauti, che tra consueti scherzi e riso il tempo ingannano. / Ricordo i volti giovani e i compagni, / la cui naufraga nave, oh, gli sarebbe divenuta sarcofago! / Ma qualcuno a gran voce grida «Attenti!». / Tutti si alzano in piedi, rimanendo immobili e in silenzio. / Entra l’uomo che regge l’ipogea / armata del pianeta e il firmamento intero della stella. / Ci perlustra con gli occhi (ci conosce / tutti per nome, dopo tanti anni), quindi ci fa sedere. / «Parliamo», disse, «ad astronauti esperti / dei quali glorïosa per le stelle vola la fama. / Da tempo la Via Lattea a noi umani / si aprì; le stelle occupiamo da molte generazioni. / Di Adamo il seme ha visto Cassiopea / meravigliosa, di un violento rosso per le implosioni di astri, / di Andromeda le enormi nebulose / ha visto pascolare nella polvere di materia celeste / e nuotare – fantasmi apparsi in sogno – / comete per le plaghe di Cefeo vuote e tremende. / Di un tetro e gelido pianeta noi / nelle viscere stiamo, come talpe, dentro tane scavate / e ormai le nostre navi per il freddo / torpide, sotto bastioni di neve giacciono e sotto il ghiaccio! / È giunto dalla Terra lo sperato / ordine, finalmente: andare verso l’ignota Lira. / Tuttavia, prima che si metta in marcia / la flotta, occorre che delle avanguardie perlustrino il cammino: / la nave Giona avrà questa missione, / dovrà percorrere per prima vie giammai tentate; / e che c’assista Iddio!» Così finisce, / attonito risuona dappertutto un mormorio di voci. / Per due anni terrestri senza posa / la nostra nave attraversò remoti templi del cielo. / Mentre Chi Cygni, lume intermittente, / aveva chiuso l’occhio nelle tenebre, / Deneb pian piano diviene una tremula / goccia, succhiata da un lontano e cieco gorgo di spazio. / Ho spesso le funzioni di pilota, / con me c’è un aiutante che sta ancora imparando il mestiere. / Copre l’ampia astronave, nella prua, / un emisfero trasparente, che ospita la mente della nave. / Mentre il fidato timone mantiene / fissa la rotta, di strumenti il dedalo prende a vibrare: / da più pannelli spie ammonitrici / lampeggiano ed emettono segnali, / sullo schermo di vetro appare un calcolo / algebrico che illustra della nave e moto e posizione. / All’esterno la notte desolata / si apre, nella nave invece splende stabile ovunque il giorno. / D’acciaio è rivestito per intero / lo scafo, ma risplende per le tenebre soltanto quella cupola; / se oscurassi la casa osserveresti / tremule stelle, contemplando i regni concavi dello spazio. / Brucia, in disparte, il nucleo dell’uranio; / della sua vivida forza si nutre il nostro impulso / e con continuo flusso scorre dentro / gli arti e le cave membra della nave, che pare mormori. / La nave ha nome Giona e somigliamo / a un cetaceo che con veloce mole fende il mare del cielo. / E già vedevo beta Lyrae splendere / più vicino, più grande già l’azzurro fuoco di Vega. / Un giorno mentre nera ci minaccia / una stella che dal rabbioso cuore continue fiamme vomita / (da lungo tempo infatti con la morte / combatte, inerte stringendo la furia dei gas del nucleo), / esprimo i miei pensieri: «È in queste plaghe / solo sacro pavore e morte torbida. / O campi della Terra, dove vissi / fanciullo giorni lieti alla splendente luce d’estate! / Ecco mi torna in mente la dolcissima / figura di mia madre che mi porta tenendomi per mano. / Su tutte le erbe verdi il giallo capo / ha già innalzato il tarassaco e grandi campi riempie; / mia madre allora gli acheni piumati / ne coglieva, e ridendo mi soffiava sulla faccia i soffioni… / In nessun luogo, attraversati mondi / e tenebre, trovammo un astro simile alla fertile Terra, / che le stagioni miti e variegate / e il colore ceruleo d’aria e mari adornino di frutti. / Che conquiste bramiamo per i cieli? / Conoscerà un traguardo il nostro incedere sotto astri torvi?». / Appena pronunciato ciò, allarmante / una spia lampeggia nel pannello degli strumenti / e con scintille intermittenti e suoni / avverte che imprevisto si avvicina alla nave un pericolo. / Dio mio! Quel rosso presagio sapeva / bene la causa del nostro naufragio! Ma a noi resta nascosta; / ignoriamo se a darci la rovina / sia del cielo la cava notte oppure la nostra stessa nave. / Il cuore ci batteva più veloce / pareggiando nei suoi frequenti impulsi la luce intermittente, / quando ad un tratto cominciano a spegnersi / tutte le luci e la nave sommersa dalle tenebre tace. / Non era certo un fatto trascurabile! / Che le luci saltassero più volte era successo, / ma in caso di mancanza di corrente / altre luci da sole si accendevano; / ora l’ombra incessante l’abitacolo / da fuori penetra e più intensi brillano gli astri nella cabina. / Con una pila perlustro i pannelli / ma nulla segnano le mute spie; / la macchina dei calcoli spaziali / per quanto spinga i tasti resta inerte: / non indica con algoritmi a quanto / viaggiamo o con ellissi verso dove ci dirigiamo; / continuiamo ad andare ma correggere / della prua l’alto slancio non è dato, né frenarne la fuga. / Dal fondo ecco che sordo un mormorio / si leva, a tratti tuona della nave l’ampia caverna. / Con voce roca il compagno «Cos’è?» / mi dice, e lì capisco che è finita. / Immagino la scena, quale forza / lì sotto assalti come una tempesta uomini e cose: / rabbioso l’atomo la sua prigione / ha scardinato e per l’interno attonito infuria senza ostacoli. / Tutto cancella edace, per il corpo / degli astronauti rapido si avvolge, aspro alone di luce. / Alcuni sono nelle stanze, dormono / profondamente, come di costume durante il proprio turno: / il fulgore esiziale li risveglia / e già la morte gli infuoca le gole bramose di gridare. / Nella cabina di prua che rimbomba / per il profondo sfacelo sinora siamo indenni ed incolumi / e senza posa inviamo S.O.S. / per le onde del cielo, poiché è nulla la speranza rimasta. / L’antenna non è muta: che le restino / alcune tracce di elettricità ci rivela il voltametro… / Qualcuno forse udrà i nostri messaggi / benché la radioattività di Vega li possa ostacolare… / Oh, voglia Iddio che la flotta del Cigno / stia dietro a noi, volando già vicina dai cieli della Lira, / o una stazione spaziale passando / per queste stelle le voci del cosmo col cavo orecchio ascolti! / Ma un improvviso affanno a noi le gole / assale, a entrambi un’anelante tosse colpisce il petto. / Grido al compagno «Attento! Manca l’aria! / Qui ci serve l’aiuto dell’ossigeno!». / Subito, spaventati, ci mettiamo / la tuta con il casco di cristallo. / Facciamo già i primi avidi respiri / quand’ecco si frantuma in mille parti il muso della nave. / E ci rapisce, riluttanti, orrenda / la violenza del cosmo, trascinandoci a forza per le tenebre. / E adesso andiamo nell’ombra cerulea / dello spazio fluttuando, corpi naufraghi senza alcun peso, / mentre della cabina, come semi / di esplosa stella, i pezzi intorno a noi bianchi dal gelo nevicano. / Dista la nave d’acciaio più o meno / trecento metri, e squassata da un turbine interno trema, / finché una parte del lato si apre, / come un fiore di fuoco, ma in silenzio si rompe a poco a poco, / come in uno spettacolo mirabile / che si svolga con lente e mute immagini. / Oh no! Al compagno le schegge metalliche / la tuta hanno strappato, e perforato il serbatoio d’aria: / come agita le mani, quasi il vuoto / voglia afferrare! Ma gli va sfuggendo la vita per gli squarci. / Ecco che prono sull’oscuro abisso / si muove sempre meno, ecco che inerte le braccia allarga, / bianca ninfea che nuota in nero stagno, / mentre una qualche onda mi trasporta ancora più lontano. / Resto da solo nel flutto deserto / dei cieli e nuoto, smarrito fantasma, per l’Infinito. / La gravità e la forza delle stelle / mi condurranno nel cosmo remoto, preda del muto spazio. / Se ho visto poco fa nave e compagno / recedere, sentendomi rapito da un movimento lieve, / ora il mio moto non mi fa notare / nulla ch’io veda, mentre mi allontano, rimpicciolirsi, / né astri dal cielo mi verranno incontro / taciti, infatti remoti biancheggiano in modo indescrivibile. / La stessa fiaccola azzurra di Vega / splende troppo lontano, dista Ofiuco tre anni luce. / Così di muovermi già non mi sembra / sotto gli astri stipati e sento, immobile, sospeso il corpo. / Ma in eterno sarò per ombre inani / condotto, dove il sole o altro pianeta voglia portarmi, / mentre mi resta vita e ho gli occhi aperti, / come d’autunno una foglia sospinta dal nero Austro. / Un giorno o uomo o alieno a questi lidi / venendo, per vedere della Lira i tristi regni, / stupiti osserveranno nello spazio / i miei mani fluttuanti con indosso ancora bianche vesti. / E se qualcuno, pio, dalla sua nave / con un traghetto sottrarrà alle tenebre il corpo inane, / di Adamo il volto sotto il vitreo casco / distinguerà, benché lo abbia bruciato il freddo siderale… / Respiro a gran fatica, la riserva / d’aria è davvero finita, il mio sangue ormai è intorpidito. / Cosa succede? I cieli che precipitano / vedo! O le cose che vedo non sono che vani sogni? / Si stringe il cosmo e tutto si fa piccolo, / quasi volesse, il tutto, avvicinare la mia piccola morte. / Ormai piccine, come per i campi / della Terra le tremule e nottivaghe fiaccole delle lucciole, / le stelle mi circondano con una / vertigine pacata, la mia veste – massa inerme – libando. / Ecco che sento, piena di dolcezza, / sotto l’angusta cavità del casco una voce parlarmi. / Chi mi consola? Nei silenzi vasti / Qualcuno che conosco, e non conosco, forse mi assiste? / È Lui che, dei soffioni dell’amata / madre per ricordarmi mentre muoio, mi soffia stelle in faccia? [trad. di Yorick Gomez Gane]
MENSE DECEMBRI DUM EXIT SECUNDUM MILLENNIUM
I
En hiemis tempus rediit dum leniter anni
extrema pars consumitur.
Nunc vespertinae subeunt maturius umbrae,
nunc maius atque obscurius
est spatium noctis, sublustri mane diu nunc
fulgent domorum lampades
ante pigra vitreas quam luce afflare fenestras
dies moratus coeperit.
Tunc ego rure vagor positis canente pruinis,
calco sepultas semitas:
nullus adest animans, trochilus nisi saepibus errans
dumisque solitarius.
Agmine, perlonge hinc, resonat ferrivia quondam
tumultuoso curruum,
dein ubicumque iterum suspensa silentia regnant
dum lenta caelo nix cadit.
Quid quaero? An pacem? Sed iam super omnia pacem
divinus halat spiritus
et mihi nix labens visa est mirabile donum
demitterent quod Caelites,
a puero canas hiemes quia semper amavi
purosque nimbos frigoris.
Saepe est candorem mea musa induta decembrem;
algentis hos lucis dies
ipso vere magis dilexit paene vel aureis
australis orae solibus,
usque nives laete celebrans, hiemalibus usque
devota tempestatibus.
II
At quamvis terrae rigeant atque omnia condat
informis alba vastitas,
est sua vita hiemi. Nemus ingrediare, remota
cum regna brumae visitas;
siste gradum, quercus ubi veneris ante vetustas
rectove trunco fraxinos:
corticis in rima, pluviae secura nivisque,
haeret sopora chrysalis.
Ornatam trepidis ac versicoloribus alis
se forsan in somnis videt;
si summis leviter digitis ea somnia tangas
movetur, usque dormiens.
Non nimbosae Hyades, non Pleiades Atlanteae
eius quietem commovent,
et leto captam dicas, occulta volatus
cum spes in illa palpitet.
Insomnis contra ceres est etsique sepulta
nisu tenaci nascitur.
Ipse ego dum calco pedetemptim mane nivales
per arva solitudines
ex imo (tacitis circumdabar undique campis)
murmur venire credidi
ceu animam messis, caecas dum germinat herbas,
subter pruinas duceret.
Hanc mersam vitam tibi testabuntur et ipsae
floritiones praecoces.
Insolitene hiemis fit mollior aura? Genistae
en dumus expergiscitur:
induit in tenerum se prodigialiter aurum
et aemulatur ramulis
vellus Iasonis necopinus tesqua colorans.
An nix alicubi solvitur?
Una duae violae iam veris tempus inisse
(heu, sole deceptae) putant
et caput exseruere solo, redeunte sed acri
subinde inhorrescent gelu.
Tantum sub terris proles abscondita florum
votum fovebat luminis!
Quin et luce palam brumae cognoscere quondam
est inquietum spiritum.
Cum Boreas nubes abigit verritque serenum
mirare magnas arbores:
aera percutiunt ramis arentibus, alto
morem gerentes flamini.
Nonne animadvertis? Tellus contingere caelum
conatur ex quo gignimur!
III
Et vice saepe sua niveos cum seminat imbres
supernus aether nos petit,
fit propius caelum perque alba silentia vocem
audimus Aeterni loqui.
Quin media bruma, male noctis frigore tutus,
nasci Redemptor maluit.
Nox Bethleem lychnis nictans insomnibus, o nox
tam grata nostrae infantiae!
Pastores puero genuflectere vidimus ad quem
bos atque asellus dormiunt.
Vidimus eoo reges a sole profectos
offerre nato munera
aurum thus myrrham (crinitum sidus ab alto
viam tenendam ostenderat).
Quando iterum stellans per inane edicere pacem
exaudiemus angelos
et nos immemores, hiemalibus edita caelis,
Divina repetet Caritas?
Onnipotens ex quo totius Conditor orbis
humanus infans vagiit
annorum duo milia sunt transacta…Videntur
nunc constitisse saecula
et nondum exortae cum germine messis, inerti
iacere Tempus sub nive.
Non pulsavit adhuc, anni sator, ostia Ianus
Millennium nec tertium
hactenus est natum. Vacuus modo candor et alta
caelestis exspectatio
omnia pervadunt sed quod res cordaque sperant
vanum vel incertum manet.
Divi Infantis heri sacrum celebravimus: arcus
templi sonabant canticis.
Nunc festas luces reliquas hoc degimus inter
aevum silenter occidens
et prope iam mussans obscura voce Futurum.
IV
Mensis Decembris ultima
ecce dies, Sanctum Silvestrum qua veneramur,
caelo sereno vergere.
Sola per hanc gelidam vox quae subtinniat horam
cum ceteri muti alites,
nunc nuper siluit vasto dum devius errat
erithacus in crepusculo,
inter nos hiemans avis advena, forsitan Alpis
nidique longinqui memor.
Iamque color noctis canum nivis inficit aequor
dum sacra vix superstiti
post montes luci valedicunt vesperis aera.
Quidnam recondit haec hiems?
Quam sortem nobis dubium Cras praeparat? Annus
en Iubilaris desiit
et Portam Sanctam, Millenni in limine, Summus
mox rite claudet Pontifex.
Aetatis serae nivibus caput illius albet,
incedit aegris passibus.
Sed videas oculos! Intacta luce renident,
ut gentiana caeruli
Beskidis florens in montibus ex quibus unda
descendit infans Vistulae.
Spes a qua visus collucet vividus eius
precamur et nos dirigat,
lampade restincto dum condomiscimus atque
obscuritate mergimur.
NEL MESE DI DICEMBRE, MENTRE FINISCE IL SECONDO MILLENNIO
I
Ecco è tornato l’inverno mentre l’ultima parte
dell’anno si consuma dolcemente.
Ora più presto calano le ombre della sera,
ora più vasto e più oscuro
è lo spazio della notte, nella penombra del mattino ora
le lampade delle case splendono a lungo
prima che sui vetri delle finestre il giorno
che indugia soffi la sua pigra luce.
Cammino per la campagna che ha una bianca coltre di neve,
calpesto sepolti sentieri;
non c’è anima viva, se non lo scricciolo che vaga
per siepi e cespugli solitario.
Di tanto in tanto, molto lontano da qui,
echeggia il rombo di un treno in corsa,
poi dovunque di nuovo regna un sospeso silenzio
mentre lenta dal cielo cade la neve.
Cosa cerco? La pace? Ma già sopra ogni cosa
un divino spirito alita pace
e la neve che fiocca mi è parsa un mirabile dono
che i Celesti lasciassero cadere,
perché sempre fin da bambino ho amato i bianchi inverni
e i puri nembi del gelo.
Spesso la mia musa si è vestita del candore di Dicembre;
questi giorni di luce algente
li ha amati quasi più della stessa primavera
o dei soli d’oro del Sud,
sempre celebrando con gioia le nevi, devota sempre
alle invernali burrasche.
II
Ma sebbene la terra sia irrigidita e un’informe
bianca desolazione nasconda ogni cosa,
l’inverno ha una sua vita. Entra nel bosco durante
le tue visite ai regni remoti della bruma,
fermati quando giungi davanti a vecchie querce
o a frassini dal tronco diritto:
in una fessura della corteccia, indifferente alla pioggia e alla neve,
è attaccata e sonnecchia una crisalide.
Forse in sogno si vede ornata di trepide
e variopinte ali;
se con la punta delle dita tocchi appena quel sogno
lei si muove, continuando a dormire.
Non le tempestose Ìadi, non le Pleiadi figlie di Atlante
la scuotono dal sonno,
e la direste morta mentre invece in lei
palpita nel segreto la speranza del volo.
Insonne è invece il grano e sebbene sepolto continua
tenacemente senza posa a nascere.
Io stesso mentre al mattino andavo per i seminati
calpestando nivali solitudini,
ho sentito (mi circondava da ogni parte il silenzio dei campi)
da sottoterra risalire un murmure,
come se la messe che faceva germogliare nel buio
i suoi fili d’erba respirasse sotto neve.
Di questa vita segreta testimoni ti saranno le stesse
fioriture anzi tempo.
Insolitamente l’aria d’inverno si fa mite? Il cespuglio
della ginestra ecco si sveglia:
come per prodigio si veste di tenero oro
ed emula coi suoi ramoscelli
il vello di Giasone colorando d’improvviso i deserti.
O in qualche parte si scioglie la neve?
Una due viole pensano sia già cominciata
la primavera (ahimè ingannate dal sole)
e tirano fuori il capo dal suolo ma subito dopo
tremeranno al ritorno del freddo pungente.
Tanta era la brama del sole che sotto la terra
la prole nascosta dei fiori covava!
Anzi apertamente alla luce talvolta si può riconoscere
l’anima irrequieta dell’inverno.
Quando Bòrea scaccia le nubi e spazza il sereno
osserva i grandi alberi:
percuotono l’azzurro con aridi rami piegandosi
all’alto soffio del vento.
Non te ne accorgi? È la terra che tenta di raggiungere
il cielo da cui siamo generati.
III
E spesso a sua volta quando semina fiocchi di neve
viene a noi lo spazio celeste,
il cielo si fa più vicino e attraverso i bianchi silenzi
sentiamo parlare la voce dell’Eterno.
È nel cuore dell’inverno, mal difeso dal freddo della notte,
che volle nascere il Redentore.
Notte di Betlemme occhieggiante di lucerne insonni, o notte
così cara alla nostra infanzia!
Vedemmo i pastori inginocchiarsi davanti al bambino presso il quale
dormono un bue e un asinello.
Vedemmo i re partiti dalla regione dove nasce il sole
offrire in dono all’infante
oro incenso mirra (una stella cometa dall’alto
aveva indicato la via da tenere).
Quando di nuovo attraverso il vuoto stellato
udremo gli angeli annunciare pace
e a noi immemori, nata dai cieli invernali,
tornerà la divina Carità?
Da quando l’Onnipotente, Creatore dell’universo,
vagì, bambino umano,
sono trascorsi duemila anni… Adesso sembra
che i secoli si siano fermati,
che il Tempo giaccia immobile sotto la neve inerte
coi germogli della messe non ancora spuntata.
Non ha ancora battuto alle porte Giano che pone
il seme dell’anno né il terzo Millennio
ancora è nato. Soltanto un vuoto candore
e un’alta celeste attesa
pervadono la terra ma quello che le cose e che i cuori
si aspettano rimane vano o incerto.
Ieri abbiamo celebrato la festa del Divino Fanciullo:
gli archi del tempio echeggiavano di cantici.
Ora ci restano altri giorni di festa che trascorriamo
tra quest’evo che termina in silenzio
e il futuro che già da vicino con voce oscura mormora.
IV
Ecco l’ultimo giorno di Dicembre
nel quale veneriamo San Silvestro
nel cielo sereno declina.
Sola voce che sommessa risuoni in questa stagione
quando tutti gli altri uccelli sono muti
poco fa si è zittito il pettirosso mentre vagava qua e là
nella vastità del crepuscolo,
uccello migrante che sverna tra noi, ricordandosi forse
dell’Alpe e del nido lontano.
E già il colore della notte tinge la bianca distesa della neve
mentre al barlume che a stento sopravvive
dietro i monti dicono addio le campane della sera.
Cosa cela in sé quest’inverno?
Che sorte ci prepara l’incerto domani? Già l’Anno
Giubilare è cessato,
e tra poco secondo il rito sulla soglia del Millennio il Sommo
Pontefice chiuderà la Porta Santa.
Le nevi della tarda età gl’imbiancano il capo,
cammina con passi malcerti.
Ma guarda i suoi occhi! D’intatta luce splendono
azzurri come la genziana
che fiorisce sui monti Beskìdi da dove discende
l’onda ancora bambina della Vistola.
La speranza da cui prende luce il suo vivido sguardo
preghiamo indirizzi anche il nostro cammino,
mentre spenta la lampada ci addormentiamo
e sprofondiamo nell’oscurità.
NOTA
Il poemetto qui edito ha ottenuto nel 2001 il premio nel Certamen Vaticanum, bandito annualmente dalla Fondazione “Latinitas”. Il metro in cui è scritto accoppia un esametro, che Bernardi Perini ricorda nella sua introduzione come verso oracolare, “pitico” (cioè relativo ad Apollo Pizio), con un dimetro giambico (il cui schema è 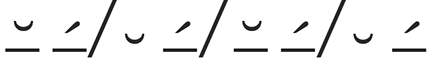 ) con la possibilità di presenza nelle sedi consentite di un tribraco (
) con la possibilità di presenza nelle sedi consentite di un tribraco (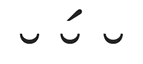 ) o di uno pseudo-dattilo (
) o di uno pseudo-dattilo (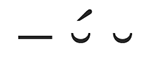 ).
).
Il giambo era nella poesia antica il piede della satira, del motteggio e dell’offesa. Ma sulla nostra scelta ha influito, oltre alla suggestione oraziana felicemente intuita da Bernardi Perini, anche il fatto che il dimetro giambico è il metro caratteristico dell’innario cristiano.
DE ADVENTU SENECTUTIS
Oh quam repente, subdolo silentio
allapsa paene, nos senectus pervenit!
Agili putamus usque nos gressu frui
et in viarum flexibus post angulum
appariturum forsan esse aliquid novi
mirique, dulces ut iuventae per dies.
Sed factus est pes tardior, post angulum
nil insolentis obviam nobis venit
solumque veteres, cognitas res cernimus.
Blanda cataque fraude (tamquam nescii
quae nos maneret meta) decepti sumus,
sensim senescebamus et non sensimus.
Sic nocte quondam nix silenter labitur
lentum soporem dum iacentes ducimus
et mane, valvas cum fenestrae pandimus,
mundum stupemus undecumque candidum.
Conficere vitae pergimus reliquam viam
neque ut solebat crastinum mens prospicit,
potius retro tuemur et revisimus
praeterita: longum pone spatium temporis,
cursus brevis pronusque nos coram patet.
Sed vita quondam praeteribat lenius
necdum memoriae nos gravabat sarcina.
Res quae fuerunt non videbantur procul
ut nunc abesse rebus a praesentibus
quin tempus abiens tempus ac veniens, diu
sunt visa nobis daedalam laeta vice
telam dierum filo eodem texere.
Subtegmen illud cumulus annorum scidit.
Quonam recessit temporis pars maxima?
Oh, nunc sub imo corde dumtaxat iacet!
Sub corde tum memoria nostra quaeritat
aetatis actae conditas imagines,
laetatur unam repperisse: ut cum puer
solus Novembri mense per campos vagans
decerpta postquamst uva laetus invenit
mitem racemum qui sub umbra manserat.
Non nos futuri cura quaevis occupat,
vindemiatas temporis per vineas
amat vagari nostra sera autumnitas.
Ne nos, memoria, deserueris, sis diu
dux cara cordis! Prima iam percepimus
tui recessus signa. Verbi gratia:
alicubi librum neglegenter ponimus,
domum per omnem deinde frustra quaerimus…
Egredimur et nos in viam committimus
quonamque eamus illico mente excidit…
Signa haec timemus, lumen elanguet tuum!
Sed aliquid en fit, admodum praeposterum:
recentiora prorsus obliviscimur,
longinqua verum meminimus dilucide
et multa quae decursus annorum fugax
e mente nostra funditus revulserat
rursum subire cernimus, longinquitas
minuitur aevi nudiusque tertius
videtur evenisse quod pridem fuit.
Miramur et res ultimas occurrere
aevo sepultas; miluus chartaceus
quem carus arte fecerat nobis pater
oblivione subvolans elabitur,
ascendit auras caerulas leviter fremens
nec patet utrumne forte longo stamine
illīus alas callidus pollex regat
glomus revolvens an gubernent angeli,
tam dia mentis ac stupenda est visio!
Sic nos, memoria fluctuans, identidem
confundis. At cur? Visne fors ut maxime
intermicet sub mente sol infantiae
reliquumque vitae nox recondat immemor?
Rides et animae tacita fur ut per iocum
modo hunc modo illum surripis nobis diem
supremus ante quam dies advenerit.
Nullo sed autem tempore obliviscimur
quod vita nobis noluit concedere.
Meminisse fasne est et quod haud unquam fuit?
Fas est: tametsi senuit, heu! non hactenus
cor acquievit nec querellas desiit
et quod iuventae prima spes promiserat
exspectat atque ut debitam rem postulat,
et hoc inepte sub dierum terminum!
Quandoque sed placatur et secum magis
desiderat cor esse, secum vivere.
Tum non viarum nos ut olim sol iuvat
laetis ubique vocibus sonantium,
aures veteribus claudimus sirenibus;
domi placet manere, quos amavimus
repetere libros. Cum poetis degimus
dum postmeridiana labi tempora
de turribus tinnitus horarum monet;
donec dies se inclinat et iam paginam
nobis opacat caerulum crepusculum.
Advesperascit et domorum primulae
primis in umbris enitescunt lampades.
Hoc oppidum valere mox iubebimus
quod una vitae totius sedes fuit
totamque nostram novit humanam vicem.
O cincta muris nostra civitatula,
quam saepe nobis visa es arcta patria!
Teneris in annis fabulis capti sumus
longinqua mundi litora enarrantibus
Tropicique maria mente navigavimus
adhuc inexplorata, consita insulis
meridie quas usque nimbus visitat,
tum brevia post diluvia silvarum viror
guttis relucet humilibus sub arcubus
floresque reduce sole nascuntur novi.
Res cogitatione fictae scilicet
erant, inane somnium puertiae!
Sed grandiores et dehinc natu viri
tritam dierum fugere consuetudinem
magnas et urbes colere somniavimus
desideravimusque Londinii vias
Novique Eboraci tecta quae fastigiis
altum videntur paene caelum tangere,
hoc oppidum tamquam esset angustum nimis
nimisque vasta cordis exspectatio.
Cessa, senectus, immorari somniis!
En metiendum mox erit nobis iter
somnurna non imago, quod reditu caret.
Et admoveri lineas cum sentiat
ad mortis animus horam saepe cogitat.
Lecto cubantes ante quam obdormiscimus
hoc cogitamus. Conticent omnes viae
et cubicularis mensulae iam lampadem
restinximus; fenestra nos coram patet
quae lene frigus noctis aestivae bibit
et unde nobis alta rident sidera.
Vici sed ecce personat silentium
nocturna summis ales in tectis querens.
Infantiae longinqua res mentem subit
domusque (pauper superius cenaculum)
a qua canentem primum eam percepimus.
Dum mater oras lintei circumsuit
et pictographicum nos libellum volvimus
caelum gradatim coeperat noctescere
opusque fuerat exedrae lumen dare,
fuscus susurrus tegulis cum innascitur
patulamque tecti per fenestellam sonat.
Questum stupemus exque matre quaerimus:
«Cuiusne volucris ista vox, matercula?
Infans videtur paene qui insomnis fleat…».
Et illa: «Bubo est, pervigil noctis comes.
Interdiu dormitat occulto in cavo
seroque tantum vespere expergiscitur.
A sole namque abhorret et mavult poli
obscuritatem mille quae stellis tremit.
Omen verendum, mortis immo nuntium,
rudis popellus carmen eius aestimat,
at philosofari potius illam iudico
cum sola tacitis murmur in tenebris ciet;
et fors profundas veritates detegit
lingua sed illam scimus arcana loqui
peregrinaque eius verba non comprendimus»…
Matrem velut si adesset audimus fere
cubiculi in umbris eloqui. Cur hactenus
nos persequimini, temporis phantasmata?
Quem fata donant iam diem consumpsimus
spatiumque quo necesse nunc est ingredi
ultra memoriae pertinet confinia.
L’AVVENTO DELLA VECCHIAIA O come improvvisa, in scaltro silenzio / quasi strisciando, ci raggiunge la vecchiaia! / Crediamo di avere sempre il passo svelto / e che magari nelle curve delle strade, dietro l’angolo / qualcosa di nuovo verrà a sorprenderci, / come nei giorni dolci della giovinezza. / Ma il piede si è fatto più lento, dietro l’angolo / nulla di insolito ci viene incontro / e vediamo solo cose vecchie e risapute. / Un’illusione seducente e astuta ci ha tratti in inganno, / come ignari di quale meta ci attendesse: / pian piano invecchiavamo, e non ce ne siamo accorti. / Come quando di notte scende silenziosa la neve / mentre a letto siamo immersi in un sonno profondo / e la mattina, quando apriamo la finestra, / guardiamo sbalorditi il mondo tutto bianco. // Continuiamo a percorrere la strada che ci rimane da vivere / e la mente non guarda al domani, come era solita fare, / piuttosto guardiamo indietro e ritorniamo / al passato: dietro, un lungo tratto di tempo, / davanti, una breve china. / Ma una volta la vita trascorreva più dolcemente / e della memoria ancora non sentivamo il peso. / Le cose che furono non sembravano lontane, / come ora, dalle presenti, / anzi a lungo ci parve che il passato e il futuro / si divertissero a tessere insieme con lo stesso filo / la tela ingegnosa dei giorni. / Il cumulo degli anni ha lacerato quella trama. /Ma dove è finita la maggior parte del tempo? / Ora, purtroppo, giace soltanto nel profondo del cuore! / Nel cuore allora la nostra memoria va a cercare / i ricordi sepolti del passato, / ed è felice di averne trovato uno: come quando un bambino / vagando solo per i campi a novembre / dopo la vendemmia trova – che gioia! – / un grappolo maturo che era rimasto nell’ombra. / Nessun pensiero del futuro ci preoccupa, / e per le vigne vendemmiate del tempo / ama vagare il nostro tardo autunno. // Memoria, non abbandonarci, per lungo tempo / sii guida preziosa del cuore! Già abbiamo percepito / i primi segnali del tuo abbandono. Ad esempio: / posiamo da qualche parte un libro, senza farci caso, / e poi invano lo cerchiamo per tutta la casa… / Usciamo e ci mettiamo in cammino / e dove andiamo subito ce lo dimentichiamo… / Temiamo questi segnali, la tua luce si fa fioca! / Ma ecco accade qualcosa, del tutto assurdo: / dimentichiamo completamente i fatti più recenti, / ma ricordiamo chiaramente quelli lontani / e molti che la corsa precipitosa degli anni / aveva sradicato dalla nostra mente / li vediamo affacciarsi di nuovo, / un lungo tratto di vita diventa breve / e pare successo l’altrieri quello che è stato molto tempo fa. / Siamo stupiti: ci vengono incontro anche le cose più remote / sepolte dal tempo; l’aquilone / che il nostro caro papà ci aveva fatto con arte / sfugge all’oblio e prende il volo, / sale nel cielo azzurro con un fremito lieve / e non è chiaro se un pollice esperto / regga le sue ali con un lungo filo / riavvolgendo il gomitolo o se siano gli angeli a guidarlo, / tanto straordinaria e stupenda è questa visione! / Così, memoria fluttuante, di tanto in tanto / ci confondi. Ma perché? Vuoi forse che sia soprattutto / il sole dell’infanzia a mandare bagliori nella mente / e che il resto della vita la notte immemore lo tenga recluso? / Ridi e come per gioco, ladra furtiva dell’anima, / ci sottrai ora questo ora quel giorno, / prima che arrivi l’ultimo. // Ma poi non dimentichiamo mai / ciò che la vita non ci ha voluto concedere. / Si può ricordare anche quello che non è mai stato? / Si può: il cuore è invecchiato, ahimè, ma non si è ancora / acquietato e non ha smesso di lamentarsi / e ciò che la prima speranza aveva promesso alla giovinezza / aspetta e pretende come cosa dovuta: / e questo poco prima, scioccamente, della fine dei giorni! / Ma prima o poi il cuore si placa e desidera / stare e vivere di più con se stesso. / Allora non ci piace più come una volta la luce delle vie / che ovunque risuonano di voci allegre, / chiudiamo le orecchie alle antiche sirene; / ci piace rimanere a casa, ritornare / ai libri che abbiamo amato. Stiamo tra i poeti / mentre il rintocco delle ore dalle torri / ci avverte che il pomeriggio se ne sta andando; / finché il giorno tramonta e ormai il cerulo crepuscolo / ci copre la pagina d’ombra. // Si fa sera e nelle prime ombre / cominciano a brillare le prime luci delle case. / Presto dovremo salutare questa città / che è stata l’unica dimora di tutta la vita / e conosce tutta la nostra umana vicenda. / O nostra cittadina cinta dalle mura, / che spesso ci sei sembrata una patria angusta! / Negli anni teneri dell’infanzia siamo stati catturati / da storie che narravano di lidi lontani / e con la mente abbiamo navigato mari tropicali / fino ad allora inesplorati, disseminati di isole / che a mezzogiorno la pioggia immancabilmente visita, / poi, dopo brevi diluvi, il verde dei boschi / risplende di gocce sotto gli arcobaleni bassi sull’orizzonte / e fiori spuntano, quando ritorna il sole, nuovi. / Erano certo fantasie della mente, / un vano sogno dell’infanzia! / Ma divenuti uomini maturi / abbiamo sognato di fuggire dalla vita sempre uguale / di tutti i giorni e di abitare grandi città / e abbiamo desiderato le vie di Londra / e i palazzi di New York che con i tetti / pare quasi che tocchino il cielo, / come se questa città ci fosse troppo stretta / e troppo grande fosse l’attesa del cuore. // Smetti, vecchiaia, di indugiare nei sogni! / Ecco, dovremo presto misurare coi nostri passi / il cammino – non l’ombra di un sogno –, da cui non si torna. / E mentre sente che si avvicina la meta, / l’animo spesso pensa all’ora della morte. / Ci pensiamo distesi a letto / prima di addormentarci. Tacciono tutte le strade / e abbiamo già spento la lampada del comodino; / è aperta davanti a noi la finestra / che respira la delicata frescura della notte estiva / e da dove ci arridono alte le stelle. / Ma ecco nel silenzio della contrada rimbomba / il lamento dell’uccello notturno in cima ai tetti. / Ci vengono in mente i ricordi lontani dell’infanzia / e la casa (una modesta soffitta) / da dove la prima volta l’abbiamo sentito cantare. / Mentre la mamma faceva orli / e noi sfogliavamo un fumetto, / il cielo pian piano cominciava a farsi scuro / e bisognava illuminare la stanza, / quando un cupo mormorio si leva dalle tegole / e risuona attraverso l’abbaino aperto. / Quel lamento ci lascia a bocca aperta e chiediamo alla mamma: / «Di che uccello è questo verso, mammina? / Sembra quasi un bimbo che non dorme e piange…». / E lei: «È il gufo, vigile compagno della notte. / Di giorno sonnecchia in una cavità nascosta / e si sveglia solo a tarda sera: / infatti rifugge dal sole e preferisce / l’oscurità del cielo e il tremolio di mille stelle. / Presagio tremendo, e perfino messaggero di morte, / è il suo canto per la gente ignorante, / ma io penso piuttosto che il gufo filosofeggi / quando da solo nelle tenebre taciturne fa risuonare il suo gemito; / e forse svela verità profonde, / ma sappiamo che parla una lingua arcana / e non comprendiamo le sue parole peregrine»… / Come se la mamma fosse qui, quasi la sentiamo / parlare nell’ombra della stanza. Perché continuate a seguirci, / fantasmi del tempo? / Ormai abbiamo consumato il giorno ricevuto dal destino / e lo spazio dove ora è inevitabile entrare / si estende oltre i confini della memoria. [trad. di Martina Elice]
FLOS NATIVITATIS DOMINI (dum dies redit maris motus in Indonesia)
Flos vivax, Euphorbia cui pulcherrima doctis
inditur in libris nomen sed Stella diei
natalis Domini communiter appellatur
en iterum floret brumae redeuntibus astris:
in tepidis ridet domuum penetralibus ardens
purpureis foliis matutinamque fenestras
per vitreas haurit lucem dum lenta cadit nix.
Nox modo praeteriit qua Sanctus nascitur Infans;
iam minus a nobis caelum procul esse videtur
terraque cum caelo (nullus flat in aere ventus)
sub niveis plumis albam componere pacem.
Flos peregrinus erat nobisque incognitus olim
utpote longinquis nascens in partibus Austri
atque recens tantum toto diffusus in orbe.
Anni tempus idem non est ubicumque locorum
et scitur quantum Boreas intersit ab Austro:
hic nostros verrunt aquilonia flamina campos,
ultima desertis rosa iam languescit in hortis;
illic laeta iniit longis sub solibus aestas
et rutilum capitis diadema euphorbia tollit.
Callidus idcirco topiarius excolit illam
calfacta in cella cum surculus advena frigus
horreat arctoum, Tropicorurn sidere suetus.
Extorrem plantam quam fictilis accipit urna
et qua nos carus nuper donavit amicus
infestos contra ventos noctisque pruinam
laesurumque gelu defendimus aedibus intus.
Hibernos menses nostri laris hospita degit;
nativae (ceu esset ei mens intima quaedam)
hactenus aestatis memor est et mense Decembri
in gelida floret septem regione trionis.
Bis senae rediere dies quibus ut sacer est mos
quotquot eunt anni natum celebramus Iesum.
Haec est prima dies et nos somno excitat ante
quam lux albescat, niveus dum labitur imber,
fistula pastorum laeti praenuntia Festi.
O genialis biems! dulce ac memorabile mane!
Qua se cumque aperit flos igneus incola mundi,
lingua quisque sua (modus est tamen unus et idem)
Caelesti Puero sollemnes dicimus hymnos
dum sacra festivis resonant tinnitibus aera.
Per caelum Bethleem resonant quod tingitur auro
et quoties alto conivet in aethere stella
in saeptis Iudae tener expergiscitur agnus;
Europae in pagis resonant atque urbibus usque
ad desolatam Thulen et hyperborearum
litora terrarum, gelidis quas alluit undis
extremum pelagus glaciatis molibus albens.
Attamen alta Novum nox hactenus occupat Orbem,
quamquam nondum etiam siluerunt funditus urbes
sed longum vigilant insomnes ut Babylones,
excelsae in tenebris ubi mille ac mille fenestrae
splendent quas dicas suspensas aere stellas.
Notum est volventis bina hemisphaeria Terrae
oppositis vicibus noctem variare diemque:
cum primum sensim mane hic aurescere coepit
nondum illic medium complerunt sidera cursum,
qua propter serus Divinus vagiet Infans.
Sed tantus trepidans hominum rerumque tumultus
infantis gracilem poteritne advertere fletum?
Atque potest! Sancta me quondam Nocte fuisse
Detroiti memini Lacuum in Regione nivali
perque vias urbis peditem solumque vagari
nunquam sopitas et curribus usque sonantes,
cum cantus quidam mihi longius accidit aures:
ex ecclesiola, quam circum fronte superba
aedes sublimes caput inter nubila condunt,
exibat vocum concentus, «Adeste, fideles»…
Et subitus ventus vellus turbabat aquarum
tanquam si nivea sub tempestate volaret
angelus obscura qui pervenisset ab Arcto.
Quin et Amazoniam nox hactenus occupat, imum
immensum planum calidi sub sidere Cancri,
et cras mane, dies Domini cum festa nitebit,
in silvis, ubi per virides anaconda recessus
furtive serpit variisque coloribus auram
miri praegrandes accendunt papiliones,
tinniet occultum densa sub fronde sacellum
Indorumque rudis cantum chorus incinet illum:
«Stellis descendis, Rex Caeli, teque latentis
accipit umbra specus, heu! frigore stricta geluque…»,
dum Tropici fervet vehemens atque humidus aestus!
Interea vetus annus abit, novus incipit annus.
Nos habet acris hiems; ningit, nihilominus album
laetitiae nostrae color est: lascivulus en grex
missilibus niveis pueri certamina ludunt
aut parvis vecti traheis rapiuntur ovantes
per pronam vallem, voces cava personat echo.
Temporis huius enim domini pueri esse videntur.
Par erit humanae divina puertia: caris
cum sociis illam ludentem Nazareth arcti
adspicient vici vel aprica cavaedia pagi.
Quin recte faciens Divinus Parvulus olim
rex erit in ludis cum sane non simulatus
Rex sit ab aeterno mundi cui summa potestas.
Et venit in mentem bene nota Prahensis imago
Divini Pueri, convexo suave sigillum
inclusum vitro. Tunicam stans induit albam,
cumque habitum vestis permutent saepius illi
vesticulas varias pretioso stamine textas,
virgo dicata Deo quas dum pia consuit atque
pingit acu, fors matrum animo sibi gaudia finxit.
At fragiles humeros regalis cingit amictus,
insigni premitur caput infantile corona;
Rex est omnipotens quamvis puer: indicat astra
ille tribus dextrae digitis laevaque pusilla
depictum in sphaera terrarum sustinet orbem.
Omnes ipse etenim stellas terramque creavit,
sunt penes hunc puerum tempestas, imber et ignes
imperat et nimbis, si vult, caelumque serenat;
usque adeo Deus ac pariter puer ut videatur
dum nix planities intacta ut pagina condit
rubra cum graphide tropicos depingere flores
qui nostram decorant hoc sacro tempore brumam,
ludi pensa fere navans argutus alumnus
sed rerum quas tam lepide delineat Auctor!
Oh, lex est quidquid puerilia labra loquuntur,
fit fatum quidquid tenero sub pectore versat,
alta Dei quamquam nobis occulta manet mens;
nescimus quare dum flet terrestris ut infans,
humani consors factus sociusque doloris,
(sic Deus erga homines mirum testatus amorem),
tantam permittat Sumatrae in litore cladem!
Altera nox aderat postquam descenderat astris
Rex Caeli misera nascens praesepis in aula,
transieratque Eius iam prima diecula vitae.
Oh, fulgebat adhuc hesterna ut nocte cometa,
somnis in nostris, submissa ac dulcis ut echo,
caelituum cantus memori sub corde sonabat!
Cum subito barathris agitari coepit in altis
Indicus Oceanus magna et fractura moveri
crustae terrestris pelagus quam mergit Eoum.
Tum late fundus maris oscitat, imitus ira
Vulcani erumpit trepidasque incalfacit undas.
Ut terrae vasto tremuit tota Asia motu!
Tune, Puer, dormis, quasi lallus blandulus esset
hoc mersi mundi grave formidabile murmur?
Nonne (ut sacra Prahae nobis icuncula monstrat)
lactea terrarum tua palmula sustinet orbem?
Non ulla a furia pelagi fuit insula sospes,
non Sumatra ferax piperis, non caerula Bali,
non Java florentis laetus paradisus hibisci.
Ex alto refluit magno impete vasta procella
nomine tsunami quam gens Iapanica dicit
actaeque accedens consurgit ad aethera fluctus,
litora transcendit, pagos invadit inermi
demersos somno penetratque fragosus in altas
silvarum latebras ubi, vestigantis odorem
umbrarum, noctu fera lumina tigridis ardent;
indignam perubique necem trahit atque ruinam
et centum pereunt duo millia paene animarum!
Cur sinis haec fieri? Rerum nonne unicus es Rex?
Atqui hominum lacrimas bene noveris, ipsa dolebit
quam mox incipies risu cognoscere mater
cum Te maesta mori fatali in colle videbit!
Sistimus ad sanctas cunas; tibi, Caelica Proles,
qui nondum loqueris, loquimur sermone latino.
Haec pia lingua precum qua quondam suevimus uti
cum pueri fuimus ducebamusque propinquum
numen adesse tuum. Longe nunc esse videris,
tum Te conatur vetus hic attingere versus.
Et nobis ridet peregrini purpura floris,
vivax paene spei mireque superstes imago,
qui iam felici novit sub sidere solem
et nunc in gelidis floret regionibus Arcti.
IL FIORE DEL NATALE (nell’anniversario del maremoto in Indonesia) Il fiore vivace, cui gli studiosi hanno dato nei libri / il nome di Euphorbia pulcherrima, ma che è chiamato / da tutti la Stella di Natale, ecco fiorisce / di nuovo al ritorno delle costellazioni invernali: / ride protetto nel tepore delle case, ardente / di petali rossi, e beve la luce mattutina dai vetri / delle finestre mentre lenta cade la neve. / È appena passata la notte in cui nasce il santo Bambino; / sembra adesso che il cielo sia meno lontano da noi / e che la terra e il cielo (non tira un alito di vento) / sotto le piume di neve suggellino una bianca pace. // Un tempo era un fiore straniero e a noi sconosciuto / perché nasce nelle lontane regioni dell’Austro / e soltanto da poco è diffuso in tutto il mondo. / La stagione dell’anno non è dovunque la stessa / e si sa la distanza che divide Borea da Austro: / qui i soffi di tramontana spazzano i nostri campi, / langue l’ultima rosa nei giardini ormai spogli; / lì comincia lieta l’estate con lunghi giorni di sole / e l’euforbia solleva la rossa corona del capo. / Per questo il giardiniere accorto la fa crescere / in una serra al caldo, perché il virgulto straniero / trema al nordico freddo, avvezzo al clima dei Tropici. / La pianta in esilio, ch’è accolta in un vaso di coccio / e che da poco ci ha regalato un amico, / contro gli ostili venti e la brina notturna / e il gelo dannoso la difendiamo in casa. / Trascorre i mesi invernali ospite del nostro tetto; / ma non scorda (come avesse un’anima dentro) / la sua estate natia e nel mese di dicembre / fiorisce nelle gelide regioni del Nord. // Tornano i dodici giorni in cui, com’è uso devoto, / ogni anno celebriamo la nascita di Gesù. / Ma questo è il primo giorno e ci desta dal sonno, / prima dell’alba, in una tormenta di neve, / il flauto dei pastori che annuncia la festa gioiosa. / O inverno fecondo! Memorabile e dolce mattino! / Dovunque s’apre il fiore di fuoco, abitante del mondo, / ognuno nella sua lingua (ma unica è la melodia) / cantiamo inni solenni al Bambino Celeste / e dovunque risuonano a festa le sacre campane. / Nel cielo di Betlemme risuonano, che si colora / d’oro e ogni volta che nel firmamento si spegne una stella / negli ovili di Giuda si sveglia un tenero agnello; / risuonano nei villaggi e nelle città d’Europa / fino alla desolata Thule e alle ultime terre / degli Iperborei, che bagna con gelide onde / l’estremo oceano, bianco di monti di ghiaccio. / Invece il nuovo mondo adesso è immerso nella notte, / anche se le città non tacciono ancora del tutto, / ma a lungo vegliano insonni, come Babilonie / dove alte nel buio mille e mille finestre / brillano, che si direbbero stelle sospese alla volta celeste. / Si sa che i due emisferi della Terra che gira / variano in modo opposto la notte e il giorno: / quando la prima mattina comincia qui a farsi d’oro / laggiù gli astri ancora non sono a metà del corso; / perciò più tardi si udrà il vagito del Bimbo Divino. / Ma tanto chiasso agitato di uomini e di cose / riuscirà a far sentire il flebile pianto del bambino? / Sì, ci riesce! Ricordo, una volta, la notte di Natale, / ero a Detroit, nella regione nevosa dei laghi / e solo, a piedi, camminavo per le strade / piene di vita, fra il rumore delle vetture, / ed ecco, da lontano un canto mi giunse all’orecchio: / da una chiesina, circondata con aria superba / da grattacieli che si alzano fino alle nuvole, / usciva un coro di voci, «Adeste, fideles»… / E un vento improvviso increspava la superficie dell’acqua / come se, sotto la fitta nevicata, volasse / un angelo che veniva dal buio cielo dell’Orsa. / Eppure in Amazzonia è ancora notte, una bassa / sconfinata pianura sotto le stelle ardenti del Cancro, / e domattina, quando splenderà la festa del Signore, / nelle foreste, dove per verdi anfratti striscia furtivo / l’anaconda e immense, straordinarie farfalle / accendono l’aria di variegati colori, / si udrà lo squillo da una cappella nascosta nel fitto fogliame / e un rozzo coro d’Indios intonerà questo canto: / «Tu scendi dalle stelle, o Re del Cielo, e l’ombra ti accoglie / di una nascosta grotta, al freddo e al gelo…», / e intanto brucia, umida e rabbiosa, l’estate tropicale. // Intanto se ne va l’anno vecchio, comincia l’anno nuovo. / Da noi l’inverno punge; nevica, ma il bianco / è il colore della nostra letizia: ecco un branco / festoso di bambini che giocano a palle di neve, / altri sugli slittini si slanciano gridando di gioia / per il pendio della valle, la cava eco rimanda le voci. / A quel che pare i bambini sono i signori di questa stagione. // Sarà uguale all’umana l’infanzia divina; lo vedranno / giocare con i coetanei le strette viuzze / di Nazareth o i luminosi cortili del borgo. / Anzi il Divino Fanciullo sarà giustamente / re nei giochi, come di certo è legittimo Re, / Lui che da sempre ha il sommo potere sull’universo. / E mi ritorna in mente l’immagine famosa di Praga / di Gesù bambino, delicata statuetta / in una campana di vetro; è in piedi, ha una tunica bianca, / però lo cambiano spesso e gli fanno indossare / vestine di varia foggia tessute di fili preziosi, / e forse la vergine suora che pia le cuce e ricama / mentre lavora immagina in cuore la gioia di una madre. / Ma le deboli spalle sono cinte da un manto regale, / sul capo infantile pesa una maestosa corona; / è un Re onnipotente, seppure è un bambino: accenna alle stelle / con tre dita della destra e nella manina sinistra / sostiene il mondo effigiato in una sfera. / È lui che ha creato il firmamento e la terra, / a questo bambino obbedisce la tempesta, la pioggia ed il fuoco, / comanda anche ai temporali, se vuole, e riporta il sereno; / davvero è Dio e anche bambino; e così, / mentre la neve ricopre i campi come una pagina bianca, / sembra dipingere con una matita rossa i fiori tropicali / che adornano il nostro inverno in questo tempo santo, / e sembra impegnarsi in un gioco, da arguto fanciullo, / ma è il Creatore delle cose che con tanta grazia disegna! / Oh, è legge ciò che pronuncia la sua bocca di bimbo, / è oracolo ciò che medita nel tenero cuore, / anche se a noi l’alta mente di Dio rimane nascosta; / non comprendiamo perché, se piange come un bambino terreno, / lui che ha condiviso e patito il dolore degli uomini / (così Dio ha rivelato il suo grande amore per noi), / permetta, sulle spiagge di Sumatra, uno spaventoso disastro! // Era il secondo giorno da quando era sceso dagli astri / il Re del Cielo, per nascere in una povera stalla, / già era passato il Suo primo breve giorno di vita. / Oh, la cometa brillava come la notte di ieri, / durante il nostro sonno, dolce e sommesso come un’eco, / suonava il canto degli angeli nella memoria del cuore! / Ma d’improvviso comincia ad agitarsi nelle fosse profonde / l’Oceano Indiano, si muove la grande faglia / della crosta terrestre sotto le acque d’Oriente, / poi, largo, si schiude l’abisso del mare, esplode dal fondo / l’ira di Vulcano e fa ribollire le onde. / Tutta l’Asia fu scossa da un terremoto immane! / E tu, Bambino, dormi, come fosse una ninna nanna che ti culla / questo grave terribile rombo sottomarino? / La tua manina bianca non sorregge la terra / (come ci mostra la piccola sacra icona di Praga)? / Nessuna isola fu risparmiata dalla furia del mare, / non Sumatra feconda di pepe, non Bali l’azzurra, / non Giava, felice paradiso dei fiori d’ibisco. / Impetuosa dal fondo rifluisce una immane tempesta / che chiama tsunami il popolo del Giappone; / appressandosi alla costa le onde s’innalzano al cielo, / balzano oltre le spiagge, invadono i villaggi immersi / in un sonno indifeso e irrompono tonanti / nei profondi recessi della giungla, dove di notte brillano / gli occhi feroci della tigre che cerca l’odore delle ombre. / Portano da per tutto iniqua strage e rovina / e quasi duecentomila sono i morti! // Perché lasci che questo succeda? Non sei unico Re del creato? / Eppure sai bene il pianto degli uomini, sarà straziata tua madre / – che presto saprai riconoscere col sorriso –, / quando vedrà dolente la Tua morte sul colle fatale! / Sostiamo davanti alla santa culla; a te, Figlio del Cielo / che ancora non parli, parliamo in latino. / Questa è la lingua devota delle preghiere che ci insegnarono a usare / un tempo, quando eravamo fanciulli e credevamo vicina / la tua potenza. Ma adesso ci appari lontano, / così cercano di raggiungere Te questi versi antichi. / E a noi ride la porpora del fiore straniero, / forse l’unico tratto vivo di speranza che resta, / fiore che ha già conosciuto il sole sotto un cielo felice / e ora fiorisce nelle fredde regioni dell’Orsa. [trad. di Leopoldo Gamberale]
NOTA
Per quel che concerne il testo è sufficiente qui un cenno molto sommario. Oltre alla copia depositata all’Istituto Nazionale di Studi Romani, nell’archivio delle Carte Bandini, busta G/I, 257, si conserva un quadernotto sulla cui copertina è un’etichetta autoadesiva con scritto a matita di mano di Bandini: «I Redazione di un / poemetto latino / “Certamen 2010”». Il quaderno contiene, scritti a penna dal poeta, numerosi abbozzi, ripensamenti per molti gruppi di versi del poemetto, riscrittura (fino a otto), che non seguono un ordine specifico ma danno occasionalmente qualche indicazione sulla collocazione di alcuni passi. Mancano comunque molti versi che sono nella stesura finale e ci sono, com’è naturale aspettarsi, versi poi non accolti. In una delle ultime pagine di sinistra si legge il titolo: «Flos Nativitatis Domini / (dum dies redit maris motus in Indonesia / a MMIV)» e, nella successiva pagina di sinistra, la destinazione: «Certamen 2010». La stesura, per quanto molto tormentata, non dev’essere dunque troppo lontana dalla redazione definitiva.
Lo tsunami che ha provocato più di duecentomila morti in Asia si verificò il 26 dicembre 2004 e riguardò pressoché tutto l’Oceano Indiano. Al. v. 51, come mi ha fatto notare Yorick Gomez Gane, c’è un’allusione a Gn 11,4: gli uomini dicono faciamus nobis civitatem et turrem cuius culmen pertingat ad caelum. Le finestre accese sono quelle degli alti grattacieli, vd. v. 67. Per l’identificazione Babele-Babilonia, già nell’esegesi di Gerolamo, vd. Thesaurus linguae Latinae II, s.v. Babylon, 1653, 16 sgg. Il Bambino Gesù di Praga (vv. 96 sgg.) è una piccola statua in cera di origine spagnola del sec. XVI, a Praga dal 1628; è conservata nella chiesa Panny Maria Vitězené (Santa Maria della Vittoria). È molto venerata e oggetto di specifici pellegrinaggi. [Leopoldo Gamberale]