Ma prescindendo dalle circostanze storiche in cui nacquero queste estremizzazioni politiche, per il califfo i qadariti avevano superato i limiti: il potere deve essere davvero donato da Dio stesso, e non come ruolo spettante di diritto (rizq)? Lo si deve meritare grazie al proprio comportamento retto? Il califfo prende provvedimenti contro i qadariti e Gailàn, che allora risiedeva nell’Armenia sconvolta dalla popolazione turca dei khazari, viene arrestato e, dopo il suo ritorno, viene giustiziato insieme a un uomo delle sue stesse idee, con l’accusa di tradimento. Alcuni qadariti vengono esiliati (sulle isole di Dahlak nel Mar Rosso, al largo dell’odierna Eritrea), tuttavia non si giunge a una vera e propria persecuzione.
Mentre Gailàn ci tramanda la «damnatio memoriae», il suo bando dalla memoria collettiva, ecco farsi largo un secondo capo dei qadariti siriani, Abū ‘Abd-Allāh Makhūl70 (neanche lui vero arabo, ma prigioniero di guerra persiano, seppure di origini probabilmente aristocratiche). Certo, nella tradizione devota egli appare come un vero e proprio padre di questo movimento «pietistico», lui, un saggio proveniente da un’altra terra, giurista e promotore del ğihād, un uomo che si è espresso altrettanto criticamente a proposito dei governanti, un uomo che però ha evitato l’esecuzione soltanto per l’intercessione di un confidente del califfo.
La continua mancanza di un’ortodossia teologica
La breve presentazione di due figure guida, al-Hasan al-Baṣrī e Ġailān, e del conflitto tra califfi ed «eretici» dà soltanto una vaga idea di tutti gli sviluppi innescatisi nell’ambito della teologia in generale, soprattutto negli ultimi decenni dell’epoca omayyade (P II), a Damasco, Bassora e Kufa come anche in Iran o in Egitto, nell’Hišīz o nell’Arabia meridionale. Josef van Ess ha raccolto, spiegato filologicamente e pubblicato in traduzione commentata tutti i testi pertinenti. Studiando questa storia della teologia islamica, si scoprono molti teologi accanto alle figure guida, personaggi che fecero letteralmente scuola, che furono poi inseriti in schemi e abbinati a etichette spesso false e distorte dalla mentalità antistorica dei successivi eresiografi islamici. Anche oggi è altrettanto difficile vendicare la loro memoria tramite ritratti realistici, scoprire dietro ai nomi i destini nascosti e riconoscere dai personaggi concreti (dal greco pròsopon), sempre che i loro nomi siano tramandati dalle fonti letterarie, le strutture di questa teologia (il «metodo prosopografico» di van Ess).
Lo scontro tra sostenitori della predestinazione e difensori del libero arbitrio umano continua ancora per molte generazioni, entrambi i movimenti continuano a evolversi indisturbati a Bassora. In questo periodo non si è ancora formata un’«ortodossia» ma la teologia è sempre alla ricerca della propria identità. Solo nell’epoca successiva si avrà l’unificazione del pensiero islamico, con tutti i suoi vantaggi e svantaggi. Ora perdura la fase di sviluppo differenziato, in base alle province culturali, i singoli sviluppi sono ricostruibili molto difficilmente. Ma da uno sguardo d’assieme si possono comunque ricavare alcuni punti.
- Mentre all’epoca delle conquiste (P I) si avevano semplici accenni di una teologia, o solo una teologia implicita, ora (P II) si sviluppano teologie esplicite e ben distinte tra loro che, tuttavia, non rivendicano alcuna pretesa a creare tra loro vincoli comuni («ortodossia»).
- Mentre all’inizio (P I) si differenziano semplicemente gli eletti (ahl al-ğanna = musulmani, spesso soltanto quelli della propria fazione) da una parte e i dannati (ahl an-nār = infedeli, tra cui ebrei e cristiani) dall’altra, ora (P II) la consapevolezza del peccato diffusa nell’ambiente ascetico, soprattutto a Bassora, fa sì che la possibilità della dannazione sia evidente anche ai musulmani.
Volendo descrivere tutte le correnti influenti di questo periodo, travalicheremmo il nostro ambito di ricerca. Qui menzioneremo solo le più importanti. Accanto ai qadariti ci sono prima di tutto gli sciiti, di cui si è parlato già abbondantemente, e al terzo posto i molto più radicali e rigorosi ḫāriğiti, oggetto della nostra prossima analisi.
Il ritorno al Corano: i ḫāriğiti
I «secessionisti», così venivano definiti,71 si erano opposti alla consegna di ‘Alī a un tribunale.72 Il loro odio per ‘Alī era enorme. Lui li aveva sconfitti, decimandoli letteralmente. E questo odio, che aveva spinto ‘Alī a uccidere uno dei Suoi, li portò infine a rifiutare qualsiasi governante che traesse la sua legittimazione da motivi di discendenza. I ḫāriğiti combattono così non solo ‘Alī e gli Alidi, ma anche i loro oppositori Mu‘āwiya e gli Omayyadi. Rifiutano l’intero sviluppo dell’islam dopo i due primi califfi Abū Bakr e ’Umar, inoltre chiedono che si torni alle origini mediniche e al Corano (P I). Con grande impegno personale e un’obbedienza incondizionata al loro capo i veri musulmani devono combattere con decisione contro gli «amici di Satana». Con lo sguardo al martirio come possibilità di accesso diretto al paradiso, essi si considerano come gli uomini che «hanno venduto» la loro vita alla «causa di Dio» (per questo si chiamano aš-Šurāt, in riferimento ad alcuni passi del Corano).73
I ḫāriğiti, la cui base sociale è formata da nomadi arabi, neomusulmani discriminati ed esponenti di professioni mal considerate, si pongono contro le crescenti differenze sociali tra i musulmani. Essi chiedono uguaglianza di diritti ed esercitano la democrazia dell’islamismo primordiale: i loro capi (imam) vengono eletti da loro stessi, a prescindere dalla loro estrazione, dall’Iran al Nordafrica essi costituiscono le loro comunità. Soprattutto, però, i ḫāriğiti insistono sull’adempimento degli obblighi musulmani. Solo chi assolve a questi obblighi è un vero credente. L’importante è la fede! Il loro modo di concepirla, tuttavia, implica una minore coesione del movimento, che presto si ritrova irrimediabilmente frammentato. Pur costituendo, con le loro bande di combattenti, una continua minaccia per il potere statale fino all’epoca degli Abbasidi, il loro successo politico è limitato ad alcune regioni. Solo con i Berberi in Nordafrica (i Rustamidi di Tahert, che si stabilirono come dinastia nel Maghreb centrale dal 761 al 908) riescono a fondare un regno hàrigitico, mentre in Oman creano un piccolo principato.
Il contributo dei ḫāriğiti alla formazione di una teologia islamica è stato comunque decisivo. Furono loro a indicare il Corano come il modello irrinunciabile di ogni musulmano. Questo punto di partenza, tuttavia, aprì la strada a un ampio spettro di diversi modelli interpretativi:
– Da una parte ci sono gli estremisti azraqiti (azāriqa: seguace di Nāfi‘ ibn al-Azraq)74 che, con fanatica caparbietà, vedono la salvezza nell’uscita dalla comunità dei musulmani, in una nuova Egira. Chi non si riconosce tra di loro o nasconde il proprio atteggiamento, va escluso dalla comunità islamica e considerato un miscredente; essi non hanno nulla da obiettare anche riguardo al massacro dei nemici, compresi donne e bambini. Però uccidere ebrei, cristiani e zoroastriani non è permesso. Molto forti all’inizio, ma indeboliti dalla continua alternanza dei loro capi e dalla divisione interna, i fanatici ḫāriğiti vengono sconfitti da ’Abd al-Malik, che scongiura così la più pericolosa minaccia all’unità dell’impero.
– Dall’altra parte ci sono gli ibaditi (ibāḍīya),75 che si mantengono uniti alla comunità islamica aspirando a una riforma dall’interno. Questi, oggi ancora presenti in Oman, in Libia e nella regione sudalgerina di confine tra il Maghreb e il Sahara, ricollegano le loro origini a ’Abdallāh ibn Ibād di Bassora (una figura che le più recenti ricerche hanno circondato di un alone di mistero ancora più spesso); la sua lettera, per lungo tempo considerata autentica, al califfo ’Abd al-Malik oggi viene però attribuita al successore di Ibn Ibàd, Ğabir ibn Zaid. Essa, inoltre, non giunge al califfo, ma a ’Abd al-Malik ibn Al-Muhallab, che allora sostituisce il governatore a Bassora.76
Un’importanza ancora maggiore sembra quella ricoperta da Abū ’Ubaida. Egli (capo della «comunità dei musulmani») fu, verso la fine della dominazione degli Omayyadi, l’esigentissimo condottiero della comunità ibadita, isolata e clandestina, e soprattutto della missione ibadita. Questa esercitava la sua influenza in tutto il mondo islamico, dal Nordafrica all’India: gli Ibaditi più illustri erano perlopiù grandi mercanti che avevano il controllo degli scambi fino in India e in Cina. Dal momento che, tuttavia, la condizione dei commercianti a Bassora era da sempre precaria, essi sostennero proprio l’ideale dell’uguaglianza e degli immigrati; le donne hanno tra loro una grande importanza, in confronto agli altri gruppi. Tutto verte sul rispetto degli insegnamenti del Corano e sulla solidarietà (wilāya: amicizia) con coloro che vivono nello spirito dell’islam, e, per contro, sull’allontanamento (barā’a) dacoloro (governo, governatori, esattori delle tasse) che non si attengono agli stessi principi. Però, a differenza degli azraqiti, gli ibaditi, nel loro odio per i quraišiti esecrano le battaglie inutili, i massacri indiscriminati e gli omicidi politici. Essi sono noti per non perseguitare i musulmani che scelgono la fuga. Ciò non impedisce loro, però, di fare propaganda contro gli Omayyadi e infine (almeno nei loro avamposti in Yemen, nel Maghreb e in Oman) di unirsi alle ribellioni, non appena si presenta il momento propizio.
Dal punto di vista teologico, gli ibaditi, sotto Abū ’Ubaida e i suoi successori, si dissociano nettamente da quel qadarismo che precedentemente avevano tollerato. Ora la maggioranza di essi abbraccia il predestinazionismo, senza però sostenere un pieno determinismo; come avrebbero potuto altrimenti ribellarsi ai potenti ingiusti? Il bando del severo Abū ’Ubaida si rivolge anche a coloro che si fanno idee false delle apparentemente antropomorfe affermazioni di Dio nel Corano e che interpretano le Sue parole letteralmente anziché metaforicamente. Come se la «mano» di Dio non simboleggiasse il suo potere o la sua ricompensa, e il suo «occhio» non fosse la sua conoscenza o la sua protezione, come se il suo «polpaccio» nudo nel Giudizio Universale non rappresentasse la sua risolutezza.
Nell’ambito dell’ibāḍīyaè interessante un’affermazione di Ḥalīl ibn Ahmad, famoso lessicografo, fondatore della metrica araba e autore di un’opera sull’immagine di Dio (fī-t-tawḥīd:«Sulla dichiarazione di unità»). Di lui ci è stata tramandata, come unico frammento, la seguente affermazione sulla trascendenza di Dio: «Oh tu che chiedi di comprendere l’Eterno! Se tu dici: "Chi è egli?", ecco che l’hai già localizzato; se chiedi: "com’è egli?" ecco che l’hai già qualificato. Egli è +A, +A; (ma anche) -A, -A; oppure +A, -A e -A, +A». Questa è l’ultima frase nella traduzione di Louis Massignon.77 O, secondo van Ess, è anche possibile: «È l’esistente di un esistente e il non-esistente di un non-esistente, l’esistente di un non-esistente e il non-esistente di un esistente».78 Questa definizione della trascendenza divina da parte dell’autore di Bassora, che non lascia spazio a compromessi, mi sembra non tanto «iperdialettica» (L. Massignon) ma piuttosto un parallelo di quella dialettica dei quattro passi del grande buddhista indiano Nagarjuna (II secolo d.C.) che, guardando all’assoluto, nega tutte e quattro le possibilità: che esso esista veramente; che esso sia diverso; che esso sia così ma anche diverso; che esso non sia né così né diverso.79 Ma qual è lo scopo di tutto questo? Perché l’uomo si liberi per l’altissima verità religioso-mistica, che supera tanto il pensiero mitico quanto la speculazione metafisica e diviene chiaro agli occhi dell’uomo solo nella tomba.
Ma le controversie teologiche tra gli ibaditi, che ora si richiudono sempre più in loro stessi, vertono soprattutto su problemi assolutamente pratici: dalla validità della preghiera del venerdì all’ingiustizia di un regnante, per passare al valore del divieto del vino, fino all’ammissibilità del rapporto anale (normale alla Mecca ma tabù a Medina, probabilmente per l’influsso giudaico). Il fatto che ovunque, nell’Ibāḍīya, si manifesti una tendenza al puritanesimo (ad esempio nelle prescrizioni riguardanti la pulizia e il cibo, che comprendevano addirittura le strette di mano con gli sconosciuti) e alla scrupolosità nell’adempimento della legge (con pubblica ammenda!), ha senza dubbio un legame con il nucleo della teoria ibadita, il rapporto tra fede e peccato, tra fede e miscredenza. Questa controversia si sviluppa soprattutto nell’epoca successiva. Contemporaneamente, tuttavia, in queste controversie ci fu un gruppo molto considerevole che non desiderava vincolarsi in ciò che è «nascosto» agli uomini.
Il rinvio del giudizio: i murğiiti
Già dopo la prima guerra civile, per via dei sanguinosissimi contrasti tra i musulmani, percepiti come una sfida (fitna = tentazione, prova), particolarmente a Kufa, si elevarono voci secondo le quali non era più possibile decidere chi avesse ragione e chi torto, e che per questo il giudizio andava «rinviato» (arğa’a), da qui la pratica del «rinvio» (irğā’) del giudizio. Questi sostenitori vengono quindi chiamati murğiiti (murği’a). Il termine originario «ritenzione» fu usato per la prima volta probabilmente nella «lettera della ritenzione» (kitāb al-irğā’) degli anni 692-695.80 La prima testimonianza attendibile comunque, non solo dell’azione ma anche del pensiero dei murgiiti, è costituita da due componimenti poetici della tarda epoca omayyade.81
Si trattò di un’evidente questione di «ritenzione» del giudizio legata alla politica anche nel caso del primo scisma islamico. A essere messo in dubbio non era tanto lo status salvifico dei musulmani, ma quello dei primi quattro califfi. Quanto a ‘Alī e a ‘Uṯmān, infatti, il giudizio doveva essere rinviato e non ridotto a un problema di fede o di incredulità. Una doppia dichiarazione di guerra, da una parte agli sciiti, che si erano legati a ‘Alī, dall’altra parte agli Omayyadi, che consideravano Abū Bakr, ’Umar e ‘Uṯmān come califfi ben guidati. I murğiiti, invece, vogliono mantenere l’unità della comunità musulmana, evitare le scomuniche e rimettere il giudizio di Dio al Giorno del giudizio universale.
Appare assolutamente evidente che il rinvio del giudizio negli affari politici deriva da motivazioni teologiche sviluppate successivamente. Dal principio politico della «ritenzione» deriva una teoria teologica: «va praticato l’irğa ogni qual volta ci sia qualcosa di "nascosto" o "dubbio", con gli uomini che non si sono mai visti o che sono morti da lungo tempo e della cui salvezza ultraterrena i versi del Corano non diano alcuna notizia».82 Non si deve presumere alcun giudizio circa la fede dei fratelli musulmani. In pratica, tuttavia, i singoli gruppi di murğiiti nei diversi accampamenti, nelle diverse località e nelle diverse epoche, seguivano condotte assolutamente differenziate: il principio originario di «ritenzione» non sempre sopravvisse.
Tutti questi problemi aperti confluiscono alla fine nell’unico grande problema: come deve essere il futuro dell’islam? Dopo la seconda guerra civile, con lo spargimento del sangue di moltissimi musulmani e la cui fine (nel 691) fu festeggiata come l’«anno della comunità concorde» (‘ām al-ğamā’a), ecco che un numero sempre maggiore di musulmani comprende che l’islam non può continuare in queste condizioni. Invece di riferirsi sempre e ovunque al Corano (comunque senza arrivare ad alcuna omogeneità) seguendo l’esempio degli sciiti e dei ḫāriğiti, o comportarsi, come i murgiiti, in modo neutrale, esiste certo un’altra possibilità: ricordare i meriti degli antenati, il cammino già percorso dagli avi. Se si ricordasse sempre più questa «sunna» («usanza») comune, non si potrebbero allora evitare più facilmente, in futuro, le divisioni e le guerre, che avevano provocato interminabili sofferenze al mondo islamico? È in questo momento che i sunniti cominciano a radunarsi. Da allora e fino a oggi il sunnitismo comprenderà la grande maggioranza dei musulmani, e considererà tutti gli altri gruppi come sette «eretiche».
8. LA CRISI DELL’IMPERO
Sotto i califfi succeduti a ’Abd al-Malik e ad al-Walīd, un elemento emerge con sempre maggiore chiarezza: nella base di potere del governo imperiale non rimane quasi più traccia del movimento arabo. La base di potere ora è costituita invece da truppe scelte siriane, dal sempre più potente apparato governativo e dalla propagandata ideologia dell’obbedienza nei confronti del califfo, rappresentante dello «stato». Ma questa base potrà resistere tanto a lungo da tenere insieme un impero ormai gigantesco e già ora, in buona parte, non più formato da soli arabi?
Che fare dei neomusulmani? Il califfato riformatore di ’Umar II
Per quanto l’impero arabo-islamico possa sembrare forte dall’esterno, esso è indebolito all’interno da tensioni sempre maggiori e da polarizzazioni. Oltre alla sempre presente «opposizione devota» nell’originaria regione araba che accusa gli Omayyadi di Damasco e la loro Realpolitik traditrice dei principi islamici, e agli iracheni che insorgono continuamente contro l’odiata dominazione siriana, oltre agli sciiti che si agitano clandestinamente, ora compaiono dappertutto nuovi ceti e gruppi che reclamano i loro diritti. In seguito alla progressiva islamizzazione, ad acquisire sempre più forza è quel movimento sociale che contesta in nome dell’islam la dominazione araba (una componente essenziale del P II!). Esso chiede che:
– i soldati non arabi vengano iscritti nelle liste di pensione statali (dīwān);
– i contadini non arabi convertitisi all’islam siano esentati dalla discriminatoria tassa pro capite;
– i mawālī in servizio nell’esercito e nell’amministrazione abbiano gli stessi diritti e gli stessi privilegi degli arabi.
Se si pensa a un califfo capace di trovare, da «idealista», una soluzione realistica in questa difficile situazione, questo è sicuramente ’Umar II ibn ’Abd al-‘Azīz (717-720).83 Non solo perché nato ed educato tradizionalmente a Medina; non solo perché, da parte di madre, discende dalla famiglia di ’Umar I e, da parte di padre, da uno storico viceré d’Egitto; non solo perché lui, che ha sposato la figlia di ’Abd al-Malik, è, sotto ogni aspetto, un uomo devoto, colto, quasi un asceta, rispettatissimo anche dai gruppi tradizionalisti musulmani e dagli sciiti. Egli, però, nonostante i suoi soli trentacinque anni, da politico lungimirante ha capito soprattutto che il dominio di un gruppo etnico su tutti gli altri, come quello proclamato dal suo omonimo bisnonno, il secondo califfo ben guidato, è un’idea sorpassata! Se l’impero deve avere vita lunga, l’opposizione conflittuale tra arabi e non arabi deve essere superata. Sotto ’Umar II, per la prima volta, la dottrina scritta islamica, finora abbastanza malvista dal califfato omayyade, ha un’influenza molto positiva.
’Umar II non è interessato a un’ulteriore espansione. Egli, invece, sin dall’inizio, si concentra sui problemi urgenti della politica interna. Già poco tempo dopo la sua elezione, egli interrompe l’assedio a Costantinopoli che il califfo Sulaimān, il suo immediato predecessore, aveva iniziato con grandissimo dispendio di risorse. Egli avrebbe rinunciato anche ad avamposti arabi come la Transoxiana, cosa che tuttavia non gli riuscì. Perciò il nuovo califfo interviene energicamente all’interno: i governatori impopolari vengono allontanati e vengono cambiate anche le cariche più importanti dell’amministrazione. Nel far questo il califfo non pensa all’accrescimento del suo potere, ma alla difesa del diritto. Per il califfo la questione centrale è il ritorno ai principi islamici originari e la restaurazione dell’unità interna dell’umma. La sua devozione musulmana si rispecchia (più di tutti i suoi predecessori omayyadi) nella sua vita privata e nella sua condotta pubblica. Egli spera così di arrestare lo sfaldamento dell’impero omayyade e di poter ristabilire una base di consenso quanto più ampia nella popolazione musulmana. Molto impegnato nella diffusione della fede islamica, fa dare lezioni di religione ai beduini e invia addirittura dieci eruditi ai berberi.
’Umar II non era neanche un tattico che intendeva placare i convertiti solo tramite concessioni pur di mantenere la dominazione araba. Al contrario, egli si impegna in una realistica politica di accordo reciproco mirante alla riconciliazione con iracheni e sciiti e soprattutto a una sostanziale equiparazione dei diritti dei musulmani non arabi. A questo scopo egli riforma ampiamente l’amministrazione: tutti i musulmani non arabi dell’esercito e dell’amministrazione, nel commercio e nell’artigianato che contribuiscono notevolmente alla diffusione dell’islam, devono essere accolti dall’impero come cittadini dotati di tutti i diritti. Ora accade ciò che finora era stato assolutamente impensabile: questo califfo permette ai clienti di diventare giudici e persino governatori.
A ciò si lega una riforma fiscale, che renda più equo il sistema, pur non trascurando gli interessi finanziari dell’impero. I convertiti devono sì pagare interamente le imposte fondiarie, ma in futuro dovranno farlo anche i grandi proprietari terrieri arabi. Coerentemente al principio dell’uguaglianza di tutti i musulmani segue un’equalizzazione delle tasse, ma a livello più alto, a discapito di relativamente pochi proprietari terrieri arabi. Le tasse pro capite vanno pagate, come prima, soltanto dai non musulmani (cristiani, ebrei e zoroastriani). Per contro tutti i musulmani devono versare i (comunque ridottissimi) contributi sociali, che in parte risarciscono lo stato per alcuni tributi soppressi.
Al posto del perdurante antagonismo tra arabi e non arabi, ora si instaura un’unità universale dei musulmani: l’impero arabo diventa l’impero di tutti i musulmani! Tutto sommato un programma grandioso, che tuttavia è più difficile da mettere in pratica di quanto pensi il secondo ’Umar, e la cui realizzazione necessita di tempo. Ma al riformatore non sono concessi neanche tre anni e mezzo di regno. Muore ad appena trentanove anni, e circolano voci che sia stato avvelenato, eventualità comunque poco probabile. In ogni caso diventa «Santo degli Omayyadi».84 Da tutte le correnti musulmane (anche quelle della nuova dinastia!) ’Umar II viene ricordato con gratitudine come modello di giustizia e devozione islamica. Riusciranno forse i suoi successori a realizzare il suo programma?
Colpo di stato e predica inaugurale
Per circa cinquant’anni il regno omayyade era riuscito a reprimere tutte le rivolte. Attorno al 740, però, scoppiano tumulti, e il decennio successivo condurrà alla caduta della dinastia. I califfi succeduti a ’Umar II non hanno lo spessore del predecessore. Ad esempio il secondo successore Hišām (724-743),85 energico nella lotta ai bizantini e ai turchi dell’Asia centrale, tenta di mettere in pratica i princìpi di ’Umar in Khorasan, nella Mesopotamia e in Egitto. Ma in genere queste iniziative hanno scarso successo e conseguenze ancora più scarse. La politica dell’ultimo decennio della dinastia degli Omayyadi è segnata da innumerevoli intrighi e rivoluzioni, destituzioni e nomine, assassinii, esecuzioni e molte teste mostrate pubblicamente...
In questa tarda fase degli Omayyadi l’evento centrale è la lotta intestina per il califfato: la rivolta di Yazīd III contro al-Walīd II. Essa è stata già descritta minuziosamente da Julius Wellhausen,86 e Josef van Ess l’ha analizzata con precisione nella sua dimensione religiosa.87 Le fonti storiche provenienti dalle cerchie dei devoti caricano probabilmente i contrasti oltre il dovuto, dal punto di vista storico, però, bisogna ricordare alcune cose.
– Il califfo ben guidato, e successore di Hišām, al-Walīd II88 (743-744) è considerato dai suoi avversari come un eretico (zindīq), un omosessuale, uno sboccato e un libertino; egli viene attaccato anche dal popolo con l’arma degli ḥadīṯ. Rintanato perlopiù nei suoi castelli nel deserto, è un gran cacciatore, bevitore e donnaiolo, ma anche grande lettore e poeta. Secondo Wellhausen avrebbe addirittura predicato «occasionalmente in versi»; «egli era capace di tutto, ma tutto per lui era semplice capriccio, e il suo capriccio cambiava in un batter d’occhio. Egli si immergeva in una dotta dissertazione teologica, poi beveva di nuovo e si faceva beffe del sacro. Riusciva a non rifiutare le richieste di nessuno e a essere non solo furioso, ma anche spietato come un bambino. Il potere nelle sue mani fu una maledizione».89
– Il suo avversario, il futuro califfo Yazīd III (744), asceta, avverso alla musica e al divertimento, era entrato a Damasco in groppa a un asino, come Gesù, il Messia a Gerusalemme. Al contrario di al-Walīd, a quanto pare vicino al predestinazionismo, lui, figlio di madre non araba, è un qadarita. Egli sa anche come applicare nella pratica politica, al momento decisivo, il principio qadarita dell’autodeterminazione umana. Appoggiato soprattutto dai giovani, non ancora affermati nella società, egli si pone come controcaliffo, un venerdì entra nella moschea più grande di Damasco, sequestra le armi là accumulate e seduta stante fa arrestare il funzionario e il governatore. Le truppe dei califfi restano nelle province e a Yazīd, dopo aver ricevuto l’omaggio dei cittadini di Damasco, non resta che volgersi con un piccolo esercito contro al-Walīd. Questi si comporta in modo stranamente passivo, e combatte valorosamente soltanto alla fine, con una piccola schiera, prima di ritirarsi, abbandonato da tutti, nella sua rocca. Leggendo il Corano, muore là per un colpo di spada, proprio come allora era morto a Medina il califfo ’Uṯmān. Gli viene tagliata la testa e portata a Yazīd, che la trascina dappertutto e solo un mese dopo la fa consegnare al fratello della vittima, che però, per viltà, non osa seppellirla.
Ma come giustifica il rivoluzionario la sua rivolta contro il legittimo regnante di Damasco? Interessantissima è la predica iniziale di Yazīd, la dichiarazione programmatica.90 Infatti, come già i rivoluzionari prima di lui, l’uomo nuovo giustifica il suo regno affermando di averlo ottenuto «con l’ira, per l’amore di Dio e della sua religione, difensore della sua santa Scrittura e della sunna del suo Profeta»91. Allo stesso tempo promette, in considerazione della pubblica critica allo spreco di denaro e al nepotismo dei precedenti regnanti omayyadi, di non costruire più alcun edificio, di non scavare canali e di non accumulare tesori. Il denaro ottenuto nelle province dovrà essere utilizzato in quei luoghi, i proprietari terrieri non musulmani non dovranno più essere sottoposti a una tassazione eccessiva e le reclute in servizio militare non dovranno più rimanere a lungo nel campo di battaglia.
Soprattutto è sorprendente (e di costante attualità) la conclusione di Yazīd riguardo all’obbedienza verso Dio: «L’obbedienza si deve solo a Dio. L’obbedienza ad altri (uomini) è quindi possibile solo nell’obbedienza verso Dio, sempre che lui stesso obbedisca a Dio! Se questi si oppone a Dio e invita all’opposizione (cioè al peccato), allora egli merita che ci si opponga a lui e che venga ucciso».92 Questa affermazione si riferisce naturalmente a al-Walīd, ma ha anche conseguenze sulla politica di stato. Infatti la motivazione di Yazīd dice a chiare lettere: la «ragione di stato», teologicamente parlando, ha un valore relativo. Religione e morale sono al di sopra della politica, e sopra a ogni regnante. È tipica l’espressione «nessuna obbedienza per colui che si oppone a Dio». Essa verrà citata molto spesso. Alla fine è stata attribuita al primo califfo Abū Bakr.
Ciononostante, la decadenza della dinastia degli Omayyadi non si arresta neanche in questo modo, tanto più che anche Yazīd non regna neppure un anno e il suo regno è tutt’altro che sostenuto dal consenso popolare. Muore nel 744, a quanto pare per cause naturali.
Verso la terza guerra civile
Il futuro era facilmente prevedibile: sempre lo stesso anno il nuovo califfo Marwān II (744-750) si erge a vendicatore di al-Walīd. Egli interpreta la critica qadarita agli Omayyadi come una provocazione. Al suo arrivo a Damasco fa disseppellire il corpo di Yazid III e lo espone in croce, con la testa rivolta verso il basso.
Agitazioni interne ora sconvolgono l’impero; a queste si aggiungono gli attacchi dei nemici all’esterno. E questo già da molto tempo: ad esempio i berberi, ora musulmani, erano stati dei fedeli alleati nelle battaglie contro i goti occidentali e contro i franchi. Poiché, però, dopo la morte di ‘Umar II, erano stati trattati dai funzionari arabi come servi soggetti a tributo, essi scatenano, sotto la guida dei ḫāriğiti , una tremenda insurrezione dal Marocco fino a Kairouan e, in nome dell’islam, arrecano agli arabi, rinforzati da truppe governative siriane, la più grande sconfitta della loro storia (con molte migliaia di morti), una sconfitta che questi ultimi riuscirono a vendicare soltanto un anno dopo. In questo momento gli arabi, tuttavia, sono sulla difensiva non solo in Nordafrica, ma anche in Transoxiana, travolta dai turchi. Anche in Armenia, dove il popolo seminomade dei kazari, proveniente dal Caucaso settentrionale, i cui notabili si convertono all’ebraismo per antipatia sia contro Bisanzio che contro l’islam, sconfigge gli arabi. Alla fine questi sono costretti a difendersi persino in Anatolia, dove i bizantini annientano un seppure più numeroso esercito siriano.
Sia dall’interno che dall’esterno è sempre più evidente che lo stato degli Omayyadi, per tanto tempo all’offensiva su tutti i fronti, è militarmente al collasso. Il collaudato e glorioso esercito siriano è stato sempre più abusato per il controllo politico degli stessi arabi e, ai confini del gigantesco impero, si è logorato col passare del tempo. È così che al regime degli Omayyadi manca sempre più la base militare per difendersi dai nemici che provengono sia dall’esterno che dall’interno. Poche migliaia di soldati ora sono in grado, e il colpo di stato di Yazīd lo testimonia, di decidere a chi consegnare lo stato.
Tra il 744 e il 750 diverse forze antagoniste si contendono il califfato e il già menzionato Marwàn II, che come califfo è tanto conosciuto quanto lontano arriva il suo esercito, era destinato a essere l’ultimo califfo di Damasco. I severi gruppi religiosi sunniti restano fondamentalmente fedeli all’istituzione del califfato e al suo significato religioso. Ma ora, in modo ancora più aspro di prima, criticano la politica temporale e la condotta di vita dei califfi di Damasco, la loro pretesa a un’autorità quasi imperiale e i loro continui interventi a fini politici nelle questioni religiose. Alcuni pensatori religiosi, che sotto ‘Umar II avevano ancora un atteggiamento positivo nei confronti della dinastia, ora la avversano in tutto e per tutto. Sono anni di terrore, e molti, soprattutto la fazione araba meridionale («yemeniti») attendono, con grandissima ansia, una svolta.
Gli ambienti sciiti non avevano comunque mai abbandonato la speranza di arrivare al califfato e ora trovano più seguito presso i molti arabi e neomusulmani insoddisfatti, nell’attesa di un mahdi che riporti il califfato in linea con i dettami del Profeta. Già tra il 736 e il 740, a Kufa, scatenano vere e proprie agitazioni, che conducono ad arresti ed esecuzioni. Intanto, però, si forma un nuovo movimento, molto più pericoloso, che infliggerà alla dinastia degli Omayyadi il colpo decisivo: il movimento degli Abbasidi.
La fine dell’impero arabo
Gli Omayyadi non sono l’unico clan di rilievo del Qurais, la discendenza del Profeta. Uno sguardo all’albero genealogico di Maometto (cfr. Tav. p. 239) mostra che questi aveva un altro zio di nome al‘Abbās, la cui discendenza tuttavia era comparsa ancora poco sulla scena politica. Ma proprio questi, gli Abbasidi, ora, nella grande crisi degli Omayyadi, rivendicano il diritto al califfato. La loro giustificazione: un nipote di ‘Alī, Abū Hāšim, avrebbe consegnato a loro la guida della famiglia del Profeta, ora intesa in senso lato, comprendente anche gli Hàsim. Questo significa che sotto il nome e il programma della famiglia del Profeta e degli Hāšim, a questo punto, al di fuori di tutti gli altri Quraisiti e soprattutto degli Omayyadi, si aspira a un principio di legittimazione nuovo, appunto quello della «ḫāšimīya»: con una strategia a lungo termine viene creato un movimento d’opposizione che si rivolge alla politica ricorrendo ai princìpi della genealogia.
In realtà, mentre il ramo alidico del clan Hāšim tenta di ribellarsi contro gli Omayyadi a Kufa (a favore degli Alidi), il ramo abbaside, a sua volta, segretamente, nel Khorasan, regione della Persia nordorientale, sta preparando già da due decenni la rivoluzione che dovrà portarlo al potere. L’abilità abbaside in fatto di agitazioni politiche e ideologiche è grande; la ḫāšimīya si è formata inizialmente come un movimento prevalentemente clandestine. Il grande sobillatore, eccellente organizzatore del movimento, e capo di un esercito e di un governo segreti, inviato dalla famiglia degli Abbasidi a Khorasan, è un certo Abū Muslim,93 di origini incerte, personaggio comunque abile e stimato. Egli ritiene di dover unire arabi e iraniani in una coalizione anti-omayyade, con un programma comune. I suoi discorsi scatenano approvazioni e consensi in tutti gli strati sociali: vendetta per ‘Alī! Guerra agli Omayyadi! Un nuovo ordine di pace e di giustizia per gli svantaggiati!
Come potrebbero i primi conquistatori arabi di Khorasan non accogliere con approvazione queste parole, proprio loro, che ora coltivano la terra nei villaggi e che tuttavia, salassati dalle pesanti tasse, sono trattati alla stregua dei berberi, come un popolo suddito? Come potrebbero loro, ai quali sotto ‘Umar II era stata promessa un’equa riforma fiscale, non combattere, dopo che quelle promesse si sono dimostrate parole vuote? Molti erano comunque convinti che la fine del mondo, la battaglia finale e l’apparizione del mahdī fosse imminente, come testimoniato dagli scritti popolari, che annunciano tempi apocalittici.
E quando, nel 747, a Marw, nelle lontane regioni orientali dell’impero, Abū Muslim issa il vessillo nero preannunciante l’arrivo del mahdi, la bandiera della rivoluzione, questo è il segnale dell’inizio dei combattimenti; il nero è anche il colore di alcuni hāšimiti, 3000 uomini agguerriti e sorprendentemente disciplinati che riescono a sconfiggere i rivali a Khorasan e anche nell’Iran occidentale, conquistando l’appoggio degli sciiti in Mesopotamia. Gli sciiti, infatti, ripongono tutte le loro speranze nell’eventualità che stavolta un successore di ‘Alī conquisti il califfato.
Un altro errore, si direbbe a posteriori. Al dunque, infatti, gli Abbasidi ignorano completamente gli alleati sciiti. A Kufa, nel 750, il nuovo califfo, per la grande delusione degli sciiti, non è un alide, ma colui che voleva aiutare gli alidi a rivendicare il loro diritto: Abū l‘Abbās as-Saffāh,94 a quanto pare l’unico ḫāimita candidato. Alidi e Abbasidi, da allora, prendono le distanze gli uni dagli altri; si creano praticamente due gruppi di nobiltà islamica. Irremovibili, gli Abbasidi portano come motivazione della loro vendetta sanguinosa addirittura la vendetta di Zaid, il successore di ‘Alī , caduto in una rivolta contro gli Omayyadi nel 740. Essi riescono a infliggere una sconfitta decisiva al califfo ancora al potere Marwān II in Mesopotamia settentrionale, nei pressi di Mossul, e poco dopo occupano Damasco. Abbandonato dalle sue truppe siriane, il califfo Marwān stesso è costretto a fuggire in Egitto attraverso la valle del Giordano e la Palestina, prima di essere ucciso, nel 750, attorniato da pochi fedeli, dagli uomini del nuovo califfo. Come sempre la sua testa viene inviata al successore, Abū l-‘Abbās.
Ma non è finita. Il primo califfo abbaside non si dà pace fino a che l’élite degli Omayyadi non sia stata eliminata fisicamente dal primo all’ultimo uomo. Alla fine si arrende anche la grande città presidio di Wāsit, dove la stragrande maggioranza degli ufficiali siriani (in contrasto con le condizioni pattuite per la resa) viene giustiziata. Dappertutto gli Abbasidi festeggiano i loro eccessi sanguinosi, tanto che il primo califfo as-Saffāh («il Generoso»), viene soprannominato «l’assetato di sangue». L’orribile picco delle violenze è rappresentato da un festino mascherato da «banchetto di conciliazione»: più di ottanta Omayyadi assolutamente ignari vi si uniscono, e tutti vengono assassinati a tradimento: alla carneficina sfugge un solo superstite. Gli sgherri di Abū l-‘Abbās «non avevano alcuna considerazione per l’essere umano, essi eseguivano il volere dell’ira divina, la vendetta legittima... il loro movente era naturalmente politico; volevano rendere del tutto inoffensiva la dinastia caduta», afferma Julius Wellhausen e aggiunge un riferimento alla storia d’Israele: «In tutto e per tutto questa storia ricorda lo sterminio della casa degli Omri da parte dei profeti». 95 Tuttavia Wellhausen avrebbe potuto ricordare anche l’imbarbarimento morale, risalente allo stesso secolo, dei Merovingi convertitisi al cristianesimo nel regno dei franchi e anche gli stermini di massa e le deportazioni di Carlo Magno ai danni dei Sassoni (per non parlare del «matrimonio di sangue» inscenato, nel 1572, nella notte di San Bartolomeo da Caterina de’ Medici a Parigi, con le molte migliaia di Ugonotti morti in tutto lo stato).
Soltanto ‘Abd ar-Rahmān, nipote di Hišām, chiamato «falco dei Quraiš», riesce a sfuggire al massacro. Dopo una fuga avventurosa finisce in Nordafrica dove, avendo sposato una berbera (inviata in dono a suo padre da un governatore), egli riscuote le simpatie della popolazione. Nel 755 egli può trasferirsi in Spagna, assoggettando al suo dominio quasi tutta la penisola. Là, nominandosi Emiro (amīr) e rinunciando a mettere in discussione l’autorità del califfato, fonda la più importante dinastia della Spagna musulmana, che durerà fino all’XI secolo: i califfi omayyadi di Cordova. Per la prima volta, nell’estremo occidente, esiste, già nell’VIII secolo, un regno islamico indipendente dal califfato!
È diversa la sorte dell’ormai popolarissimo Abū Muslim. Come ricompensa per i suoi meriti egli fu nominato dagli Abbasidi governatore di Khorasan. In questa occasione si parla per la prima volta di «esperti nella discussione» (mutakallimūn), che devono convincere gli abitanti di Marw che Abū Muslim sta seguendo la retta via; non ci è dato sapere se già a questo punto si tratti di esperti in dispute teologiche. 96 Quel che è certo è che Abū Muslim diviene presto davvero troppo potente per i nuovi signori. Il califfo successivo, al-Mansūr, lo fa eliminare a tradimento: egli viene convocato a corte e, mentre entra disarmato nella tenda del califfo, viene assalito da due assassini. Questo omicidio perpetrato ai danni di un amico e di un leggendario eroe popolare, inspirerà successivamente molte rivolte; Abū Muslim diventa il simbolo dell’opposizione religioso-sociale agli Abbasidi.
Questi, tuttavia, mettono mano con decisione al loro programma. Ora non vi è soltanto un cambio dinastico, ma, come avremo modo di analizzare nel capitolo seguente, una trasformazione globale degli equilibri di potere. In altre parole: il modello arabo di impero (P II) è arrivato, con gli Omayyadi, alla sua fine politica. Esso continua a vivere in una forma diversa.
Il modello arabo di impero come visione della speranza: il panarabismo Mentre il modello delle scienze naturali (ad esempio quelle tolemaiche) veniva superato definitivamente, con l’aiuto della matematica e della sperimentazione, da un nuovo modello (quello copernicano), nella sfera delle religioni (e anche dell’arte) i vecchi paradigmi non necessariamente scompaiono. Anche il modello arabo di impero dimostra un’alta capacità di resistenza e sopravvivenza. Nonostante l’ignobile caduta dei califfi di Damasco, nel corso dei secoli il popolo continua a coltivare il ricordo di quell’epoca gloriosa, di una dinastia e di un impero arabi in senso stretto. E non solo in Siria! Questa rimarrà una convinzione di molti musulmani: gli arabi ora sono il migliore tra tutti i popoli; Dio, infatti, non a caso ha riservato proprio a loro la sua definitiva e universale rivelazione.
In futuro, quando il confronto tra l’islam e la modernità europea, e con essa anche la crisi d’identità dell’islam nel XIX secolo tende a raggiungere il massimo (di questo sviluppo, naturalmente, si parlerà molto analizzando il modello della modernità) a Damasco, a Beirut e al Cairo si torna a ricordare l’elemento arabo. Il movimento del «rinnovamento» si occuperà dapprima della lingua araba dell’età antica, poi studierà e modernizzerà l’alto arabo classico del medioevo. Il movimento mira prima di tutto a creare una nazione culturalmente araba.
Ma all’inizio del XX secolo, accanto all’arabismo culturale, affiora anche un arabismo politico. Tutti gli uomini di lingua araba, per via della loro grande storia comune, devono formare un’unica «nazione araba». Come reazione al colonialismo e all’imperialismo europei, o anche al panosmanismo e al panturchismo, nasce un movimento panarabo. Esso ha davanti agli occhi, ora coscientemente, ora inconsapevolmente, il modello dell’impero degli Omayyadi, nel coltivare la lingua e la religione araba e nel desiderio di ottenere, in forza di tali presupposti, l’unità sopranazionale di tutti gli stati arabi.
In fin dei conti, però, riesce a imporsi soprattutto un pragmatico arabismo economico: la nascita dell’OPEC, o OAPEC (Organization of Arab Petroleum Exporting Countries) nel 1960 e nel 1968, e la formazione di un Mercato Comune Arabo tra il 1964 e il 1965 hanno un notevole significato per la formulazione di una politica petrolifera unitaria e per questo i due eventi devono essere considerati in questa continuità storica, sebbene alla cooperazione economica non corrispose una cooperazione politica.
Su tutto questo torneremo parlando dell’epoca moderna. Intanto, però, sorge un interrogativo: che conseguenze avrà la rivoluzione abbaside, intrapresa in nome dell’islam? Porterà forse a quell’urgente e necessaria riforma islamica?
III. Il paradigma islamico classico della religione universale
I precedenti cambi di paradigma possono essere stati percepiti dalla storiografia spesso più come cambiamenti di regime che come un mutamento della costellazione generale. Ma per quanto riguarda il cambiamento di paradigma dall’impero arabo degli Omayyadi all’impero islamico degli Abbasidi le cose sono diverse. Anche la storiografia tradizionale lo ha considerato più di un semplice avvicendamento nella dinastia regnante. Tilman Nagel scrive giustamente: «Gli avvenimenti degli anni dal 129/747 al 132/750 segnano un cambiamento che ha abbracciato tutti gli ambiti della comunità islamica e della giovane cultura musulmana, cosicché non si ha avuto timore di parlare di una rivoluzione (M.A. Shaban)».1
1. HA INIZIO UNA NUOVA ERA
Gli stessi Abbasidi, sull’onda dell’entusiasmo rivoluzionario, definirono il loro governo «la svolta» (dawla): dopo il passato di corruzione, un rivolgimento di tutti i valori e una «nuova era»! In effetti il rivolgimento fu un vero e proprio cambiamento di paradigma. L’impero universale doveva essere ricostruito dalle fondamenta religiose dopo la caduta degli «usurpatori»: moltissimo sangue fu versato con questa giustificazione. Gli Abbasidi, che erano saliti al potere in modo poco piacevole, dopo «la svolta» si adoperarono per:
– screditare gli Omayyadi (ad eccezione dell’esemplare ‘Umar II) come miscredenti: il loro califfato fu presentato come un «dominio monarchico» di «tiranni», fondato sull’arroganza, la violenza e l’oppressione; un dominio, inoltre, che aveva tenuto i musulmani non arabi in una condizione di inferiorità rispetto ai musulmani arabi;
– legittimare la propria signoria, che ora si faceva risalire ai quattro califfi «ben guidati», di cui essi sarebbero stati i diretti successori. In questo modo la loro «rivoluzione» si radicò come istituzione, e il termine «dawla» avrebbe assunto in seguito semplicemente il significato di «dinastia», «regno». La loro ideologia di potere mirava a una comunità fondata, rafforzata e pacificata attraverso il credo islamico, con al centro il califfato, su cui gli Abbasidi, da quel momento, avrebbero avanzato i diritti. Dopo tutto appartenevano alla «casa» (bayt, che significa anche «famiglia») del Profeta: al-‘Abbās era zio di Muḥammad, mentre ‘Alī era solo suo cugino e doveva la sua legittimità alla moglie Fàtima.
La nuova metropoli culturale dell’islam: Baghdad
Per simboleggiare un nuovo inizio, spesso viene fondata una nuova capitale: lo avevano dimostrato già gli assiri, con la fondazione di Ninive, o i romani, con quella di Costantinopoli. E gli Abbasidi? Dapprima si limitarono a spostare la sede di governo a Kufa. Damasco, sede dei loro nemici, perdette ovviamente il ruolo di capitale, ma non fu distrutta. Solo allora gli abitanti della Siria si accorsero di avere perso il loro potere assieme agli Omayyadi, di cui si erano comunque stancati. E servì a poco che ricominciassero a simpatizzare per la loro antica dinastia, che tramassero disordini in Siria ed Egitto e che, ancora per secoli, si recassero in pellegrinaggio alla tomba di Mu‘āwiya.
Una cosa resta certa: l’egemonia della Siria, durata quasi un secolo, era stata definitivamente soppiantata dal predominio dell’Iraq, come era già accaduto, per breve tempo, con ‘Alī. La nuova dinastia veniva da Kufa, roccaforte degli alidi; ma era dal Khorasan («Terra dell’aurora») che traeva la sua forza. Ai siriani mediterranei subentrarono le popolazioni del Khorasan, iranico-medioasiatiche. Caratterizzati militarmente da una straordinaria forza in combattimento e da un incondizionato spirito di obbedienza, le truppe khorasaniche formano la guardia più disciplinata del califfo e il cuore del suo esercito permanente, conquistando nel tempo ulteriori posizioni di potere. Questi soldati, privi di appoggi tribali o di clan, erano sottomessi in obbedienza cieca al volere del loro capo, considerato spesso come un dio – una concezione che peraltro, in seguito, sarebbe diventata pericolosa per lo stesso califfo.
Il nuovo ordine divenne evidente assai presto, già sotto il secondo califfo abbaside, al-Manṣūr (754-775)2, che a causa della morte improvvisa del fratello, Abū l-‘Abbās as-Saffāh, era diventato l’effettivo fondatore del califfato abbaside e che avrebbe fatto moltissimo per consolidare (con l’aiuto dei sunniti) il regime dopo i suoi inizi rivoluzionari (resi possibili dall’aiuto degli Alidi): da un lato, per ricondurre all’ordine le aspettative apocalittiche dei propri affiliati più estremistici (rawanditi)3, dall’altro reprimere i nemici antichi (gli Omayyadi) e nuovi (gli Alidi).
Dopo aver fatto assassinare l’audace antesignano degli Abbasidi ed esponente dei dissidenti iranici, Abū Muslim, oltre a compagni di partito e potenziali rivali, al-Manṣūr si rivolse poi anche contro gli ex alleati Alidi (perlomeno contro quelli che non si lasciarono corrompere con la concessione di rendite) e infine annientò anche l’opposizione di Medina: a quel punto, questo sovrano alto e magro, abituato alla vita semplice, fondò una nuova capitale. All’inizio la pensò, probabilmente, come un semplice campo di sosta per le sue truppe del Khorasan, una residenza più sicura della turbolenta Kufa, roccaforte degli Alidi. Ma nei fatti la nuova città divenne il grande centro dell’impero.
Nel 762 al-Manṣūr diede inizio ai lavori, ricavando non pochi dei materiali dalle rovine della vicina Ctesifonte, capitale dell’ultima dinastia iranica autoctona. Il califfo chiamò la sua nuova capitale, programmaticamente, «Città della pace» (Madinat as-Salam), ma presto essa divenne universalmente nota come Baghdad, dal nome del piccolo villaggio che da millenni vi era sito (la parola è di etimo incerto, in persiano significa «dono di Dio»).4 Il luogo fu scelto con occhio strategico, in una posizione straordinariamente vantaggiosa sia dal punto di vista militare che da quello climatico ed economico – una fertile pianura al punto di incrocio delle vie commerciali tra il Khorasan, l’Iran, l’Iraq, la Siria e l’Egitto, che il sistema fluviale e di canalizzazione del Tigri e dell’Eufrate proteggeva e al tempo stesso collegava con il resto della Mesopotamia e anche con il Golfo Persico. Le relazioni commerciali si spinsero ben presto in direzione dell’India e dell’Africa orientale, per arrivare sino all’Estremo Oriente e all’Atlantico. Da tutto il mondo poterono giungere alla sede del califfo merci e beni culturali, mentre allo stesso tempo l’islam riusciva a insinuarsi, in modo silenzioso e pacifico, in Africa, in Asia meridionale e nel Sud-Est asiatico.
Baghdad non aveva nulla della città araba, si presentava invece – coerentemente con l’egemonia khorasanico-iranica – come una città in stile persiano. La sua pianta, che secondo modelli iranicoorientali aveva forma circolare, aveva probabilmente un diametro di 2,3 km e fu concepita secondo chiari principi geometrici, con al centro i sontuosi edifici della moschea e del palazzo del califfo. Da qui si dipartono quattro strade con altrettante porte, così che la città risulta suddivisa in quattro quartieri di uguali dimensioni, disposti ai quattro punti cardinali, a simboleggiare l’aspirazione al dominio universale. Ma questo centro del potere, difeso da due cerchia di mura – per raggiungerlo è necessario attraversare tutte le porte, riccamente decorate e ben difese – non potrebbe reggersi senza il grande esercito che occupa un quartiere specifico (al-Ḥarbīya) a nord-ovest della cerchia muraria, così come senza l’immensa forza lavoro (migliaia di operai edili, tessili, artigiani della carta e della pelle provenienti da Iraq, Iran, Siria ed Egitto) anch’essa alloggiata in un proprio sobborgo (al-Karḥ) a sud della cerchia muraria, con i suoi innumerevoli mercati, botteghe artigiane e fabbriche. Tutto è stato pianificato al meglio.
Solo la corte, l’harem, la guardia reale e le più alte cariche amministrative risiedevano all’interno della cerchia delle mura, con una massa enorme di schiavi e servitori. Eppure già durante il suo completamento questo centro militare, economico e culturale perfettamente organizzato e controllato si rivelò troppo piccolo. Su entrambe le sponde del Tigri, al-Manşūr e i suoi successori cominciarono a far costruire sempre nuovi palazzi ed edifici amministrativi con innumerevoli giardini, bagni e persino banche. Così la città dell’esercito e dell’amministrazione divenne ben presto una metropoli multietnica, grande dieci volte la Ctesifonte sasanide, persino più di Costantinopoli. Baghdad fu davvero la più vasta e la più splendida città dell’epoca (escludendo la Cina), lunga più di sette chilometri e larga sei, con una popolazione tra i 300.000 e i 500.000 abitanti, che nel X secolo diventarono forse un milione e mezzo: la metropoli culturale del mondo musulmano per secoli. Lo era già all’inizio di quel IX secolo in cui, in Europa, l’impero di Carlo Magno con le sue città ancora primitive, si spezzava in tre tronconi, che dovevano scivolare in una profonda decadenza economica e culturale, minacciati dalle invasioni dei normanni a ovest, degli ungari a est e dei saraceni musulmani (la Sicilia apparteneva a loro già dall’827!) a sud.
Baghdad, invece, si ergeva ora in tutta la sua potenza: capitale dell’islam, ricca, internazionale, portatrice di elementi arabi e non arabi, essa incarna splendidamente la nuova costellazione generale (P III):
- Al posto degli Omayyadi, il cui orientamento politico era arabo e siriaco (P II), comandavano ora gli Abbasidi. La loro tendenza politica era antisiriaca, irachena e cosmopolita.
- La legittimazione storico-teologica del nuovo regime rivoluzionario consisteva nel presunto legame con il paradigma proto-islamico dei califfi di Medina (P I), che da ora sarebbero stati considerati «i quattro ben guidati» (ar-rāšidūn), con l’inclusione di ‘Alī e in contrapposizione ai loro successori.
- Non erano più le tribù arabe a costituire il contingente principale dell’esercito, bensì i non arabi: dapprima gli abitanti del Khorasan, in seguito i turchi. Essi furono il sostegno più potente del regime abbaside.
- Programmaticamente, l’obiettivo fu quello di rinnovare l’impero non su base araba, ma islamica. I califfi abbasidi ripresero a considerarsi, consapevolmente, guide religiose della umma di tutti i musulmani e antesignani dell’islam come religione universale che abbraccia e unisce tutti i popoli.
- L’essenza dell’islam – l’unico Dio e Muḥammad come suo profeta – non solo rimase indiscussa, ma fu nuovamente ribadita.
Era la fine di un impero dominato dagli arabi, dunque? È più che evidente che «la svolta» aveva drasticamente cambiato la posizione degli arabi in tutto l’impero.
Al posto della nazione araba, l’islam come religione mondiale
Occorre distinguere, ma non separare, tre grandezze che, sulla base della rivoluzionaria politica sociale degli Abbasidi, cambiano di valore nella nuova costellazione generale:
– il popolo arabo: la «nazione» degli arabi;
– la cultura araba: la lingua araba come sua espressione fondamentale;
– la religione araba: l’islam.
Concretamente, queste sono le conseguenze:
1. L’egemonia del popolo arabo è finita. La vecchia struttura araba della «nazione in armi», così come l’aveva sognata il secondo califfo «ben guidato» ‘Umar, era crollata. I suoi sostenitori erano in fin dei conti solo gli Omayyadi e i siriani. Ora non bastava più essere arabi per far parte dell’élite di governo. Gli arabi, la cui posizione privilegiata si fondava originariamente sui diritti conquistati in guerra, vennero scacciati dalle posizioni di potere militare e trovarono ora impiego nel settore civile. A loro volta, i numerosi non arabi, che fino ad ora erano stati esclusi dall’élite, ottennero finalmente accesso anche alle più alte cariche militari e amministrative. Diveniva realtà quell’impero rinnovato che già l’omayyade ‘Umar II aveva sognato, ma che non era stato in grado di realizzare: gli arabi persero i loro privilegi, le tribù arabe non erano più i «quadri» dello stato di Dio; la loro aristocrazia non ricopriva più l’intero impero come una rete (peraltro indebolita già sotto gli Omayyadi) di gruppi di potere tra loro collegate per parentela. Come già era successo, quanti più neomusulmani erano accolti nell’ordine genealogico tramite affiliazione, tanto più questo ordine veniva poco alla volta minato. Ora tutti i musulmani, che fossero stati arabi o meno, dovevano potersi riconoscere nel regno islamico. Si ritornava all’ideale dell’uguaglianza di tutti i credenti, come previsto dal Profeta nel Corano.
Proprio nel Khorasan (città di Merw!), da dove gli Abbasidi erano partiti alla conquista dell’intero regno, anche gli arabi si erano così ben ambientati da denominarsi non più secondo la tribù di origine, ma secondo il luogo di residenza. Comunque il contributo decisivo alla vittoria degli Abbasidi era venuto dagli innumerevoli neomusulmani di origine straniera (mawālī): costoro avevano acquisito ora pari diritti e, in un’epoca di crescita demografica e di rilancio economico, potevano vantare gli stessi diritti e gli stessi doveri nell’esercito o nell’amministrazione, nel commercio o nell’artigianato, anzi, di fatto in questi campi conquistarono spesso il predominio. Anche se la famiglia regnante (per lo meno nei suoi rappresentanti maschili) rimaneva araba e anche se le regioni d’origine dei conquistatori rimanevano a maggioranza araba, in futuro sarebbero stati i non arabi a costituire la maggioranza della popolazione islamica. Dopo un secolo di dominazione abbaside cadeva persino in disuso la definizione mawālī, ormai priva di significato nonostante le tensioni che permanevano tra i due gruppi. In breve: l’impero islamico non era più uno stato arabo, ma uno stato multietnico. E quante più etnie trovavano la strada della fede islamica, tanto più grande diventava l’impero.
2. La cultura araba si trasformò in un patrimonio comune. Il crollo della «nazione» araba non portò a quello della sua cultura: essa divenne piuttosto una cultura internazionale condivisa da tutti i musulmani. La lingua araba non scomparve, rimase anzi la lingua del Corano e di conseguenza dell’islam. In misura crescente, anche moltissimi non arabi la utilizzavano come lingua franca. Persino presso gli iranici si impone l’arabo nella scrittura e nell’uso colto; solo la poesia – ora sempre più coltivata anche in Persia – rimane persiana.
Per quanto riguarda i non musulmani, in Siria ed Egitto – al contrario che in Persia – l’arabizzazione fu più efficace dell’islamizzazione. Col tempo, l’arabo assorbì anche le lingue dei popoli cristiani del Vicino Oriente: si impose come lingua degli scambi anche nelle regioni del regno che erano state bizantine, con una popolazione prevalentemente aramaica. L’arabo si insinuò persino nella liturgia cristiana: ancora oggi, in quei luoghi parte della funzione religiosa cristiana viene celebrata in arabo. È anche importante ricordare che l’alfabeto arabo subentrò all’alfabeto più antico dovunque si impose l’islam. Questo vale non solo per il persiano, ma anche per il turco – una lingua a cui la scrittura araba si adatta ancor meno.
3. La religione islamica divenne religione mondiale. L’islam non fu danneggiato, ma anzi rafforzato dal dissolvimento della «nazione» araba. La religione islamica non solo rimase il fondamento della cultura araba, ma riuscì a perdere i suoi vincoli etnici. Solo ora, sulla base dell’uguaglianza, poté diventare anche la religione degli egiziani e dei berberi, dei greci e dei persiani, dei centroasiatici e dei turchi. Dunque, in sostanza:
- Mentre in Arabia, patria degli arabi e dell’islam (P I), la situazione si faceva sempre più caotica, tanto che gli stessi pellegrinaggi alla Mecca comportavano molti rischi, l’islam si liberò dal suo radicamento provinciale e dispiegò la sua forza universale.
- Al posto della tradizionale lealtà tribale araba, valevano ora l’ordine e la fratellanza universali islamici.
- Anche se l’Arabia giocò un ruolo ancora molto periferico in economia e politica, la sua religione mantenne per i musulmani un significato universale. L’islam diventò una religione mondiale in senso stretto.
Non si può ignorare che l’islamizzazione faceva passi da gigante. Ad esempio, ben presto l’islam cancellò quasi completamente lo zoroastrismo in Persia. Anche nel Maghreb, dove il cristianesimo si era insediato solo nella forma di una chiesa coloniale, una gran parte dei berberi passò all’islam. Il cristianesimo riuscì a resistere solo in enclavi in Siria, Mesopotamia ed Egitto. Così proprio i copti, gli antichi abitanti dell’Egitto, rimasero fedeli al loro credo cristiano benché ora arabizzati.
Lo splendore cosmopolita del califfato
Tutto ciò non disturbava molto i califfi: del resto anche presso la loro corte si trovavano non soltanto le più svariate nazionalità, ma anche ebrei e cristiani, molti dei quali immigrati dai villaggi iracheni – per non parlare dei cripto-«pagani». Per quanto eterogenea fosse questa popolazione, essa venne tuttavia integrata, nonostante alcune tendenze separatistiche nelle province esterne e sporadici disordini, in una società caratterizzata dalla cultura araba e dalla religione islamica, il cui centro era proprio Baghdad: una corte ricca, sontuosa, cosmopolita.
I califfi di Baghdad: prima di loro il califfato non era mai stato così imponente. Non occorreva più interpellare i capi tribali arabi, né tenere conto delle strutture tribali. Il califfo presiedeva ancora la preghiera del venerdì e di tanto in tanto amministrava la giustizia di persona e con grande pompa. La centralizzazione, che già sotto gli Omayyadi era molto avanzata, raggiunse ora il suo apice: i califfi abbasidi erano i dominatori supremi, e ben presto superarono di gran lunga gli Omayyadi nel loro assolutismo e nel loro sfarzo.
In occasioni solenni il califfo – che con la sua famiglia era il successore del Profeta e la massima incarnazione dell’isiam – indossava la burda, il mantello del Profeta. Quando, raramente, si degnava di mostrarsi al popolo, dava prova di grande munificenza. Dopo che tutte le differenze tra arabi e non arabi, e con ciò anche le importanti differenze di ceto sociale, furono cadute, il califfo – in qualità di «Principe dei credenti» (amīr al mu’minīn) e «vicario di Dio» (ḫalīfat Allāh) – si contrappose «per grazia di Dio» alla massa dei musulmani: era al di sopra del popolo, secondo un modello persiano-antico-orientale, al di sopra anche della stessa aristocrazia, e dotato di una plena potestas quale avrebbero posseduto, secoli dopo, solo i papi romani dopo Gregorio VII (vicarii Dei, vicari di Dio) e i re francesi a partire da Luigi XIV: «L’état, l’église, l’umma – c’est moi!». L’obiezione secondo cui non erano «vicari di Dio», ma soltanto «vicari del Profeta», soltanto «vicari di Pietro o di Cristo» veniva semplicemente ignorata da codesti «autocrati». Di un senato, un organo di «consiglio» (sura) ritennero tutti quanti di poter fare a meno.
I califfi organizzarono il governo in maniera autocratica, secondo quanto richiesto dagli interessi statali e da quello personale. Chi avrebbe potuto opporsi a loro? Che fossero arabi o non arabi, tutti erano sudditi, nient’altro che sudditi. E mentre si sforzava di prendere sul serio le loro lamentele, il nuovo regime ne favoriva allo stesso tempo la passività politica. Lo stato si ridusse in larga misura alla corte. Se al tempo dei califfi damasceni vi era stata un’aristocrazia legata da vincoli di sangue, nel senso più lato, ora erano subentrati i plebei del Khorasan, addestrati all’obbedienza, che si mostravano nel centro stesso del palazzo. Eletti dagli Abbasidi a loro «guardia pretoriana», erano pronti a eseguire qualsiasi ordine del sovrano. A fianco dei loro ufficiali comparivano a corte in grande numero anche gli affiliati del clan dominante, cioè gli Hasimiti (hāšimīya). Consapevoli di essere gli unici rappresentanti del clan del Profeta, essi godevano della vita opulenta di corte – spesso senza rinunciare al vino, proibito al popolo dei credenti – circondati da una miriade di servi di entrambi i sessi. Gli intrighi all’interno degli harem e altre macchinazioni erano all’ordine del giorno.
Al fianco del sovrano assoluto si definirono tre nuove significative cariche di corte, che non esistevano né a Medina né a Damasco:
– l’astrologo di corte, che veniva interrogato per tutte le iniziative importanti (come la posa della prima pietra di Baghdad) e veniva portato persino sui campi di battaglia;
– il capo della posta, che come responsabile del servizio postale, ottimamente organizzato, doveva controllare segretamente tutta la corrispondenza e (tramite persone di fiducia selezionate) persino i governatori delle province;
– il boia, che col suo cappuccio di pelle poteva intervenire, secondo il modello iranico, direttamente a lato del trono per un’esecuzione o una tortura estemporanee.
Gli Abbasidi avevano annunciato «la svolta», un ordinamento migliore e più giusto, e in effetti già al-Manṣūr prese in mano la riforma in modo energico ed efficiente: operando cambiamenti rivoluzionari nell’esercito e nell’amministrazione egli seppe dare una base sicura al nuovo regime. L’organizzazione dell’esercito determinò un microcambiamento di paradigma:5 i privilegi degli arabi furono aboliti e si costituirono nuove schiere non più legate da obblighi nei confronti dei vari interessi di clan o di classe, ma solo ed esclusivamente nei confronti del califfato. In realtà, già gli Omayyadi si erano resi conto che l’idea di una «nazione araba in armi» formata dai diversi clan, così come l’aveva un tempo sostenuta il secondo califfo «ben guidato» ‘Umar (P I), era divenuta anacronistica e doveva essere sostituita da quella di un esercito professionista al soldo del califfato e dipendente unicamente da esso. Ma sino a che sotto gli Omayyadi continuarono le guerre di conquista (P II), si rimase totalmente dipendenti dalle leali truppe tribali arabe.
Tuttavia con gli Abbasidi quest’epoca era terminata, e la principale funzione delle truppe arabe era la difesa dei confini: in Anatolia, nello Yemen, in Armenia e in India. Qui, in caso di necessità, era possibile reclutare anche i mawālī o persino i non musulmani del luogo. È quello che successe nell’armata principale del califfato, che consisteva di arabi del Khorasan con i loro discendenti e clienti, e che assunse un’importanza capitale, sia per azioni contro l’impero bizantino, che ancora resisteva a ogni offensiva, sia per la soppressione di disordini interni (P III). Durante le spedizioni militari, una consistente riserva dell’esercito rimaneva di stanza nella reggia: a Baghdad i vertici dell’esercito facevano parte della corte – diversamente che a Medina e a Damasco. Questo significava d’altra parte che gli arabi in Iraq, in Siria, in Egitto e nel Khorasan ora potevano venire affrancati dal servizio militare e intraprendere un’attività civile.
Il governo dei califfi
Ancora più importante della riforma dell’esercito fu la riforma dell’amministrazione. Già i califfi di Damasco avevano tentato di creare una burocrazia che facesse capo soltanto a loro: ma si trattò di un’operazione modesta rispetto a quella compiuta dai califfi di Baghdad, che si basò soprattutto su favoriti e fantocci del sovrano (per lo più liberti). Chiunque poteva ottenere l’accesso alle sfere più alte, ma altrettanto facilmente poteva finire in disgrazia – gli intrighi non mancavano di certo. Tutto ciò che riguardava titoli, uniformi e onorificenze dipendeva dalla benevolenza del califfo. Anche qui gli arabi continuarono a occupare posizioni di rilievo – soprattutto all’interno della stessa dinastia, nonché nel settore della giustizia – ma un gran numero di funzionari era ora non musulmano: scribi persiani dal Khorasan, cristiani nestoriani dall’Iraq e nel settore finanziario anche non pochi ebrei. Tutti costoro si attirarono troppo spesso, al posto del califfo, l’odio della popolazione. Ma era diventato chiaro quale atteggiamento fosse ormai richiesto a un funzionario o a un soldato:
- non l’appartenenza a una stirpe o a un clan, ma l’obbedienza al sovrano;
- non più i privilegi di nascita, ma, a fianco della qualificazione professionale, soltanto la lealtà incondizionata alla dinastia era determinante per ottenere una posizione nell’amministrazione e nell’esercito.
Gli Abbasidi attingevano a esperienze e tradizioni precedenti, ricorrendo anche a parte del vecchio personale degli Omayyadi. Al tempo stesso, però, essi ingrossarono considerevolmente la gerarchia dei funzionari di corte – in un processo che ricorda la «legge» definita dall’inglese C.N. Parkinson, secondo cui gli amministratori si procurano reciprocamente lavoro per aumentare il numero dei loro sottoposti e poter così far crescere il proprio prestigio personale. All’inizio il califfo rispose personalmente di ogni questione: poi però furono introdotti, in modo decisamente razionale, tre tipi di uffici (dīwān6): la cancelleria (dīwān ar-rasā’il), l’autorità finanziaria (dīwān al-harāǧ) e, il più importante, il comando supremo militare (dīwān al-ǧaiš). Tutti questi svilupparono – oltre a un sistema burocratico completamente nuovo (corrispondenza, sigillo, tribunale amministrativo) – una serie crescente di ulteriori sottodivisioni, per le quali naturalmente c’era bisogno di nuove autorità di controllo. Si crearono così numerosi «segretari» (kuttāb, sing. kātib), esperti o funzionari, che, coscienti del proprio rango e ottimamente formati, costruirono una burocrazia destinata a sopravvivere a tutti i califfi e ai loro governatori. Non esisteva però un «gabinetto», cioè un ristretto gruppo di funzionari dove ognuno di essi fosse chiamato a guidare indipendentemente uno specifico settore,7
Il fatto che i califfi fossero sovrani assoluti non significava tuttavia che fosse molto facile per loro imporre il proprio volere in tutto l’impero fino ai territori più lontani:8 l’impero era troppo vasto e complesso per farlo. Solo le province adiacenti al centro erano sotto il diretto controllo del califfo, quelle più decentrate erano per così dire affiliate, quelle lontanissime invece furono governate da dinastie locali per conto del califfo. In teoria il califfato poteva, dove necessario, imporre la propria volontà anche con la forza tramite esercito, polizia e ispettori. Questo era però possibile solo in parte, poiché l’immenso impero e le sue province si componevano appunto di piccole comunità estremamente diversificate. E fu proprio negli innumerevoli villaggi in cui i rapporti di proprietà risultavano spesso non chiari e il calcolo delle entrate difficile, che i funzionari centrali e provinciali si videro costretti a collaborare con le autorità locali, grandi patriarchi e proprietari terrieri, notabili che sulla base di parentela, clientela, rapporti finanziari e amministrativi erano legati più ai governi provinciali che a quello centrale. Furono loro a far funzionare l’apparato amministrativo, il sistema di comunicazione e quello di tassazione, così diversamente strutturati a seconda dei luoghi.
Il regime abbaside mostrò grande tolleranza nei confronti delle antiche religioni (zoroastrismo e anche cristianesimo), che del resto erano già piuttosto disorganizzate. L’interesse principale del califfato fu quello di racchiudere le élite locali e centrali, di qualunque origine etnica o religiosa, in un sistema il più possibile coerente, naturalmente su base religiosa: «Questo sistema di alleanze era fondato su un concetto di impero come prodotto della volontà divina. Attraverso questa volontà divina la sublime persona del califfo regnava aspettandosi l’obbedienza passiva di tutti i suoi sudditi».9
Si trattava, insomma, di un gigantesco apparato amministrativo che il califfo non poteva più tenere sotto controllo, e che necessitava quindi di responsabili dell’amministrazione statale per il coordinamento, la supervisione e il controllo. Probabilmente al-Manṣūr si occupava ancora personalmente di tutto, ma già il figlio e successore – chiamato per spirito apocalittico al-Mahdī, «il guidato»10 (775-785) – designò come supervisore di tutti gli uffici centrali un visir (wazīr = «che porta un peso»), le cui competenze dapprima dipendevano totalmente dall’autorità del califfo, ma che in seguito assunse un ruolo sempre maggiore.
Al-Mahdī cercò, per il resto, di fare onore al suo nome apocalittico-messianico: fece svuotare le prigioni, istituire corti d’appello, restaurare moschee, segnaletica e pozzi sulle vie di pellegrinaggio e fece donazioni alla Mecca e a Medina. E val la pena di ricordare inoltre che al-Mahdī seppe intrattenere con il patriarca nestoriano Timoteo I un dialogo religioso che ci è stato tramandato da parte cristiana.11
Già sotto questo califfo veniva tuttavia emanata un’esortazione ai teologi (mutakallimūn) a dibattere con gli «eretici» (zanādiqa); non solo, ma già sotto il suo califfato si giunse alle crocifissioni di «eretici». Il suo successore al-Hādī (785-786) istituì la carica di «giudice di eretici». Nell’apparato burocratico era facile ora essere sospettato come «eretico» (zindīq); si arrivò a una vera e propria epurazione. Vennero perseguitati in special modo i manichei (già perseguitati peraltro dalla religione di stato zoroastrista-sasanide della Persia), la cui professione di fede dualistica in un principio primordiale buono e uno cattivo risultava particolarmente scandalosa per il monoteismo dei musulmani. Spesso tuttavia furono accusati di «eresia» anche personaggi malvisti politicamente, come Ibn al-Muqaffa, che abbiamo già nominato, il primo importante prosatore e traduttore dal persiano, giustiziato sotto al-Manṣūr.
Una favola da mille e una notte?
Questo primo periodo del califfato abbaside rimase nella memoria di tutte le successive generazioni musulmane attraverso i racconti di Le Mille e una notte, un titolo che nell’originale arabo suona ancora più poetico: Alf Laila wa-Laila. Quest’antologia araba di più di 300 racconti di genere diverso, che affondano le loro radici nell’epica popolare orientale, in svariati paesi dall’Egitto all’India, è senza dubbio la più famosa raccolta di racconti della letteratura mondiale, nella sua versione definitiva viene posta interamente sulle labbra di una sagace donna di nome Sherazad.12 La raccolta è legata al nome del califfo Hārūn ar-Rašīd. Che cosa abbiamo di fronte? Semplici fantasie o la pura verità? Certamente più finzione che realtà.
I califfi abbasidi Fino alla perdita dell’Indipendenza
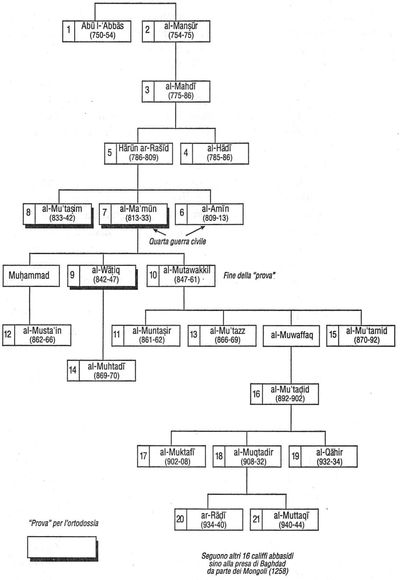
È vero che i racconti, ambientati in un milieu cortese-cittadino di inaudita ricchezza e lusso, hanno senz’altro come sfondo reale il mondo di Hārūn ar-Rašīd ibn al-Mahdī (786-809),13 il quinto califfo abbaside. Si tratta del figlio di al-Mahdī (terzo califfo) e nipote di al-Mansūr (secondo califfo). Suo fratello al-Hādī (quarto califfo), per essere sicuro che non insidiasse la successione del proprio figlio, lo aveva fatto gettare in carcere, e per questo suo gesto era stato assassinato sei mesi dopo la presa di potere (non senza l’intervento della madre, che preferiva Hārūn). Nelle favole Hārūn appare come un principe esemplare, in realtà però non era dotato né di un carattere molto affascinante né di una straordinaria statura come sovrano. Persino nelle favole egli è solito perlustrare in incognito la Baghdad notturna, spesso accompagnato dal poeta della spensierata gioia di vivere, Abū Nuwas – e dal boia.
L’anno 803 mostrò le debolezze del suo carattere. Hārūn, un califfo che per molti anni si era appoggiato alla casta di funzionari dei barmakidi, di grande esperienza politica, come visir e generali, con un voltafaccia improvviso fece giustiziare il suo fratello di latte e amico personale di vecchia data, il barmakide Ğa ‘far, assieme a numerosi membri della sua famiglia, ed esautorare tutti i membri rimanenti. Probabilmente voleva solo liberarsi (in maniera purtroppo tipica del luogo) da un’influenza divenuta fastidiosa. Non sono verificabili le dicerie su relazioni omosessuali con Ğa ‘far o sulla gravidanza della sorella di Hārūn per mano di un amico barmakide. In ogni caso non può sfuggire che sotto Hārūn è già iniziata l’estinzione del califfato: in cambio di un «riscatto» egli in pratica concesse l’indipendenza, sotto la sovranità formale del califfo, agli aglabidi in Tunisia, mentre negò questo riconoscimento ai ribelli idrisidi in Marocco.14 Non c’è dunque motivo di trasfigurare Hārūn nel tipo ideale di sovrano orientale.
Hārūn non fu nemmeno particolarmente tollerante. Lui, che già da principe aveva condotto una spedizione militare fino al Bosforo ed estorto un trattato di pace per lui vantaggioso all’allora imperatrice bizantina Irene (da allora venne chiamato «ar-Rašīd», «colui che segue il giusto sentiero»), inviò all’imperatore bizantino una lettera di stato in cui metteva in guardia il sovrano greco dai falsi consiglieri (i vescovi) e portava argomenti contro la trinità e la natura di figlio di Dio di Gesù. Questa lettera rappresenta «la più antica apologia della natura profetica di Muḥammad» (J. Van Ess):15 raccoglie profezie dall’Antico16 e dal Nuovo Testamento17 e per la prima volta anche l’accenno a miracoli. Sotto Hārūn ar-Rašīd il Gran Qadi Abū Yūsuf fece redigere norme speciali per i "protetti" non musulmani. A costoro veniva prescritto di indossare abiti diversi dai musulmani. Hārūn fece inoltre abbattere molte chiese dopo un aspro scontro militare con l’imperatore Niceforo I, e questo non soltanto nel territorio confinante con Bisanzio, ma anche a Bassora e altrove. Fece anche giustiziare senza pietà un altolocato quraisita convertito al cristianesimo, per di più suo lontano congiunto.
Malgrado tutto questo, rimane un dato incontestabile: sotto il quinto califfo Baghdad raggiunse uno splendore economico e culturale senza precedenti, con amplissimi contatti internazionali. Hārūn scambiò ambascerie anche con il suo contemporaneo Carlo Magno, inviandogli in dono ad Aquisgrana un elefante bianco. Nell’anno dell’incoronazione romana di Carlo (800), mercanti musulmani raggiungevano già il porto cinese di Canton (per tacere dei contatti con la Russia e il regno dei kazari). La base economica di questa fioritura era un’industria tessile, metallurgica e della carta che procurava benessere ad ampi strati della popolazione, permettendo al califfo e alle classi dominanti un inaudito sfoggio di magnificenza e potenza. La madre di Hārūn, una ex schiava yemenita, aveva il vezzo di mangiare solamente da piatti d’oro o d’argento, incastonati con pietre preziose. L’immenso palazzo di Hārūn era colmo di eunuchi, concubine, cantanti, nonché di servitù maschile e femminile di ogni genere. No, Hārūn non fu grande come statista, ma come viveur: come prodigo finanziatore delle arti e degli artisti, come conoscitore di musica e di poesia; le scienze, a parte la filologia, erano all’epoca ancora poco diffuse nel mondo islamico. Molto di quello che qui si presenta come cultura araba è senz’altro derivato, per quanto riguarda astronomia e medicina, soprattutto dai greci.18
Quel mondo conobbe certo numerose rivolte, dominate comunque dal quinto califfo con relativa facilità; vi furono anche, naturalmente, grandi discussioni sulla politica da intraprendere nell’impero. Si delinearono qui due partiti: da una parte, i funzionari, molti di loro persiani e originari delle province orientali, sostenuti in un primo tempo dai barmakidi; dall’altra, gli esperti di religione, molti di loro arabi, sostenuti dal nuovo visir. La domanda era: quale doveva essere il futuro dell’impero? La mancanza di un rigido sistema di discendenza (padre-figlio primogenito ecc.) ebbe ancora una volta conseguenze fatali. Hārūn credette di poter superare il conflitto con la suddivisione dell’eredità: ad al-Amīn, figlio di un’araba libera e moglie legittima, lasciò in eredità quasi tutti i paesi arabi; ad al-Ma’mūn, figlio di una schiava persiana, le province iraniche; al terzo figlio, al-Mu‘tasim, infine, le regioni sul confine bizantino.
Eppure proprio questa spartizione favorì il frantumarsi dell’impero. Nell’808, infatti, Hārūn ar-Rašīd partì per il Khorasan per reprimere una rivolta che durava già da due anni e morì a Tus (presso l’odierna Meshed) dopo pochi mesi di malattia. Il figlio al-Amīn,19 allora, gli succedette a Baghdad come sesto califfo. In un primo momento, però, tutte le sue energie furono impegnate per escludere dal potere il fratello al-Ma’mūn. Questa lotta fratricida per la successione al trono sfociò infine, nell’810, in uno scontro aperto che si sarebbe concluso solo tre anni dopo con la morte violenta del sesto califfo.
Il vincitore era al-Ma’mūn,20 che avrebbe guidato la dinastia abbaside per i successivi vent’anni (813-833) come settimo califfo. In qualità di promotore dell’accademia di Baghdad, egli ebbe una rilevanza culturale sicuramente maggiore di quella del padre; ci occuperemo di lui soprattutto in relazione alle dispute sulla teologia razionalistica. Da questo momento in avanti quasi tutti i califfi sarebbero stati, come lui, figli di schiave concubine. Perché? La famiglia dei califfi, che rivendicava il diritto esclusivo alla carica imperiale, voleva sottrarsi a ogni possibile complicazione derivante da un matrimonio con famiglie di sudditi. Nel futuro non si sarebbe più potuto parlare, dunque, di califfi di puro sangue arabo.
2. L’ISLAM CLASSICO: UNA CULTURA UNIVERSALE
Il primo periodo abbaside, un’età di splendore della cultura in tutta la storia dell’umanità, può a buon diritto essere designato come l’epoca in cui l’islam raggiunge la sua forma classica. Non solo per la prosperità economica senza precedenti e per lo sviluppo degli apparati di governo, dell’amministrazione e della giurisprudenza che caratterizzano da ora in poi l’islam «classico», ma soprattutto per tre evoluzioni le cui conseguenze si ripercuotono ancora oggi sull’islam e di cui ci dovremo occupare con grande attenzione. All’interno di questo paradigma (P III) si giunge cioè
- al delinearsi della cultura specificamente islamica: essa è fondata sull’arabo classico, sull’arte di vivere persiana e sulla scienza ellenistica;
- alla formazione del diritto islamico (fiqh): si creano le quattro scuole di diritto tuttora esistenti;
- allo sviluppo della teologia islamica (kalam): nasce una sorta di «Scolastica», che ha ancora oggi ripercussioni sul pensiero teologico-sistematico dei musulmani.
Il periodo aureo dell’islam, del suo diritto, della sua teologia, della sua cultura, è dunque e rimane il medioevo – l’Alto medioevo, dalla prospettiva europea. All’epoca degli Abbasidi a Baghdad e dei Fatimidi in Egitto, la Roma medievale del X secolo sta vivendo il suo «saeculum obscurum» come città provinciale periferica, in mano a congreghe di nobili e a papi incapaci e criminali. La scienza islamica di allora è molto più avanzata di quella europea; una condizione di cui, ancora oggi, recano testimonianza gli innumerevoli prestiti linguistici arabi – da alcool, algebra e arsenale, magazzino, maschera e mocca sino a zenit, zero e zucchero.21
Ciò che si delineava già prima nell’architettura islamica si realizza ora, sotto gli Abbasidi, nella cultura islamica in generale: elementi arabi si mescolano a quelli ellenistici e persiani nella sintesi superiore di una cultura mondiale in cui l’islam è immerso. A ciò contribuiscono la mescolanza tra le etnie nei grandi centri, le relazioni commerciali internazionali e le rotte dei pellegrinaggi. I singoli elementi arabi, persiani ed ellenistici di questo «islam cosmopolita» sono stati analizzati in dettaglio da Ira M. Lapidus,22 e questo mi permette di mostrare con chiarezza la differenza con la costellazione precedente.
L’arabo come lingua franca e lingua standard
Come si è già accennato, sotto il nuovo regime abbaside diminuisce l’importanza politica degli arabi ma non certo quella della lingua araba, che continua a fungere da lingua franca universale dell’immenso impero. Anche gli oppositori dell’egemonia araba scrivono in arabo; l’arabo rimane il fondamento della cultura comune di popoli così diversi. Sia a corte sia nelle città e nei circoli scientifici ci si occupa intensamente della letteratura araba, persino di quella pre-islamica, per testimoniare in questa maniera la fama del conquistatore arabo e del califfato; la lingua della poesia araba antica e quella del Corano non si differenziano in maniera sostanziale. Com’è ovvio, nell’ambiente cittadino lo studio dell’arabo è in larga misura legato allo studio del Corano.
Col passare del tempo, però, gli arabi si trovano di fronte a un problema complesso: i dialetti arabi, già comunque molto diversi tra loro nelle diverse province, si stanno allontanando dall’arabo puro del Corano – nel lessico, nella grammatica, nella sintassi, nello stile – sotto l’influsso dell’idioma locale. Che fare? Sono soprattutto gli esperti di religione, nelle scuole di grammatica di Kufa e di Bassora, poi anche di Baghdad, a impegnarsi con ammirevole energia per insegnare l’arabo puro della Mecca e delle tribù del deserto. Le radici delle parole vengono descritte in maniera sistematica, il lessico spiegato, si sviluppano le regole della grammatica e della sintassi. Viene così ricostruito – con un occhio alle necessità del periodo abbaside – quello che ora si chiama l’arabo classico o arabo standard: la lingua di riferimento e il modello per le persone colte fino ai nostri giorni. Se ne indagano le origini nella poesia e nella saggezza proverbiale preislamica e al tempo stesso si redigono una poderosa grammatica e numerosi vocabolari.
Contemporaneamente si sviluppa la storiografia araba classica. Essa ruota attorno alla vita (sīra) del Profeta e alle rivelazioni coraniche, e in seguito attorno alle conquiste e alla vita dei primi capi musulmani. L’apice è raggiunto con i monumentali «Annali dei Profeti e dei Re» (839-923) di aṭ-Ṭabarī, una raccolta di tutte le tradizioni sugli avvenimenti della storia mondiale, e con le biografie del Profeta rispettivamente di Ibn Ishāq (morto nel 767) e di Ibn Hišām (morto nell’834) e con il «Libro delle conquiste» di al-Balādurī (morto nell’892). Gli Abbasidi si interessano molto a questi testi, da cui ricavano una legittimazione religiosa per la loro supremazia.
Si aggiunge tuttavia anche un interesse del tutto secolare: la poesia, da sempre di casa in Arabia (cfr. cap. A II, 2), diviene lo specchio letterario della vita mondana, di corte e cittadina, una raccolta enciclopedica dell’intero sapere dell’epoca. Anche nella letteratura viene in luce un nuovo paradigma:
– nella poesia beduina araba i temi prevalenti erano i cammelli, le imprese eroiche dei condottieri tribali e le loro amate lontane nel deserto; questa letteratura ora viene addirittura raccolta in antologie;
– nella nuova poesia si sente parlare ancor più di palazzi, giardini e battute di caccia, di passioni e intrighi, di «vino, donne (anche bei fanciulli) e canto». Il principale esponente di questa poesia è il già nominato Abù Nuwas (morto intorno all’815). Di orientamento più mistico, nella seconda metà del IX secolo, Ibn ar-Rūmī («il Romano», ovvero bizantino), figlio di un prigioniero bizantino e di una persiana, sulla cui poesia piena di appassionato esistenzialismo torneremo. Mancano, è vero, in questo periodo di splendore culturale, una poesia epica e una poesia drammatica araba; ma, a confronto con la letteratura carolingia o bizantina della stessa epoca, quella araba è considerevolmente più avanzata.
Questo sviluppo letterario avrà importanti conseguenze religiose. Sono fin troppo chiari i paralleli con lo sviluppo e il successivo isolamento del latino nel cristianesimo occidentale:
– l’intera cultura araba contribuisce a riflettere e a illuminare il Cofano;
– chi vuole davvero conoscere il Corano deve avere piena confidenza con la lingua araba classica e le sue tradizioni letterarie;
– nonostante tutti questi sforzi a difesa dell’arabo classico, conservatosi come lingua letteraria, la lingua del popolo continuerà ad allontanarsi nella sua evoluzione dall’arabo del Corano, registrando tendenzialmente una forte semplificazione tanto nel patrimonio fonetico e lessicale quanto nella morfologia e nella sintassi. Già dalla fine dell’VIII secolo si parla questo arabo volgare e non più l’arabo classico. Benché non con la stessa portata del latino della chiesa occidentale, l’arabo del Corano è tuttavia divenuto in larga misura un’antiquata lingua sacra, intesa dagli stessi arabi solo con difficoltà – per non parlare dei musulmani non arabi. Ancora oggi, i cinque gruppi dialettali neoarabi – della penisola araba, della Mesopotamia, della Siria e Palestina, dell’Egitto e Sudan, infine del Nordafrica – quanto a lessico, sintassi, morfologia e fonetica si differenziano considerevolmente non solo tra di loro, ma anche rispetto all’arabo classico, che ancor oggi tuttavia è la forma linguistica utilizzata dalla letteratura musulmana e dai mass media.
Cultura e modo di vivere persiani
Rispetto agli arabi e alla loro originaria cultura del deserto, il persiano rappresentava un’antichissima civiltà, che offriva alla corte e alle élite acculturate, per alcuni aspetti, una seria alternativa letteraria e culturale all’arabismo e all’islam: «Adab» = il «protocollo», il «saper vivere», l’«educazione squisita» per tutti coloro che tengono alle buone maniere e allo stile raffinato; in questo Ibn Qutaiba (828-889) fu una guida affidabile. Già sotto gli Omayyadi l’influenza persiana si era rafforzata ed erano state redatte le prime traduzioni di documenti politici persiani. Ora più che mai, nella Baghdad degli Abbasidi, si predilige spesso uno stile di vita persiano e si importano conoscenze scientifico-tecniche persiane – soprattutto in medicina, matematica, astronomia, agronomia e tecnica militare.
C’è persino un movimento letterario (šu‘ūbīya), influente anche a corte, che, senza porre in discussione l’islam, sottolinea la parità di rango di tutti i popoli islamici (šu’ūb)23 e soprattutto della cultura persiana nei confronti di quella araba. Il movimento verrà attaccato con forza da al-Ğāḥiẓ (776-868), il vero inventore della prosa araba e il più versatile autore di questa letteratura, a cui si devono, tra gli altri, libri sulla retorica e sugli animali, e un «Libro degli avari» in cui satireggia brillantemente l’avarizia dei non arabi.
Non stupisce che, in queste condizioni, si accresca la rivalità tra cortigiani e intellettuali arabi e persiani:
– il pensiero arabo è per natura orientato in maniera più egualitaria e resta fedele alla concezione secondo cui il sovrano non ha alcuna autorità legislativa in questioni religiose, ma è piuttosto responsabile della comunità dei musulmani;
– il pensiero persiano invece è per natura più gerarchico: il sovrano è un eletto di Dio e possiede pertanto un’autorità illimitata, assoluta; sulla base del suo ceto, ciascuno ha il suo posto immodificabile nella società; non sono ancora per nulla estinte le simpatie per lo zoroastrismo, il manicheismo o la gnosi.
Gli studiosi arabi sanno però come difendersi: cercano di integrare nel loro pensiero idee persiane, naturalmente dopo un’attenta analisi critica. Così, per esempio, un uomo come Ibn Qutaiba, nelle sue considerazioni su governo, guerra, erudizione, ascesi, amicizia, amore e donne, sa collegare alle citazioni dal Corano, dagli ḥadīṯ e dalla letteratura araba numerose idee persiane, racconti indiani e filosofia aristotelica, omettendo semplicemente gli elementi anti-islamici delle altre tradizioni. È così che si giunge a una sintesi culturale arabo-persiana, che lascia intatto l’isiam, anzi, lo rafforza addirittura, appropriandosi di un’eredità che comprende non solo elementi persiani, ma anche ellenistici.
Filosofia e scienza ellenistica
Si è già accennato a quanto impararono i conquistatori arabi dai conquistati, che spesso erano di cultura ellenistica, soprattutto per quanto riguarda governo, amministrazione e sistema fiscale. Ora cominciano a essere assimilati anche concetti filosofici, non tanto desunti, a dire il vero, dalla grecità classica, quanto dall’allora dominante neoplatonismo. Diventano popolari anche alcune scienze occulte, come ad esempio l’alchimia o la matematica neopitagorica (mistica dei numeri), che sperano di penetrare un mondo nascosto, più alto, spirituale, tramite rivelazioni esoteriche, invece che attraverso il Corano e l’obbedienza islamica alla legge.
Il pensiero ellenistico si presenta all’élite araba dapprima mediante discussioni teologiche. Già alla liberale corte di Damasco si erano avute dispute tra arabi e cristiani; il vocabolario greco-cristiano raffinatissimo di questi ultimi, oltre alle specifiche tipologie argomentative e forme letterarie che usano, suscitano interesse anche tra gli arabi. Alla tavola rotonda (nudamā’: «compagni di bevute», «amici») dei califfi di Baghdad si ritrovano ora intellettuali delle più diverse provenienze e si tengono dispute religiose.
I musulmani si aprono ora sempre di più al ricco patrimonio culturale ellenistico: per questa trasmissione del sapere sono importanti le accademie greche di Atene e Alessandria. La pressione della chiesa ortodossa le aveva dapprima confinate nei settori cristiani, ma non bizantini, del Vicino Oriente: la scuola di Atene si era spostata presso i nestoriani di Edessa e di Nasibin, più tardi in Persia, infine a Baghdad; la scuola di Alessandria nella siriaca Antiochia, più tardi a Merw in Khorasan, poi a Harran in Mesopotamia e da ultimo, alla fine del IX secolo, anch’essa a Baghdad.
In questa metropoli culturale si sviluppa così un’intensa ricerca scientifica, e prende vita una vivace attività di traduzione nella locale «Casa della scienza» (bayt al-Iḥikma): innumerevoli opere greche e siriache, dai trattati di logica di Aristotele alle opere mediche di Galeno e di Ippocrate, vengono tradotte in arabo in maniera filologicamente impeccabile, per lo più da cristiani o convertiti siriaci. La sete di conoscenza è ampiamente diffusa: a Baghdad – dove tra i molti mercati, che secondo l’uso ellenistico avevano tutti un sorvegliante, c’è anche un mercato dei librai – si contano in determinati periodi più di cento librerie. Ben presto i contributi originali dei musulmani alla matematica e all’astronomia, alla medicina e alla chimica, alla mineralogia, alla zoologia e alla meteorologia superano le conoscenze che derivano dal retaggio greco, persiano e indiano. È in gran parte merito dell’islam se l’Europa ha potuto riscoprire e tornare a comprendere la propria eredità antica.
In questo modo l’islam come religione e teologia instaura un intenso contatto con la filosofia ellenistica, con la logica, la filosofia della natura e la metafisica e, quel che più conta, con un pensiero fortemente razionale, inedito per gli arabi, e con modalità del tutto nuove di porre le questioni problematiche. Le tradizionali concezioni islamiche sulla natura di Dio e sui suoi predicati, su rivelazione e profezia e sull’etica sembrano messe in discussione: la filosofia non si sostituisce qui alla religione? A chi spetta dunque il primato nella teoria e nella prassi? Non forse al Corano, rivelazione di Dio? O piuttosto alla ragione umana, che tenta di ricercare da sola la verità divina?
Nell’incontro con la filosofia greca sembra esplodere un dilemma non dissimile da quello in cui incapperà, due secoli più tardi – non da ultimo attraverso le traduzioni dall’arabo – anche la Scolastica cristiana (si pensi alla disputa tra Abelardo e Bernardo di Chiaravalle).
– Si può scegliere di credere alla rivelazione, al Corano e al Profeta e al primato della fede sulla ragione nella ricerca della verità religiosa e dunque: non c’è bisogno di alcuna giustificazione filosofica degli insegnamenti del Corano; non si devono prendere sul serio certe dottrine filosofiche contrarie di Platone o di Aristotele; la ragione ha solo la funzione di contribuire, a posteriori, alla chiarificazione e all’approfondimento filosofici della dottrina rivelata.
– Si può scegliere altrimenti di accettare il primato della ragione e della riflessione filosofica, e dunque: si concepisce Dio, l’Essere supremo, in maniera filosofica-razionale come si fa con il mondo e l’uomo; l’islam appare certo la vera religione che tuttavia, poiché rappresenta per la massa dei fedeli un avvicinamento alla verità divina ancora troppo antropomorfo, deve essere superata dal metodo filosofico.
Questa disputa non poteva non portare a una crisi nel pensiero islamico. Più importante per l’epoca abbaside è però, innanzitutto, non tanto il confronto con la filosofia, quanto il definitivo consolidamento del diritto islamico, il cui peso sulla filosofia e sulla teologia sarà determinante anche in futuro.
Il nuovo ruolo degli esperti di religione
La popolazione musulmana ha bisogno di orientamento spirituale e guida morale. La comunità dei fedeli viene ufficialmente guidata dai califfi e dai governatori, che detengono il potere politico; ma l’abisso che separa il regime assolutistico dalla società si fa sempre più profondo. Nel concreto, i credenti si rivolgono in maniera crescente agli esperti di religione, che si fanno sempre più numerosi e che incarnano l’autorità etico-religiosa.
Ciò che si era preparato già negli ultimi decenni dell’epoca omayyade (P II) si afferma ora pienamente sotto gli Abbasidi (P III): il riconoscimento ufficiale dell’auto-organizzazione degli esperti di religione, che si specializzano sempre più al tempo stesso come esegeti, teologi e soprattutto esperti di diritto. Si tratta di uno sviluppo epocale:
- Gli esperti di religione, che sotto gli Omayyadi operavano ancora del tutto «privatamente», diventano ora di professione i maître à penser della nuova concezione islamica di stato e società che gli Abbasidi si sono prefissi di realizzare, con riconoscimento ufficiale e sostegno statale.
- Gli Abbasidi riconoscono come unica norma legittima nell’islam la legge religiosa, così come viene insegnata dagli specialisti religiosi.
- La spaccatura tra la giustizia pragmatica dei qādī e la teoria giuridica islamica degli esperti di religione viene ampiamente superata, poiché sempre più ulama vengono chiamati a ricoprire l’ufficio di giudice (qāḍīz).
Senza un diritto consolidato e una giurisdizione avanzata, il sistema politico-religioso degli Abbasidi non avrebbe potuto funzionare. Molti dei problemi caratterizzanti la fine del periodo omayyade erano infatti dovuti proprio all’instabilità e all’arbitrio della giustizia dei governatori e dei loro aiutanti e alle decisioni giuridiche spesso soggettive dei qādī. D’altra parte diventa evidente che il diritto islamico non è per sua natura un sistema rigido, immutabile, che comprenda norme dalla validità assoluta, eterna. Il diritto islamico ha avuto una storia, anche se essa è stata fino ad oggi poco indagata dagli studiosi islamici. È stato necessario un lungo e complicato processo, durato in pratica tre secoli (dal VII al IX), perché, attraverso l’interazione di diversi gruppi e personalità, si sviluppasse poco alla volta ciò che si intende come diritto nella umma islamica.
Sulla storia dello sviluppo del diritto islamico prima del 750 (P II), possediamo solo poche testimonianze scritte, per lo più esplicitamente e tendenziosamente anti-omayyadi. Solo con gli Abbasidi (P III) ha inizio il periodo del diritto islamico pienamente documentato dalle fonti scritte. Ora il suo sviluppo si presenta storicamente sicuro, ricostruibile passo dopo passo, personalità dopo personalità: in Iraq, ad esempio, da Hammàd (morto nel 738), attraverso Ibn Abi Laila (morto nel 765) e Abū Hanīfa (morto nel 767) fino al Gran Qadi Abū Yūsuf (morto nel 798) e ad aš-Šaibānī (morto nell’805), dagli orientamenti più teorici. Solo ora si sviluppano scuole di diritto. E solo sotto il regime degli Abbasidi, verso la metà del IX secolo – comunque già due secoli prima della stesura e della raccolta di leggi da parte dei papi assolutistici della «riforma» gregoriana – questo sviluppo si può dire bene o male concluso. Quali le tappe di questo processo tanto denso di conseguenze?24
Il diritto islamico classico: la sharia
I potenti califfi di Baghdad, benché «successori del Profeta» e «rappresentanti di Dio in terra», dichiarano di volersi attenere, diversamente dagli Omayyadi, al contesto giuridico tramandato, così come è dato dal Corano e dalla sunna. Non pretendono di essere signori del diritto, bensì suoi servitori. Il diritto vigente vale dunque anche per loro, benché essi lo trasgrediscano sempre più spesso; hanno poche possibilità di mettere mano direttamente al processo di sviluppo giuridico. Essi non possono, in senso stretto, legiferare, anche se sono in grado di influenzare l’interpretazione e l’applicazione del diritto.
Proprio per questo, tuttavia, il califfato è obbligato a collaborare con gli specialisti della «scienza» (‘ilm): per comprendere, interpretare e adattare questo «diritto» (fiqh) divino bisogna affidarsi alla competenza di una corporazione divenuta nel frattempo molto potente e indipendente, costituita da un lato dagli esperti di religione (‘ulamā, sing. alim), che si occupano della dottrina della legge e dei suoi princìpi; dall’altro dagli esperti di diritto (fuqahā’, sing. faqīh), che si occupano delle singole prescrizioni giuridiche e della loro casistica. Nel corso della loro discussione si viene a stabilire, sotto gli Abbasidi, quel diritto vasto e articolato (in maniera pressoché identica per il diritto religioso, privato e penale) che è ancora in vigore, immutato, per i musulmani tradizionalisti: la «legge» sacra, la sharia (šarī‘a), il complesso delle prescrizioni giuridiche canoniche (compresi i doveri di culto e sociali).
La cosa importante, però, è che la sharia in sé non è codificata e tale è rimasta – diversamente dal diritto religioso romano – fino ad oggi. È vero che già nel 757 Ibn al-Muqaffa‘, segretario di stato e di tradizione persiano-sasanide, in considerazione delle grandi differenze e incertezze nel diritto, aveva proposto in un memoriale al califfo al-Manṣūr la raccolta e l’ordinamento di procedure, giudizi e norme come un desideratum estremamente urgente per l’amministrazione e la pratica giudiziaria; ma per una codificazione mancano al «successore del Profeta» quei pieni poteri e quella competenza, a cui più tardi i «successori di san Pietro», per parte loro, avrebbero invece fatto ricorso con naturalezza.
Non c’è da meravigliarsi, dunque, che, data la naturale discrepanza tra ciò che gli esperti di religione mettono in risalto come ordine giuridico islamico ideale e ciò che esercitano i detentori del potere come prassi giuridica reale, sorgano continui contrasti sulle specifiche decisioni del califfato abbaside: sono a norma dell’islam o non islamiche? «Rinnovamento» (bid’a, plur. Bida’) diviene molto presto l’irrevocabile parola d’ordine con cui ricacciare qualunque progresso o riforma nel diritto o nella teologia. Se non ci si può accordare su di un determinato problema giuridico, questo diviene generalmente un problema puramente di potere, cioè di chi nei fatti può imporsi.
Che cosa è successo? Gli Omayyadi si erano opposti, con sempre maggior decisione, agli esperti del Corano e della sunna, che non di rado, erano davvero troppo attaccati alla teoria; gli Abbasidi, viceversa, che fin da principio avevano fatto degli esperti di diritto i loro alleati, convocano a Baghdad autorevoli esperti della sunna e chiedono loro perizie in tutti i casi difficili della prassi giuridica. Al tempo stesso lo stato finanzia l’eminente scuola di giuristi di Kufa. Anzi, si giunge alla fine ad un impoverimento intellettuale dei centri Kufa e Bassora, perché tanti studiosi emigrano a Baghdad (una vera «fuga di cervelli»), dove sperano di essere perlomeno ricevuti in udienza dal califfo o addirittura di venire assunti (un fenomeno simile riguarderà più tardi gli artisti nella Roma rinascimentale).
È evidente che, se gli Abbasidi si legano in questo modo agli esperti di religione, è perché ne traggono una utilità politica per se stessi. Giacché, tramite questo «abbraccio» degli esperti di religione, i califfi non solo fanno mostra di volere decidere di tutte le questioni politiche in forma giuridicamente corretta; essi possono in questo modo fare di alcuni di questi studiosi – con altri non sarà possibile – altrettanti docili servitori. I califfi addomesticano dunque una parte rilevante dei dottori della legge e fanno loro giustificare, in qualità di teologi e giuristi di corte, anche i provvedimenti arbitrari che presto si moltiplicano. Inglobare nel governo l’opposizione religiosa significa al tempo stesso disarmarla.
Il popolo intanto deve ricevere questo messaggio: ora è tutto in ordine nello stato, i sovrani si attengono, proprio come tutti gli altri, al diritto santo. Ora finalmente possono regnare di nuovo «pace e ordine» nello stato, perché la politica e la religione vanno nuovamente a braccetto. Come non dare il benvenuto a questo risultato, dopo tutte le lotte e le battaglie, dopo tanto sangue e lacrime? Nei fatti, però, la teocrazia abbaside (non del tutto dissimile da quella, successiva, papale) si rivela ben presto essere il camuffamento di una tirannia assoluta, che si arroga tutte le possibili facoltà legislative sotto forma di prescrizioni amministrative, sostenuta e adulata da innumerevoli studiosi e letterati che si crogiolano ora a schiere nello splendore della capitale abbaside.
Una circostanza vale innanzitutto a favorire la riconciliazione tra la dottrina giuridica degli studiosi e la pratica legislativa delle corti di giustizia: ora si ricorre normalmente ai religiosi non solo in quanto esperti di diritto, ma anche per l’ufficio di giudice (qādī). Il compito del qadi è quello di amministrare la giustizia, secondo la legge sacra di Dio, in tutte le questioni di diritto civile e penale per la popolazione musulmana. Diversamente che in precedenza, cioè, egli non deve semplicemente riflettere, per poi esprimere la sua personale opinione (ra’y); egli deve piuttosto sentirsi obbligato nei confronti della sharia. Al contempo però, nelle comunità piccole, rimane spesso in vigore il diritto consuetudinario (di origine protoaraba-preislamica, protoislamica, bizantina o sasanide), mentre per le questioni statali vere e proprie sono attivi giudici specifici.
È il califfo Hārūn ar-Rašīd che sottomette tutti i qadi all’autorità di un Gran Qadi: Abū Yùsuf, che riunisce in sé in maniera ideale le funzioni di studioso e di giudice e che scrive addirittura, su richiesta del califfo, il «libro delle imposte», una trattazione di diritto tributario e penale. Questo «Qadi dei Qadi» (qāḍī l-quḍāt), che non rappresenta un’istanza a cui appellarsi, ma un’autorità di vigilanza (soprattutto nelle importanti prove di idoneità, ma anche in seguito), può persino designare, a partire dal X secolo, i qadi delle province. Ma la differenza tra dottrina e prassi giuridica rimane, anzi, col tempo è destinata a crescere nuovamente: un problema permanente, per l’islam.
3. LA NASCITA DELLA «TRADIZIONE DEL PROFETA»: LA SUNNA
Un ulteriore sviluppo, non meno epocale del riconoscimento degli esperti di diritto, riguarda il riconoscimento di determinate parole e gesta del Profeta come «Sunna del Profeta». Secondo gli esponenti di questo movimento, a essere determinante per tutti i credenti non è ciò che dicono i teologi e gli esperti di diritto, bensì ciò che il Profeta ha detto e fatto. Il Profeta, dopotutto, è al di sopra di tutte le partigianerie e di tutti i conflitti umani. Si comincia quindi a raccogliere, non per un interesse primariamente storico o teologico, ma per uno del tutto pratico, tutto ciò che possa servire in qualunque forma come esempio autorevole per l’organizzazione della propria vita secondo la pietra di paragone del Profeta. Ma molto presto sorgono i primi dubbi: risale davvero tutto, così come viene tramandato, al Profeta? Su questo esiste un’accesa discussione nell’islam classico e più che mai nella più recente scienza storica.
Quello che il Profeta ha detto e fatto: gli ḥadīṯ
Già all’inizio dell’VIII secolo comincia la raccolta degli ḥadīṯ (ḥadīṯ: «resoconto», «tradizione», plur. aḥādiṯ),25 tradizioni per lo più brevi di un detto o di un atto del profeta Muḥammad. Con ḥadīṯ si intende il singolo testo tramandato, ma anche la totalità della tradizione che costituisce la sunna del Profeta.
Qual è il loro contenuto? Si tratta di asserzioni autorevoli su ogni genere di questione rituale, morale e religiosa. Non c’è pressoché nulla di importante per la vita di un musulmano per il quale non ci sia un detto del Profeta: a cominciare dalle questioni di fede (carattere del Profeta e dei suoi discendenti, significato del Corano e della sua esegesi, doveri religiosi), attraverso problemi di condotta morale di vita (atteggiamento con la famiglia, trattamento degli schiavi e relazioni commerciali) fino a quelli sulla giusta conduzione degli affari di governo (qualità del sovrano, diritto penale). Vengono trattate anche questioni quotidiane come l’abbigliamento e l’alimentazione. Per tutto ciò per cui il Corano non ha fissato norme, il musulmano trova ora negli ḥadīṯ esempi concreti e regole. Può usarli per orientarsi, e in essi percepisce inequivocabilmente la voce del Profeta.
In quale forma vengono presentate queste storie di detti o fatti del Profeta? Negli ḥadīṯ si dà «il discorso letterale assicurato da una vera catena di trasmettitori»: «Le scene standardizzate servono unicamente a collocare in maniera plausibile il narratore, soprattutto nel caso del compagno del Profeta o del Profeta stesso».26 Verso la metà dell’VIII secolo questo schema aveva riscosso tanto successo e prestigio che le versioni prive di questi caratteri vengono considerate insoddisfacenti. Ora, nell’epoca abbaside, esse vengono addirittura rielaborate secondo lo schema suddetto. Si afferma l’esistenza di una trasmissione orale persino là dove restano trascrizioni di dimostrabile autenticità. Perché questo? Il lettore deve avere l’impressione di essere entrato in contatto diretto con le parole e le opere del Profeta.
Il principio della tradizione orale rende tuttavia necessario indicare i passaggi di tale tradizione e indicare per nome i concreti informatori: già in quest’epoca sono passati molti decenni dal tempo del Profeta. Ci si aiuta differenziando tra i compagni di Muḥammad, come fonte primaria, e «i successivi» (tābi’ūn), che non avevano avuto alcun legame diretto con il Profeta. In ciò si presuppone fin dall’inizio che ci siano buone e cattive tradizioni, ḥadīṯ autentici e falsi. Ma in base a quali criteri li si sceglie?
La scienza degli ḥadīṯ
A causa della «divergenza delle opinioni» si sviluppa ora una vera e propria scienza degli ḥadīṯ, che a fianco della scienza coranica e della scienza del diritto raggiunge un alto grado di raffinatezza e un altrettanto elevato prestigio sociale. Compito dello studioso di ḥadīṯ è innanzitutto, a fronte dell’enorme quantità di detti e tradizioni in circolazione, indagare il testo originale (il matn = «dorso») per controllarne la veridicità ed effettuare una classificazione dettagliata; in secondo luogo, suo compito è verificare la catena di informatori (isnād = «appoggio»). Così, ad esempio, gli sciiti eliminano fin dall’inizio tutti gli ḥadīṯ che non possono essere ricondotti ad ’Alī e ai suoi seguaci. Le conseguenze sono evidenti: lo studio della catena di tradizione porta a un’ampia letteratura biografica: alla «scienza degli uomini» (’ilm ar-riğāl), su cui il primo grande rappresentante, Ibn Sa’d (morto nell’845), ha prodotto la prima opera importante.
Al tempo stesso sorgono, a partire dal IX secolo, anche le grandi raccolte di ḥadīṯ, ordinate o secondo i trasmettitori o – con più successo – secondo i temi trattati. La prima grande opera, e la più apprezzata nei secoli, proviene da al-Buḫārī (morto nell’870).27 Porta il titolo programmatico di «aṣ-Ṣaḥīḥ», = «ciò che è sano». al-Buḫārī (il cui nome deriva dalla città natale Buchara), è appena undicenne quando comincia a imparare a memoria gli ḥadīṯ. La missione della sua vita diventa viaggiare dalla patria, nell’Asia centrale, fino alla Mecca e a Medina, all’Egitto e per tutta l’Asia, per accogliere infine nella sua raccolta, dopo severo vaglio del testo e della catena di tradizione, solo gli ḥadīṯ «sani» e non quelli «deboli» o falsi. Alla fine riesce comunque a pubblicarne 97 libri, con rimandi al Corano e proprie annotazioni. I libri sono suddivisi, in maniera estremamente pratica, secondo i temi dei manuali giuridici: fede, purificazione, preghiera, elemosina, digiuno, pellegrinaggio, commercio, eredità, testamenti, voti e giuramenti, crimini, assassini e procedimenti giudiziari. La raccolta conta 7397 ḥadīṯ, e anche tralasciando quelli che si ripetono sotto diverse rubriche ne restano comunque 2762.
Seguono, ancora nel IX secolo, altre cinque raccolte canoniche di ḥadīṯ, riconosciute come autorevoli dai sunniti: quelle di Muslim (morto nell’875), di Abū Dāwūd (morto nell’889), di Ibn Māğa (morto nell’886), di at-Tirmiḏī (morto nell’892) e di an-Nasa’i (morto nel 915). A esse si aggiungono le raccolte, altrettanto apprezzate, dei fondatori delle diverse scuole di diritto. Come spiegarsi questo gigantesco proliferare di tradizioni? Con un dato di fatto: gli ḥadīṯ diventano, dopo il Corano, la seconda fonte di giurisprudenza islamica (fiqh), a cui presentano però, in un primo tempo, una sfida non indifferente. All’inizio gli studiosi di ḥadīṯ si oppongono esplicitamente agli studiosi di diritto. Alla fine saranno loro i vincitori. Come hanno potuto imporsi?
La vittoria dei custodi della tradizione
Già in passato si erano formati movimenti di opposizione contro le antiche scuole di diritto, che rappresentavano nel «consenso (igma) degli studiosi» le concezioni della maggioranza. Questi movimenti, per risolvere le loro assai varie questioni, dovevano anch’essi rifarsi a grandi nomi. A Kufa, città intellettualmente più aperta e giuridicamente di primo piano, aveva a lungo tenuto il suo quartiere come califfo il cugino del Profeta, ’Alī: egli era il nome a portata di mano a cui ci si poteva richiamare nei casi più svariati.
Viceversa a Medina, che dal punto di vista della giurisprudenza era rimasta piuttosto indietro, nasce, a partire all’incirca dal 770, un movimento di opposizione del tutto diverso, e molto più rigoroso, destinato a portare a compimento il cambiamento di paradigma nel diritto: il movimento dei «tradizionisti» o custodi della tradizione, che ben presto doveva costituire i suoi gruppi di adepti in tutti i grandi centri dell’impero. Questa «gente della tradizione» (ahl al-ḥadīṯ) rifiuta i metodi logici della «gente dell’opinione» (ahl ar-ra’y) che si affatica per il chiarimento razionale e la sistematizzazione, per la libera formazione di opinioni (ra’y), per la deduzione logica (qiyās) o l’argomentazione (iğtihād o iğtihād ar-ra’y) in questioni teologiche e giuridiche. Tale scelta razionale tra opinioni differenti, già sin dall’inizio propria della scienza giuridica islamica, viene esercitata sia dai qadi che dagli specialisti religiosi (ad esempio il ragionamento per analogia che porta a dedurre dal valore minimo di una refurtiva l’entità minima di una dote). Fintanto che una determinata pratica, così si dice in questi circoli, non si contrappone a una disposizione esplicita del Corano, deve essere tollerata.
Diversamente si comportano ora i tradizionisti, che, con molto più rigore, pretendono un’esatta osservanza delle prescrizioni coraniche. La loro intenzione di base non è tanto giuridica quanto etico-religiosa: se la «sunna della scuola», la vivace tradizione delle scuole di diritto che usavano l’argomentazione razionale, si era richiamata per la sua autorità ai compagni del Profeta, i tradizionisti si richiamano ora semplicemente e direttamente alla superiore «Sunna del Profeta»: e questo non solo, come le antiche scuole di diritto, in modo generico e vago, per certificare la propria dottrina, ma molto concretamente attraverso la citazione di precise parole e imprese del Profeta, appunto gli ḥadīṯ. Il conflitto vero e proprio riguarda dunque la legittimazione del diritto. Dato che i tradizionisti vogliono a tutti i costi orientarsi secondo l’esempio del Profeta, si giunge ad attribuire a quest’ultimo quante più parole e storie possibile. Si tratta di un inganno deliberato? No. È un’operazione bona fide, portata avanti nella convinzione che queste parole e storie esprimano l’autentica norma islamica e che il Profeta stesso avrebbe agito così, se si fosse dovuto confrontare con quel medesimo problema.
Ma qual è la tendenza generale degli ḥadīṯ? Essi tendono – con le dovute eccezioni – a una maggiore severità e ristrettezza nelle questioni controverse. L’interesse principale dei tradizionisti, tuttavia, non va alle questioni giuridiche tecniche, ma alla rigorosa subordinazione dell’intero diritto all’autorità religiosa e morale del Profeta: così, ad esempio, si diffonde come «tradizione del Profeta» il divieto di rialzare i prezzi, per combattere in questo modo le oscillazioni del mercato.
E le vecchie scuole di diritto? Che cos’altro resta loro infine, dopo l’opposizione e la polemica, se non piegarsi alle tradizioni del Profeta che diventano sempre più popolari? In realtà esse faranno di tutto per minimizzare, da un lato, per via interpretativa l’importanza di queste tradizioni, e dall’altro per riaffermare la propria posizione e la propria dottrina tramite propri ḥadīṯ. Anche molti antichi principi giuridici vengono ora posti in bocca al Profeta. Risultato: anche se le vecchie scuole cercano di accettare le tradizioni del Profeta solo nella misura in cui concordino con le proprie tradizioni, il fatto è che i tradizionisti in linea di massima si sono imposti. Ne conseguono però incoerenze tra il diritto islamico tradizionale e la tradizione degli ḥadīṯ, cosicché il tutto necessita di una nuova sintesi. Ma dovranno passare decenni prima che una tale sintesi possa essere compiuta. Nel frattempo, la tradizione acquista sempre più peso nell’islam. Ma questo serve solo a rendere il problema ancora più urgente.
Controdomanda: gli ḥadīṯ sono autentici?
Dietro a questa semplice domanda si celano spinosissimi problemi storici e di metodo. È vero che nel mondo arabo, come in India e in Pakistan, vengono oggigiorno curati filologicamente e pubblicati molti manoscritti di ḥadīṯ; ma la maggior parte degli studiosi musulmani si accontenta dello studio delle trattazioni e dei commentari del passato. I moderni orientalisti, al contrario, guidati da Ignaz Goldziher, 28 hanno sottoposto gli ḥadīṯ ad una critica storica radicale. In seguito, soprattutto Joseph Schacht – la cui interpretazione della storia del diritto islamico, dopo essere stata criticata a partire dagli anni Trenta, è stata quasi canonizzata nelle scienze storiche – ha sostenuto la tesi secondo cui sarebbero stati, almeno in buona parte, gli stessi tradizionisti a mettere in circolazione, oppure a modificare parzialmente, gli ḥadīṯ, prima completamente sconosciuti, per portare avanti le battaglie della propria fazione. Col tempo gli stessi tradizionisti avrebbero inoltre attribuito a ognuno di essi una precisa catena di tradizione (isnād): «Vennero messi in circolazione, senza dubbio per i motivi più nobili, dagli stessi tradizionisti a partire dalla prima metà del II secolo (dell’Egira)».29 Si deve allora supporre nella tradizione musulmana una lacuna di quasi cent’anni?
Questo è poco probabile, affermano studiosi più conservatori come N. Abbott,30 E Sezgin31 e M.M. Azami.32 Secondo loro, ritenere a priori inventata qualsiasi tradizione la cui autenticità non possa essere dimostrata secondo i parametri storici odierni implica una pretesa critica eccessiva. Su di una posizione intermedia si collocano studiosi come F. Rahman,33 H. Motzki34 o l’islamista britannico Noel J. Coulson: pur concordando sostanzialmente con Schacht per quanto riguarda la massa di materiale fittizio, Coulson ipotizza però un «nucleo autentico» che potrebbe aver conservato «la sostanza delle azioni e delle parole di Muḥammad, soprattutto in cose certe e incontrastate». 35 Per questo, secondo Coulson, dovrebbe valere come «principio sensato di ricerca storica» il seguente: «un regolamento asserito» per bocca del Profeta dovrebbe essere «accettato come tale in via sperimentale», fintanto che non possa essere addotto un motivo convincente per considerarlo «fittizio (fictitious)».36
Al momento sembra che i due fronti, quello dei conservatori e quello degli scettici, si trovino in una situazione di stallo e poggino entrambi su ipotesi aprioristiche, come ha messo in luce Herbert Berg, in un’acuta analisi dello status quaestionis: «Gli scettici continueranno a rifiutare la prova delle catene di tradizione (isnād) e supporranno che questa prova oscuri la vera origine del testo (matn). Quest’origine rimonterebbe normalmente a un’epoca molto più tarda di quella stabilita pretestuosamente dalla catena di tradizione; la funzione di quest’ultima, difatti, sarebbe appunto quella di proiettare il testo nel passato. Gli studiosi ottimisti, invece, continuerebbero ad accettare la prova della catena, dando per scontato che essa tramandi informazioni quasi sempre autentiche e utili. Qualunque conclusione che venga tratta in questo caso sarà dunque il prodotto delle ipotesi su cui poggia».37
Di questo stato della ricerca la grande maggioranza dei musulmani sa ben poco. Si leggono gli ḥadīṯ senza interrogarsi sulla loro autenticità, così come fanno molti cristiani con la Bibbia, che intendono in maniera letterale, senza venire sfiorati da considerazioni esegetiche. E come molti predicatori cristiani, in malafede, tacciono i risultati della ricerca storico-critica, così anche molti capi spirituali e politici musulmani – forse più per ignoranza – tacciono i risultati della ricerca sugli ḥadīṯ. I teologi cristiani e musulmani dovrebbero però chiedersi:
- Non ha conosciuto anche la ricerca storica dell’Antico e del Nuovo Testamento una fase, in cui o si difendeva più o meno tutto come storico, in maniera fondamentalistica, oppure si poneva tutto in discussione, con atteggiamento ipercritico (Gesù non sarebbe esistito, il Vangelo più antico sarebbe l’invenzione di un «Ur-Marco»)? Simili posizioni estremistiche vengono solitamente relativizzate, di regola, nel corso della storia degli studi.
- Perché dunque si dovrebbe escludere storicamente che in una «cultura orale» parole e fatti autentici del Profeta venissero trasmessi solo oralmente per uno, due secoli? Perché non dovrebbe esserci stata continuità tra il primo e il terzo paradigma? Essa dovrebbe essere ipotizzabile per lo meno là, dove una tradizione non è in contraddizione con i dati della situazione contemporanea del Profeta a Medina (niente anacronismi!).
- Non è consigliabile pertanto metodicamente una via di mezzo: decidere caso per caso (anche proprio con l’aiuto di varianti), senza una decisione preliminare «dogmatica» pro o contro la storia delle forme (Formgeschichte), quali delle centinaia di ḥadīṯ e loro varianti potrebbero essere autentici e quali falsi? Ciò richiederebbe tuttavia il lavoro di più di una generazione di studiosi.
Controdomanda: una seconda fonte di rivelazione?
Difficilmente si può illustrare in modo più chiaro il cambiamento paradigmatico di una religione: è evidente che a fianco della prima e originaria fonte della rivelazione, il Corano, ne è comparsa ora una seconda. Naturalmente, per il credente musulmano gli ḥadīṯ si trovano fin dall’inizio in stretto rapporto oggettivo con il Corano, e si può anche accertare che in alcuni casi gli ḥadīṯ siano stati adattati a posteriori al Corano. D’altra parte, non devono certo correggere o sostituire del tutto il Corano, bensì chiarirlo, completarlo e renderlo concreto. Così uno ḥadīṯ originariamente indipendente può addirittura cambiare funzione ed essere usato come commento a una determinata sura.38 Eppure in questo paradigma (P III) è accaduto qualcosa di decisivo: il Corano e gli ḥadīṯ diventano, in pratica, fonti equipollenti nell’orientamento dei musulmani.
I paralleli con l’evoluzione ebraica e cristiana sono evidenti: Torah e Talmud, Scritture e tradizione, Corano e sunna. In modo del tutto simile a quanto già accaduto nell’ebraismo e nel cristianesimo, compare ora, a fianco dell’originaria Scrittura sacra, il Corano, e con pari diritti, una tradizione «orale» che difficilmente si può ignorare e che anzi spesso viene anteposta ad esso. Accade infatti che, nel porre le due tradizioni sullo stesso livello, ciò che prima era di livello superiore automaticamente si abbassa. E come la Halakah nell’ebraismo e i dogmi e i canoni della Chiesa, spesso, sono stabiliti già prima della loro giustificazione biblica, così anche nella tradizione musulmana determinate dottrine e leggi si sono stabilite fin dall’inizio, e gli studiosi possono limitare la loro esegesi a «motivare» a posteriori come conforme al Corano la dottrina tradizionale. Così capita che in tutte e tre le religioni profetiche ci si porti dietro nella tradizione anche molti elementi ormai desueti, a malapena comprensibili, ma che si pretende siano «giustificati» nella Scrittura originaria. E molto materiale, elaborato a suo tempo per una situazione completamente diversa, viene adattato a posteriori tramite un’interpretazione spesso tortuosa.
Scrittura e tradizione

Qui occorre tuttavia sottolineare una differenza rilevante. Né nell’ebraismo, né nell’islam, al contrario del cristianesimo nella sua forma ellenistico-bizantina (P II cristiano) o romano-cattolica (P III cristiano), esiste qualcosa di simile a un magistero universale, concilio o papa, che possa definire eretiche o scomunicare opinioni diverse; si vedrà in seguito come il califfo che tenterà di arrogarsi un simile magistero sia destinato al fallimento. La gamma ampiamente diversificata di specifici problemi e soluzioni nella tradizione degli ḥadīṯ permette in ogni caso asserzioni e direttive davvero diverse. Dopotutto lo ḥadīṯ, come il Talmud, non è un manuale catechistico (Enchiridion) di testi prescritti per legge (come ad esempio il «Denzinger» cattolico-romano): è la raccolta, in linea di principio aperta, di asserzioni e comandamenti spesso addirittura contraddittori, tra i quali di conseguenza alcuni vengono realmente seguiti, altri invece trascurati, altri ancora reinterpretati e altri semplicemente non più compresi. È forse possibile che quest’apertura della tradizione e l’assenza di un autorevole magistero universale abbiano reso l’islam, fin dall’inizio, più incline al settarismo rispetto al cristianesimo e alla sua grande chiesa, come talora viene affermato? L’ipotesi non è molto plausibile, se si considera che sia la scissione tra chiesa orientale e occidentale, sia quella tra chiesa cattolica e protestante furono originate fondamentalmente dall’assolutismo e dal centralismo romano nelle questioni di dottrina e di guida.
4. LE QUATTRO GRANDI SCUOLE DI DIRITTO
La scienza giuridica islamica, che aveva preso l’avvio in modo tanto semplice ed elementare con analogismi, si perfeziona ora sempre di più. Sempre più vengono alla luce tradizioni profetiche che devono essere inserite nel sistema giuridico; sempre più riflessioni etico-religiose si mescolano alle argomentazioni sistematiche. Le conseguenze? Nelle diverse province culturali si formano – a seconda delle condizioni, comunque molto diversificate, delle singole regioni del regno – parecchie grandi scuole di diritto (maḏhab, plur. maḏāhib). Col tempo però ne rimangono solo quattro, che hanno ancora oggi un ruolo importante: la scuola malikita, quella hanafita, la shafi’ita e la hanbalita. Vediamo di osservare più da vicino i loro principali esponenti.
Le scuole di diritto malikita e hanafita
Alla «destra» dello spettro sta il grande studioso di Medina Mālik ibn Anas (710-795), che riassume l’uso giuridico del Ḥiğāz e in particolare la prassi vigente nella città del Profeta, Medina. A lui (e al suo allievo Ibn al-Qāsim) si richiama la scuola di diritto malikita (mālīkiya), che in passato dominò dall’Arabia attraverso l’Egitto fino in Spagna, e che ancora ai nostri giorni è influente nel Maghreb, sulla costa arabo-orientale, nell’Alto Egitto, in Mauritania e in Nigeria. Essa si caratterizza per la sua stretta aderenza alla sunna e per un aperto conservatorismo.
Lo stesso Malik ha scritto il primo manuale di diritto islamico, con il titolo «La via appianata» («al-muwatta’»), che, benché conservatosi solo nelle trascrizioni degli allievi, sarebbe stato oggetto di numerosi commenti. È suddiviso in «libri», che corrispondono alle diverse sezioni del diritto vigente (matrimonio, contratti, pene...), in ciascuno dei quali viene trattata una grande messe di temi e regole giuridiche spesso tra loro molto diversi, senza che vengano assunti all’inizio principi o definizioni concettuali generali. Malik comincia la discussione di ogni soggetto con la citazione della tradizione pertinente alla materia (si trovano qui numerosi ḥadīṯ su questioni rituali e giuridiche); si mantiene così fedele all’ḥadīṯ e alla prassi giuridica dominante a Medina. Ma non di raro capita che egli scarti il primo a favore della seconda, il che mostra che il suo conservatorismo ha certamente dei limiti. Non si deve infatti tener conto solo della tradizione, ma anche considerare l’utilità del diritto ( ) per la umma. Il criterio supremo di Malik resta così in pratica il consenso locale di Medina, cioè il diritto consuetudinario sanzionato dal consenso (iǧmā‘), tanto che il suo manuale viene anche accettato senza riserve dall’establishment locale. Nel 762 Malik giustifica, definendola legale, una rivolta nelle città sante, che però sarà rapidamente soffocata dal califfo.
) per la umma. Il criterio supremo di Malik resta così in pratica il consenso locale di Medina, cioè il diritto consuetudinario sanzionato dal consenso (iǧmā‘), tanto che il suo manuale viene anche accettato senza riserve dall’establishment locale. Nel 762 Malik giustifica, definendola legale, una rivolta nelle città sante, che però sarà rapidamente soffocata dal califfo.
Al lato opposto dello spettro sta come figura rappresentativa Abū Ḥanīfa (699-767), che anche Abū Yūsuf, il primo Gran Qadi, considerava suo maestro. Essendosi rifiutato di assumere un incarico da giudice, Abū Ḥanīfa, che era un ricco fabbricante di seta, fu gettato per qualche tempo in prigione. Questo però non compromise la sua reputazione di studioso di diritto: a lui, anche se non ci sono stati tramandati testi giuridici autentici, si richiama la scuola di diritto hanafita (ḥanafīya), che subentra a quella antica di Kufa e alla cui formazione hanno contribuito probabilmente in misura molto maggiore Abū Yūsuf e soprattutto aš-Šaibānī. Sotto gli Abbasidi essa costituisce la scuola di diritto ufficiale, perde però poi la sua importanza con la loro caduta, fino a divenire di nuovo scuola ufficiale dell’impero ottomano. Ancor oggi essa rimane forte in Egitto e Siria, in Iraq, in Turchia e nei Balcani, vanta però anche in India, Pakistan e in Medio Oriente rappresentanti di spicco. A questa corrente, la più liberale e tollerante nell’interpretazione della legge islamica, potrebbe appartenere la maggioranza relativa di musulmani, cioè circa un terzo. Gli hanafiti sono ancor oggi considerati gli esponenti della libertà di opinione e della spigliata dialettica giuridica: per questo gli avversari rinfacciano loro di aver tentato, con «artifici giuridici» (ḥiyal), di aggirare o adattare prescrizioni fastidiose.
La scuola di Abū Ḥanīfa, pur prendendo sul serio Corano e sunna, lascia un considerevole margine alla libertà di scelta (ra’y) del giudice. Se non si riesce a procedere con l’analogismo, si utilizza la propria capacità di «ritenere giusto» (istiḥsān: «discrezione»). Tale scuola è soprattutto interessata alla penetrazione razionale della fede musulmana e non vuole eliminare la discrezionalità del giurista competente. Le opinioni sostenute sono talvolta più vicine a concezioni persiane che a quelle degli studiosi della sunna, ai quali interessa primariamente l’acquisizione devota del modello profetico secondo la tradizione della sunna stessa. Certamente anche per questo motivo si sono attribuite ad Abū Ḥanīfa alcune concezioni eterodosse che dovevano in seguito venir scartate.
La sua tomba si trova a Baghdad.
La sintesi giuridica classica: aš-Šafi‘ī
La grande sintesi giuridica è merito, poche generazioni dopo, di Muḥammad ibn Idrīs aš-Šafi‘ī (767-820), nato in Palestina, uno studioso che ha viaggiato in lungo e in largo, che non vuole affatto fondare una nuova scuola di diritto, bensì piuttosto, contro tutte le tendenze centrifughe, uniformare il diritto islamico, così differenziato a seconda dei luoghi.39 Costui aveva studiato in quasi tutti i grandi centri della giurisprudenza: alla Mecca e a Medina presso Malik, poi a Baghdad presso aš-Šaibānī, dopo essere stato coinvolto in attività insurrezionali nello Yemen ed essere stato per breve tempo rinchiuso in Siria, sotto Hārūn ar-Rašīd. Si trasferisce infine nell’egizia Fusṭāṭ (Il Cairo): qui, negli ultimi cinque anni di vita, scrive la sua opera, brillante per lo stile e per la scienza profusa, «Risāla», che ne farà il padre della giurisprudenza musulmana. La sua reputazione è tanto grande che la sua tomba diviene ben presto meta di pellegrinaggio.
Con aš-Šafi‘ī giunge a compimento il cambiamento di paradigma dalle antiche scuole di diritto (P II) ad una nuova giurisprudenza, che integra gli ḥadīṯ profetici (P III). È il maestro del metodo giuridico che, pur introducendo nel diritto pochi nuovi concetti e idee, li interpreta però tutti quanti in maniera nuova e li connette tra loro in un sistema rigido, per escludere in futuro, per quanto possibile, qualsiasi argomentazione giuridica arbitraria. Il suo contributo alla metodologia giuridica per l’utilizzo di queste tradizioni sarà quindi fondamentale. Aš-Šafì‘ī sintetizza molto del materiale di cui dispone nell’elaborata dottrina dei quattro principi (uṣūl: «fonti, radici») della scienza giuridica (fiqh), e cioè Corano, sunna, analogismo (qiyās) e consenso (iǧma‘), sollevando definitivamente la sunna all’altezza del Corano e svalutando in maniera decisiva, al contrario, ogni argomentazione svolta con l’aiuto dell’analogia o del consenso tra dotti.
Sul piano del metodo, aš-Šafi‘ī è superiore alle antiche scuole di diritto in quanto comprende la necessità di rappacificare e collegare il «partito della ragione» e il «partito della tradizione», un’operazione fino a quel momento contrastata o tutt’al più portata avanti in maniera blanda.
– Come gli esponenti delle antiche scuole di diritto, anche aš-Šafi‘ī è un maestro dell’argomentazione razionale; ne fa un uso più ampio rispetto alla maggior parte dei suoi predecessori. Poiché il processo di islamizzazione del diritto è già in sostanza concluso prima di lui, non gli è più necessario mettere continuamente in gioco punti di vista specificamente religiosi o morali. Egli può ora, meglio di chi lo ha preceduto, distinguere in linea di principio l’aspetto morale e giuridico, e diversamente dai tradizionisti non ha bisogno di spiegare ancora come «non valido» tutto ciò che è «proibito».
– D’altra parte, però, aš-Šafi‘ī, proprio come i tradizionisti e diversamente dalle antiche scuole, prende le tradizioni profetiche come base delle sue riflessioni giuridiche. Egli sostiene con fermezza la convinzione che queste non potrebbero venire abrogate da nessuna autorità superiore. Anche per lui la sunna non è costituita dalla viva tradizione locale della scuola, ma esclusivamente dalle parole e azioni del Profeta in persona, anche se talora testimoniate in una generazione da un’unica persona.
Come stanno allora le cose con le numerose contraddizioni che si trovano tra le diverse tradizioni del Profeta? Secondo aš-Šafi‘ī, in alcuni casi si può preferire una determinata tradizione poiché la catena di tradizione che porta a essa è più saldamente documentata, in altri casi si può interpretarla come eccezione particolare di una regola generale. Ma al centro della sua argomentazione giuridica sta il concetto di revoca (nasḫ: «abrogazione») di una precedente norma giuridica per mezzo di una più recente, il che offre una scappatoia dalle difficoltà in certi casi scomodi. Al tempo stesso, tuttavia, aš-Šafi‘ī sostiene la concezione, densa di conseguenze, che il Corano possa essere abrogato solo dal Corano e la sunna solo dalla sunna. La sua motivazione? – La sunna non potrebbe revocare alcuna disposizione del Corano perché la sua unica funzione sarebbe quella di interpretare il Corano. – Anche il Corano, però, non potrebbe revocare alcuna disposizione della sunna, perché questo porrebbe in questione il ruolo interpretativo della sunna ispirata.
Questo secondo punto sottintende un’enorme rivalutazione della tradizione orale. Quale la conseguenza?
Si impone il principio tradizionistico
Le riflessioni che precedono evidenziano la specificità dell’approccio di aš-Šafi‘ī, che supera di gran lunga le posizioni precedenti e rappresenta il suo contributo decisivo, e al tempo stesso estremamente problematico, alla giurisprudenza islamica: il Corano rimane ovviamente anche per lui la prima fonte di rivelazione, ma poiché nel Corano compare più volte il comandamento «ubbidite a Dio e al suo Profeta», egli ne deduce che le parole e le gesta tramandate per il Profeta siano da considerare come ispirate da Dio.
Non può sfuggire, qui, un cambiamento di paradigma riguardo all’importanza della figura del Profeta:
– per gli antichi esperti di diritto, Muḥammad era, in quanto interprete del Corano, solamente il «primus inter pares», e poteva senz’altro essere contraddetto, con buone ragioni (e soprattutto sulla base del Corano);
– ora però il Profeta è divenuto il legislatore per antonomasia, e al tempo stesso l’interprete ispirato divinamente del Corano. Ai suoi ḥadīṯ non è permesso muovere la benché minima obiezione.
La conseguenza è una significativa uniformazione del diritto: al posto delle molte tradizioni locali delle scuole di diritto deve esserci ora la sola ed unica, universale e ispirata «tradizione del Profeta». Essa è con ciò definitivamente assunta a seconda fonte di rivelazione della volontà divina; non gode solo di pari diritti rispetto al Corano, ma diventa ora persino più importante, in quanto il Corano è da interpretare alla luce di questa sunna. Tutto ciò che nel Corano è rimasto indefinito, può essere ora deciso tramite uno delle migliaia di ḥadīṯ data la loro autorità divina.
In questa maniera aš-Šafi‘ī può presentarsi al tempo stesso come un pensatore sistematico-razionale e come profondamente legato alla tradizione; analogismo e consenso dei dotti vengono completamente subordinati alla sunna:
– al contrario di Abu Ḥanīfa, aš-Šafi‘ī limita il valore dell’opinione autonoma (ra’y) raggiunta attraverso l’analogismo e respinge la «discrezione» (istiḥsān), cosicché non sono quasi più possibili pareri soggettivi e decisioni discrezionali. La sua posizione è chiarissima: l’analogismo ha come conseguenza la mancanza di disciplina, se non muove dalle tre altre, primarie fonti del diritto e non è da esse tutelato; un’argomentazione giuridica non può pertanto mai giungere a un risultato che sia in contraddizione col Corano, con la sunna o con il consenso. Solamente in questa maniera si possono ridurre le differenze tra le diverse dottrine.
– al tempo stesso, aš-Šafi‘ī respinge la considerazione dell’utilità del diritto (maṣlaḥa) nel senso malikita. Egli sostituisce all’autorità del «consenso dei dotti» locale quella del «consenso dei musulmani» universale (dei dotti e della gente comune). Quest’ultimo ha cioè conservato le tradizioni del Profeta nel loro complesso e non può contenere assolutamente alcun errore. Deve essere «infallibile», ma naturalmente viene preso in considerazione, come argomento giuridico, solo per questioni molto elementari (ad esempio l’esecuzione quotidiana delle preghiere). Al tempo stesso, aš-Šafi‘ī estende, a differenza di Malik, il consenso vincolante alla totalità delle leggi islamiche, così da non lasciare alcuna scappatoia per il singolo individuo. La dottrina della comunità e l’autorità delle tradizioni profetiche vengono così a coincidere.
Qual è il risultato del grande lavoro di aš-Šafi‘ī? Un sistema chiuso vasto e coerente, molto più logico e convincente dei sistemi dei suoi predecessori. E tuttavia: dato che ora l’autorità della tradizione profetica si è affermata in maniera irrevocabile richiamandosi all’ispirazione divina, questo sistema chiuso blocca qualsiasi sviluppo ulteriore naturale della dottrina, come invece accadeva ancora, ovviamente, per gli antichi studiosi di diritto e la loro tradizione viva. Con ciò, in pratica, la tradizione è elevata a principio universale, cosa che nel lungo periodo porterà all’immobilismo e alla rigidità. A fronte di una determinata tradizione profetica non è più di alcun aiuto neppure l’appello, in passato del tutto consueto, allo spirito del Corano.
In effetti, l’ermeneutica di aš-Šafi‘ī ha qui preso precauzioni in ogni senso: il Corano deve essere interpretato alla luce della tradizione profetica, e non viceversa. Per la capacità di giudizio personale rimane davvero poco spazio, come nel sistema cattolico-romano in cui la Bibbia è da interpretare alla luce della tradizione, attraverso il «magistero autentico», e non è possibile appellarsi alle Scritture scavalcando tradizione e magistero. Contro il Profeta ispirato da Dio e le sue parole e azioni che ci sono state tramandate c’è ben poco da argomentare, come contro il Papa assistito dallo Spirito Santo e le sue precise asserzioni. In entrambi i casi non si può più porre in discussione la verità dell’affermazione, bensì solo le modalità di tradizione ad essa connesse: ecco perché la scienza giuridica islamica si concentra così tanto sulle questioni della catena di tradizione.
La dottrina di aš-Šafi‘ī non può, naturalmente, imporsi subito, e nel corso del tempo viene modificata in alcuni punti. Ma la sua impostazione centrale, l’autorità divina della sunna del Profeta, sembra ora in linea generale inconfutabile. Egli stesso l’aveva così formulata: «Nei punti in cui esista una decisione esplicita di Allāh o una sunna del Profeta o un consenso di musulmani, non è consentito alcuno scarto di opinione; in altri punti gli studiosi devono esercitare il loro personale giudizio tramite la ricerca di un’indicazione in una di queste tre fonti».40
Nel tempo, le altre scuole di diritto dovranno adattarsi, per quanto riguarda l’autorità della tradizione, alle posizioni di base di aš-Šafi‘ī. Persino gli hanafiti devono accondiscendere a fondare le loro soluzioni sull’ḥadīṯ. Tuttavia né a Medina, dove si era già da sempre orientati alla prassi locale, né a Kufa, dove si prediligeva l’argomentazione razionale libera, ci si mostra pronti ad accettare il carattere vincolante di ogni singola tradizione, se questa contraddice la propria dottrina consolidata. In questo modo entrambe queste scuole riescono a conservare, in ambiti limitati, il proprio carattere specifico.
La scuola di diritto shafi‘ita si propaga in seguito al di fuori dell’Egitto e di Baghdad. Ha la sua fase aurea in particolare in Egitto, tra l’epoca abbaside e quella ottomana, e produce teologi celeberrimi come al-Aš‘arī e al-Ġazzālī, di cui parleremo ancora. Anche oggi essa ha molti adepti soprattutto nell’Alto Egitto, in Siria, nell’Arabia meridionale, nell’Africa orientale e nel Sud-Est asiatico. Purtroppo bisogna notare come proprio aš-Šafi’ī, contribuendo al consolidamento della scienza giuridica islamica, ne abbia nel contempo favorito la fossilizzazione.
È chiusa la «porta dell’argomentazione giuridica»? Ibn Hanbal
Quello che il grande sistematico aš-Šafi‘ī voleva a tutti i costi evitare si verifica: la fondazione di una nuova scuola di diritto che si richiama specificamente a lui, ma con un’impostazione ancora più rigorosa. Ahmad ibn Hanbal (780-855), proveniente da una famiglia pro-alidica di Merw, era stato un allievo dello stesso aš-Šafi‘ī: trascorse la sua vita principalmente a Baghdad e raccolse nella sua opera più di 80.000 ḥadīṯ. A suo parere, aš-Šafi‘ī avrebbe lasciato troppo spazio alla riflessione e alla decisione personale; ci si dovrebbe discostare il meno possibile dal senso letterale del Corano e degli ḥadīṯ. È sintomatica della mentalità di Ibn Ḥanbal la tradizione secondo cui non avrebbe mai mangiato cocomero perché non c’era alcun precedente in tal senso nella tradizione del Profeta. Eppure quest’impostazione rigorosa ha, paradossalmente, anche conseguenze «liberali» perché ciò che non viene chiaramente ordinato non si può prescrivere, e ciò che non è esplicitamente proibito non si può vietare. Vedremo però che Ibn Hanbal, che è propenso a considerare legittima sia la dinastia omayyade che quella abbaside, rifiuta la dottrina ufficiale, allora sostenuta dagli Abbasidi, della teologia razionale (Mu‘tazila), e viene per questo gettato in prigione dall’833 all’835; solo negli ultimi suoi cinque anni di vita può nuovamente raccogliere allievi attorno a sé.
A lui si richiama pertanto la quarta scuola di diritto, la scuola ḥanbalita, nota per la sua interpretazione letterale del Corano e della sunna e la stretta osservanza della sharia. Pure, in essa il rigorismo nelle questioni cultuali e dogmatiche si mescola a liberalità in questioni che non sono nettamente definite nelle fonti di rivelazione, come ad esempio questioni di contratti di debito e diritto commerciale, tanto che proprio in questa scuola, a differenza delle altre, non causa difficoltà il principio della libertà contrattuale.
La scuola hanbalita si diffuse soprattutto in Iraq, dove ebbe un ruolo importante nelle dispute con gli sciiti; venne poi però risospinta nell’ombra dagli Ottomani e dalla scuola hanafita. Attraverso il riformatore di tendenze conservatrici Ibn Taimīya, questa rigorosissima corrente influenzerà, nel XVIII secolo, il movimento riformatore wahhabita, e benché sia numericamente la più debole delle scuole di diritto ha grande importanza, perché gode tuttora di un largo seguito in Arabia Saudita e negli Emirati Uniti.
Quale doveva però essere, allora, il futuro della scienza giuridica islamica? E deve poi esserci un futuro? È evidente che ha conosciuto un’incredibile fioritura nell’ambito del paradigma abbaside (P III) – e questo secoli prima della fioritura della scienza canonica nel medioevo latino! Ma, a differenza che in passato, ora nell’islam gli esperti di religione (‘ulamā’) non sono più liberi. È ragionevole, e anzi rientra nell’interesse degli Abbasidi, che lo sviluppo del diritto religioso giunga nell’VIII secolo a una conclusione. A partire dal IX secolo, l’interpretazione del Corano e della sunna è ancora ammessa solo nell’ambito delle quattro scuole di diritto. È il periodo aureo di quelle grandi raccolte di ḥadīṯ, compilate da al-Buḫārī e dai suoi successori, che abbiamo già nominato.
Attraverso il richiamo, ora sempre più forte, alla tradizione e al consenso, l’argomentazione giuridica indipendente (iǧtihād) viene progressivamente limitata fino all’estinzione definitiva della sua forza creativa. Intorno al 900, le posizioni fondamentali di aš-Šafi‘ī si sono ormai imposte. Da nessuna parte è però documentato che, come viene spesso sostenuto, la «porta della argomentazione giuridica indipendente» (bāb al-iǧtihād) sia da considerarsi chiusa a partire dal X secolo – un secolo prima che fosse formulato un diritto ecclesiastico papale unitario – per lo meno nell’islam sunnita. Più rapidamente di quanto ci si potesse aspettare, la primavera piena di speranze della giurisprudenza musulmana era stata seguita dall’autunno del tradizionalismo.
Controdomanda: l’innovazione diventa rigida tradizione?
Come per l’ebraismo e per il cristianesimo, anche per l’islam è di importanza vitale la questione del peso della tradizione, che si pone non solo per gli estranei, ma soprattutto per i musulmani stessi. Nella comunità islamica ci sono infatti oggi molti credenti seri (benché, in molti casi, non abbiano il coraggio di esprimersi apertamente) che trovano problematico il ruolo di rivelazione attribuito agli ḥadīṯ, dato che in tal modo il Corano stesso viene quasi completamente relegato sullo sfondo. Anche i musulmani hanno scrupoli su questo punto, ma tali scrupoli non dipendono dal fatto che, nell’attuale prospettiva storica, è difficile separare ciò che è autentico da ciò che è falso, e che si sollevano dubbi sull’autenticità della maggior parte degli ḥadīṯ – molti dei quali sembrano in effetti riflettere, piuttosto che l’epoca del Profeta, le discussioni presenti nella prima comunità musulmana. Certo, nella tradizione degli ḥadīṯ si trovano anche citazioni dai filosofi greci, per non parlare della Bibbia. Ma non è questo il punto. Il fatto è che a molti musulmani di oggi interessa ritornare alle origini, all’essenza vera dell’islam, per svincolarsi da tradizioni ormai ingessate. Il Corano appare loro (in modo simile alla Bibbia per molti ebrei e cristiani) più profondo, più semplice e più aperto di molto di ciò che l’ha seguito, persino in questioni tanto complesse come il ruolo della donna e dei non musulmani, oppure in specifiche problematiche di diritto penale.
Anche in questo caso si crea un paradosso: in origine, l’islam era entrato nella vita tradizionale degli arabi come un’enorme spinta innovativa e aveva messo in dubbio con successo l’antichissima sunna araba, trasformando la tradizione locale o regionale e modificando tantissimo nel diritto consuetudinario arabo. Era stata un’impresa già di per sé notevole, se è vero che gli arabi si sentono da sempre molto più fortemente legati alla tradizione e ai precedenti di quanto non lo siano, ad esempio, i greci. Ciò che è sempre stato consueto, non è per principio giusto e buono? Ciò che facevano già gli avi, può essere stato falso? Eppure, contro tutte le resistenze della sunna antico-araba, il Profeta fu in grado di imporsi con il suo messaggio del Dio unico e della sua giustizia (P I).
Però, quando l’islam ebbe vinto, l’islam dell’innovazione non divenne forse l’islam della tradizione? Già il primo califfo Abū Bakr (P I) sembra essersi richiamato alla sunna del Profeta (intesa tuttavia ancora in senso del tutto generico). E presto il grande contrasto fu su questo: se il terzo califfo, ’Uṯmān, si fosse discostato o meno dalla sunna di Abū Bakr e di ‘Umar, e con ciò dal Corano e dalla sunna del Profeta – un’accusa che venne poi sollevata dai conservatori religiosi a Medina anche contro gli Omayyadi (P II) e doveva essere addotta come causa della rivoluzione abbaside (P III). In seguito a ciò, si giunge poi all’assolutizzazione e dunque alla fossilizzazione della tradizione. Al posto del diritto di esercitare autonomamente l’argomentazione giuridica (iǧtihād) subentrava ora il dovere dell’«imitazione» (taqlīd), senza la quale non è certo pensabile una scuola di diritto, ma che degrada il singolo giurista a semplice «imitatore» (muqallid), che si limita a seguire la dottrina stabilita dai suoi celebri e idealizzati predecessori.
Qui bisogna ora interrogare non solo l’islam, ma anche le altre due religioni profetiche, che dopo un avvio innovativo si sono fossilizzate, in molteplici maniere, come tradizioni.
Domande sul tradizionalismo
 Molti cristiani lo hanno riconosciuto: nel cristianesimo si è assolutizzata la tradizione ecclesiastica a spese dell’annuncio biblico. Così come nel paradigma ellenistico-bizantino (P II), la tradizione dei Padri e dei concili divenne praticamente la norma suprema del cristiano, nel paradigma medievale cattolico-romano (P III) lo divenne l’autorità di Roma nella dottrina, nella morale e nella disciplina. Con questo,
il cristianesimo non ha forse oscurato una parte della sua natura? Un tradizionalismo cristiano non va decisamente a scapito del sentimento cristiano? Determinate tradizioni non devono essere riformate, corrette o abolite alla luce dell’essenza del cristianesimo, come richiesto dalla Riforma (P IV)?
Molti cristiani lo hanno riconosciuto: nel cristianesimo si è assolutizzata la tradizione ecclesiastica a spese dell’annuncio biblico. Così come nel paradigma ellenistico-bizantino (P II), la tradizione dei Padri e dei concili divenne praticamente la norma suprema del cristiano, nel paradigma medievale cattolico-romano (P III) lo divenne l’autorità di Roma nella dottrina, nella morale e nella disciplina. Con questo,
il cristianesimo non ha forse oscurato una parte della sua natura? Un tradizionalismo cristiano non va decisamente a scapito del sentimento cristiano? Determinate tradizioni non devono essere riformate, corrette o abolite alla luce dell’essenza del cristianesimo, come richiesto dalla Riforma (P IV)?
 Molti ebrei lo hanno riconosciuto: nell’ebraismo la Torah (P I) venne soffocata da una seconda «Torah orale» (P III): complicate «tradizioni dei padri» nel Talmud (P IV), che divennero in pratica fondamenti normativi per la dottrina e la legge religiose. Eppure, in questo modo la tradizione non è divenuta più importante della «documentazione» (Torah) di Dio stesso? Un tradizionalismo ebraico non va eccessivamente a scapito dello spirito dell’ebraismo? Determinate tradizioni non dovrebbero poter essere superate, per far ritornare alla superficie ciò che è veramente essenziale?
Molti ebrei lo hanno riconosciuto: nell’ebraismo la Torah (P I) venne soffocata da una seconda «Torah orale» (P III): complicate «tradizioni dei padri» nel Talmud (P IV), che divennero in pratica fondamenti normativi per la dottrina e la legge religiose. Eppure, in questo modo la tradizione non è divenuta più importante della «documentazione» (Torah) di Dio stesso? Un tradizionalismo ebraico non va eccessivamente a scapito dello spirito dell’ebraismo? Determinate tradizioni non dovrebbero poter essere superate, per far ritornare alla superficie ciò che è veramente essenziale?
 Molti musulmani lo hanno riconosciuto: dove l’islam ha costruito e idealizzato in maniera troppo forte il suo passato, la sunna è divenuta un’istituzione surrogato della guida profetica, e gli ḥadīṯ una rivelazione diretta di Dio. Anzi, per la scienza giuridica islamica, che tutto determina, gli ḥadīṯ sono divenuti più importanti del Corano stesso. Gli insegnamenti degli avi furono in larga misura adottati e spesso conservati solo in formule meccaniche. Ciò che non è di per sé rivelazione di Dio, ma il risultato di uno sviluppo storico, può essere prescritto per sempre e per uomini di ogni epoca? Non hanno nuociuto all’islam, come religione viva, l’assolutizzazione e la fossilizzazione della tradizione e il rispetto eccessivo per gli scolarchi del passato? L’essenza del grande messaggio profetico non è stata più volte oscurata tradizionalisticamente? Non si dovrebbe anche qui potersi liberare da determinate tradizioni, facendo ricorso all’essenza dell’islam?
Molti musulmani lo hanno riconosciuto: dove l’islam ha costruito e idealizzato in maniera troppo forte il suo passato, la sunna è divenuta un’istituzione surrogato della guida profetica, e gli ḥadīṯ una rivelazione diretta di Dio. Anzi, per la scienza giuridica islamica, che tutto determina, gli ḥadīṯ sono divenuti più importanti del Corano stesso. Gli insegnamenti degli avi furono in larga misura adottati e spesso conservati solo in formule meccaniche. Ciò che non è di per sé rivelazione di Dio, ma il risultato di uno sviluppo storico, può essere prescritto per sempre e per uomini di ogni epoca? Non hanno nuociuto all’islam, come religione viva, l’assolutizzazione e la fossilizzazione della tradizione e il rispetto eccessivo per gli scolarchi del passato? L’essenza del grande messaggio profetico non è stata più volte oscurata tradizionalisticamente? Non si dovrebbe anche qui potersi liberare da determinate tradizioni, facendo ricorso all’essenza dell’islam?
Almeno in campo teologico, molti studiosi musulmani erano consapevoli del fatto che la ripetizione di versetti coranici e di citazioni dai profeti non è sufficiente, ma che si tratta di interpretare razionalmente il Corano e la sunna. Tuttavia quest’intenzione condusse – dopo la prima disputa teologica sulla predestinazione divina e l’autodeterminazione umana (P II) – a un secondo grande conflitto teologico, quello su rivelazione e ragione (P III).
5. IL SECONDO CONFLITTO TEOLOGICO: RIVELAZIONE E RAGIONE
Sono passate ormai generazioni dalla conversione degli arabi alla fede nell’unico Dio. Con «infedeli» in senso stretto, cioè con politeisti, si ha ancora a che fare in maniera consistente soltanto ai margini dell’immenso impero: in India, nell’Asia centrale presso i popoli turchi e in Africa, con le religioni tribali. Dal punto di vista teologico, secondo la concezione musulmana, non c’è quasi bisogno di prendere sul serio questa pura e semplice «superstizione».
Ben altrimenti stanno le cose con i «diversamente credenti», gli ebrei e i cristiani. Non c’è dubbio che anch’essi siano «popoli del Libro», a cui Dio ha donato una specifica rivelazione. Ad essi i musulmani sono legati grazie alla fede nell’unico Dio di Abramo, ma se ne differenziano anche, soprattutto dai cristiani a cui un musulmano può facilmente rivolgere l’accusa di «politeismo» per via del dogma trinitario. Ogni sorta di «associazionismo» (širk), che minacci la fede nel solo e unico Dio, deve essere respinta sia che venga dall’esterno, dalla dottrina cristiana, o dall’interno, vale a dire da tutto ciò che può distogliere un musulmano da Dio. La teologia, la ragione teologica, ha proprio in questo caso un compito particolare.
La nuova importanza della ragione
L’epoca degli Abbasidi fu il momento di massima fioritura non solo del diritto islamico, ma anche della teologia islamica. Anche per la teologia proprio nell’ambito di questo paradigma (P III) furono raggiunte le posizioni classiche che conservano ancor oggi, in gran parte, la loro validità. Esse si erano preannunciate, a dire il vero, già nella tarda epoca omayyade (ogni cambiamento di paradigma viene infatti preparato in quello precedente): solo all’inizio dell’epoca abbaside, però, prende forma chiaramente il nuovo paradigma per la teologia.
- Il centro di gravitazione della teologia si è spostato completamente a est. La Siria, l’Egitto e anche lo Higàz rivestono ora, teologicamente, un ruolo periferico; le decisioni teologiche si prendono soprattutto a Baghdad e in Iran.
- Non è il contrasto tra «sette» o tra città a essere ora decisivo, ma il contrasto tra metodi: la scienza della tradizione (dei muḥaddiṯūn, degli esperti di ḥadīṯ) o la teologia razionale (= kalām dei mutakallimūn).
- L’oggetto di discussione si sposta dall’ambito «predeterminazione divina – autodeterminazione umana» alla problematica «rivelazione divina – ragione umana», e di conseguenza alla natura del Corano: è frutto di creazione o no?
- Ancora in P II, la fede nel Dio uno era stata accettata in larga misura senza riserve; non necessitava di alcuna riflessione particolare. Ora però l’unità e unicità (tawhid) di Dio diventa un tema teologico molto dibattuto, indicato talvolta persino come la prima verità di fede dell’islam: il primo dei cinque «fondamenti» (uṣūl) della fede (īmān), che si potrebbero mettere in parallelo ai cinque «pilastri» (arkan) o comandamenti pratici.
- Fino a ora la capacità di immaginarsi Dio veniva di gran lunga considerata come innata all’uomo: questi (anche il non credente!) può riconoscere Dio a partire da se stesso. Ora invece – analogamente a quanto farà in seguito la Scolastica cristiana – si comincia a distinguere due livelli di conoscenza di Dio: ciò che l’uomo può riconoscere da solo (come minimo l’esistenza di Dio), e ciò che egli conosce tramite la rivelazione divina. Si dà ora uno sviluppo razionale a quello che nel Corano si trova solo per accenni: prove di Dio accuratamente formulate (in base sia alla teleologia, sia alla contingenza del mondo) e una dottrina ponderata delle qualità (attributi) di Dio.
- Si giunge così alla fine a un’unificazione del pensiero islamico e all’apice della sua teologia.
In un primo tempo, tuttavia, questa teologia appare fortemente polarizzata ed esposta a tensioni crescenti tra i sostenitori degli ḥadīṯ e quelli del kalām, entrambi in lotta per ottenere il favore dei califfi.
– Da una parte si trova la teologia tradizionale della «gente della tradizione» (ahl al-ḥadīṯ) e, a essa collegata, la scuola di diritto, a noi nota, di Ahmad ibn Hanbal. Gli hanbaliti, non di rado molto aggressivi, sostengono un’interpretazione letterale del Corano e della sunna (ḥadīṯ): nessun metodo logico è ammesso nella trattazione di questioni giuridiche e teologiche; la ragione umana non è in alcun modo determinante per la conoscenza teologica. Il milieu sociale di questa teologia è costituito più che altro dalla piccola borghesia, disorientata dal crogiuolo della metropoli, e dai ceti bassi. Questa teologia degli esperti di ḥadīṯ fa sembrare l’islam più angusto di quel che è.
– Dall’altra parte si trova la teologia razionale della cosiddetta Mu’tazila, comparsa già alla fine dell’epoca omayyade, che raggiunge ora il suo apice sotto gli Abbasidi: la esamineremo più in dettaglio fra poco. Essa non vuole sostituire la rivelazione con la ragione, o assoggettarvela; da questo punto di vista non è – come spesso viene etichettata – «razionalistica», bensì piuttosto «razionale»: essa vuole, restando fedele alla rivelazione, comprendere, spiegare, motivare il Corano e la sunna con l’ausilio della ragione, e difenderli contro i loro avversari – ebrei e cristiani, dai quali essa al tempo stesso impara e deriva non poco. Questa teologia razionale è figlia del dialogo tra intellettuali delle classi alte cittadine e mostra l’islam come religione aperta al mondo e alla vita reale.
È a quest’ultima che dobbiamo ora dedicare tutta la nostra attenzione. Perché da essa, che dominerà per i decenni successivi, derivano problematiche, concetti e argomentazioni che si sono mantenuti fino a oggi, nonostante la successiva decadenza della scuola. Purtroppo non abbiamo quasi nessun testo originale di questo primo periodo; la teologia razionale ci è nota solo tramite confutazioni e successivi resoconti o rielaborazioni. Anche in questo campo, l’opera di Josef van Ess ha fornito un contributo decisivo di conoscenze e giudizi.41
Inizi della teologia razionale: Wāṣil e ’Amr
La Mu’tazila, che dopo la guerra civile tra i due figli di Hārūn ar-Rašīd e la vittoria di al-Ma’mūn su al-Amīn diviene la teologia ufficiale di stato, ha una preistoria complessa e non è mai stata per natura una teologia filo-governativa. Al contrario: gli studi più recenti sull’origine del nome Mu’tazila42 mostrano che esso è da intendere in senso primariamente politico e risale già all’epoca della prima guerra civile tra Mu’āwiya e ’Alī:
– al-mu ’tazil (singolare; non ancora maiuscolo, nel senso di un movimento, partito o scuola teologica) è qualcuno che in una lite si mantiene neutrale, che «prende le distanze», «si distacca» (i’tazala) da tutti i correligionari che, in maniera non islamica, sollevano la spada l’un contro l’altro;
– al-Mu’tazila (singolare) è il movimento di quelli che si distaccano: «la Mu’tazila si distaccava da ogni partito politico», dunque non solo dagli Omayyadi, ma originariamente (così sostiene J. van Ess43 contro H.S. Nyberg)44 anche dagli Abbasidi e dalla loro opposizione alidica.
Fondatori della Mu’tazila in senso teologico sono considerati due allievi coetanei del celebre Hasan al-Basrī, nei quali però non si nota ancora nessuno scontro con i tradizionisti:
– il mawla (originario forse di Medina) Wàsil ibn ’Aṭā’ (699-748 /749),45 un facoltoso commerciante di stoffe (e per questo additato come piccolo-borghese), di grande cultura, ma con un difetto di pronuncia, la erre moscia, che sapeva destramente aggirare, da retore trascinante qual era, da ḥaṭib. Influenzato dall’ascetismo di Hasan, di ispirazione qadarita, Wāṣil organizza un movimento missionario. Il suo è un ascetismo moderato, che non si apparta dal mondo, e fa sì che Wāṣil non si appelli al sentimento, ma al giudizio razionale. Deve la sua fama a un’orazione improvvisata di grandissimo impatto, tenuta al cospetto di ’Abdallāh, figlio di ’Umar II, governatore dell’Iraq, e che sbaragliò tutti gli altri discorsi; Wàsil muore però subito prima della rivoluzione abbaside.
– Il suo compagno di studi e parimenti mawla ’Amr ibn ’Ubaid (699-761),46 un taciturno più che un oratore, polemizzatore o scrittore. È ancora più asceta di Wāṣil, dal quale sarebbe stato «convertito» in una disputa – la cui veridicità storica non è però provata. Del denaro e del lusso gli importa poco, per lui contano molto la preghiera incessante e il pellegrinaggio alla Mecca, dalla quale, una dozzina d’anni dopo la morte di Wāṣil, non doveva ritornare vivo. L’influsso di ’Amr mentre era ancora in vita è testimoniato dall’esistenza di un’associazione giovanile che rappresenta, a fronte dell’evidente ingiustizia politica e sociale, una sorta di rete di comunità, un’organizzazione borghese di auto-aiuto.
La leggenda associa strettamente, dal punto di vista teologico, Wàsil e ’Amr, tanto da farli comparire sempre in coppia, come «Goethe e Schiller» o «Marx e Engels». Ma i due hanno profonde differenze, per quanto possano aver avuto una stretta collaborazione politica a Bassora, come sostenitori qadariti del libero arbitrio. Infatti, l’affinità teologico-mu’tazilita, spesso presupposta tra i due, è quasi assente. Anche i loro allievi sono diversi: quelli di Wāṣil sono in prevalenza giuristi, quelli di ’Amr invece soprattutto tradizionisti. Mentre’Amr opera come docente a Bassora, Wāṣil invia i suoi allievi come missionari con le carovane in giro per il mondo: dove giungono, essi si procurano dapprima una base di consenso grazie alla loro opera di consulenza giuridica, per poi, da missionari, sollevare questioni religiose. Wāṣil invia i suoi messaggeri, di cui conosciamo persino i nomi, 47 non solo nella penisola araba, a Medina e Bahrein e nello Yemen, ma anche nel Maghreb, nel Khorasan e in Armenia. Ma che tipo di teologia sostengono i due?
Per primo, Wāṣil ipotizza in ogni caso con risolutezza – per mettere d’accordo la comunità, divisa su tale questione – una speciale condizione provvisoria per il peccatore grave, cosa che in seguito vale poi come tipicamente mu’tazilita. Un assassino, ad esempio, non è un credente che può andare in paradiso, ma nemmeno soltanto un miscredente destinato all’inferno; potrebbe in fondo pentirsi, e comunque le sue buone azioni verrebbero scalate da quelle cattive – un interessante parallelo con specifiche dottrine penitenziali cattoliche. I bambini inconsapevoli, però, che un maestro della chiesa cattolica come Agostino ha condannato all’inferno (in caso di mancato battesimo), per il tollerante teologo musulmano non vengono chiamati a rendere conto delle loro azioni, ma vanno in paradiso.
’Amr non è affatto rivoluzionario sul piano teologico. Si sente talmente legato al suo venerato maestro Hasan al-Basri che cura, egregiamente, l’edizione del suo commento al Corano e anche come giurista si rifa fortemente al suo maestro nell’interpretare il Libro sacro. Per il resto, tuttavia, il suo lavoro è indipendente, come testimonia il suo scritto sulla suddivisione del Corano in 360 parti, l’unico che ci sia rimasto (di altri due ci sono stati tramandati solo i titoli). In alcuni punti ’Amr sembra superare il suo maestro: non solo dà più peso, in generale, a un’esegesi sostenuta dall’analisi testuale, ma interpreta anche alcuni versetti coranici in chiave decisamente qadarita, nel senso della libertà di scelta umana. Tuttavia egli non sostiene affatto le posizioni razionali della successiva Mu’tazila, se non in quanto ancora rifiuta, senza alcun problema, ḥadīṯ che sono dogmaticamente predestinazionisti o che sono in contraddizione con la prassi giuridica consueta di Bassora. Non solo Dio non determina il male, per ’Amr, ma neppure il bene.
Scontro con il califfato?
Di sicuro, né Wāṣil, né ’Amr hanno predicato l’insurrezione armata contro gli Omayyadi e poi contro gli Abbasidi (a differenza di Bašīr ar-Raḥḥal, anch’egli mu’tazilita). Piuttosto, essi hanno mantenuto le distanze dall’autorità anche sotto gli Abbasidi, e al tempo stesso hanno reclamato giustizia sociale e politica. È probabile che il circolo di ’Amr si sia distaccato dai Qurais già sotto l’effetto della condanna a morte (di cui sopra) di Ġailān (732), ma anche dopo la vittoria degli Abbasidi ha mantenuto un comportamento tranquillo.
Avvolto dalla leggenda (e talvolta estremamente ingigantito) è l’incontro tra ’Amr e il califfo al-Manṣūr nell’anno 759. Sull’occasione di questo incontro si sono tentate diverse congetture: al-Manşūr vede forse in ’Amr un amico fidato, addirittura un padre spirituale (così H.S. Nyberg?)48 Lo fa venire se non altro per rispetto e per chiedergli un parere in questioni morali-religiose (così W.M. Watt?)49 O si trattò di ragioni politiche: il sospetto di cospirazione e di attività anti-governativa da parte dei suoi adepti, che si contavano a migliaia? Così la pensa ora, dopo una nuova radicale analisi delle fonti, Josef van Ess:50 la «Mu’tazila», con la sua rete di comunità che non sono solo raggruppamenti religiosi, ma anche cellule di lotta politica, costituisce senz’altro un fattore di potere in considerazione del lavoro di sobillazione degli Alidi. Quando però nel 759 Muḥammad, il figlio di Abdallāh ibn al-Hasan ibn ’Alī, ricompare da Medina a Bassora, il califfo reagisce rapidamente con una dimostrazione di forza. Quest’ultima influenza così profondamente la Mu’tazila da spingere ’Amr, pur se riluttante, a recarsi dal califfo e dichiarargli lealtà. Quando poi, ciò nonostante, nel 762 scoppia l’insurrezione, ’Amr, che in precedenza era stato umiliato dal califfo, è morto da un anno. I suoi seguaci si spaccano però in due tronconi: gli attivisti militanti, sotto la guida di Bašīr ar-Raḥḥal, tra i quali non c’è nessun teologo, e i moderati, che però non hanno quasi lasciato tracce nella storia.
In seguito si giunse a un’alleanza sempre più stretta dei mu’taziliti con il califfato: al tempo del califfo al-Mahdī essi non hanno ancora accesso alla corte, ma già sotto Hārūn ar-Rašīd sono i benvenuti nelle sedute di discussione dei Barmakidi, una famiglia di visir, dove si incontrano studiosi di ogni provenienza. Nell’ultima fase del califfato di Hārūn devono lasciare il palazzo, perché i tradizionisti hanno il sopravvento, ma già sotto suo figlio, al-Mamun, sono i mu’taziliti a dominare.
Il paradigma di una teologia razionale
La Mu’tazila riesce sotto gli Abbasidi a elaborare un nuovo paradigma di teologia, nel quale gioca un ruolo completamente nuovo la razionalità, dalla «fisica» fino alla comprensione di Dio e all’escatologia. Nessuno, nell’islam, ha fatto propria la filosofia greca e le altre scienze in maniera così decisa come la Mu’tazila. Solo così essa fu in grado di costruire un sistema scientifico coerente, di ampliare le problematiche della teologia islamica, di affinare la costruzione dei concetti e di rafforzare la loro argomentazione. Le menti propulsive sono qui due studiosi che già sotto i Barmakidi entrano a corte: Ḍirār ibn ’Amr, molto produttivo, nel quale per la prima volta si incontrano il pensiero antico (Aristotele) e il pensiero islamico (esegesi coranica), e Mu’ammar, interessato soprattutto alle scienze naturali (specchio, bilancia). 51
Con riguardo alla formazione del paradigma, tuttavia, ci devono interessare soprattutto le posizioni raggiunte dai grandi sistematizzatori, attraverso le quali la Mu’tazila classica tocca il suo culmine. La cosa interessante è che qui si ha una coppia polare formata da uno zio e da un nipote: Abū l-Huḏail e il nipote an-Naẓẓām, inizialmente suo assistente e poi in conflitto con lui. Qui ci concentreremo soprattutto su Abū l-Huḏail, che ha avuto maggiore influsso del nipote, il quale però è stato un outsider estremamente originale, che ebbe fama di poeta e raffinato cultore della lingua (e cattiva fama di amante di ragazzi) e che fece parlare di sé con la «filosofia» (spiegazione della natura), per poi dedicarsi in seguito maggiormente alla teologia.
Come cristiani si è stupefatti di come, secoli prima di qualunque Scolastica latina, in un’epoca in cui sull’Europa incombe la minaccia della perdita di continuità col proprio passato (scongiurata solo dai monaci), nelle regioni arabe sotto influsso greco questi due sistematizzatori discutano in maniera estremamente sottile:52
– di «fisica»: atomismo, corpi e accidenti (costanti e non costanti), moto, aria e luce, fuoco e combustione, percezioni sensoriali, dottrina dei colori e acustica, identità e differenza, la collocazione della terra nel vuoto...
– di antropologia: corpi e principio vitale («vita», «spirito»), l’unità della persona e dell’agire, percezione e conoscenza, ma anche resurrezione, vita eterna, Satana e demoni...
– di questioni ermeneutico-criteriologiche: esegesi coranica e affidabilità della tradizione profetica, la metodica giuridica e la problematica dell’analogismo e del consenso.
Sarebbe certo interessante discutere, per esempio, l’originale «metafisica dell’Essere creato» (R.M. Frank) costruita da Abū l-Huḏail con l’ausilio dell’atomismo (gli atomi, come mattoncini invisibili dell’Essere, vengono assemblati in corpi da Dio stesso e alla fine anche nuovamente disgregati!); il nostro interesse si deve tuttavia concentrare sulla teologia, e precisamente sulla theo-logía in senso stretto, la dottrina di Dio. I mu’taziliti sono stati continuamente considerati eretici in quanto piatti razionalisti: ma abbandonare il Corano come fondamento della loro teologia è tanto poco l’intenzione di Abū l-Hudail e an-Naẓẓām, quanto lo è per Alberto Magno e Tommaso d’Aquino quella di abbandonare la Bibbia. Tutti costoro rivendicano la ratio più dei loro predecessori, sono tutti consapevolmente razionali, ma non sono per nulla razionalisti.
Dal punto di vista storico, Abū l-Huḏail e an-Naẓẓām si collocano tra due direttrici: da un lato, gli antropomorfisti tradizionalisti, che com’è noto si accontentano della comprensione letterale del Corano (e degli ḥadīṯ), escludono qualsiasi interpretazione metaforica del testo sacro e non hanno difficoltà con le numerose espressioni antropomorfe con cui viene descritto Dio; dall’altro lato, i trascendentalisti estremi o ğahmiti (ğahmīya), che accentuano in maniera estrema la trascendenza, l’alterità di Dio per la conoscenza dell’uomo. Questi e i mu’taziliti vengono spesso identificati, ma si distinguono in maniera molto netta.
Un Dio senza qualità? Ǧahm
I trascendentalisti estremi risalgono a Gahm ibn Ṣafwān53 (giustiziato nel 746), un mawla di grandi doti retoriche e anche politicamente molto impegnato, un khorasano che ha vissuto la maggior parte della sua vita a Tirmid, nella Battriana (oggi Afghanistan settentrionale), dove la sua dottrina godette di alta considerazione ancora per molte generazioni dopo la sua morte. Tirmid era allora una sede del buddhismo dell’Asia centrale, e nei suoi pressi si trovavano numerosi monumenti buddhisti.
Gahm, in base a tutto quello che sappiamo, ha condotto dialoghi con i «sumaniti»,54 a quanto pare sensualisti che non credevano a nessuna realtà spirituale, di certo a nessun Dio personale. Si tratta in ogni caso di Indi (sanscrito: śramana, medioindiano: samana: probabilmente asceti) di probabile credo buddhista, forse addirittura proprio di monaci buddhisti. Non dovette certo essere facile difendere contro costoro il concetto di Dio come persona: ma forse proprio il contatto con buddhisti spiega (a meno che non si vogliano presupporre fonti neoplatoniche) perché Gahm, pur restando aderente al carattere di Dio come persona, radicalizzi molte posizioni.55 Questo vale per la comprensione di Dio (rifiuto di tutti gli attributi divini), e vale per la comprensione della fede (conoscenza di Dio, in questa regione di missione musulmana, al limite anche senza professione esplicita). Anche il suo determinismo radicale si trova del tutto isolato nell’islam.
Osserviamo da vicino, come problema centrale, la comprensione di Dio di Gahm: egli crede a un Dio che, onnipresente, determina da solo tutto ciò che avviene, che crea nell’uomo stesso ogni buona azione e crea anche la fede, anzi, che provoca anche nella natura ogni evento, persino il sorgere e il tramontare del sole. Un determinismo universale, dunque, che lascia l’uomo, che al proposito si fa volentieri illusioni, completamente in balìa di Dio.
Al tempo stesso, l’uomo che è in questa maniera alla mercé di Dio non può conoscerlo veramente. Per Ǧahm è fondamentale che, pur con ogni immanenza ontologica, rimanga garantita la radicale trascendenza di Dio per la conoscenza: per quanto Dio operi dentro ogni cosa, egli è tuttavia l’assolutamente altro, non un «qualcosa» (šay’) e non una «cosa», per antonomasia incommensurabile con qualsiasi cosa, come già dice il Corano.56 Dio è piuttosto il creatore «di ogni singola cosa»,57 il cui Essere supera infinitamente l’essere di ogni singola cosa. Per questo non possono nemmeno essergli attribuite le qualità di una «cosa», né estensione né colore, né direzione né confini, assolutamente nessuna delle qualità che possiamo constatare nel nostro mondo. I predicati di Dio nel Corano sono metafore: non parola di Dio veramente (predicati di sé), ma parola umana su Dio. Dio in sé è inconoscibile, non ha nomi né qualità.
Non c’è da stupirsi che i ğahmiti siano chiamati «svuotatori», coloro che esercitano uno «svuotamento» dell’essenza divina, il che non deve essere loro affatto dispiaciuto – dato che il «vuoto» (in sanscrito: śūnyatā) è un termine tecnico per la realtà suprema nel buddhismo Mahayana. Gli altri musulmani forse attaccavano i ğahmiti per il fatto che avevano sottratto a Dio ogni attributo: «Essi (i ğahmiti) fecero grandi discorsi su Dio e lo oltraggiarono nel modo più vergognoso, gli attribuirono ignoranza e lo derubarono un po’ alla volta degli attributi con cui è descritto. Alla fine gli presero anche il suo sapere precedente (agli eventi), il parlare, l’ascoltare, il vedere, proprio tutto», così scrive il sunnita ad-Dārimī (morto nell’869).58
Ora, è vero che già il capo degli ibaditi Abū ’Ubaida, come abbiamo già detto (cfr. cap. C II, 7), ha lanciato la scomunica su coloro che vogliono intendere le asserzioni su Dio di sapore metaforico letteralmente, invece che metaforicamente; con «mano» di Dio si intenderebbe appunto la sua potenza o la sua ricompensa, il suo «occhio» sarebbe il suo sapere o la sua protezione... E tuttavia Gahm e i ğahmiti vanno ancora oltre, se i resoconti sono autentici: per loro, Dio è l’Infinito nello spazio e nel tempo; egli è in ogni luogo e non è in nessun luogo più che in un altro. Sotto il concetto di unità di Dio è da intendere l’onnipresenza del suo Essere, che si sottrae a ogni determinazione concettuale umana. Eppure Dio si è egli stesso offerto alla conoscenza nella rivelazione, che, come le cose di questo mondo, è limitata in quanto creatura e in quanto collocata nel tempo.
Si può facilmente capire come questa dottrina dovesse trovare opposizione, e non solo presso i tradizionisti, che si limitano semplicemente al testo sacro, ma anche presso i teologi che utilizzano l’argomentazione razionale: come potrebbe un simile Dio intervenire ancora nel destino dei popoli e degli individui? Come potrebbe rivolgersi direttamente ai suoi profeti? Come potrebbe aver comunicato di sé in un libro? Non solo qui appaiono messi in questione l’agire di Dio e il Corano come Sua rivelazione, ma forse anche riti concreti, come l’obbligo della preghiera in direzione della Mecca o il pellegrinaggio alla Ka’ba, nel luogo in cui appunto viene sperimentata una speciale presenza di Dio.
Ma come si potrebbe dare una risposta teologica alla sfida dei ğahmiti che sia più conforme all’immagine di Dio presente nel Corano, senza fare marcia indietro rispetto al livello di riflessione fin qui raggiunto? C’era bisogno del grande sistematizzatore che fosse in grado di compensare gli estremi.
Dio ha caratteristiche: la sistematizzazione razionale di Abū l-Huḏail
Il grande sistematizzatore della Mu’tazila, Abū l-Huḏail al-’Allāf, che abbiamo già nominato, è un teologo di probabile origine iranica, nato nel 752, attivo per molti decenni come discepolo e poi successore di Ḍirār ibn ’Amr, capo del circolo locale di docenti di teologia. A quanto pare, al tempo del califfo al-Mahdī egli era stato portato a Baghdad per essere interrogato, nonostante la protesta dei suoi adepti; ora però, a più di sessant’anni, si spinge lui stesso a Baghdad per ottenere influenza anche alla corte di al-Ma’mūn. Abū l-Huḏail, che si presenta ai califfi appassionati delle stelle con un ragionevole discorso contro l’astrologia, è persona di vasta cultura filosofico-teologica e di capacità progettuale sistematica, dotata di spirito, ironia e sicurezza argomentativa, che sa confrontarsi polemicamente con ebrei, cristiani e zoroastriani, ma soprattutto con i suoi contemporanei musulmani. Per le generazioni che seguiranno egli sarà per antonomasia il rappresentante del kalām, della teologia razionale; ma negli studi moderni otterrà solo tardi il posto che gli spetta.59
Non occorre, per un’analisi del paradigma teologico, che ci occupiamo della «fisica» e dell’antropologia di Abū l-Huḏail, e neppure della sua escatologia estremamente originale, la cui reputazione è ormai compromessa, almeno presso le menti più semplici, più di quanto non lo sia quella di molte altre concezioni. Secondo la sua teoria, alla fine dei tempi paradiso e inferno non smetterebbero di esistere perché, come aveva sostenuto Gahm, questo significherebbe por termine all’azione creatrice di Dio; piuttosto, tutto giungerebbe finalmente e definitivamente a una pace eterna, immutabile. I beati dunque cesserebbero un giorno di mangiare, bere, visitarsi l’un l’altro e avere rapporti carnali... in effetti, questo genere di asserzioni sull’aldilà non sono ideali per guadagnare il favore delle masse.
Diversamente dal suo maestro Diràr, Abū l-Huḏail non combatté i tradizionisti, ma formulò severi criteri per la tradizione ḥadīṯ tenendo in considerazione le testimonianze contraddittorie e spesso falsificate (per an-Nazzām deve essere chiaro soprattutto il contenuto): secondo lui venti persone, e tra essi almeno un musulmano esemplare, devono trovarsi concordi su uno stesso resoconto. Qui ci interessa soprattutto l’idea di Dio di Abū l-Huḏail, perché è qui che le differenze tra i mu’taziliti, rappresentati da Abū l-Huḏail, e i ğahmiti sono particolarmente evidenti:
– secondo i ğahmiti, l’uomo non può assolutamente conoscere Dio, mentre secondo i mu’taziliti l’uomo non può conoscere Dio con i sensi, ma certo lo può con la ragione;
– secondo i ğahmiti, non ci sono prove dell’esistenza di Dio; secondo la Mu’tazila ci sono, anzi, Abù l-Huḏail è il primo teologo nell’islam che fornisca una prova accuratamente formulata, costruita in quattro fasi (a partire dal movimento e dalla contingenza del mondo).
Il tutto è portato alle estreme conseguenze nella dottrina – sviluppata positivamente in maniera sistematica per la prima volta da Abū l-Huḏail – delle qualità di Dio. Il teologo vuole compensare gli estremi: certo, gli antropomorfismi dovrebbero (come in Gahm) venire interpretati tramite la riflessione filosofica; al tempo stesso, però, bisognerebbe rendere giustizia al Corano, per non scivolare (come in Ǧahm) in una sterile «teologia negativa». Ma come si deve procedere?
Abū l-Huḏail, basandosi sull’esegesi coranica, non mostra alcuna remora nell’ascrivere a Dio la qualità dell’onnipotenza, come potevano fare al limite anche i ğahmiti, per spiegarne la capacità di operare sempre e dovunque. Di più: questo teologo, che accetta tutti i predicati che compaiono nel Corano ma unicamente questi, ascrive decisamente a Dio anche le proprietà della grandezza, maestà, superiorità e splendore – e precisamente in quanto espressione delle perfezioni eterne di Dio. Esse pertanto non possono essere distinte da Dio stesso, bensì devono essere asserite «con Lui» o «in Lui», anzi, sostanzialmente «di Lui». Perché? Perché esse sono identiche con la Sua essenza. Identici a Dio sono anche attributi che non hanno alcun oggetto, come «vita», o che non hanno alcun opposto come «volto» o «sé» (nafs). In rapporto alla sapienza di Dio – un caso paradigmatico per la dottrina degli attributi – questo vuole dire: «Dio è sapiente» non significa solo che non è insipiente, e nemmeno soltanto che «possiede» una sapienza, bensì piuttosto che Egli «è» sapienza. Dunque: la sapienza è identica con l’essenza di Dio: Dio è sapienza.
Ma allora, ad esempio, la potenza di Dio, che è identica all’essenza di Dio, coincide anche con la sua sapienza? Dovrebbe di conseguenza Dio fare anche tutto ciò che sa? Sulla soluzione offerta da Abū l-Hudail, che cerca di porre dei distinguo, si potrebbe discutere – soprattutto dal punto di vista della logica formale. Essa venne poi discussa non solo all’interno della Mu’tazila, ma anche da un teologo cristiano contemporaneo di Bassora. L’argomentazione di questo ’Ammār al-Baṣrī sarà stata degna di considerazione per i musulmani? Costui ha tratto dalla dottrina degli attributi una deduzione esattamente opposta: saggezza e vita non sono solo attributi di Dio, ma persone divine, cioè Figlio e Spirito Santo, autonome ed eterne in maniera sostanziale. Fu Abū l-Huḏail stesso a scrivere un libello polemico contro ’Ammār al-Baṣrī.60 Mentre per i ğahmiti già il carattere di Dio come persona (nafs) è un’ipotesi inutile, i mu’taziliti rifiutano radicalmente, come tutti i musulmani, la «associazione» di due persone a un Dio persona. E per quel che concerne la saggezza o sapienza di Dio, si deve riflettere sul fatto che Dio diviene sapiente non attraverso un atto di sapere, ma, come precisa an-Naẓẓām, è sapiente «attraverso se stesso», «da se stesso». I diversi attributi descriverebbero di volta in volta semplicemente un altro aspetto di Dio.
Controdomanda: e le conseguenze per lu concezione dell’uomo?
Le controversie sulla concezione di Dio dovevano naturalmente riflettersi anche in discussioni sulla concezione dell’uomo. Di queste ultime ci limiteremo a dare un breve resoconto: abbiamo infatti già trattato gli antichi contrasti tra qadariti e predestinazionisti, come anche le nuove opinioni contrapposte.
– Chi, come i ğahmiti, sostiene una divisione netta tra Dio e il mondo e un determinismo universale, praticamente non può attribuire all’uomo la benché minima forza e attività autonoma: nessuna volontà e nessuna possibilità di scelta libera. Allora come si può ricollegare al carattere metaforico dell’agire una responsabilità dell’uomo per la propria salvezza?
– Chi, viceversa, come i mu’taziliti, pur salvaguardando la trascendenza, vede tuttavia un rapporto tra Dio e il mondo, riconosce un profondo legame tra l’agire di Dio nella creazione e il fare umano: l’uomo ha una responsabilità, «genera» egli stesso le conseguenze delle sue azioni (come il ferimento e il dolore con il lancio di una pietra), dunque almeno le conseguenze prevedibili dell’agire umano sono da imputare all’uomo stesso. Il rapporto tra causa ed effetto non si può osservare dappertutto nella natura? I mu’taziliti si sono impegnati per dare una spiegazione chiara a questa domanda, così come per analizzare in maniera quasi chirurgica gli impulsi della volontà e i moventi dell’agire umano.
Nonostante tutto questo sforzo di pensiero, non si può non vedere che tale teologia razionale rischia facilmente di invischiarsi nei dettagli e di innalzare costruzioni arbitrarie. Resta comunque una consolazione ai mu’taziliti, come ha già messo in evidenza Abū l-Huḏail: Dio è sotto ogni rispetto buono e misericordioso e opera in ogni caso il bene («ciò che è adatto»). Ancor più precisamente si esprime an-Naẓẓām, che si arrovella sul problema della teodicea: Dio, il Perfetto, può fare solo ciò che è perfetto, e crea così sempre la «cosa più salutare» per il singolo uomo (non, ad esempio, la «cosa migliore» nel senso del migliore dei mondi possibili). L’uomo stesso deve naturalmente rispondere all’azione di Dio riconoscendo la legge divina. Può, però, un simile ottimismo resistere, considerato il reale mondo dell’islam?
Abū l-Huḏail muore a Baghdad all’età di circa novant’anni, probabilmente nell’842, quasi cieco, suo nipote probabilmente muore appena tre anni più tardi; le date sono incerte. Tuttavia, l’alterità di Dio (Abū l-Huḏail definisce Dio addirittura l’«opposto del mondo») rimane ancor oggi una caratteristica della visione musulmana di Dio – il che però non deve assolutamente significare che Dio è qualcosa di estraneo, freddo e irraggiungibile! Ci si chiede se, per lo meno nella questione dei «nomi» e degli attributi di Dio, non sia possibile un certo consenso tra musulmani e cristiani. Anche la Scolastica cristiana si occuperà di questi temi. Ma ci vorranno ancora più di due secoli: in Europa è appena cominciata l’epoca carolingia. A Baghdad, però, la politica si è già da tempo impossessata di queste delicate questioni teologiche e ha preso posizioni definite. Il nuovo paradigma dell’islam vive nel IX secolo il suo apice, ma anche la sua discesa.
6. LO STATO E LA TEOLOGIA
La teologia e la politica arrivano a convergere nella questione centrale della Mu’tazila: il monoteismo coerente. «Combattenti per l’unità e la giustizia di Dio», questo vogliono essere i mu’taziliti delle generazioni successive. Quello però che col tempo provoca le controversie più accese è la tesi mu’tazilita della natura creata del Corano, che ora – per ragioni ancora da chiarire – viene elevata addirittura a dogma di stato. A dire il vero, solo dopo una quarta guerra civile musulmana.
La quarta guerra civile e le sue conseguenze per la teologia
Chi l’avrebbe mai detto: la Mu’tazila, così a lungo distante dalle sfere alte, giunge al potere, e da teologia di opposizione diviene teologia di stato,61 grazie al già citato dissidio tra fratelli – con sottofondo teologico – nella casa di ’Abbās, tra i due figli di Hārūn ar-Rašīd, coetanei ma molto diversi tra loro:
– al-Amīn, figlio di una moglie legittima di sangue arabo, designato suo successore da Hārūn dopo lunghi tentennamenti, è legato alla cultura araba e alla tradizione religiosa; appena divenuto califfo (809), tenta di degradare il fratello al secondo posto della successione dopo il proprio figlio;
– al-Ma’mūn, suo fratellastro molto più intelligente, nato solo sei mesi più tardi da una concubina iraniana, diventa in pratica signore autonomo della metà orientale dell’impero, con sede imperiale a Merw (Khorasan); è aperto a nuovi indirizzi di pensiero e a influssi esterni e ha dalla sua parte le province orientali, l’élite iraniana e le truppe khorasaniche, quando nell’810 lo scontro diviene ineludibile.
Si giunge così all’estenuante quarta guerra civile musulmana, che infuria ferocemente per due anni e che i generali di Ma’mūn decidono a proprio favore nell’813, dopo una battaglia vittoriosa nella zona dell’attuale Teheran e dopo un lungo assedio di Baghdad con sanguinosi combattimenti nelle strade.
Ma’mūn, che per il momento rimane nella sicura Merw, proclama ora, richiamandosi alla prima «svolta» abbaside, una nuova «svolta» (dawla), che deve inaugurare una nuova epoca, e fa sostituire dovunque alle bandiere nere (degli Abbasidi) quelle verdi (del paradiso, ma anche degli Alidi). Ma’mùn vuole superare la divisione della società islamica in sunniti e sciiti: tra lo stupore di tutti, e lo sconcerto della sua famiglia, promette la successione a un alide (’Alī ar-Riḍā). Ma invece che a una riconciliazione tra le due famiglie rivali, questo porta in Baghdad alla scelta di un controcaliffo abbaside, lo zio di Ma’mūn Ibrāhīm ibn al-Mahdī. A questo punto Ma’mūn si dirige immediatamente alla volta di Baghdad: durante il viaggio un suo visir (fino a poco prima zoroastriano) viene assassinato da ufficiali della guardia del corpo, e anche il suo candidato alide al trono muore in circostanze non chiare, forse per avvelenamento; Ma’mūn trae comunque vantaggio dalla situazione, che gli permette nell’818 un accomodamento pacifico con la sua famiglia. Il colore nero abbaside ritorna ora a essere la sua bandiera.
Dopo il suo ingresso a Baghdad, il califfo si appella con fiducia al buonsenso di tutti i coinvolti, perché si ripristini la pace. Al-Ma’mūn, un sovrano avveduto e benedetto dal successo, per sua inclinazione più sciita che mu’tazilita, già a Merw si era rivelato un appassionato dei dibattiti religiosi e scientifici. Autore lui stesso di trattati, ora organizza nella capitale, ogni martedì sera, momenti conviviali con dibattito, dedicati soprattutto a questioni di teologia e di giurisprudenza. Vi partecipano venti studiosi scelti, che Ma’mūn chiama «fratelli»: teologi, ma anche grammatici, come i due figli dell’educatore mu’tazilita del giovane califfo.
Così i mu’taziliti, che in principio si adoperavano per una teologia molto vicina al popolo, dopo la guerra civile trovano accesso anche alla corte. Questa teologia fondata su rivelazione e ragione apparve infatti al califfo adatta per appoggiare la sua opera di riconciliazione e rinnovamento. Diversamente dal padre Hārūn, che verso la fine della sua vita aveva bandito i mu’taziliti dal palazzo, Ma’mūn, uomo dai vasti interessi e che si occupa anche di medicina e di scienze naturali, non prova alcuno scrupolo religioso: tra Aristotele (e il patrimonio culturale ellenistico in generale) e la rivelazione, così gli viene confermato in un sogno, non c’è conflitto! Ma quale sintesi è possibile? Questo è un lavoro intellettuale che la tavola rotonda del califfo non è in grado di compiere, neppure quei mutakallimūn che si trovano nella cerchia della corte e che non appartengono a nessuna scuola. Una sintesi la realizzano, in tutto silenzio, i citati grandi sistematizzatori mu’taziliti.
Un magistero islamico: al-Ma’mūn e la Mu’tazila
L’opposizione di gran parte della popolazione di Baghdad è però tenace. Che cosa vogliono tutti quei khorasani nella loro città, qual è lo scopo di questa incomprensibile teologia della ragione, di cui pure non avevano avuto bisogno né il Profeta, né i primi califfi ben guidati? Così reagisce la «gente della sunna» e si solleva contro il califfo, che vuole proclamare e imporre una dottrina che si pretende infallibile. Al-Ma’mūn perde la pazienza, e così il rinnovamento spirituale, iniziato a suo tempo con grandi speranze, assume poi, negli ultimi anni di vita del califfo, di nuovo una «svolta» repentina, e questa volta al peggio. Come nessun califfo prima di lui, al-Ma’mūn si presenta anche come maestro dei credenti, che cerca di regolamentare sovranamente con decreti la vita religiosa del popolo – e questo, come da formula introduttiva di tutti i decreti, «in nome di Dio, clemente e misericordioso»! Con le categorie occidentali si potrebbe qui parlare di «cesaropapismo»: politica e religione nelle mani di un sovrano assoluto, situazione che i citati teologi mu’taziliti evidenziano (in tutto simili, in questo, ai teologi bizantini) come ideale assoluto di califfo.
Ci si chiede come il califfo giunga a:
– proibire, nell’826, tramite un decreto, sotto minaccia di perdita dei diritti civili, qualsiasi lode all’omayyade Mu’āwiya;
– far proclamare, nell’827, ’Alī la persona migliore dopo Muḥammad, nonché la creazione del Corano (ḫalq al-Qur’ān);
– ordinare, nell’831, durante la campagna della guerra di religione antibizantina in Siria, che le truppe rimaste a Baghdad recitino un triplice Allahu akbar alla fine di ogni preghiera del venerdì;
– ordinare, nell’833, persino che si metta alla prova l’ortodossia della fede di tutti gli esperti di religione e giuristi autorevoli (soprattutto se funzionari statali) riguardo al «dogma» della creazione del Corano.
Nella critica odierna sembra delinearsi un consenso sui motivi religiosi e politici che si celano dietro a questi provvedimenti, e all’introduzione di novità che portarono l’impero di nuovo a una crisi pericolosa. Tutto sarebbe da ricondurre alla politica pro-alidica, filosciita del califfo, si diceva un tempo.62 Questo però mal si accorda con il dogma, così fortemente propugnato, della creazione del Corano, che difficilmente poteva essere gradito agli sciiti. Perciò oggi si sottolinea il fatto che il califfo, sostanzialmente distante dal popolo, legato solo all’intellighenzia irachena, con i suoi provvedimenti voleva difendere il «popolo bue» dagli studiosi popolari, ma pericolosi.63 Questa tesi diventa davvero chiara, in verità, solo a partire dal retroscena teologico: 64 gli esperti criticati dal califfo e la «gente della sunna» si appoggiano infatti a una visione di Dio tradizionale, assolutamente antropomorfa, mentre il califfo, con i mu’taziliti, ritiene di dover sostenere una visione di Dio «evoluta», che sottolinea la trascendenza.
Questo è, con tutta evidenza, il punto nevralgico della discussione: con la trascendenza, unità e unicità di Dio è congiunta, per i mu’taziliti, anche la verità della creazione del Corano. Perché questo? Perché, secondo la loro concezione, niente è simile a Dio. Ma ciò che non è simile a Dio, deve essere creato: dunque anche il Corano è creato!
Questo pensiero conosce diverse esplicitazioni teologiche. Abū l-Hudail, ad esempio, definisce il Corano (come già parola di creazione di Dio) come accidente che ha bisogno di sostanza: il Corano in quanto Parola di Dio esiste in un libro, nella memoria degli uomini o nella recitazione, anzi già prima, da qualche parte in cielo sulla «tavola ben custodita» – ma sempre e solo come accidente e quindi creato. Per an-Naẓẓām la Parola di Dio viene creata nell’istante della rivelazione, ed è espressa in gran parte in una lingua difficile da comprendere. Il Corano è retoricamente bello, ma non insuperabile. Tuttavia an-Naẓẓām prepara il successivo dogma dell’insuperabilità col fatto che egli, come primo teologo, assume coerentemente il Corano – non a partire dallo stile, ma dal contenuto – come prova per il profetare di Muḥammad.65 È così sorprendente che queste e simili argomentazioni per la creazione del Corano siano apparse al califfo chiare come la vera fede? Quella vera fede che deve essere difesa con ogni mezzo!
Controdomanda: l’Inquisizione («esame, prova») è nelle intenzioni del Profeta?
Tilman Nagel lo ha evidenziato in maniera più chiara di altri: con i suoi decreti Ma’mūn attacca soprattutto l’ingenuità religiosa del popolo e degli studiosi, che potrebbe portare a conseguenze politiche distruttive. Per questo il califfo chiarisce già nell’introduzione ai suoi decreti religiosi che egli ha davanti a Dio il compito di difendere la vera fede (dīn Allāh) e preservare l’eredità del Profeta – e precisamente contro «coloro che con falsa dialettica incitano alla loro dottrina e si definiscono sunniti»; costoro «annunciano apertamente di rappresentare la verità, la religione e la comunità (ğamā’a), e che tutti gli altri sostengono solo falsità, miscredenza e divisione. Con ciò essi si elevano al di sopra degli uomini e ingannano gli ignoranti...». Al contrario il califfo: «il sovrano dei credenti ritiene invece che essi siano i peggiori nella comunità, i capi dell’eresia, che quasi non hanno più parte alla professione di unità...».66
La questione ruota dunque intorno alla professione di unità (tawḥīd), che deve assolutamente essere mantenuta pura: «Chi non riconosce che il Corano è creato, non ha alcun tawḥīd», poiché «attribuisce a qualcosa che Dio ha creato e fatto quella caratteristica che compete solo a Dio (vale a dire l’essere eterno)».67 Anzi, Ma’mūn è fermamente deciso a impiegare anche gli strumenti di potere statale per questa vera fede e, seguendo motivazioni religiose come anche politiche, educare e controllare, nello spirito giusto e secondo precisi dogmi speculativi, i credenti antropomorfisti.
Così, questo maestro dei credenti dà vita a Baghdad (com’era già successo nella Bisanzio cristiana e come in seguito avverrà a Roma) a una vera e propria Inquisizione religioso-statale – per la prima volta nell’islam! Questa azione a tappeto effettuata sotto il comando del capo della polizia di Baghdad viene chiamata miḥna, «esame».68 Non tutta la burocrazia viene «inquisita», certo, ma tutti i giudici supremi, i qadi, ai quali spetta poi fare i successivi esami. Chi non supera la prova della professione di unità di Dio e creazione del Corano non viene più ammesso in tribunale come «testimone» (šāhid), espressione con cui non viene inteso, come nel diritto moderno, solo il testimone di un reato, ma anche la persona che garantisce per la correttezza del processo e per questo è strettissimo consigliere del qadi. Di più: l’esame ideologico dell’apparato di giustizia non ha luogo solo a Baghdad; nella sua autoritaria pretesa di obbedienza «infallibile», il califfo invia missive dello stesso tenore anche in altre province, anzi probabilmente in tutte. I capi più in vista dei sunniti vengono esaminati allo stesso modo: Ma’mūn addirittura chiama al controllo i sette principali esperti di ḥadīṯ di Baghdad appositamente nella sua residenza a Raqqa (nell’Alta Mesopotamia occidentale), e là non resta loro altro che condividere a denti stretti la visione del califfo. Altrimenti c’è forse la minaccia della tortura, persino della morte...
Nella prospettiva moderna, tutto ciò fa sorgere inevitabilmente domande critiche di chiarimento. Questa Inquisizione infatti non solo oscura l’immagine di un califfo straordinariamente aperto come Ma’mūn, ma pone anche una domanda molto più radicale: tutto questo corrisponde al Corano e alla sunna del Profeta? Il Profeta ha mai preteso o addirittura praticato l’Inquisizione tra i suoi fedeli? Ed è nelle intenzioni del Profeta che l’Inquisizione venga condotta richiamandosi a lui?
Potere ed esautorazione della Mu’tazila
Inaspettatamente, nel corso della sua campagna militare, il califfo alMa’ mùn muore nell’833 a Tarso, dopo aver regnato per vent’anni. Ancora nel suo testamento si parlava del «Corano creato». È dunque la fine degli «esami»? No: l’ottavo califfo abbaside, al-Mu’tasim (833-842), un terzo figlio minore di Hārūn, prosegue la stessa politica religiosa. A dire il vero, la sua principale preoccupazione è quella di creare a propria difesa una guardia del corpo a lui solo devota, traendola dagli schiavi di guerra turchi – una decisione densa di conseguenze, come vedremo. Sempre per motivi di sicurezza egli fonda, appena settant’anni dopo la fondazione di Baghdad, una nuova capitale a Samarra. Favorisce il riconoscimento generale della Mu’tazila, tuttavia senza lo spirito missionario teologico del fratello; gli interrogatori inquisitori vengono effettuati non da lui in persona, ma dagli esperti presenti.
Così il califfo fa esaminare una seconda volta anche Ibn Hanbal (che abbiamo già incontrato come fondatore della scuola di diritto hanbalita, ma che all’epoca non apparteneva ancora a quei sette grandi degli ḥadīṯ), benché fosse già stato arrestato e sottoposto a interrogatorio sotto Ma’mūn. Ibn Hanbal aveva iniziato lo studio degli ḥadīṯ a più di cinquant’anni, tuttavia aveva sostenuto fin dall’inizio una visione tradizionale di Dio secondo l’ḥadīṯ. Come gli altri esperti di ḥadīṯ, non aveva sostenuto che il Corano fosse «eterno», dato che questa asserzione non si trova affatto nella tradizione precedente; il Corano, questa era in passato l’opinione diffusa, non sarebbe «né creatore né creato», piuttosto «discorso o parola di Dio» (kalām Allāh).69 Ma’mūn era stato il primo a esasperare la controversia: se «non creato», allora logicamente «increato», «eterno». Sembra che Ibn Hanbal, messo alle strette, abbia mantenuto un basso profilo nel suo esame; avrebbe detto di non essere un teologo e di non volere interpretare la Parola di Dio.
Noi non sappiamo esattamente come sia davvero finito l’esame, dato che qui i resoconti divergono: alcuni sostengono che la punizione fu terribile, ma che Ibn Hanbal rimase saldo fino alla fine. Secondo altri, ricevette solo trenta leggeri colpi di frusta, ma alla fine ritrattò. In realtà è difficile ipotizzare che potesse essere rilasciato senza una confessione. Comunque sia, ora Ibn Hanbal vive in seguito del tutto appartato e indisturbato dall’autorità. Può fondare una scuola e sembra aver fatto il passo verso l’asserzione positiva – da «non creato» a «increato» o «eterno»; muore nell’855 a Baghdad. Per i sunniti però egli rimane ancora oggi il grande testimone che da solo oppone resistenza all’ingiusto stato laico. Un supertestimone per i tradizionisti, che nel frattempo sono diventati un movimento di massa.
L’Inquisizione ebbe andamenti molto diversi – dipendenti dalle autorità locali – nelle province, e le fonti, spesso scarse, per la Siria, la Mesopotamia, l’Egitto, lo Higàz, il Maghreb e l’Iran parlano più frequentemente di casi isolati: ad esempio, che alla Mecca il qadi fece esaminare tutti gli appartenenti all’antica aristocrazia indigena e ogni venerdì faceva proclamare a un devoto della «bandiera nera» abbaside, intorno al quartiere sacro, che il Corano era stato creato. O che a Kufa, di 120 testimoni di tribunale, 118 furono allontanati, mentre in Egitto alle grandi famiglie di giuristi fu risparmiata la «prova»... In nessun luogo i fedeli furono perseguitati indiscriminatamente: a seconda della situazione, però, giudici e teologi vennero rinchiusi, frustati o internati. Eppure i teologi, una categoria per lo più non coraggiosissima, si allinearono, a parte alcuni irriducibili. Essi tacquero o fuggirono, cercarono formule di compromesso, si piegarono senza proteste e per il resto attesero tempi migliori.
La repressione doveva durare dodici anni interi: in essa si sprecarono incalcolabili energie. Sotto il successore di Mu’tasim, al-Wāṯiq (842-847), il nono califfo abbaside, il controverso dogma coranico venne addirittura propagato nelle scuole elementari. Tuttavia avvengono ora i primi disordini, azioni sovversive e infine un vero e proprio tentato golpe che ottiene il sostegno della gente degli ḥadīṯ ma viene scoperto prima del tempo, cosicché i golpisti vengono portati a Samarra e il loro caporione decapitato.
Ancora sotto il decimo califfo, al-Mutawakkil (847-861), in un primo tempo la politica religiosa repressiva viene portata avanti. Quando, un anno dopo il suo avvento al potere, il potente Gran Qadi Ibn Abī Duwād, che dai tempi di al-Ma’mūn è considerato la forza trainante dell’«esame» o persecuzione,70 viene paralizzato da un ictus e perde quasi del tutto l’uso della parola, gli subentra inizialmente il figlio. Ma già un anno più tardi il califfo corregge il tiro: i tradizionisti ora possono predicare nelle moschee dottrine pubblicamente proibite. Questo porta rapidamente a un cambiamento di rotta: non si può portare avanti a lungo nessuna politica ostile al popolo sostenuto dai tradizionisti! L’Inquisizione viene fermata, il nuovo Gran Qadi deposto e inviato assieme al padre semi-paralizzato a Baghdad, dove muore nell’854, un mese prima di suo padre che era stato pubblicamente maledetto da un predicatore popolare. Gli adepti della sunna hanno vinto! Dopo due decenni di «prova» sotto Ma’mūn (813-833) e quindici anni sotto i suoi due successori (833-847), si giunge ora a una restaurazione. Il decimo califfo si mette completamente dalla parte dei tradizionisti e con ciò contro i Mu’taziliti e anche contro gli sciiti, come dimostra la distruzione della tomba di Ḥusayn a Kerbala. In seguito, però, il califfo viene assassinato dal proprio figlio.
Benché la «prova» sia chiaramente frutto dell’iniziativa personale di Ma’mūn, nella tradizione successiva il califfo stesso viene discolpato a spese del suo Gran Qadi, che probabilmente non era affatto un mu’tazilita. Anche la critica più recente, però, spesso attribuisce ancora la responsabilità maggiore delle persecuzioni alla Mu’tazila. Certo, questa continuò ancora a lungo ad avere sostenitori, ma il suo declino era già annunciato: prese a riposarsi sempre di più sugli allori del passato, in una sorta di tarda Scolastica, con argomentazioni sempre più sterili, un sistema sempre più inaridito, un divario sempre più profondo tra l’elite intellettuale, originariamente tesa al contatto con il popolo, e la gente comune. Nel X secolo, però, doveva sorgere dalle sue stesse fila un forte avversario della Mu’tazila.
Superamento della teologia della ragione nella teologia della tradizione: al-Aš‘arī
Quello che aš-Šāfi’ī fece per il diritto islamico, per la teologia l’ottenne un dotto a lungo sottovalutato, Abū 1-Hasan al-Aš’arī,71 nato nell’873-874 a Bassora, morto a Baghdad nel 935-936 – dieci anni prima del crollo del regno abbaside. Della vita di questo discendente del compagno del Profeta Abū Mūsā al-Aš’arī sappiamo poco: è l’allievo prediletto di al-Ǧubbā’ī, il capo della Mu’tazila a Bassora, forse anche un concorrente del brillante figlio di quest’ultimo, Abū Hàsim. Per ragioni esterne o interne che siano, Aš’arī diventa verso i quarant’anni un convertito – dalla Mu’tazila ai tradizionisti! In una fase successiva della sua vita si trasferisce a Baghdad.
Una svolta enigmatica. Che sia da spiegare con la leggenda secondo la quale Aš’arī avrebbe avuto nel mese del Ramadan tre sogni o visioni del profeta Muḥammad, che gli ordinava di aderire alla vera dottrina, ma nella terza visione lo esortava a non abbandonare per questo la teologia razionale? Questa storia della sua conversione, raccontata con le più disparate varianti, descrive in ogni caso con esattezza la posizione di Aš’arī tra la Mu’tazila e i tradizionisti: egli sostiene sì la teologia dei difensori della tradizione, ma con il metodo dei «moderni» dell’epoca. Questo significa per la sua teologia: l’argomento razionale tutto al servizio della dottrina ortodossa, il kalām tutto al servizio della sunna!
Riesce così ad Aš’arī ciò che non era riuscito prima di lui ad altri – tra i quali anche Muhasibi – di orientamento più mistico: unire la fede ingenua degli adepti della tradizione con l’argomentazione razionale e convincere così, a più lungo termine, la grande maggioranza dell’ortodossia tradizionistica. Per superare le resistenze degli hanbaliti al procedimento probatorio razionale, Aš’arī si richiama a numerosi ḥadīṯ in cui il Profeta in persona argomenta in maniera razionale, anzi, si richiama al Corano stesso, dove, ad esempio, per l’unicità di Dio si argomenta che due onnipotenti si sarebbero ostacolati a vicenda nella creazione del mondo.72 Aš‘arī concede ai tradizionisti che di per sé non ci sarebbe bisogno di una teologia razionale (essa è, anzi, proibita ancora nel XXI secolo in stati arabi conservatori come l’Arabia Saudita); ma, per via della religiosità in diminuzione fin dai tempi della prima comunità, essa sarebbe per così dire indispensabile come soluzione d’emergenza.
Quando Aš’arī, andando in direzione opposta alla Mu’tazila, pone alla base della sua teologia decisamente la rivelazione, cioè appunto il Corano e la tradizione ḥadīṯ, egli intende ribaltare completamente la Mu’tazila, anche se soltanto con i suoi discepoli tutti i suoi giudizi verranno collocati in un sistema chiuso e coerente. Si tratta non tanto, come spesso sostenuto, di una «pacificazione» di teologia razionale e tradizionale, quanto piuttosto della «risoluzione» della prima nella seconda. Al teologo cristiano, essa ricorda quasi il mutamento radicale dalla teologia moderna liberale alla teologia dialettica della rivelazione dopo la Prima guerra mondiale: nell’intera teologia di al-Aš’arī la questione più profonda, dopo la sua conversione, è quella di prendere sul serio in modo nuovo la travolgente realtà di Dio, da cui dipendono totalmente l’essere e l’agire umani. E che ripercussioni ha quest’impresa sui contenuti: per la comprensione di Dio, del Corano, della natura e dell’uomo?73
1. Per la comprensione di Dio questa nuova sintesi significa dapprima una vittoria della visione concreta coranica di Dio su quella astratta filosofica.
– La Mu’tazila suppone che Dio non abbia attributi differenti dal suo essere. Espressioni come «mano» o «volto» sono da intendere come «grazia» o «essenza». Poiché però l’essenza di Dio si manifesta nella creazione, dal suo agire in e con la sua creatura è possibile trarre delle conclusioni (benché in maniera prudente) sui suoi attributi, trarre quindi da ciò che è evidente conclusioni su ciò che è nascosto, anche se questo ci resta, in ultima analisi, nascosto. Infatti nemmeno al compimento dei tempi l’uomo può «vedere» in senso stretto Dio; questo degraderebbe appunto Dio a essere materiale e limitato.
– Aš’arī vuole un legame più forte con il testo della rivelazione e così una rivitalizzazione dell’immagine divina. L’essere unico di Dio si manifesterebbe in diversi attributi eterni come il sapere, la vista e la parola. Attraverso questi attributi Dio sarebbe sapiente, vedente, parlante. Questi concetti fondamentali racchiudono però anche i loro sinonimi: così, «sapere» comprende anche «conoscenza», «visione», «giudizio», «sentimento», così «parlante» racchiude anche «dicente». Bisognerebbe tuttavia opporsi a una completa assimilazione del creatore alle sue creature, nonché all’antropomorfismo ingenuo di molti credenti tradizionalisti: espressioni come «mano» o «volto» di Dio o anche «sedere sul trono» non intendono certamente nulla di corporeo-umano, e nonostante siano attributi reali non ne conosciamo la natura precisa. Viene usata cautela anche nel caso di quegli attributi che noi traiamo attraverso un processo di deduzione da ciò che è evidente a ciò che è nascosto, sulla base dell’analogia tra creatore e creatura: chi, in una determinata regione del mondo, conoscesse solo uomini di colore o chi presso un lago conoscesse solo acqua dolce, si guardi dal dedurre che esistano solo uomini di colore e solo acqua dolce. Noi percepiamo in ogni caso sempre solo minuscoli frammenti dell’opera e dell’essere divini. A fianco della sapienza, della visione e della parola di Dio esistono certo altri nomi divini completamente diversi, importanti per l’animo religioso: per esempio, «Colui che resta», «Colui che aiuta», «il magnanimo». Sono stati raccolti 99 nomi di Dio (cfr. cap. B II, 1):74 tutti questi attributi rendono vivace, vitale, edificante, nella sua totale pienezza di senso, l’immagine di Dio, altrimenti sbiadita, puramente razionale, sempre esposta al pericolo dello «svuotamento», così che si può davvero rivolgersi a Dio in preghiera. Solo in paradiso, l’uomo potrà finalmente vedere Dio: la visione di Dio diverrà realtà, benché non possiamo spiegare le modalità di questa visione.
2. Per la comprensione del Corano, la nuova integrazione delle teologie significa la vittoria della fede nell’eternità del Corano sulla sua storicità.
– Per la Mu’tazila è chiaro che il Corano può essere solo una realtà creata, parola creata di Dio. Il Corano stesso è il vero e proprio miracolo (non per lo stile, ma per il contenuto), e attesta così il compito del Profeta. Viene espresso scetticismo nei confronti dei miracoli, non quelli riportati nel Corano, ma di certo quelli riportati negli ḥadīṯ.
– Per al-Aš’arī, al contrario, il Corano non è Parola diversa nella sostanza da Dio, tanto meno gli altri nomi di Dio, la sapienza di Dio e la sua forza o anche la sua unicità. Piuttosto, il Corano è Parola di Dio e con ciò un attributo eterno di Dio, quindi increato. Chi invece coltiva speculazioni scientifico-filosofiche, nega l’eternità del Corano e dubita delle gesta miracolose del Profeta testimoniate nella tradizione, attacca l’essenza dell’islam.
3. Per la comprensione della natura e dell’uomo, questa «risoluzione» della teologia razionale nella teologia tradizionale significa una vittoria della metafisica sulla fisica.
– I mu’taziliti attribuiscono un grandissimo valore alla possibilità di scelta umana, alla sua libera decisione e così alla sua responsabilità morale. Nell’uomo, come nella natura al di fuori dell’uomo, la connessione tra causa ed effetto deve essere presa sul serio. Analisi della causalità nella natura possono aiutare a comprendere meglio l’operare di Dio e così anche le ricompense e le punizioni che aspettano l’uomo responsabile alla fine della sua vita. Coloro che si trovano in peccato mortale non sono tuttavia da considerare né come miscredenti né come credenti; è ancora possibile, in fondo, che si convertano prima della fine. Le diverse immagini escatologiche della fine del singolo uomo, i ponti e le bilance così come l’intercessione del Profeta, sono però da interpretare razionalmente.
– Al-Aš’arī, invece, dà peso al potere, anzi all’onnipotenza di Dio: ogni cosa, che sia bene o male, è voluta da Dio. Già nell’ambito della creazione extraumana, Aš’arī rifiuta la dottrina delle «nature» delle cose create e della connessione causale. Piuttosto, ogni «cosa» è legata direttamente a Dio, qualsiasi agire è causato direttamente da Dio. Tutti gli eventi sono azioni di Dio, nascono dal suo volere, dalla sua scelta, dalla sua pressione e dal suo condizionamento. Anzi, Dio crea nell’uomo la capacità di realizzare ogni singola azione. Al-Aš’arī tenta di dimostrare, sulla base del Corano, che Dio può volere la peccaminosità e la stoltezza senza essere egli stesso peccaminoso e stolto. Sulla responsabilità dell’uomo in questo si dà meno pensieri; la dottrina dell’«acquisizione» da parte dell’uomo delle azioni in realtà compiute da Dio viene probabilmente sviluppata per la prima volta nella sua scuola, in ogni caso si è imposta la visione secondo cui anche questo «acquisire» deve essere causato da Dio in tutti i suoi aspetti. Per quel che riguarda i peccatori mortali, costoro rimangono comunque credenti, ma sono destinati alla punizione col fuoco. Le visioni escatologiche sono cioè da prendere sul serio, in particolare l’intercessione del Profeta, anche se essa non è riportata in nessun passo del Corano.
La scuola di Aš‘arī, la Aš’arīya, trionfò alla fine nel grande conflitto tra teologi tradizionali e razionali. Venne in questo modo attuata una forma razionale-tradizionale della teologia sunnita. Ciò che un secolo prima aveva compiuto Šā’fi’ī nel diritto islamico, ha compiuto ora Aš‘arī nella teologia: l’immobilizzazione sul principio tradizionalistico! Al-Ġazzālī doveva in seguito sviluppare ulteriormente questa teologia e farne la corrente scolastica dogmatica principale nell’islam sunnita, le cui dottrine hanno resistito fino ad oggi.
7. LA DISINTEGRAZIONE DELL’IMPERO
Nessuno, ai tempi dello splendore di Hārūn ar-Rašīd, avrebbe pensato che si sarebbe potuti giungere, solo pochi decenni più tardi, a una rovina quasi totale della potenza e del prestigio del califfato abbaside. Eppure non sono colpi inferti dall’esterno, con l’invasione di nuovi popoli nomadi, che mandano in frantumi nel IX-X secolo l’impero universale mediorientale (come accade nello stesso periodo, in maniera simile, al regno dei franchi), bensì la disintegrazione interna delle sue istituzioni portanti.
La crisi delle istituzioni
La crisi che si va delineando riguarda tutti e tre i fattori di potere del regno abbaside: il califfo stesso, le sue armate e la sua burocrazia. La crisi del califfato e le contraddizioni interne alla società dovevano assumere le dimensioni di una crisi dell’islam, in fondo alla quale sta la sua regionalizzazione, la scissione dell’unico, grande regno islamico in diversi regni parziali regionali, il che avrà come conseguenza un nuovo paradigma dell’islam.75
Fattore di potere 1: il califfo. Il califfo da solo non è più in grado di sovraintendere, dirigere e controllare una burocrazia sempre più numerosa e altamente complessa. La carica di wazīr avrebbe dovuto portare un alleggerimento nell’amministrazione ma questo incarico centrale, concepito inizialmente come semplice assistenza, sviluppa nel corso del tempo la sua propria dinamica e il wazīr diventa una sorta di primo ministro; egli dispone anzi per lo più di un vantaggio informativo e di una maggiore vicinanza agli organi sottoposti. Non c’è da meravigliarsi se sempre più incombenze vengano sbrigate dal wazīr, per motivi di semplificazione, senza consultare il califfo, e se sempre meno impiegati e postulanti giungono ad avere a che fare personalmente con quest’ultimo. Già questo diminuisce la lealtà delle élite verso il califfo, che pure fino ad ora era la forza unificante di questo regno. Una simile situazione poteva difficilmente funzionare a lungo in un impero che era divenuto immensamente diversificato e stratificato, composto di soldati arabi o khorasani, di proprietari terrieri iracheni, iraniani e egiziani, di commercianti ebrei, di scribi nestoriani e di generali centroasiatici. L’aspirazione teocratica degli Abbasidi diventa pura ideologia.
Eppure alcuni califfi sono assolutamente grati se li si solleva di molte preoccupazioni pressanti dell’impegno quotidiano di governo. Già sotto Hārūn ar-Rašīd, il wazīr ha assunto così tanti incarichi che il califfo, agli occhi di parecchi, sembra condurre la vita di un fannullone. In effetti ora ha più tempo per attività più piacevoli e divertimenti sempre più raffinati. In questo modo però il califfo diventa una figura piena di mistero, nascosta come dietro a una tenda, il che tuttavia non gli impedisce di destituire in qualunque momento il suo wazīr, se gli viene a noia. Questo accade sempre più spesso, tanto che, considerato nell’insieme, il periodo di carica dei wazīr cala mentre cresce il numero di wazīr che si succedono l’uno all’altro. Anche gli intrighi di corte non diminuiscono, e alla mentalità del servizio disinteressato per lo stato si sostituisce sempre più quella dell’arricchimento spudorato. La stabilità del governo viene scossa.
Fattore di potere 2: l’esercito. Anche agli Abbasidi non viene risparmiato il vecchio adagio: l’esercito costa. E poiché le regioni di confine nell’Asia centrale e nella valle dell’Indo non sono sicure, si rendono necessari continuamente nuovi interventi militari, tanto più che le guerre condizionate dall’ideologia, contro la Bisanzio cristiana, continuano anche con i successori di Hārūn. Tutto questo aumenta continuamente i compiti dell’esercito. Ma la decisione che si rivela fatale è quella di assumere sempre più in servizio, in considerazione del degrado dell’organizzazione militare araba, truppe formate da schiavi di guerra provenienti dalle regioni di confine (turchi, slavi). A differenza dei mercenari, questi schiavi di guerra possono, da liberti, elevarsi ai ranghi di ufficiali, generali e governatori, mentre i berberi sono equiparati nell’esercito fin dall’inizio agli arabi liberi. Già durante la guerra tra fratelli, al-Mu’taṣim, in seguito successore del califfo al-Ma’mūn (833-842), si circonda di una guardia del corpo composta da turchi! E in seguito verranno assunti nell’esercito così tanti schiavi militari turchi, che se ne potranno costituire interi reggimenti turchi. Essi hanno a disposizione propri acquartieramenti, moschee, mercati, comandanti che li addestrano, vettovagliano e pagano: si tratta di unità militari che si sentono più in obbligo nei confronti del loro comandante (spesso appartenente alla nobiltà turca) che al califfo! Un’innovazione fatale nella storia militare del Vicino Oriente, che alla lunga rende i califfi dipendenti dai propri stessi reggimenti di schiavi e dai loro generali!
Un segnale d’allarme avrebbe potuto esserci: quelli che fino ad allora erano i «pretoriani», i Khorasani, tramano una congiura; questa fallisce, e si viene alla rottura con il califfo. Da quel momento in poi i reggimenti turchi allontanano il califfo dal popolo, che li osteggia, spesso rivaleggiano e litigano tra di loro. Per isolarli dalla popolazione, che si ribella piuttosto spesso, e per provvedere alla propria sicurezza, il califfo al-Mu’taṣim fonda nell’836 una seconda residenza imperiale: Samarra, 125 chilometri a nord di Baghdad. Il distacco del califfato dal popolo non si sarebbe potuto palesare in maniera più chiara. Samarra funge fino all’870 da centro militare e amministrativo del califfato, con a fianco dell’accampamento un proprio quartiere turco; Baghdad è tuttavia sopravvissuta al temporaneo trasloco di corte e funzionari. Eppure ora le fila dei mercenari si ingrossano sempre di più, sempre più ufficiali turchi riescono a raggiungere importanti posizioni di comando, anzi, nella seconda metà del IX secolo diventano addirittura governatori della Siria e dell’Egitto dove cominciano, di fatto, a costruire dinastie di governo indipendenti (i Tulunidi in Egitto, gli Ihsididi in Egitto e Siria), che allargano il loro influsso anche alla Palestina.
Già due generali turchi siedono nella commissione che designa il califfo al-Mutawakkil (847-861). E allorché questi, con il reclutamento di mercenari arabi e persiani e piani di trasferimento della capitale a Damasco, tenta di sottrarsi all’influsso turco, alcuni generali turchi organizzano una congiura, uccidendo il califfo senza tante cerimonie, cogliendo l’occasione per un massacro. Probabilmente viene assassinato anche suo figlio e successore al-Muntaṣir (861-862), che era al corrente del delitto e muore poco dopo. Che svolta tragica: i primi Abbasidi erano indipendenti dal sostegno militare dei propri sudditi, gli ultimi invece sono dipendenti da truppe straniere, con cui devono tenere sotto controllo la loro stessa popolazione. Sì, il califfato abbaside è divenuto sempre più un fantoccio nelle mani degli schiavi di guerra turchi.
Fattore di potere 3: finanza e burocrazia. Le spese militari elevate portano allo sfascio totale della finanza statale. Il soldato, infatti, percepisce tre volte il salario di un lavoratore artigiano, e un soldato di cavalleria ancora di più. A ciò si aggiungono i costi per armi, vestiario, soggiorno. Quanti più schiavi di guerra vengono impiegati, tanto maggiori sono le spese dello stato. Si rende necessaria la feudalizzazione della riscossione delle tasse per la retribuzione dell’esercito, cosa che accelera lo sfascio delle finanze statali, soprattutto dopo che era stata abbandonata la divisione, dimostratasi efficace, tra amministrazione finanziaria e amministrazione militare. Poiché però, per un altro verso, le province si fanno sempre più indipendenti e in questo modo gli introiti dell’ufficio centrale calano, le finanze del califfato diventano sempre più scarse. Ne seguono proteste e rivolte tra gli schiavi di guerra, se gli stipendi possono essere pagati solo a fatica e spesso solo in ritardo. Al califfo non resta altro che assegnare ai soldati, invece di denaro contante, terre in proprietà dai domini statali. Così alti ufficiali diventano rapidamente grandi proprietari terrieri a spese dello stato. Anzi, alcuni proprietari terrieri privati collocano la propria terra, dietro pagamento, sotto la «protezione» di un capo militare, per essere armato contro alte tassazioni e soprusi.
L’aumento di potere dell’esercito va a braccetto con la corruzione della burocrazia. Questa lavora sempre meno al servizio del califfo e dell’impero e sempre più per gli interessi personali e partigiani di accolite e fazioni in lotta tra di loro. E ciò che vale per il wazīr, vale anche per il suo seguito: la parola d’ordine non è più servire lo stato, ma arricchirsi. Dato che il wazīr stesso è giunto al potere tramite corruzione del califfo e degli alti funzionari di corte, trova giusto recuperare grazie al suo incarico i suoi grandi «investimenti» (e molto di più ancora). Si tratta tuttavia, a tutti i livelli, non solamente di concussione individuale, ma di un sistema di corruzione istituzionalizzato in molteplici modi. Comincia già col fatto che un giovane scriba deve essere ingaggiato per il suo tirocinio nella casa di un futuro protettore, verso il quale poi si deve sentire in obbligo per tutta la vita.
La fine dell’impero mondiale
Ai cambiamenti distruttivi nel califfato del suo apparato amministrativo e del suo esercito, al dissanguamento fiscale e alla destabilizzazione politica si aggiunge una recessione economica impensabile, in un primo momento, in quel regno in passato così prospero. Infatti per più di un secolo i califfi di Baghdad, assorbiti da altri interessi, hanno trascurato gli investimenti nei sistemi di irrigazione e in progetti di acquisizione di terre, hanno fatto inaridire e spopolato interi territori rurali sul Tigri con continue guerre e hanno compromesso anche alcune vie internazionali di commercio. Dunque, nel IX-X secolo, l’economia soprattutto dell’Iraq appare in larga misura in rovina. Questo agiatissimo paese del Vicino Oriente diventa una delle regioni più povere, rimanendolo fino al XX secolo. Anche l’Egitto subisce una simile decadenza economica, l’Iran invece no.
La crisi economica accentua naturalmente quella politica, e il grande impero abbaside ben presto va in frantumi – in sostanza, già da tre secoli esatti prima dell’assalto mongolo che tutto distruggerà, quando nel 1258 Baghdad viene conquistata e la dinastia decade definitivamente con l’ultimo califfo. Infatti, dal 945 non esiste più di fatto nessun impero mondiale. In questo anno i Buyidi iraniani, una dinastia originaria dalla costa meridionale del Mar Caspio convertita solo tardi all’islam di impronta sciita, ha finalmente conquistato, dopo la presa dell’Iran centrale e occidentale, anche l’Iraq conteso tra turchi e arabi, e infine anche Baghdad. Certo, i Buyidi lasciano in vita pro forma il califfato a sostegno della loro politica estera contro i potenti Samanidi, nell’Iran orientale, e i Fatimidi che si stanno fortemente insediando in Egitto: ma «salvando» il califfo ne fanno il loro strumento politico. I veri sovrani sono ora i «grandi emiri» («Maestri di palazzo»), che trattano i califfi come marionette (come, poco prima, nel regno dei franchi i Pipinidi trattavano i re merovingi). Tuttavia i Buyidi ebbero un ruolo decisivo solo per un paio di decenni; la loro politica, orientata sulla società agraria iranica, non è in grado di risolvere i problemi delle città in forte crescita e di superare le tensioni sociali, accompagnate da ribellioni di schiavi africani. Li seguiranno i Selgiuchidi.
Per l’analisi dei paradigmi dobbiamo qui trarre il seguente bilancio: il paradigma di religione universale affermatosi con la rivoluzione abbaside (P III) è giunto alla sua fine politica a causa della crisi del califfato, dell’esercito, della burocrazia e dell’economia; Baghdad rimane sì, ancora, la sede dei califfi, ma i califfi non sono più i signori dell’impero. Le forze centrifughe nelle province si dimostrano più forti e conducono infine a una molteplicità di principati regionali. Tuttavia, il paradigma allora regnante mantiene per molti musulmani dei secoli venturi ancora molto del suo splendore e della sua forza di irradiazione.
Il paradigma classico di religione universale come immagine di speranza: il panislamismo
Anche il paradigma islamico classico di una religione universale dimostrò una capacità di resistenza e di sopravvivenza notevole: nonostante le sfavorevoli condizioni politiche è divenuto possibile, grazie alla libera concorrenza delle forze spirituali nel X secolo nei confronti della «classicità» del primo periodo di splendore abbaside, una sorta di «Rinascimento» spirituale. Ancora per secoli il califfo rimane, benché quasi privo di potere politico, il simbolo dell’unità musulmana. Ancora per secoli si idealizza la grandiosa cultura dell’epoca «da Mille e una notte». Ancora per secoli si rimpiange, nella letteratura islamica, lo splendore senza precedenti di Baghdad, centro spirituale di tutto il mondo allora conosciuto, come in precedenza la Roma precristiana e molto più tardi la Roma papale. Ci fu in gioco molta stilizzazione letteraria, di certo, ma tre fattori sono di valore duraturo: la teologia islamica allora sviluppata, il diritto islamico all’epoca completamente formato, la cultura islamica cosmopolita di cui si erano poste allora le basi. È stato questo paradigma che – pur con tutti i suoi lati oscuri – ha tenuto assieme una società multiculturale per eccellenza, per molti aspetti più tollerante della cristianità latina o bizantina contemporanee anche nei confronti dei credenti di fedi diverse.
Quanto è stato detto già all’inizio dell’analisi di questo paradigma può qui, alla sua fine, essere confermato: l’essenza dell’islam – l’unico Dio e Muḥammad suo profeta – venne in quest’epoca non solo mantenuta, ma, per un certo verso, accentuata, nonostante tutte le guerre, i dissidi religiosi e i crimini, usuali in tutte le religioni. Come mai prima di allora ci si sforzò di descrivere questa essenza basandosi sulla ragione e di difenderla nei confronti delle due altre religioni profetiche. In quest’epoca l’islam è divenuto una religione profondamente caratterizzata dalla riflessione, persino per coloro che tendevano più verso la tradizione. E nonostante l’inclusione di ambiti culturali sempre più grandi, il singolo musulmano è rimasto consapevole, forse ancor più di prima, dell’essenza del suo credo.
E così non c’è da meravigliarsi del fatto che molti musulmani proprio nell’età moderna, quando l’islam andò in pezzi e al tempo stesso finì sempre più sulla difensiva economicamente, militarmente e culturalmente nei confronti dell’Europa «cristiana», ricordassero quei tempi gloriosi del paradigma classico-islamico di religione mondiale, quando ancora tutti i popoli musulmani erano uniti sotto l’unico califfo nell’unico grande regno, basato sui valori fondamentali islamici. Non doveva essere possibile ridare vita all’unità della umma islamica? Così si chiedono a partire dal XIX secolo molti esperti di religione in atenei e moschee sulla base del loro «sapere» islamico. Così si chiedono però anche molti intellettuali presenti sulla scena pubblica, sulla base del pensiero scientifico europeo di cui si sono appropriati. Così si chiedono, infine, persino alcuni ordini neo-sufiti sulla base della loro esperienza di un «vero Islam».
Da ciò nascerà, all’apice della modernità europea (P V), nel XIX secolo, il movimento del così (anche) detto panislamismo, che si differenzia fondamentalmente dal panarabismo di cui abbiamo già parlato (P III; cfr. cap. D II, 1). Il fine del panislamismo è riunire non solo i popoli arabi, ma i tutti i popoli islamici, magari di nuovo sotto un califfo, nonché ripristinare uno stato islamico o addirittura un mondo islamico unitario. Su questa base, si spera di poter fronteggiare in maniera efficace la superiorità economico-politica e l’espansione coloniale delle potenze europee, dal Nordafrica all’Indonesia.
Ci dovremo occupare ancora delle idee e concezioni dei capi di questo movimento, come Gamal ad-din al-Afġānī, e poi anche Abdallāh as-Suhrazardi, che diede vita alla conferenza panislamica alla Mecca. Anche il sultano spodestato nel 1908 dai Giovani Turchi aveva tentato, in precedenza, di conquistare ancora una volta, con l’aiuto di una visione panislamica, il consenso di tutti i musulmani alla sua aspirazione di comando come califfo. Fatica inutile. Ci si dovrà però chiedere se il nazionalismo (arabo) emerso poi in Turchia e in molti paesi musulmani, un tipico prodotto dell’epoca moderna europea, sia in grado di dare la soluzione ai problemi fondamentali dell’islam.
Vedremo. In ogni caso, il panislamismo nel XX secolo doveva realizzarsi soltanto ancora nell’ambito di stati nazionali indipendenti, per i quali si adoperarono tanto la fratellanza musulmana in Egitto quanto i seguaci di Muḥammad Iqbal in India, uno scopo che sembrò concretizzarsi con la fondazione, nel 1947, del Pakistan interamente musulmano. Ma all’ambìto blocco di tutti gli stati islamici non si è ancora giunti, anche dopo mezzo secolo – nonostante il congresso mondiale islamico costituito nel 1949 a Karachi (MAI), nonostante il congresso generale islamico istituito nel 1953 a Gerusalemme (MIAQ) e nonostante la lega mondiale islamica fondata nel 1962 dall’Arabia Saudita (RAI). Tenuto conto proprio di questa frammentazione e delle concorrenza delle organizzazioni tra di loro, tuttavia, la fascinazione di un’unificazione panislamica degli stati nazionali musulmani non è completamente estinta e può in ogni momento venire di nuovo strumentalizzata politicamente.
Che l’islam, dopo la caduta del califfato, non disponesse più, come al tempo del Profeta o dei califfi ben guidati (P I), degli Omayyadi (P II) e degli Abbasidi (P III) di un governo monarchico efficiente, contribuì in maniera decisiva alla sua crisi a partire dal IX secolo. Il nuovo modello di regime di quest’epoca, divenuto in seguito necessario, è la ragione esterna per cui ora ci dobbiamo dedicare al nuovo paradigma (P IV).
IV. Il paradigma degli ulama e dei sufi
In tutti i paradigmi precedenti, la storia dell’islam si poteva descrivere a partire da un epicentro degli eventi storici, che fosse La Mecca /Medina e l’Arabia, Damasco e la Siria oppure invece Baghdad con Mesopotamia/Iran. Questo ora non è più possibile, perché si entra in un periodo storico piuttosto intricato, che non si può più apprezzare sotto un’unica angolatura centrale: è paragonabile al tardo medioevo in Europa, quando l’impero universale cesaropapista va in frantumi e gli subentrano gli stati nazionali. E come nel cristianesimo del XV secolo ci saranno tre papi contemporaneamente, così nell’islam già nel X secolo ci sono tre califfi rivali: a Baghdad, al Cairo e a Cordova. Una scissione dell’umma islamica, dunque – diversamente da come pensano molti musulmani – già molto tempo prima delle crociate, causata non da forze nemiche esterne, ma dall’interno. Tutti chiari indizi di un cambiamento di paradigma epocale. Non possiamo qui approfondire i numerosi sviluppi singoli e i rapporti complicati, fluttuanti. Potrebbe però essere utile dare, all’inizio di questo capitolo, una panoramica sintetica sui rapporti tra dinastia (cfr. tavola), prima di descrivere più in dettaglio alcuni sviluppi più significativi e passare all’analisi sistematica del nuovo paradigma.
1. DOPO L’IMPERO UNICO, I MOLTI STATI
All’unico impero dotato di un governo centrale subentra ora un’accentuata regionalizzazione. Le forze centrifughe, che erano divenute sempre più forti già sotto gli Abbasidi e avevano portato all’autonomia di fatto di intere parti del regno (Spagna, Marocco, Algeria, Egitto, Khorasan, Transoxania...), si sono imposte anche nelle regioni centrali. Sorgono stati di dimensioni minori – all’inizio senza governo centrale ed élite burocratiche. Piccole unità sotto la sovranità di diversi grandi proprietari terrieri e capi militari spesso anti-centralisti, il cui potere poggia esclusivamente su truppe mercenarie. Questo vale per l’Oriente come per l’Occidente, come risulta chiaro da una breve panoramica. Solo col tempo nasceranno altri grandi regni, nessuno dei quali però vanterà mai di nuovo un’estensione panislamica. Guardiamo prima a Oriente, e poi a Occidente!
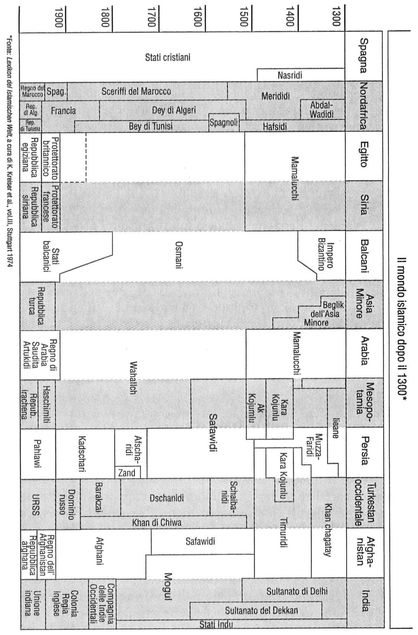
Regionalizzazione a Oriente e a Occidente
A Oriente succedono agli Abbasidi:
– la «dinastia dei Maestri di palazzo» dei Buyidi sciiti, come abbiamo visto, in Iraq e nell’Iran occidentale, che esercitano per 110 anni esatti la supremazia e il protettorato sui califfi abbasidi (945-1055);
– i Samanidi nell’Iraq orientale e nella Transoxania (al di là dell’Oxus o Amudarja) con lo splendido centro culturale di Bukhara (fino al 999);
– i Ghaznavidi di origine turca nel Khorasan (nella regione nordorientale dell’Iran) con al centro Ghazna nell’Afghanistan, che conducono una politica pro-sunnita e compiono campagne militari verso l’India (fino al 1040).
Ma a partire dall’XI secolo, dopo la disintegrazione interna, si frantumano anche le frontiere tra zone civilizzate e regioni nomadi, e i popoli turchi nomadi cominciano a infiltrarsi nella regione. Sconvolgimenti sociali e riassetto politico sono la conseguenza. Si formano uno dopo l’altro regni di popoli nomadi: