2. David Hume

Thomas Gainsborough, Ritratto della signora Graham, 1775, Edimburgo, National Gallery of Scotland
2.1 Il metodo sperimentale applicato alla filosofia
La filosofia di David Hume segna profondamente la cultura europea del Settecento per il tentativo di costruire una scienza dell’uomo che, muovendo dalle premesse teoriche poste dalla filosofia induttivo-sperimentale di matrice newtoniana, si estende alla comprensione della mente umana e delle sue molteplici azioni morali, sociali, estetiche e storiche. Il sottotitolo della sua opera più celebre, il Trattato sulla natura umana, recita infatti così: Un tentativo di introdurre il metodo sperimentale di ragionamento negli argomenti morali. A Hume interessa riconoscere prioritariamente il legame che le scienze in generale hanno con la natura umana, anche quelle ritenute oggettive come la matematica e la filosofia naturale. Occorre sempre partire dal principio, già ribadito da John Locke, che i progressi nella scienza dell’uomo sono ammissibili solo a condizione che si conoscano la portata e i limiti dell’intelletto e si indaghi sulla natura delle idee e delle operazioni mentali su cui esse si basano. Questa indagine sulla natura, di carattere psicologico ed epistemologico, fa di Hume uno dei grandi teorici ispiratori delle scienze umane e sociali come si configureranno nell’Ottocento e Novecento.
LETTURE
Isaac Newton
Diplomatico e filosofo: vita di Hume
David Hume nasce il 26 aprile del 1711 a Edimburgo, dove muore il 25 agosto 1776. Trascorre la giovinezza nella residenza di famiglia a Ninewells (Berwickshire). Secondogenito di una famiglia di piccola nobiltà, non ha diritto a ereditare né titolo né patrimonio, ed è quindi costretto a cercarsi una professione. Esclusa la carriera ecclesiastica e quella militare, intraprende studi di diritto. Dopo una breve esperienza lavorativa presso un mercante, lascia Edimburgo per recarsi in Francia nel collegio di La Flèche, dove aveva studiato Descartes. Entra così in contatto con la cultura europea e ha l’opportunità di conoscere i testi di autori francesi come Nicolas Malebranche, René Descartes, Pierre Nicole e Antoine Arnauld.

David Martin, Ritratto di David Hume, 1770, Collezione privata
Al ritorno in Gran Bretagna, pubblica il Trattato sulla natura umana (i primi due libri nel 1739, il terzo nel 1740). Hume non ha ancora trent’anni, è desideroso di fama e successo ed è convinto di aver scritto un capolavoro, ma il libro non suscita pressoché alcuna reazione. La delusione non frena lo slancio del giovane Hume che da quel momento si impegna a trasformare il suo ponderoso trattato in una serie di pubblicazioni snelle e più comprensibili non solo al tradizionale pubblico maschile ma anche a quello femminile, diventato consumatore attento anche di libri a soggetto, in senso lato, filosofico. Nel 1741 e nel 1742 Hume pubblica due volumi di saggi, Saggi morali e politici, che ottengono immediato successo. Nel 1745 tenta la carriera accademica candidandosi alla cattedra di Filosofia morale all’università di Edimburgo che però gli viene negata a motivo delle sue idee antireligiose. Lo scacco subito spinge Hume ad accettare un posto come tutore del marchese di Annandale e, nel 1746, come segretario del generale James St Clair.
Negli anni successivi Hume accresce costantemente la sua produzione filosofica. Nel 1748 compaiono i Saggi filosofici sull’intelletto umano (ribattezzati Ricerca sull’intelletto umano nel 1758). Seguono nel 1751 la Ricerca sui principi della morale e nel 1752 i Discorsi politici. Nel 1753 esce la prima edizione collettanea dei suoi Saggi e trattati e nel 1754 il primo dei sei volumi della Storia d’Inghilterra, che lo renderanno famoso in Gran Bretagna e in Europa. Il successo editoriale avanza di pari passo con le molte controversie filosofiche e religiose sorte nelle cerchie dei letterati e delle gerarchie ecclesiastiche: in particolare a causa delle considerazioni contenute nel saggio su I miracoli, e dei suoi ripetuti attacchi alla Chiesa cattolica e alla superstizione nel primo volume della Storia. La sua fortuna economica migliora quando viene chiamato nella sua città come bibliotecario presso la facoltà degli avvocati, incarico che gli consente l’accesso a una straordinaria biblioteca. All’età di quarant’anni, ormai ricco e famoso, incarna la figura dell’uomo di lettere che vive del proprio mestiere di scrittore.
Alla fine degli anni Cinquanta, Hume si trasferisce a Londra, capitale editoriale e culturale della Gran Bretagna. Al seguito di Lord Hertford compie un viaggio a Parigi, centro dell’élite filosofica e scientifica del Settecento europeo. Qui incontra, oltre ai philosophesDenis Diderot e Jean-Baptiste Le Rond d’Alembert, anche Jean-Jacques Rousseau, il quale da amico sincero si trasforma ben presto in suo fiero oppositore: nel tentativo di sopperire alle sue difficoltà economiche, Hume gli offre asilo in Inghilterra, ma a causa del carattere ombroso di Rousseau il rapporto si incrina e si conclude con uno scambio di pubbliche accuse.
Dal 1767 al 1768 Hume ricopre l’incarico di sottosegretario di Stato al Dipartimento del Nord nel governo di William Pitt, e per il resto della vita sarà costantemente impegnato nella cura delle edizioni delle sue opere.
LETTURE
René Descartes
LETTURE
Denis Diderot
LETTURE
Malebranche e l'occasionalismo
LETTURE
jean-Jacques Rousseau
Mente e conoscenza
La scienza dell’uomo è la base di tutte le altre scienze; essa si fonda sull’esperienza e l’osservazione, secondo il modello newtoniano, cui Hume dichiara di ispirarsi nella costruzione della sua “nuova scena del pensiero”. La mente è ritratta come una collezione di percezioni, una sorta di teatro, dove le diverse percezioni compaiono in successione. Aderendo, nella scia di Locke, alla teoria dell’associazione delle idee, Hume ne modifica profondamente gli effetti. Le percezioni si articolano inimpressioni e idee, che differiscono per l’intensità con cui si presentano. Ad apparire per prime alla mente sono le impressioni, ovvero le sensazioni, le passioni, le emozioni e le immagini, mentre le idee sono le copie illanguidite delle impressioni. Memoria e immaginazione operano per rappresentarci le idee e richiamarle alla mente o nella forma primigenia o in una forma modificata. Le proprietà che danno origine all’unione fra le idee in modo tale che da una si generi un’altra, sono la rassomiglianza, la contiguità nel tempo e nello spazio, la causa e l’effetto. Quest’ultima è la più estensiva perché coinvolge la maggior parte delle relazioni umane e sociali, si estende sia nel passato sia nel futuro, inglobando ciò che è direttamente presente al senso e alla memoria. Compito del filosofo è primariamente quello di esaminare gli effetti più che ricercare le cause.
ESERCIZIO
E3: Hume
TESTO
T2: David Hume, Impressioni e idee
ESERCIZIO
E5: Hume
Critica al concetto di “causa”
La forza dell’associazione e la ripetizione delle osservazioni inducono gli uomini a ritenere sostanziale il legame fra i fenomeni percepiti e conseguentemente a credere che sia possibile stabilire una deduzione logica l’uno dall’altro. In questo modo di rappresentarci i fenomeni Hume introduce i concetti di inferenza e di probabilità. Non abbiamo nessuna prova certa che la serie degli eventi osservati si ripeterà nella stessa modalità di oggi anche nel futuro, ma per un principio di economia gli uomini tendono a inferire per il futuro accadimenti simili da eventi simili. Siamo convinti che le questioni di fatto si adeguino alle questioni di ragione, proprie delle scienze matematico-geometriche. La connessione, però, fra due o più eventi è opera della mente umana e non una proprietà intrinseca alle cose. L’evento x che nella nostra esperienza precede l’evento y non può essere indicato come la sua causa; esso appartiene a una combinazione attestabile tramite l’esperienza ma non affermabile a priori.
Elementi extrarazionali, come l’abitudine e la credenza, sono considerati da Hume determinanti ai fini dell’orientamento gnoseologico della specie umana nel mondo, ma non scientificamente fondanti i principi del sapere. La credenza è determinante nella fondazione dell’esistenza di corpi esterni e dell’identità personale, che viene paragonata a “un fascio o collezione di percezioni differenti, unite da certe relazioni, e che si suppongono, sebbene erroneamente, dotate di una perfetta semplicità e identità” (Trattato I, IV, 2).

David Hume, “Essays, Moral and Political”. Frontespizio della terza edizione. Londra, 1748, Dunedin (Nuova Zelanda), University of Otago
Tali prese di posizioni aprono la discussione sull’interpretazione della natura dello scetticismo di Hume (moderato o radicale, ovvero “pirroniano”), da intendersi quale unico strumento principe dei meccanismi mentali sottesi alla sostanzializzazione del mondo interno ed esterno dell’uomo e delle conseguenti forme di validazione, oppure, in alternativa, quale metodica rigorosa per mantenere entro legittimi confini scientifici l’argomentazione probabilistica nei vari ambiti della ricerca umana.
2.2 Passioni e morale: la natura degli affetti
Il secondo libro del Trattato è dedicato alle passioni, la cui analisi costituisce la premessa per affrontare il tema della morale. In linea con i teorici del moral sense, Anthony Ashley Cooper conte di Shaftesbury e Francis Hutcheson, Hume dispiega il suo anti-intellettualismo etico nell’esame delle radici emotive della natura umana e dei meccanismi associativi che ruotano principalmente attorno al sentimento della simpatia.
Sino a oggi, scrive Hume, la discussione sui fondamenti della morale si è sviluppata attorno alle tesi che ne attribuiscono l’origine ora alla ragione ora al sentimento. Per Hume, se le distinzioni morali – virtù/vizio, buono/cattivo – sono poste in modo apodittico dalla ragione, allora non sarà mai possibile muovere all’azione gli uomini. Il giudizio morale, ove fosse anche opera della razionalità, non potrebbe contrastare quella struttura di sentimento caratteristica della natura umana. Coerentemente con la sua impostazione, Hume ritiene la morale oggetto prevalentemente di sentimento piuttosto che di giudizio e valuta le questioni morali come questioni di fatto. Definisce “virtuosa” ogni qualità e azione della mente che sia accompagnata dalla generale approvazione dell’umanità, e “viziosa” ogni qualità che sia oggetto di biasimo o di censura da parte di tutti. L’accento si sposta così sul biasimo o l’approvazione del comportamento da parte degli altri come chiave per comprendere cosa rende un uomo oggetto di stima e di affetto, oppure di odio o di disprezzo. Il linguaggio stesso ci offre un catalogo delle qualità umane, che racchiude in sé le categorie morali; attraverso il ragionamento sarà facile elencare e raggruppare i comportamenti con criteri semplici, seguendo il metodo sperimentale, cioè traendo massime generali dal raffronto con casi particolari.
Ragione e sentimento
Le passioni sono esaminate a coppie – orgoglio e umiltà, odio e amore – e analizzate nei mutamenti che provocano in noi. Esse ci motivano costringendoci sovente a un giudizio che di solito è il risultato di un compromesso tra ragione e sentimento. Il vizio e la virtù non sono qualità intrinseche ma qualità della nostra mente, cui si devono aggiungere l’utile e il gradevole. Attraverso la distinzione fra virtù naturali (amore di sé e benevolenza) e artificiali (obblighi che regolano la proprietà, la giustizia e il governo, o la castità delle donne per rendere coesa la società), Hume crea un ponte tra la politica e l’economia. Un particolare ruolo svolge la simpatia come meccanismo di rafforzamento degli affetti attraverso un rapporto reciproco.
L'estetica del gusto
Hume offre un’analisi del giudizio di gusto – in particolare nel Trattato, nelle Ricerche e nel saggio La regola del gusto (1757) – muovendo dall’esperienza e tenendo fede all’impostazione della scienza dell’uomo in cui egli colloca, accanto alla logica e alla morale, il criticismo, cioè l’estetica. Nella trattatistica di primo Settecento – Lord Shaftesbury e Francis Hutcheson fra gli altri – l’idea di bellezza viene riportata all’ordine, alla proporzione e all’armonia tra le parti rinvenibili nella natura o in qualsiasi opera creativa dell’uomo. Hume, invece, nel Trattato elabora un’idea di bellezza come “comunicazione”, o relazione. È questo il caso in cui la “simpatia” viene detta parte determinante del piacere estetico dello spettatore, generato dalla considerazione della funzione utilitaristica e del vantaggio pratico impliciti nell’oggetto contemplato: il piacere per la vista di una casa, ad esempio, sarebbe in realtà determinato dall’immaginare il piacere di esserne proprietari e abitarvi.

John Closterman, Maurice Ashley-Cooper e Anthony Ashley-Cooper, III conte di Shaftesbury, 1702, Londra, National Portrait Gallery
In seguito, nel saggio La regola del gusto (1757), Hume giunge a riconoscere che, pur affidato al sentimento individuale, il giudizio sulla bellezza sembra fondarsi su dati empirici i cui effetti di piacere o dispiacere risultano invariati nel pubblico d’ogni tempo e luogo. Ciò giustifica la ricerca di un criterio normativo in base al quale accordare l’elemento soggettivo del gusto con la validità “oggettiva” del prodotto, e stabilire la maggior veridicità di alcuni giudizi su altri: se pure la bellezza non è nelle cose ma solo “negli occhi di chi guarda”, non tutte le impressioni hanno pari autorevolezza. Ne deriva che il vero giudizio estetico, in quanto attività intellettuale, è appannaggio solo di critici esperti, nei quali il gusto si è fondato e sviluppato sulla base di canoni e standard non dedotti aprioristicamente ma inferiti dall’esperienza: delicatezza di gusto, serenità di spirito, familiarità con gli oggetti dei quali ci si occupa, libertà dal pregiudizio grazie al controllo del buon senso. Una volta raggiunti simili requisiti, il critico può cogliere i processi mentali (disegno e riflessioni) che hanno presieduto alla realizzazione di un’opera d’arte, valutando in modo imparziale l’artista e la sua opera, insieme alle condizioni storiche del processo creativo e all’accoglienza da parte del pubblico.
2.3 La religione
Nelle due opere dedicate espressamente al tema della religione, Storia naturale della religione, pubblicata nel 1757 – una della Quattro Dissertazioni –, e I dialoghi sulla religione naturale, pubblicati postumi nel 1779, Hume affronta la questione da due punti di vista differenti ma complementari, mostrando il suo atteggiamento profondamente critico nei confronti del fenomeno religioso.
Storia naturale della religione
Nella Storia naturale della religione, come rivela il titolo, viene applicato il metodo – in seguito definito da Dugald Stewart (1753-1828) “storia congetturale”, – secondo cui occorre esaminare quali motivazioni psicologiche e sociali spingano gli uomini ad abbracciare il credo religioso. Quest’ultimo, sostiene Hume, non ha alcun fondamento diretto nella natura umana ed è spiegabile solo in quanto portato secondario delle passioni e del sentimento, come è ben illustrato dalle relazioni di viaggio degli esploratori nelle società primitive. Hume ribalta un’opinione molto diffusa non soltanto fra i gesuiti, ma anche tra i deisti: il monoteismo visto come religione originaria dell’umanità. Nelle società primitive la religione originaria è rappresentata piuttosto dal politeismo con le sue molteplici divinità, che rappresentano, “reificati”, i bisogni primari degli uomini, esseri fragili, ansiosi circa il futuro, alla ricerca spasmodica di protezione. Il monoteismo sorge in epoche successive grazie a un processo di razionalizzazione che investe soltanto l’élite intellettuale e colta della società, e non il popolo semplice e superstizioso, confortato dall’idea di potersi affidare a figure di intermediari tra sé e l’essere assoluto. Il continuo e capriccioso flusso e riflusso di politeismo e teismo (inteso qui come la naturale credenza in un Dio personale) caratterizza le variazioni nelle forme della mentalità religiosa.
ESERCIZIO
E6: Hume
I Dialoghi
Nei Dialoghi Hume sceglie tale forma letteraria per meglio rappresentare le varie posizioni in materia di religione naturale, attribuendo tesi e caratteri differenti a ciascun personaggio, rendendo la discussione simile a una rappresentazione teatrale e lasciando infine al lettore il compito di realizzare la sintesi tra i diversi punti di vista. Demea è un rigido dogmatico esponente del misticismo, Cleante un deista illuminato e Filone uno scettico spregiudicato. Il tema in discussione è la possibilità di conoscere gli attributi di Dio e i disegni della provvidenza attraverso il lume naturale, in particolare attraverso l’uso dell’analogia, che comporta differenze oltre che somiglianze. La prova dell’esistenza di Dio e della sua natura infinitamente intelligente è sostenuta da Demea mediante il ragionamento a priori, e successivamente da Cleante mediante quello a posteriori.
Cleante fa proprie le argomentazioni del teismo scientifico. L’argumentum from design, adottato da Cleante e popolare nel corso del XVIII secolo, fa leva sulla perfetta corrispondenza dei mezzi ai fini, sulla funzionalità di ogni singola parte rispetto alla totalità dell’universo e sull’evidenza empirica del disegno delineato dal supremo architetto. “Volgete gli occhi intorno a voi sul mondo”, dice Cleante, “contemplatene l’insieme e ogni singola parte; troverete che esso non è altro che una grande macchina, suddivisa in un numero infinito di macchine più piccole le quali, a loro volta, ammettono ulteriori divisioni fino a un grado che supera ciò che i sensi e le facoltà umane possono scorgere e spiegare. […] La singolare corrispondenza dei mezzi ai fini in tutta la natura rassomiglia esattamente, pur sorpassandole di molto, alle produzioni dell’artificio umano, dei propositi, del pensiero, della saggezza e dell’intelligenza umana” (Dialoghi sulla religione naturale). L’analogia fra la composizione dell’universo e la costruzione dei manufatti umani e delle opere d’arte porta la mente ad attribuire cause simili a effetti simili.
A Demea e a Cleante si oppone Filone che rappresenta l’istanza anti-metafisica, cioè l’esigenza di non oltrepassare i confini della conoscenza umana. Nel dialogo inoltre non mancano i riferimenti al tema della presenza del male nel mondo, del finalismo e della tendenza umana all’antropomorfizzazione della divinità. L’esito del dialogo è di natura scettica, in quanto afferma l’impossibilità di raggiungere una decisione nel campo delle questioni religiose.
2.4 La politica, l’economia e la storia
La teoria politica, cui Hume si ispira, è principalmente contenuta nei Discorsi politici (1752). Hume tenta la definizione di una scienza politica che contribuisca più delle altre scienze al pubblico bene e che si ponga lo scopo di suggerire previsioni sull’alternarsi delle forme politiche destinate, come le forme viventi, a nascere e a morire. Una scienza non prescrittiva, che imponga valori politici, ma descrittiva, costituita di massime e leggi in grado di spiegare il comportamento dell’uomo in società. Sia contro la teoria contrattualistica sull’origine dello Stato sostenuta dai whig (esponenti del partito progressista inglese), sia contro la teoria dell’origine divina del potere sostenuta dai tory (di stampo conservatore), Hume traccia la possibilità di uno sviluppo di diverse forme costituzionali che mirino principalmente alla difesa della proprietà privata e della stabilità sociale, in nome di una costituzione accettata da tutti i partiti, contro la faziosità dei gruppi.
Anche in ambito economico Hume ha il merito precipuo di affrontare alcuni temi chiave della nascente economia politica, come la teoria stadiale della società – che, sviluppata in ambiente illuministico tra Francia e Scozia, sostiene che le società umane si siano sviluppate per tappe successive, caratterizzate da forme diverse di sussistenza –, il ruolo della moneta, il debito pubblico, la ricchezza originata dalla produzione umana, l’analisi dei settori fondamentali della produzione economica – agricoltura, manifattura e commercio –, l’importanza del libero scambio contro le teorie mercantilistiche allora in voga (che ritenevano la potenza di una nazione legata a un maggior volume di esportazioni rispetto alle importazioni), la necessità dell’interazione tra stati nello scambio delle merci al fine di superare il divario esistente fra paesi poveri e paesi ricchi. Oscurata nei due secoli successivi dalla fama che avrà quella di Adam Smith (1723-1790), la teoria economica di Hume ha in seguito ritrovato ampi riscontri.
BOX
I fondamenti dell'utilitarismo: Adam Smith
Vol.3
L’impossibilità di ottenere una posizione accademica nell’università di Edimburgo è tra i fattori che nel 1745 inducono Hume a dedicarsi agli studi storici. Dal 1752, nel ruolo di conservatore presso la facoltà degli avvocati, può disporre di una biblioteca di oltre 20.000 volumi. In dieci anni la Storia d’Inghilterra è conclusa; grande è il successo di pubblico: sette edizioni complete durante la sua vita. L’opera muove dall’invasione di Giulio Cesare alla Gloriosa Rivoluzione. L’alternanza tra autorità e libertà, che si è incarnata nel conflitto fra corte e parlamento inglese, costituisce il tema generale. L’intento metodologico di Hume è di riscrivere la storia “da filosofo”. Le questioni cruciali sollevate alla luce della sua filosofia scettica sono la ricerca dell’autenticità delle fonti e il vaglio critico delle testimonianze e delle prove evidenti a supporto dei fatti.

Philip James de Loutherbourg, La casa Lancaster, illustrazione per il frontespizio della “Storia d’Inghilterra” di David Hume, 1805, Londra, British Museum
Hume e la teodicea
Nelle sue riflessioni sulla teodicea David Hume trae le conseguenze del carattere contraddittorio del Dio cristiano di fronte al male, già messo in luce da Bayle nel suo Dizionario storico e critico. Nei Dialoghi sulla religione naturale – composti da Hume alla metà del secolo ma pubblicati solo dopo la sua morte nel 1779 – si fronteggiano infatti lo scettico Filone, il deista illuminato Cleante e il rigido dogmatico Demea. L’impossibilità di una conciliazione tra fede e ragione costituisce lo sfondo dei dialoghi e produce l’insolita alleanza tra lo scettico Filone e il “mistico” Demea contro l’unico sostenitore della conciliazione tra fede e ragione, cioè Cleante. Cleante, infatti, rimane solo a difendere la compatibilità tra fede e ragione, e le sue difficoltà emergono in modo particolare proprio nell’affrontare il problema del male, nelle parti X e XI dei Dialoghi. Mentre Cleante si serve ancora una volta di argomenti tradizionali come la minimizzazione del male del mondo, tanto Filone quanto Demea ne sottolineano la realtà e l’intensità, sostenendone l’evidenza empirica sia per l’uomo comune sia per il dotto. Lo scetticismo di Filone non giunge però mai a concluderne l’inesistenza di Dio, ma si concentra sul carattere problematico, e contraddittorio, della natura di Dio e dei suoi attributi.
LETTURE
Pierre Bayle
Il compito del filosofo
Gli eventi storici offrono testimonianze utili a chiarire le leggi della natura umana e offrono dati empirici a sostegno della spiegazione dei movimenti religiosi, politici e dei processi economici che guidano in ultima istanza lo sviluppo delle arti e dei costumi. Il filosofo deve non solo cogliere la dinamica delle leggi generali ma anche analizzare la struttura in cui esse operano, il che significa studiare la natura umana nel suo divenire. La storia si presenta così come la disciplina più utile alla costruzione della scienza umana in quanto integra conoscenze che sarebbero troppo limitate se circoscritte solo al presente.
È evidente, in questa posizione di Hume, l’influenza di Montesquieu, il quale – pur criticato da Hume nel suo saggio Dei caratteri nazionali – nello Spirito delle leggi (1748) imposta la storia in termini di “tipi ideali”. Secondo Montesquieu, infatti, lo spirito di un popolo è non già un’essenza, bensì un processo in continuo divenire.
Inoltre, secondo Hume, lo storico deve saper descrivere l’influenza delle leggi sulla religione, della religione sui costumi, dei costumi sulle leggi per creare fra storia e natura un circolo virtuoso di reciproca contaminazione.
Thomas Reid e la filosofia del senso comune
Le verità della vita quotidiana

Henry Raeburn, Thomas Reid, 1801, Fyvie (Aberdeenshire, Scozia), Fyvie Castle
Il filosofo Thomas Reid (1710-1796) è oggi considerato il maggior esponente della scuola scozzese del “senso comune”. Reid è tra i fondatori di un circolo di Wise Men, professori dell’università di Aberdeen che si incontrano regolarmente e che, con le loro discussioni, danno vita alla filosofia del senso comune. Il club include, tra gli altri, il medico John Gregory (1724-1773), James Beattie (1735-1803), professore di logica e filosofia morale, George Campbell (1719-1796).
Reid concepisce l’appello al senso comune come una riabilitazione delle natural beliefs, cioè le credenze che l’uomo ha naturalmente e che si ritrovano in tutti i popoli, tutte le epoche e tutte le lingue. I principi del senso comune sono dunque quelle verità che l’uomo usa nella sua vita quotidiana, che sono così evidenti da non richiedere alcuna prova e che pertanto tutte le persone ragionevoli sono disposte ad accogliere e difendere. Nonostante i principi del senso comune così concepiti riguardino un ampio spettro di credenze, che includono per esempio la scienza, la morale, la logica e l’economia, Reid si dedica soprattutto alle credenze nell’esistenza del mondo esterno, della relazione causa-effetto e dell’identità personale, i punti messi in discussione da Berkeley e Hume.
La dimostrazione per assurdo
Il terreno che Reid esplora per dimostrare l’esistenza del senso comune è tuttavia l’analisi della percezione, dalla quale sia Berkeley sia Hume hanno tratto conclusioni scettiche o paradossali. Reid piuttosto descrive il meccanismo della suggestion, la capacità della percezione di suscitare immediatamente le credenze nell’esistenza della qualità percepita, nell’esistenza dell’oggetto a cui quella qualità appartiene e nell’esistenza del soggetto percipiente. Gli argomenti di Berkeley a favore dell’immaterialismo e quelli di Hume sull’impossibilità di dedurre l’esistenza dell’oggetto dalla sua rappresentazione mentale vengono respinti in nome della fiducia naturalmente accordata dagli uomini alle loro sensazioni.
Reid è consapevole che l’esistenza dei principi del senso comune non può propriamente essere dimostrata, in quanto sono essi stessi la base di qualsiasi corretto ragionamento. Essi possono piuttosto godere di una dimostrazione per assurdo, per il fatto che, per esempio, soltanto i pazzi e gli idioti hanno reali dubbi riguardo l’identità personale e l’esistenza del mondo esterno.
Agli occhi di Reid l’esistenza di un senso comune è anche un segno della provvidenza divina, che ha creato l’uomo non come tabula rasa, ma come un’officina ben equipaggiata, e lo ha dispensato dal peso di dover dare una dimostrazione anche delle credenze più evidenti.
La credenza nei miracoli
Mentre Reid fonda il suo attacco a Hume sulla gnoseologia e sulla metafisica, Beattie e Campbell si concentrano su argomenti strettamente religiosi.
Campbell prende in esame la credenza nei miracoli, che Hume aveva risolto come caso di credenza poco probabile in quanto non fondata sulla ripetizione di casi simili e dunque decisamente priva di prove. Campbell obietta che la tendenza umana a credere nella testimonianza dei sensi è in realtà immediata e “antecedente rispetto all’esperienza” (Dissertazione sui miracoli, parte I, sez. 1). Il miracolo è infatti una violazione delle leggi di natura e la credenza nei miracoli non può essere assimilata a quella nel corso ordinario dei fenomeni. Analogamente, la fiducia nella veridicità dei racconti e delle testimonianze riportate da altri uomini non è fondata su prove, ma è naturale e spontanea, come confermato dalla credulità con cui i bambini accettano ciò che viene loro raccontato. In generale, la credenza nella testimonianza degli altri uomini è un principio primo della mente umana, che la filosofia della mente non è in grado di spiegare o giustificare e per questo deve essere accettato come un principio del senso comune.
AMBIENTE CULTURALE
Scienza della politica: dalla teoria dello Stato alla filosofia della storia
Poteri e forme di governo
Il processo politico fondamentale dell’età moderna è la formazione degli stati nazionali e la fine delle guerre di religione. Il risvolto concettuale di questo processo è l’elaborazione della teoria contrattualistica dello Stato, in base alla quale esso è il risultato di un patto con cui gli individui escono da una condizione prestatuale (ipotetico “stato di natura”) e si sottopongono a un sovrano riconosciuto universalmente. Il patto viene concepito in due modalità diverse a seconda del prevalere dell’una o dell’altra delle istanze politiche fondamentali che lo motivano: la garanzia della sicurezza, da un lato, e la tutela dei diritti individuali, dall’altro. La prima esigenza porta a un rapporto pattizio in cui i contraenti rinunciano a ogni diritto in favore di un terzo, il sovrano, ricevendone in cambio la sola garanzia della sicurezza fisica (Thomas Hobbes, 1588-1679); la seconda porta invece a concepire il patto come cessione parziale di prerogative, in cui i futuri cittadini conservano alcuni diritti naturali (cioè inalienabili), quali vita, libertà e proprietà (John Locke, 1632-1704). Le due soluzioni esprimono le due forme teoriche fondamentali in cui si realizza il processo di razionalizzazione dello stato: l’assolutismo e il costituzionalismo.
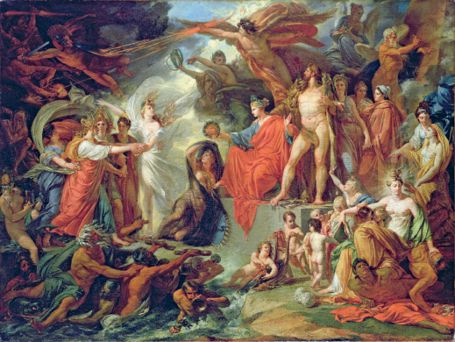
Jacques Reattu, Il trionfo della Civiltà, 1794-1798, Amburgo, Hamburger Kunsthalle
Nella prospettiva assolutistica di Hobbes ogni divisione dei poteri politici è ovviamente esclusa, perché riprodurrebbe all’interno dello Stato la pluralità che è alla base del conflitto naturale. Locke ritiene invece che la separazione dei poteri sia condizione indispensabile per garantire la tutela dei diritti fondamentali, fornendo in questo modo una elaborazione teorica, in direzione del liberalismo moderno, del tradizionale costituzionalismo inglese. Si devono quindi distinguere tre funzioni del potere. Il “legislativo” è il potere sovrano, ma non assoluto. L’“esecutivo” (governo), che applica la legge e punisce i trasgressori (comprendendo anche il potere giudiziario), è subordinato al legislativo. Il “federativo”, che gestisce i rapporti con gli altri stati, cioè la politica estera, dipende a sua volta dall’esecutivo. Cinquant’anni dopo l’idea della distribuzione del potere come garanzia della libertà è ripresa in Francia da Charles-Louis de Secondat de Montesquieu (1689-1755), il quale la connette alla tradizionale distinzione delle forme di governo. Esse vengono distinte intrecciando due criteri: il numero di coloro che detengono di potere e il modo in cui esso è esercitato. Nel governo repubblicano (oligarchico o democratico) il potere viene esercitato da più persone (pochi o tutti) secondo la legge; nel governo monarchico da uno solo e in ossequio alla legge; nel governo tirannico ancora da uno solo, ma in maniera arbitraria. La libertà politica che connota le prime due forme di governo, indipendentemente dal numero delle persone, è data dalla distribuzione dei poteri, che può avvenire in forme diverse a seconda delle situazioni storiche: se in Inghilterra essa si traduce in un vero balance of power, in Francia può essere più opportunamente realizzata dalla funzione di controllo che i parlamenti esercitano nei confronti del potere monarchico.
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), in relazione alla cessione dei diritti individuali al corpo sovrano nella stipulazione del patto, parla di “alienazione totale di ogni associato, con tutti i suoi diritti, in favore di tutta la comunità” (Contratto sociale, I, VI). Ma il corpo politico cui l’individuo cede se stesso non è che l’io collettivo, in cui ciascun membro, come “parte indivisibile del tutto”, ritrova rafforzati i diritti che ha ceduto. La concezione politica di Rousseau è quindi essenzialmente connessa a una forma di democrazia diretta, in cui ciascun cittadino partecipa personalmente del potere in una sua gestione assembleare, sul modello delle póleis greche. In questo modo Rousseau risponde all’esigenza di garantire sia l’assolutezza del potere statale, necessaria per una pacifica convivenza sociale, sia la libertà dell’individuo. Questo modello sarà ripreso da Immanuel Kant (1724-1804), anch’egli preoccupato che la forza irresistibile di cui deve godere lo stato non vada a detrimento della libertà del cittadino. Ma con una differenza. Affinché il potere dello Stato sia assoluto, Rousseau respinge le dottrine della separazione dei poteri (la sovranità è indivisibile) e della rappresentanza politica (la sovranità non è rappresentabile). Viceversa Kant ritiene che l’incoercibilità del potere sovrano non sia incompatibile con la divisione dei poteri e con la concezione rappresentativa della sovranità, condizioni indispensabili per realizzare la forma costituzionale “repubblicana” (il potere è esercitato secondo la legge) in opposizione a quella “dispotica” (il potere è detenuto arbitrariamente).
La tolleranza
Il problema della salvaguardia della libertà dei cittadini nei confronti del potere costituito, quando viene considerato dal punto di vista religioso anziché strettamente politico, configura la questione della tolleranza. Accanto alla disputa tra assolutismo e costituzionalismo essa rappresenta uno dei temi più importanti della riflessione politica moderna. Il dibattito attraversa tutto il periodo dell’Illuminismo. Sul piano storico è racchiuso da due documenti fondamentali: il Toleration Act del 1689, con cui vengono mitigate le pene contro le confessioni diverse dalla Chiesa anglicana, e l’Editto di tolleranza verso i protestanti con cui nel 1787 Luigi XVI cerca di porre riparo alle disastrose conseguenze socio-economiche della revoca nel 1685 dell’Editto di Nantes. Le Rivoluzioni americana e francese concludono il dibattito, trasformando in “diritti dell’uomo” – libertà di pensiero, di culto, di espressione – ciò che prima era solo tollerato. Tolleranza e intolleranza – dirà Thomas Paine in I diritti dell’uomo (1791) – sono entrambe espressione di dispotismo: l’una pretende di negare, l’altra di concedere, un diritto che gli uomini già possiedono naturalmente.
Ancora una volta era stato Locke ad avviare la discussione con il Saggio sulla tolleranza (1667) e le tre Lettere sulla tolleranza (1689, 1690 e 1693). Locke afferma il principio della separazione tra Stato e Chiesa, che diventerà uno dei cardini del pensiero liberale. L’assunto di partenza è che Stato e Chiesa sono associazioni aventi finalità diverse e indipendenti. Se la società politica tende alla conservazione dei diritti naturali dell’uomo, la Chiesa dovrà avere come scopo la salvezza dell’anima. In altri termini, se Hobbes lascia all’individuo solo la libertà interiore di pensiero, con Locke si perviene a un’esplicita difesa della libertà esteriore di culto.

Nicolas Henri Jeaurat de Bertry, Allegoria della Rivoluzione Francese con ritratto di Jean-Jacques Rousseau, 1794, Parigi, Museo Carnavalet
Alla questione della tolleranza è strettamente connesso l’atteggiamento filosofico del deismo. A differenza del teismo, che presuppone la credenza in un Dio personale oggetto di rivelazione positiva, esso intende la divinità come un Essere impersonale, causa intelligente dell’universo e garante delle sue leggi armoniche, ma ininfluente rispetto alle singole vicende individuali. Il deismo è una religione razionale, rispetto a cui le diverse religioni positive o perdono completamente valore o sono ridotte a espressioni storiche di un contenuto concettuale universale. Ciò ha un’immediata ricaduta politica sulla questione della tolleranza. Le religioni positive, relativizzate e storicizzate, cioè liberate dal riferimento a un’unica rivelazione, sono considerate sostanzialmente equivalenti: si ricordi la storia dei tre anelli, le tre religioni monoteistiche, raccontata da Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) in Nathan il saggio. Ciascun culto esprime quindi convinzioni religiose che hanno gli stessi diritti delle altre e implicano il dovere di tolleranza reciproca.
Sviluppatosi in Gran Bretagna alla fine del XVII secolo, il deismo trova grande diffusione in Francia anche grazie alle Lettere filosofiche di Voltaire (1694-1778). Attraverso l’incontro con la tradizione libertina autoctona e con il pensiero di Pierre Bayle (1647-1706), anche il deismo francese è strettamente legato all’idea di tolleranza, spesso estesa agli atei, di cui si difende la capacità di essere soggetti morali. In Voltaire, come in genere nel movimento illuministico, l’idea di tolleranza viene confortata da una concezione debole e talvolta, come in Bayle, decisamente scettica della verità: la ragione umana, seppur unico strumento di giudizio e di conoscenza, ha limiti precisi e non può conseguire un sapere assoluto. Inoltre in Voltaire – che scrive nel 1763 il Trattato sulla tolleranza – la questione assume un significato più ampio. Il termine infâme (“infame”), sinonimo di intolleranza, non comprende solo la Chiesa e la religione istituzionale ma, più in generale, ogni forma di fanatismo, di superstizione, di prevaricazione del potere politico e giudiziario. L’azione di Voltaire non si limita all’ambito teorico, ma si sviluppa anche in azioni pratiche come l’opera di riabilitazione del protestante Jean Calas, giustiziato con l’accusa di aver impiccato il figlio – in realtà suicidatosi – per impedire che si convertisse al cattolicesimo.
La guerra e la pace
Teoria della separazione dei poteri e difesa della tolleranza religiosa sono intesi come strumenti per garantire all’interno della società politica forme di libertà che non si traducano in conflitto. Il problema non è quello di eliminare il conflitto, ma di sospingerlo al di là dei confini dello Stato. Che lo stato di natura sia viceversa una condizione di conflitto permanente, almeno potenzialmente, è invece un assunto che almeno fino all’Illuminismo non sembra essere messo in discussione. La dottrina del diritto naturale moderno che caratterizza il secolo XVI (Ugo Grozio, 1583-1645; Samuel Pufendorf, 1632-1694) e influenza fortemente anche il razionalismo settecentesco (Christian Wolff, 1679-1754), riconosceva la guerra come strumento giuridico naturale per dirimere le vertenze laddove, come nei rapporti internazionali, non fosse possibile ricorrere all’autorità di un potere superiore. Il giusnaturalismo non si propone di eliminare la guerra, ma soltanto di regolamentarla in modo che essa venga dichiarata solo per una causa valida (teoria della guerra giusta) e condotta secondo norme formali prestabilite (teoria della guerra solenne). Tra le “giuste cause” di guerre era solitamente contemplata non solo la guerra di difesa, ma anche quella intrapresa per la ripetizione del dovuto (cioè per l’affermazione di un diritto accampato per ragioni dinastiche, contrattuali o di altro genere) e quella per la punizione di un torto, subito in prima persona o da altri. Ovviamente ciò rendeva alquanto difficile, eccetto che nel caso si subisse un attacco o un’invasione, determinare se e in quale misura sussistessero le condizioni per la “guerra giusta”. Di qui il contrapporsi delle motivazioni e contromotivazioni di diritto e l’effettiva impossibilità di controllare l’espansione bellica con strumenti giuridici.
La cultura illuministica, tendenzialmente pacifistica, cerca di contrastare il dilagare del conflitto e della guerra con due strumenti. Il primo, di natura culturale, è la diffusione del cosmopolitismo. Il secondo, di carattere più espressamente giuridico, è l’estensione del modello contrattualistico dal piano infrastatuale a quello internazionale.
Il cosmopolitismo settecentesco prende a modello quello dell’antichità classica, nelle due versioni cinica e stoica. Nel caso di Diogene il Cinico si tratta di un cosmopolitismo individualistico (Diogene abbandona la pólis per vivere in una botte), il cui fulcro consiste in un processo di depoliticizzazione dell’individuo, che rivendica la sua libertà di uomo contro i vincoli che gli derivano dall’appartenenza a una società politica. “Il filosofo non è né francese, né inglese, né fiorentino – dice Voltaire – è di tutti i paesi” (Dizionario filosofico, voce “Cartesianesimo”). Questo tipo di cosmopolitismo individualistico è fruttuoso dal punto di vista culturale: è alla base della république des lettres, per cui tutti i dotti del mondo sono apparentati da un legame che li solleva al di sopra delle loro nazionalità. Esso appare tuttavia poco produttivo dal punto di vista politico, poiché rischia di fare dell’individuo un cattivo cittadino che non si interessa al destino del proprio Stato. Questa critica favorisce la prevalenza del secondo modello classico, quello stoico, documentato da Zenone di Cizio a Epitteto e Marco Aurelio. Qui la cittadinanza si articola in una serie di sfere concentriche, che vanno dalla partecipazione alla propria pólis alla condivisione di un’unica natura umana. Questo modello consentiva di conciliare il rispetto dei doveri del patriottismo con quelli del filantropismo universale. La tendenza alla tolleranza è insita in ogni forma di cosmopolitismo. Ma mentre nel caso del patriottismo individualistico essa nasce da un atteggiamento di disinteresse per le differenze nazionali, nel caso del cosmopolitismo “universalistico” essa tende a promuovere la collaborazione tra popoli diversi senza negare le diversità che li distinguono.
Questa seconda espressione di cosmopolitismo assume spesso la forma di un cosmopolitismo istituzionale, legato all’estensione del modello contrattuale all’intera comunità delle nazioni. Nel 1713-14 l’abate Charles-Irenée de Saint-Pierre (1658-1743) dà voce a questa esigenza con il Progetto per rendere perpetua la pace in Europa (1713-1714), dove tuttavia l’estensione della “federazione” per la pace è limitata al continente europeo. Una completa realizzazione di questo ideale si avrà soltanto con il Progetto di pace perpetua (1795) di Kant, che prevede l’unione mondiale di tutti gli stati intesa come federazione di popoli che, lasciando intatta la sovranità nazionale dei singoli stati, li impegni comunque in un’alleanza per la pace.
La politica e la storia

Claude-Louis Desrais, Allegoria dei benefici del progresso della scienza e della tecnica, XVIII sec., Parigi, Musée Carnavalet
Ovviamente tanto l’espansione del cosmopolitismo universalistico quanto la realizzazione della federazione internazionale per la pace presuppongono una prospettiva storica a lungo termine. La fiducia nella loro possibilità non è dunque separabile dalla concezione progressistica della storia che rappresenta una delle peculiarità del pensiero illuministico. Già Voltaire – cui si deve anche la creazione dell’espressione “filosofia della storia” – nelle sue opere storiografiche prospetta uno sviluppo storico che, seppure con periodi di stasi, procede nell’insieme verso un sempre maggiore sviluppo della ragione, della conoscenza e delle arti. Anne-Robert-Jacques Turgot (1727-1781), a sua volta, contrappone all’andamento circolare della natura quello rettilineo della storia, individuando come criteri di progresso lo sviluppo della tecnica e l’espansione della libertà. Ma la più chiara teorizzazione del progresso storico in età illuministica si ha con Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marchese di Condorcet (1743-1794), quando la Rivoluzione francese – di cui egli sarà tuttavia vittima – accresce le speranze degli uomini nell’avanzamento inarrestabile della storia. Nell’Abbozzo di un quadro storico dei progressi dello spirito umano, Condorcet sostiene che l’avanzamento storico è determinato da “leggi generali dello sviluppo delle nostre facoltà”. È così possibile una “scienza dell’uomo” che non solo spieghi le fasi del passato dell’umanità, ma ne preveda anche lo sviluppo futuro. Condorcet divide la storia del genere umano in dieci epoche, di cui la decima è appunto dedicata ai progressi futuri, che prevedono l’eliminazione della diseguaglianza tra le nazioni, il progresso dell’eguaglianza tra i membri di uno stesso popolo e l’indefinito perfezionamento della natura umana, sia dal punto di vista fisico (una vita sempre più lunga) sia del punto di vista morale.
Il fattore politico costituisce per Condorcet uno dei principali criteri dell’avanzamento storico. L’aumento di conoscenza e di razionalità che caratterizza il progresso dovrà andare di pari passo con l’espansione della libertà e dell’eguaglianza.