7. Denis Diderot

Jean-Honoré Fragonard, Ritratto di Denis Diderot, 1769 ca., Parigi, Museo del Louvre
7.1 Vita di un enciclopedista
Denis Diderot nasce nel 1713 a Langres, una cittadina dell’attuale Alta Marna. Destinato dai genitori a divenire prete, in quanto ottimo studente, viene mandato a Parigi per completare gli studi nel 1729. Qui diventa nel 1732 magister artium, ma disattende profondamente le aspettative della famiglia e dopo un breve periodo nello studio di un procuratore abbandona il diritto e qualsiasi volontà di “carriera” per dedicarsi alla letteratura, al teatro e alla filosofia. Il padre taglia ogni aiuto e per circa una decina d’anni il giovane Denis vive di espedienti, piccoli lavori e aiuti di amici e della moglie, la ricamatrice Antoinette Champion, sposata nel 1742.
I primi lavori filosofici e letterari
In questi anni difficili, anche grazie alle frequentazioni parigine e all’amicizia burrascosa con Jean-Jacques Rousseau, si completa tuttavia la sua formazione. La svolta avviene nel 1745, quando la traduzione del Saggio sulla virtù e sul merito di Shaftesbury fa conoscere Diderot anche ad alcuni editori e in particolare a Le Breton, che gli affida, in collaborazione con il matematico d’Alembert, la traduzione e l’adattamento della Cyclopaedia del britannico Chambers. In questi anni pubblica i suoi primi lavori filosofici e letterari, ovvero i Pensieri filosofici del 1746, La sufficienza della religione naturale e La passeggiata dello scettico del 1747, oltre al romanzo licenzioso I gioielli indiscreti (1748) e la Lettera sui ciechi ad uso di coloro che vedono (1749). A seguito delle tesi deiste e materialiste sostenute in questo saggio, viene incarcerato a Vincennes: la prigionia dura cinque mesi e non è particolarmente dura, ma lascia il segno. Da allora Diderot sarà più prudente nella scelta dei canali di comunicazione dei propri scritti.
LETTURE
L'Encyclopédie: storia di un progetto filosofico
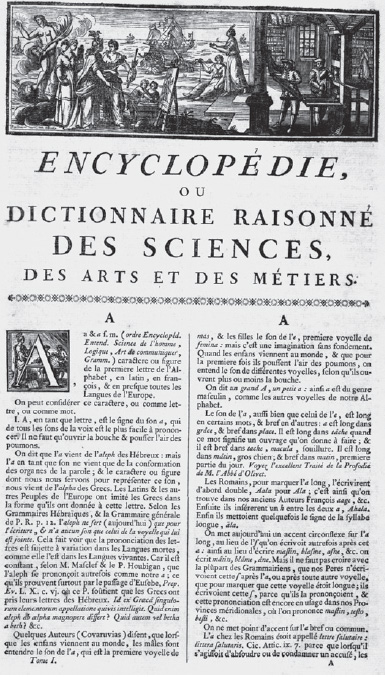
Lettera A, prima pagina dell’“Encyclopédie”, 1751
L’Encyclopédie
Dopo la prigionia si apre il periodo forse più difficile, ma senza dubbio più fecondo, della esistenza filosofica di Diderot, che coincide con la straordinaria fatica che porta a termine solo nel 1773, dopo oltre vent’anni di lavoro, con la realizzazione dell’Encyclopédie. Presto abbandonato da d’Alembert, Diderot, che con frequenza redige voci “mancanti” e cura editorialmente l’intera opera, scrive tuttavia in questo periodo i suoi lavori maggiori, sia sul piano filosofico con L’interpretazione della natura (1753) e il Sogno di d’Alembert (1769), sia su quello letterario: i romanzi La monaca (1760), Il nipote di Rameau (1762), Giacomo il fatalista (1773); le due opere teatrali Il figlio naturale e Il padre di famiglia; il saggio La poesia drammatica (1757-1758). Muore infine a Parigi il 31 luglio del 1784.
La lettera sui ciechi e il materialismo di Diderot
Nella Lettera sui ciechi, Diderot recupera un “caso” filosofico già sollevato da Locke mezzo secolo prima, nel Saggio sull’intelletto umano: il problema del “cieco di Molyneux”. William Molyneux (1656-1698) era un medico amico di Locke il quale s’interrogò sul tipo di conoscenza del mondo sensibile che può avere un cieco dalla nascita il quale, grazie a un intervento chirurgico, ritrovi la vista. La questione è la seguente: riuscirà il cieco a riconoscere e a nominare un cubo e una sfera, di cui ha avuto fin lì una conoscenza solo di tipo tattile, con l’aiuto degli occhi e senza far uso del tatto? Locke, che teneva a confutare la dottrina cartesiana delle idee innate, risponde di no. Diderot svolge un ragionamento più sottile e complesso. Il cieco, in un primo tempo, non riesce a riconoscere il cubo e la sfera, in quanto l’occhio non è ancora abituato a far esperienza della visione ed è ancora incapace di “guardare” veramente: può solo vedere, senza capire cosa vede. Poco a poco, facendo esperienza, il cieco inizia a capire ciò che vede senza l’aiuto del tatto, grazie all’azione dell’esperienza sensibile e del cervello, il quale è come un sensorium commune (materiale in cui confluiscono le diverse sensazioni), e che traduce le impressioni sensibili ricevute dal senso della vista nei segni del senso del tatto, che il cieco conosce già. Questi, infine, riuscirà a riconoscere e a nominare i due oggetti.

Denis Diderot, "Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient", Londra, 1749
Nell’ambito delle scienze del vivente Diderot ha inaugurato una forma di vitalismo filosofico molto originale, basato sulle nozioni di sensibilità della materia e di “irritabilità” della fibra organica, la capacità di essere contrattile: concetto quest’ultimo introdotto dal fisiologo svizzero Albrecht von Haller (1708-1777). Il corpo vivente, l’“essere organizzato”, è come una federazione di esseri viventi distinti (gli organi), ciascuno dotato di una vita e di una sensibilità proprie. Negli Elementi di fisiologia (1770-1782) Diderot afferma che esistono non una ma più vite, almeno tre: (1) la vita della “molecola organica”, concetto introdotto dal naturalista Buffon (1707-1788) nella Storia naturale generale e particolare (1749); (2) la vita dell’organo; (3) la vita dell’animale intero. Ciascuna vita obbedisce a dinamiche fisiche e chimiche diverse. Il sogno di d’Alembert (1769) è il grande affresco letterario in cui Diderot espone le nuove idee sulla generazione dell’organismo da un “punto sensibile” di materia organica, dotata di sensibilità propria, che si espande attraverso un processo di epigenesi – formazione per giustapposizione di parti – prendendo le mosse da un primo “fascio di fibre” (il sistema nervoso centrale), per giungere infine alla costituzione dell’animale intero. La coscienza e la ragione sono il prodotto ultimo del medesimo processo fisico-chimico, estremamente complesso, di costruzione dell’intero corpo vivente.
7.2 L’interpretazione della natura
Diderot non è un pensatore sistematico e il suo valore filosofico e culturale non può essere ristretto ai soli saggi filosofici. Vero protagonista dei Lumi francesi, personalità trascinante, spazia dalla teoria letteraria a quella teatrale, dall’estetica alla critica delle arti con i commenti ai biennali Salons parigini di pittura. È difficile enucleare una “linea” filosofica unitaria. In apparenza, Diderot è vicino a teorie materialiste e deiste, ma al tempo stesso è affascinato dalla visione della natura mobile e “sentimentale”, attraversata da utopie etico-politiche, di Jean-Jacques Rousseau. Punti di vista che integra con quelli di Spinoza e, soprattutto, Francesco Bacone, a sottolineare che l’autentico centro del suo pensiero è, come nella quasi totalità di pensatori del suo tempo, il concetto di natura.
LETTURE
Jean-Jacques Rousseau
L’elogio dello sperimentalismo
L’interpretazione della natura è un saggio di metodologia della scienza, un elogio dello sperimentalismo che critica la sterilità delle matematiche a favore di una concezione “qualitativa” della natura, considerata come un corpo unitario da interpretare nelle sue leggi intrinseche per poter meglio trarre da essa elementi di conoscenza e di utilità. La natura va considerata da un punto di vista “monistico”, ovvero in un quadro che metta in rilievo l’importanza della sensibilità sullo sfondo di una profonda unità organica tra la materia, la vita e la coscienza. Diderot vede la natura come una “grande catena” in un costante divenire evoluzionistico che coinvolge la totalità vitale degli esseri animati e inanimati: è guidata da un’idea di metamorfosi, all’interno della quale il concetto di forma non è un dato fisso immutabilmente connesso a un’immagine, bensì un elemento dinamico, che ha nel movimento, nella sua dialogicità, la sua unica possibile definizione. La forma è fenomeno ibrido perché ha bisogno di mutare i propri confini, il proprio “apparire”, senza potersi rinchiudere in un’immagine isolata. Su questa linea ideale, Diderot va alla ricerca di un “prototipo” di tutti gli animali, in grado di giustificare, di metamorfosi in metamorfosi, l’incessante movimento genetico della natura come forza e “fermentazione generale”.
7.3 Arte ed espressione
I vari motivi presenti nella filosofia della natura di Diderot, dalla critica della matematica all’idea della necessità di un approccio sperimentale, sono il filo conduttore per comprendere sia l’impostazione generale del lavoro enciclopedico sia la possibilità di spaziare, da questi principi epistemologici generali, ad altri ambiti di sapere. Particolarmente importante è, a questo proposito, la voce “Arte”, che è uno degli scritti programmatici dell’Encyclopédie e che, proprio per tale motivo, viene pubblicata “in anteprima” nel 1751. Partendo dal presupposto che le arti “meccaniche” e le arti “liberali” hanno identica dignità, sia sociale sia conoscitiva, Diderot osserva che l’arte è una modalità di interpretazione della natura che sente la necessità di “provare” la natura stessa attraverso la costruzione di oggetti. La filosofia ha di conseguenza bisogno dell’arte in base al principio (baconiano) che l’uomo è il ministro o l’interprete della natura e non può né comprendere né fare se non nella misura in cui ha conoscenza, sperimentale o razionale, degli esseri che lo circondano.
La voce “Arte” nell’Encyclopédie
Il termine “arte” non può dunque riferirsi soltanto alle produzioni “belle”, bensì a qualsiasi organizzazione di strumenti e regole finalizzate a produrre oggetti. “Chi si incaricherà della materia delle arti – scrive Diderot nella voce dell’Encyclopédie – dovrà avere studiato in profondità l’intera storia naturale, cercando di ricavare da essa una rete di saperi, tra loro sempre connessi”.
Nel momento in cui si vogliono trarre da questa natura, attraverso una profonda intelligenza della mano, gli aspetti espressivi e sentimentali, si avranno i prodotti dell’arte “bella”, il cui fine è quello di ricavare dalle cose i segreti “geroglifici” che nascondono in sé, portandoli a “espressione”. Espressione che è per Diderot “l’immagine di un sentimento”, una risposta antropologica ai caratteri delle cose stesse, al loro stato e alle loro qualità naturali.
La bellezza di un “geroglifico espressivo” è data così dalla sua capacità di esprimere la natura o un evento, dalla capacità di esibirlo senza mai ridurlo a qualcosa che possa essere bloccato o “spiegato”, cogliendone invece sempre l’energia gestuale che racchiude. Nella Lettera sui sordomuti, scritta nel 1751, si comprende dunque che l’interpretazione della natura non è riducibile a Bacone, ma implica una più generale lettura estetico-espressiva del mondo e degli atti costruttivi che lo afferrano e manipolano tecnicamente. Quella del dialogo, per Diderot, non è soltanto una forma letteraria bensì l’immagine vivente di quella polifonia che è caratteristica della natura stessa, con tutta la sua forza espressiva.
LETTURE
Francis Bacon
La percezione dei rapporti

Voltaire nel ruolo di Zopir nella tragedia "Maometto", 1820, Parigi, Bibliothèque Nationale de France
La bellezza non è dunque un dono degli dèi, ma deriva da uno sforzo costruttivo che è comprensione dei rapporti intrinseci dell’oggetto. Diderot, infatti, per collegare bellezza e natura, parla di “teoria dei rapporti”, riprendendo un’espressione contenuta nel cartesiano Compendium musicae del 1618. I rapporti, semplici o composti, costituiscono la simmetria, l’ordine interno alla “natura delle cose”, che si esprime proprio attraverso di loro: percepire tali rapporti significa comprendere la bellezza come forza espressiva. “Chiamo bello fuori di me – scrive Diderot – tutto ciò che contiene in sé qualcosa che possa risvegliare nel mio intelletto l’idea di rapporti; e bello per me tutto ciò che risveglia questa idea”. Questa nozione non è un principio soggettivamente relativo in quanto ha il suo limite nell’oggetto: l’intelletto non aggiunge o toglie nulla alle cose e la loro bellezza deriva soltanto dalle connessioni e dai rapporti concreti che sono in loro, tra le loro parti, che è compito dell’arte unire, comporre, organizzare in modo che il sentimento le riconosca, le afferri, le esprima.
La questione assume così un senso simbolico per l’intero pensiero di Diderot: costruire opere d’arte o manufatti è sempre un’interpretazione espressiva della natura. In questo lavoro espressivo la natura si mostra come insieme di molteplicità e differenze, che tra loro collaborano, dialogano, scambiandosi valori, significati, possibilità, che si traducono in rapporti “belli”, in forme che mantengono la dinamicità che le ha costruite. Il pensiero di Diderot è dunque, in tutte le sue manifestazioni, un pensiero “viaggiante”: il bello è un risultato di questo viaggio, che permette di comprendere, in primo luogo in via sperimentale, le possibilità che sono nella natura umana e nella natura delle cose.
La metafora del viaggio diviene così l’evidente sigillo dell’evoluzione subita nel Settecento dal concetto di “natura”: natura che non è più un sistema di leggi quantitative stabilite da Dio nel mondo fisico, ma di cui sempre più si scoprono i lati oscuri o, comunque, qualitativi, che ne spezzano la rigidità volgendo l’attenzione verso la sua varietà sperimentale e biologica. Questa natura viaggiante non è più l’oggetto immobile di un’analisi scientifica basata su antichi modelli, in quanto richiede nuovi sguardi e un rinnovamento del concetto di “scienza”, più adeguato alla mobilità di oggetti tematici come il bello, l’uomo, la società, strati differenti di un’unica natura in movimento sempre suscettibile di nuove interpretazioni.
Casanova e Don Giovanni: libertinismo e libertinaggio
Madamina, il catalogo è questo…

Jean-Honoré Fragonard, La serratura, 1776-1779, Parigi, Musée du Louvre
Il lettore che apra le prime pagine della Storia della mia vita di Giacomo Casanova (1725-1798) potrà gustare l’autoritratto del grande libertino veneziano, che si definisce paradossalmente come colui che è stato allievo di se stesso e si fa un dovere di amare il proprio precettore. Casanova deve gran parte della sua fama all’impressionante elenco di conquiste femminili che popola le pagine delle sue memorie, non meno del piacere di averne beffato i mariti. Facendo l’apologia del proprio temperamento e dichiarando di non avergli mai resistito, Casanova sembra soffermarsi, nelle prime pagine della Storia, nella rievocazione dei piaceri che hanno invaso la sua esistenza. I volti di attrici e gentildonne, monache e novizie, matrone e giovani ragazze, accompagnano Casanova nelle contrade d’Europa, da Mosca a Istanbul.
Il libertino in maschera
Il libertino in maschera al ballo della mondanità settecentesca compie le sue riflessioni a margine dei fortunati incontri amorosi e riveste di un manto estetico le proprie pulsioni: “Così quello che sempre ha esercitato un eccezionale fascino su di me è la bellezza animata di una donna, e propriamente quella bellezza che ogni donna porta in viso, perché è nel viso che risiede ciò che incanta; ed è un fatto che le sfingi che vediamo a Roma o a Versailles ci facciano innamorare dei loro corpi nonostante siano deformi nel pieno senso della parola”. Questo profilo del dongiovanni posto in attitudine contemplativa davanti alla sfinge femminile rende omaggio a quanto Diderot scrive nella voce “Libertinage” dell’Encyclopédie, riconoscendo al libertino, quando la sua condizione non privilegi il soddisfacimento dei meri bisogni materiali, i talenti di un bel esprit. I volti e le maschere, le silhouettes e i ritratti femminili inseguono la vita del dongiovanni facendo capolino dalla conversazione della scrittura memorialistica.
Da Casanova a Laclos
All’incostante seduttore è concesso il piacere di rievocare sul piano della memoria, una a una, le diverse conquiste così come avviene nella gioiosa messa in scena del “catalogo” scritto dalla penna di Da Ponte (1749-1838) per la musica di Mozart nel Don Giovanni. In maschera o a volto scoperto, il libertino è sempre travestito perché nasconde nella brillante immagine mondana non solo il fine della conquista erotica, ma la stessa identità sociale del suo personaggio che si vedrà trafitto dalle lucide osservazioni che la marchesa di Merteuil dedica al bel Valmont, libertino e protagonista come lei del romanzo di Choderlos de Laclos, Le relazioni pericolose (1782): “Un bel volto mero effetto del caso; un’eleganza che l’uso del mondo dà quasi sempre, e in verità un’intelligenza alla quale del resto potrebbe supplire una volgare chiacchiera; un’abbastanza lodevole impudenza, dovuta forse però esclusivamente alla facilità dei primi successi: ecco, se non faccio errore, tutti i vostri mezzi”.
Case, libri e alcove
Nelle case di piacere veneziane e nelle alcove parigine il libertino e la dama alternano il piacere dei sensi a quello del testo, e si contendono con ammiccante complicità i romanzi di un nuovo tipo di letteratura. Il tema erotico sfiora nel Settecento sia l’indagine medico-psicologica – è il caso de La monaca di Diderot – sia la polemica anticlericale, ma non si identifica propriamente con la cultura dei philosophes, anche se da questa viene influenzato. Giocando sull’ambiguità dei travestimenti mondani e di quelli erotici, il romanzo di intrattenimento si diffonde tra le mascherine del bel mondo. Una straordinaria raffinatezza di intuizione mette poi in scena la psicologia dei caratteri nel delicato tratteggio delle scene galanti e dei dialoghi arguti che hanno i tempi e le movenze del teatro di Marivaux (1688-1763).
Dal all’apologia del crimine: Sade
Il travestimento galante lascia il posto allo spessore violento dell’oscenità che si dichiara con tutto il suo effetto di aperta provocazione con Donatien-Alphonse-Françoise de Sade (1740-1814). Qui i motivi antireligiosi del libertinismo si uniscono a quelli osceni, sicché la scrittura dell’erotismo galante lascia il posto alle bestemmie e agli atti criminali dei monaci di Sainte-Marie-des-Bois nel romanzo Justine. Quando il libertino veste i panni del monaco, il travestimento ha raggiunto la perfezione, perché il convento nasconde il serraglio nel quale Justine e le altre vittime soddisfano i desideri dei loro carnefici. Una sorta di sensismo criminale guida Sade nel descrivere, con l’eloquenza del monaco Clement, il rapporto tra immaginazione e crimine: “Ora quale sensazione è più viva del dolore? Le sue manifestazioni sono vive e non ingannano; ingannano invece quelle del piacere, perpetua messinscena delle donne, che quasi mai lo provano veramente [...]. Per produrre dolore, invece, non sono necessari requisiti: più difetti ha un uomo, più è vecchio, meno è amabile, meglio riuscirà”. Il travestimento monastico aggrava l’espressione di un pensiero materialista che affonda le radici nella cultura edonistica e che si risolve nella paradossale assoluzione di ogni progetto criminale proprio in ragione delle sue premesse edonistiche.
7.4 Il teatro come metafora
Il movimento interpretativo operato dal filosofo, dallo scienziato, dall’artista trova nel teatro la sua metafora privilegiata. Il teatro non è una rappresentazione astratta, bensì una pratica gestuale e corporea che va ricondotta nel quadro di una forma e che, di conseguenza, ha bisogno di regole. Le regole sono necessarie ogniqualvolta il corpo si trovi a esprimere sentimenti. I sentimenti, infatti, vanno “controllati” (tema che accompagna Diderot sino al Paradosso sull’attore, 1830). “La poesia vuole qualcosa d’enorme, di barbaro e di selvaggio”, ma si realizza solo all’interno di una forma e la forma è data dall’attore, che, seguendo le regole, riesce a conferire alla rappresentazione aspetti corporei – il tono, il gesto, l’azione – attribuendo energia alla scena. Accanto a questo aspetto passionale quindi, in cui l’attore inserisce la sua intera sensibilità, si deve tuttavia porre un freno razionale. Il teatro così assume un compito insieme etico e logico.
Il paradosso sull’attore
Il teatro non è corruzione, come sosterrà Rousseau vedendo in esso la metafora di una mediazione culturale che allontana dalla natura. Al contrario, esso interpreta la natura esercitando quella collaborazione tra dimensione sensibile e dimensione ideale da cui trae origine la rappresentazione. Là dove Rousseau, in nome della natura, vorrà reprimere, annullando la rappresentazione teatrale, Diderot ritiene invece che il teatro sia il modello di come vadano costruite le forme delle rappresentazioni: quando si generano o interpretano forme è necessario trovare mediazioni che introducano nella forma stessa una dinamicità e nel sentimento un rigore. Il teatro, come la natura, è un sistema che deve essere conosciuto nella sua ricchezza e varietà, di manifestazioni e di leggi, perché possa generare conoscenza ed espressione. Il gesto teatrale, pur ripetuto come i movimenti della natura, è sempre diverso, sempre rinnovato. Il paradosso dell’attore è il medesimo della natura, e della filosofia, per le quali la rappresentazione non è l’identico concettualizzato che si ripropone, ma lo sguardo, i sensi, il corpo, il giudizio che provano con i loro gesti la multiforme varietà del senso del mondo. L’istinto non è un buon giudice, come non lo è l’immediatezza: l’attore, come il filosofo, deve essere simile al poeta, cioè a colui che “va continuamente ad attingere nel fondo inesauribile della natura” e, se così non fosse, “presto vedrebbe estinguersi la sua ricchezza”.
Compensare, mediare, moderare, fare dialogare esperienza e giudizio, espressione e riflessione. È questa l’essenza profonda dell’intero percorso di Diderot: osservare, riconoscere, imitare sono le qualità della conoscenza, non il sentimento indistinto, bensì la volontà di finalizzare alla forma i movimenti del corpo. Il grande attore, quando rappresenta, non è catturato e dominato dalla scena, ma esce da sé e la controlla: la verità non è la presenza immediata, né la riproduzione, bensì, come il lavoro enciclopedico, una rappresentazione che descrive il senso molteplice delle cose, riflettendo sulla loro natura, cogliendone il principio, facendola divenire un modello formale di riferimento, che supera l’istante e afferra ciò che caratterizza il fenomeno.
ESERCIZIO
E14: Diderot
L’incipit dei Saggi sulla pittura (1766) di Diderot – “La natura non fa nulla di scorretto. Ogni forma, bella o brutta, ha la sua ragion d’essere, e in tutto ciò che esiste non c’è nulla che non sia come deve essere” – sembrerebbe ingenuamente leibniziano, se lo interpretiamo come un procedimento per enunciare il principio di ragion sufficiente. Da un lato, infatti, la distinzione leibniziana tra verità di ragione e verità di fatto ha reso possibile una metafisica delle cose che giustifica molte affermazioni illuministiche e le “nuove scienze” che da esse sono nate. D’altro lato, tuttavia, segna una novità, implicita in Diderot, cioè la volontà di plasmare e interpretare la metafisica, guardando alle “ragioni” intrinseche alle cose, alle loro qualità fenomeniche. Il principio di ragion sufficiente può infatti essere interpretato, all’interno di uno spirito razionalista, come ricerca di cause: ma Diderot non si riduce a questa interpretazione dal momento che le “ragioni”, i lógoi, sono un modo per scavare il reale, ma anche uno strumento per agire su di esso. Se cause ed effetti fossero per noi sempre chiari e distinti – e non lo sono – allora, scrive Diderot, “non avremmo nulla di meglio da fare che rappresentare gli esseri così come sono”. Ciò invece non può accadere: non è l’evidenza del sistema causale a permetterne la comprensione, bensì la complessità stratificata dei modi di rappresentazione del reale, l’intelligente abilità di organizzare l’insieme in un organismo stratificato, che deve essere sempre di nuovo descritto, indagato, interpretato.
VIDEO
A proposito di Chardin, per il Salon del 1763
Gli idéologues
L’impegno politico
Attivi tra il 1771 e il 1810, i filosofi e gli scienziati dell’idéologie costituiscono un gruppo compatto di intellettuali con stabili relazioni di collaborazione e scambio, tanto che i loro studi possono essere considerati come un unico sistema filosofico. Diretti eredi degli illuministi, gli idéologues si impegnano attivamente nella vita politica della Rivoluzione francese, poiché ritengono che l’impegno civile sia una conseguenza necessaria della conoscenza filosofica. Nel periodo del Direttorio, all’interno del Comitato di istruzione pubblica, realizzano una riforma del sistema scolastico che resterà esemplare.

Antoine-Jean Gros, Il generale Bonaparte sul ponte di Arcole, 17 Novembre 1796, 1796-1797, Arenenberg, Castello
Allievi di Etienne Bonnot de Condillac, Claude-Adrien Helvétius e Jean-Antoine-Nicolas Caritat de Condorcet (1743-1794), gli idéologues iniziano a riunirsi a Auteuil nel 1771. I più noti saranno Antoine-Louis-Claude Destutt de Tracy (1754-1836), Pierre-Jean-George Cabanis (1757-1808), Constantin-François Volney (1757-1820), François Thurot (1727-1760).
Teoria dell’uomo e della conoscenza
Gli Elementi di ideologia di Destutt de Tracy (1801-1815) e i Rapporti tra il fisico e il morale dell’uomo di Cabanis (1796-1802) sono i principali testi in cui gli idéologues costruiscono una storia generale dell’uomo, delle sue caratteristiche e facoltà. Gli idéologues intendono questo edificio teorico come una nuova “scienza dell’uomo”: è l’idéologie, ovvero la filosofia intesa come disciplina generale, che riunisce e organizza le diverse scienze autonome e specifiche del sapere sull’uomo.
La costruzione del sapere idéologique prende le mosse dall’analisi delle idee, della loro origine, formazione, combinazione ed espressione: da qui il termine “ideologia”, con cui lo stesso Tracy definì l’orientamento teorico del gruppo.
Per Cabanis la materia vivente è un tipo particolare di sostanza la cui proprietà specifica è quella di essere la sede della sensibilità, localizzata nel sistema nervoso.
Attraverso la sensibilità del sistema nervoso la materia organica genera le sensazioni e le percezioni, quindi il pensiero: idee e pensiero sono così intesi come prodotti della materia stessa, e non più contrapposti a essa. Anche per Tracy le idee sono prodotte dalle sensazioni, che hanno una sede fisica, il sistema nervoso. Per Tracy l’idéologie è la storia del processo di formazione del pensiero: ogni idea trae origine dalla sensazione. In primo luogo c’è il sentire, in secondo luogo la memoria che ricorda una sensazione del passato, in terzo luogo il giudizio che consente di porre in relazione una sensazione con l’oggetto che l’ha causata e, da ultimo, la volontà che genera il desiderio di un oggetto ricordando la sensazione che ha suscitato.
La teoria del linguaggio, i segni e le lingue universali
Gli idéologues elaborano una teoria linguistica compatta e omogenea, che si trova principalmente nella Grammatica degli Elementi di ideologia. La lingua serve a fissare e a comunicare il pensiero, contribuendo a sviluppare le facoltà intellettuali superiori come l’astrazione e l’immaginazione. Una lingua è un sistema di segni organizzati, ovvero è un insieme di elementi significativi (un lessico) organizzati da una sintassi (un sistema di istruzioni d’uso).
Da queste premesse Tracy ricava alcune conseguenze. Oltre alla parola, qualsiasi materia fisica può fare da supporto a una lingua, posto che sia costituita da un insieme di elementi e sia organizzata da una sintassi.
Le lingue sono, inoltre, determinate dalla storia e dalla dinamica evolutiva dell’uomo e della società. Gli idéologues elencano i diversi linguaggi che si sono succeduti nella storia umana, in connessione con le fasi dello sviluppo sociale e intellettuale dell’uomo.
La lingua originale è fatta di gesti e grida. La lingua articolata nasce per convenzione nel momento in cui nasce la società civile: l’accordo linguistico. La lingua verbale si sviluppa dunque insieme all’ampiezza e all’organizzazione delle formazioni sociali. Di pari passo, secondo gli idéologues, procede la scrittura, che nasce geroglifica (cioè simbolica, per immagini), diviene poi sillabica e infine alfabetica.
Da queste osservazioni Tracy ricava l’idea che la grammatica delle lingue sia storicamente determinata e che la grammatica generale non sia altro che una descrizione molto astratta. Perciò, per Tracy è impossibile costruire una lingua universale: se non esiste un pensiero universale e innato da esprimere, qualsiasi lingua che avesse pretese di universalità si frantumerebbe nel giro di una generazione in dialetti e usi individuali.
Geografia, antropologia e scienze dell’uomo
La principale innovazione introdotta dagli idéologues in ambito antropologico è costituita dal tentativo di mettere a punto un nuovo metodo di osservazione dei “popoli selvaggi” in grado di demistificare i racconti esotici e rendere le relazioni di viaggio più rigorose. È necessario istruire nuovi viaggiatori a un’osservazione attenta del luogo fisico, del paesaggio ma anche dell’organizzazione politica e sociale e degli aspetti della vita spirituale e materiale delle popolazioni incontrate, compresi linguaggio e scrittura. Questi studi alimentano in Europa un diffuso interesse e ricerche sulla cultura popolare e sulle tradizioni locali. Di grande risonanza è all’epoca il caso del ragazzo selvaggio trovato nel 1798 nelle foreste dell’Aveyron e studiato da Pinel e Jean Marc Gaspard Itard (1774-1838), che lo considerano un esempio di uomo rimasto fermo allo stato naturale. La sua educazione diventa un esperimento antropologico sull’acquisizione del linguaggio e della socialità a partire dallo stato di natura.